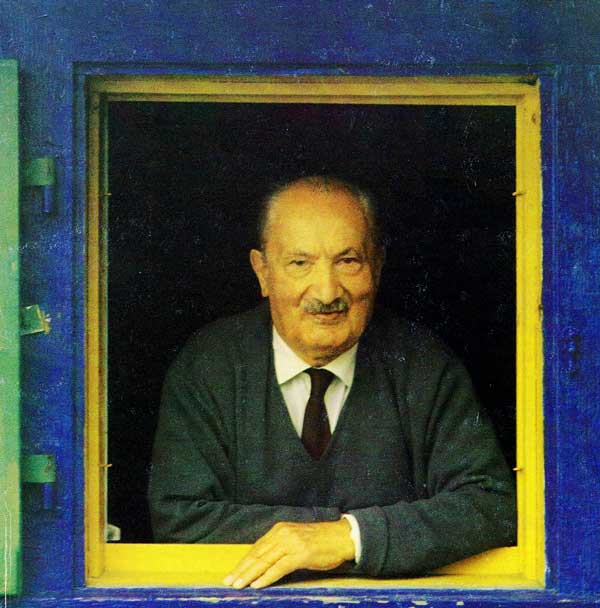di
Bruno Montanari
1. Il comune cittadino, italiano e non solo, è quotidianamente sommerso da una cascata di notizie, che, per intensità di conseguenze, talora solo potenziali, appare somigliare ad un vero e proprio bombardamento. E del bombardamento, questo affluire incessante di notizie – eventi produce i suoi effetti più scontati: macerie.
Tra le macerie c’è chi continua a vivere e chi muore; nella esperienza che investe l’attuale ambiente sociale ciò che appare esser morto è l’idea stessa di società, di opinione pubblica, di diritto, di ordinamento giuridico, di legittimità istituzionale. Appaiono essere morte, cioè, quelle figure concettuali attraverso le quali il pensiero politico della “modernità” aveva stabilizzato la relazione tra gli uomini e il potere, imprimendo all’interpretazione di quest’ultimo una direzione sempre più “funzionale”, sostituendo via via gli aspetti “padronali”. Contemporaneamente, a supporto di una tale direzione, era emerso forte il consolidarsi di una idea di società come “opinione pubblica”, con la quale chi detiene il potere deve fare i conti[ref]Basta aver presente il classico J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, tr. it. Roma – Bari 1974.[/ref].
Il Novecento, proprio nella sua “brevità”, è segnato da questo movimento di forte interazione tra potere e società, che trova la sua manifestazione, ora pacifica ora tragicamente conflittuale, nelle vicende politiche del secolo e nelle relative manifestazioni giuridico – ordinamentali.
Tutto ciò appare ora in macerie; si ergono solo le bandiere logore e stracciate, gli spezzoni di edifici… ricordi di un mondo che ha subito la distruzione di un uragano; di un uragano umano.
In questo nuovo mondo sopravvive solo l’effettività potere ed in una conformazione di nuovo “padronale”. Riferendomi ad un altro tempo storico, avrei specificato il senso dell’“effettività” del potere come controllo di un “territorio” o di un “ambiente sociale”. Non credo, invece, che oggi questa terminologia sarebbe appropriata, per la ragione che il “territorio” non è più un parametro rilevante e perché è in corso una frantumazione dell’idea di società a vantaggio di individualismi, di singoli o di gruppi.
Ciò che sopravvive, insomma, è un potere nuovamente “padronale”, la cui iconografia è del tutto inedita, ma perfettamente aderente a quella trasformazione epocale che può essere riassunta sotto l’espressione “governance della complessità”.
L’iconografia “moderna” del potere poteva essere testimoniata da tre immagini: quella classica che avvolge (è il caso di dirlo) il frontespizio dell’edizione del 1651 del Leviatano, o quella dell’uomo seduto sul trono di fronte ad una platea di uomini sotto-posti, alla Canetti, o, infine, quella della piramide, che esprime l’esistenza di un ordine costituito da un vertice e da una base.
Comunque si voglia raffigurare il potere, ci si avvede che nella modernità e fino al Novecento, nella sua accezione “breve”, il fattore costitutivo del potere è un confine, che delimita e determina la sua “effettività”. Sia questo costituito dal corpo del Leviatano, dalla sala di un trono o dalle linee di una struttura burocratica, l’effettività del potere non appare disgiunta dall’esistenza di uno spazio chiuso, dove la sua chiusura coincide con il determinarsi di un sistema, la cui origine è nell’ idea di ordine e il cui fine è nel fatto della stabilità.
In altre parole, l’idea di confine, che evoca, come riferimento immediato, il “territorio”, è ciò che nella cultura della modernità è un fattore costitutivo dell’effettività del potere, così scontato ed indiscutibile che non sfiora nessun pensatore la possibilità teorica di prenderlo in considerazione, se non come ovvia determinazione.
Nel secolo che viviamo, che è indicato dal numero romano XXI, l’iconografia del potere cambia, riflettendo la radicalità di mutamento dei fattori costituenti. Non più territorio – ordine – sistema, ma globalità – complessità – equilibrio.
Il tratto distintivo dell’immagine che ne scaturisce è il suo essere senza confine; tale immagine è la “rete”, che nella sua versione inglese – network – è largamente usata nel lessico comune, per indicare fenomeni di connessione diffusa e plurima.
In effetti la rete, come oggetto fisico, è caratterizzata dal non avere un ambito oggettivamente pre-determinabile; essa si estende fin là dove la si vuol far arrivare e si può continuamente intervenire per modificarne l’ampiezza. La rete, cioè, individua un oggetto di grandezza indeterminata, che dipende da due fattori: dalla orizzontalitàdello svolgersi della trama e dai nodi che ne sorreggono la struttura. Trama e nodi sono elementi che si implicano a vicenda: se non ci fossero i fili non potrebbero costituirsi dei nodi e senza i nodi non si formerebbe una trama. In più: ogni nodo è intersezione di diversi fili, alcuni dei quali, rimanendo gli stessi, vanno a connettersi con altri per mezzo di nuovi nodi.
Ecco, questa è l’immagine del potere così come si presenta oggi nel mondo globale: non più un trono o una piramide, che protegge e ordina, ma una rete, la cui trama include ed esclude. C’è chi appartiene alla rete, e raccoglie puntualmente i frutti della pesca, e chi ne è fuori, e nuota liberamente nel mare aperto, cibandosi di ciò che il mare nella sua naturale, ma anche intermittente, generosità offre. Per rimanere nella metafora, non vanno esclusi neppure gli allevamenti artificiali, dove la rete è il mezzo che assicura la raccolta del prodotto e l’autoriproduzione, lontano da fattori di interferenza ambientale. L’ambiente sociale risulta così diviso a metà in senso orizzontale, tra chi appartiene alla rete e chi non vi appartiene; non una separazione di censo o di cultura, né di classi sociali, ma una semplice divisione tra l’essere “dentro” la trama oppure restarne “fuori”.
La conferma è negli scoop quotidiani dei mass media, che mettono in mostra un ambiente social nel quale, come si usa dire, “si conoscono tutti” tra di loro, come in una enorme comitiva ludica, dai politici agli attori, agli sportivi, ad alcuni industriali, a magistrati e professionisti, fino agli alti burocrati, ai managers, pubblici e privati, ai banchieri.
L’immagine della rete modifica, allora, il paradigma tradizionale del potere, in quantofunzione della politica, rispetto a quello rappresentato dall’immagine della piramide. Modifica anche, e radicalmente, l’ idea che del diritto hanno gli attori del nuovo spazio reticolare: non più apparato di controllo delle decisioni politiche e della loro compatibilità con l’ordinamento giuridico, ma semplice appendice tecnico – normativa delle decisioni economiche.
L’iconografia della piramide mette in chiaro come vertice e base siano tra loro posti in relazione reciproca come i due lati di una sezione triangolare. A buon diritto, può essere considerata come la rappresentazione di quel paradigma relazionale tra società e organi di governo tipico delle democrazie rappresentative, delle quali il partito costituiva il principale luogo di formazione del progetto politico e la cinghia di trasmissione del consenso, strumento insostituibile – quest’ultimo – della legittimazione delle istituzioni di governo. Vi è da aggiungere un particolare, niente affatto trascurabile: la struttura piramidale, in virtù della sua forma chiusa allusiva dell’ordine giuridico – politico, consente di racchiudere al proprio interno la dialettica tra movimento e istituzione, propria dell’agire politico, ideale e progettuale.
L’immagine della rete rende visivamente palpabile un paradigma del tutto diverso, poiché il fattore caratterizzante non è più costituito da un elemento che per la sua forma fisica possa veicolare l’idea di una relazione tra vertice e base: la rete, infatti, non halati, ma la sua trama opera una divisione tra un dentro e un fuori. E’ una immagine che annulla ab origine l’idea di una relazione tra ambiti sociali: il potere, come luogo della “raccolta”, è dentro; l’ambiente sociale, genericamente inteso, è ciò che è fuori.
Di qui una serie di conseguenze sostanziali, che risultano del tutto estranee alla semantica formale del proceduralismo politico tradizionale.
Le più evidenti sono due: la prima consiste nell’evaporare dell’idea di partito politico in favore dell’affermarsi di comitati affaristico – elettorali, centrati sulla figura di unleader, che assicura la funzionalità dell’essere in rete; la seconda, nell’emergere di un alto astensionismo elettorale, che è la testimonianza più evidente della frattura che attraversa orizzontalmente l’ambiente sociale.
Oltre a queste due principali conseguenze, la novità del paradigma consente di coglierne altre, come corollari. In particolare, la disaffezione sociale per le istituzioni si converte in un diffuso individualismo di massa, che pervade coloro che non appartengono al tessuto reticolare, cui corrisponde, al di qua della rete, il formarsi di una struttura di potere di origine burocratica e tecnocratica, evocata, ma al tempo stesso nascosta, dal termine governance, che come è ormai noto, è di incerto significato e per questo assolutamente privo di traducibilità[ref]Per un’analisi delle ambiguità concettuali del termine governance e della sua “intraducibilità” semantica cfr. soprattutto S. Maffettone, La pensabilità del mondo. Filosofia e governanza globale, Milano 2006.[/ref].
In un paradigma così strutturato, privo cioè di strutture politicamente e sociologicamente relazionali, ciò che si delinea è una frattura tra la dimensione movimentista (di tipo populista) e quella istituzionale, che politica e diritto, nella connotazione che assumono nella nuova versione reticolare (che mostrerò di qui a poco), non sono in grado di comporre, metabolizzare, in una parola, “ordinare”.
Aggiungerei un ulteriore corollario, che mostra un inedito nella storia del potere: un potere reticolare impedisce la possibilità di una sua imputazione soggettivamente determinata. In altre parole, con una frase ad effetto, a chi si potrebbe tagliare la testa? Al più, si possono fare buchi nella rete, ma, come ogni esperto pescatore sa, la rete si può sempre riparare, aspettando il giorno che sia così logora che ripararla sarà impossibile.
Lo svolgersi attuale di questo paradigma ha il suo immediato antecedente nel modello socio-epistemologico allestito negli anni ’70 da Niklas Luhmann, che è conosciuto come “sistemico – funzionalistico”. Fin da ora voglio sottolineare, tuttavia, che tra quel modello e il suo attuale svolgimento reticolare vi è una specifica differenza: quella conseguente all’affermarsi di una linea di pensiero materialistico – pragmatica, centrata sulla diffusione applicativa della categoria, di origine economicistica, “costi – benefici”.
Il richiamo a Luhmann mi sembra tuttavia indispensabile per due ragioni: la prima, perché legittima lo spostamento del ragionamento attorno al potere su quel piano epistemologico che contrappone “ordine” a “complessità”; la seconda, perché la differenza tra la versione originaria luhmanniana, detta “sistemica”, e l’attuale conversione in una governance “reticolare”, mette in luce quale mutamento culturale l’avvento della globalizzazione economica abbia determinato rispetto al paradigma tradizionale che ha legittimato le democrazie parlamentari.
2. Le immagini con le quali ho descritto metaforicamente il potere, tra modernità e globalizzazione, rimandano a mondi culturali, nei quali si avvicendano figure concettuali, quali “ordine” e “complessità”, che corrispondono, come ho sottolineato, a percorsi epistemologici radicalmente diversi, sui quali incide, e in modo determinante, qualcosa che sulle prime non appare avere alcuna relazione con il potere: mi riferisco all’idea di “verità”. Ma una qualche relazione diviene intuibile se si coniuga quell’idea con un’ altra: quella di “realtà”.
Il nesso “verità” – “realtà” è ciò che salda l’ambito epistemologico ai modelli pratico – comportamentistici inscritti nell’alternativa “ordine – complessità”; a questo punto, il modo di determinare il potere, in quanto effettività, dipende dallo svolgimento di questo nesso.
Intendo dire che registrare l’effettività del potere a partire da un modello epistemologico fondato sul concetto di “ordine”, e sulla figura della piramide (vertice e base), è il contrario che assumere come chiave epistemologica il concetto di “complessità” e vederne la sua proiezione pratica nella “rete”. Ne derivano due rappresentazioni della “realtà” sociale così diverse da condizionare il connotarsi stesso dell’effettività. Nel primo caso, essa coincide con un sistema di comando, mentre, nel secondo, consiste in un meccanismo di raccolta.
Il passaggio dall’ “ordine” alla “complessità” è l’esito, come ho detto, dell’avvicendarsi di due modelli epistemologici, che si svolgono secondo quelle “sequenze” concettuali sopra indicate. Il primo modello consiste nella sequenza “ordine – sistema – ordinamento”, il secondo in quella: “complessità – equilibrio – governance”. Si notino i contrappunti: così come all’ordine corrisponde la complessità, all’idea di sistemacorrisponde quella di equilibrio e, infine, alla nozione giuridica di ordinamento quella di governance.
E’ proprio facendo centro su tali contrappunti, che rinviano a rappresentazioni concrete del mondo umano, che si mostra la relazione tutta epistemologica tra “verità” e “realtà”, che può riassumersi nella espressione comune, che funge spesso da premessa direttivo – comportamentistica: “poiché le cose stanno così, allora…”.
La profondità del passaggio è tale che non è configurabile come un mero aggiornamento nozionistico-semantico, determinato dalla contaminazione di un lessico sociologico con uno specificamente giuridico e politico, come il prevalere del termine governance su quello di ordinamento lascerebbe intendere (esemplare è la prevalenza della nozione di “portatori di interessi” al posto di “legittimazione soggettiva). Ben altrimenti, si tratta dell’emergere di una sottesa e diversa modalità di conoscenza della realtà, che trova poi specifico svolgimento nella forma “regolativa” detta appunto governance.
Stabilendo il contrappunto tra due sequenze concettuali, intendo sottolineare quanto sia indispensabile cogliere, proprio nelle epoche segnate da forti mutamenti, il nesso tra il piano epistemologico e quello della “realtà”, consegnata ad una rappresentazioneumano – sociale.
In tali epoche, infatti, la necessità di realizzare immediati adattamenti teorici e pratici, in particolare socio – politici e giuridici, può non lasciare il tempo di soffermarsi, con l’attenzione necessaria, sulla portata effettiva del cambiamento in atto, con il rischio di perderne il controllo e di ritrovarsi in un “nuovo mondo”, senza aver capito né il “come” né il “perché”.
La differenza tra le due sequenze prospettate ha, dunque, il suo centro contrappuntistico nei termini “ordine” e “complessità”.
Il termine “ordine” fa pensare a qualcosa che si offre come un dato oggettivo, che rinvia a qualcosa di posto e, in più, come ulteriore ed immediata conseguenza logica, “posto”da qualcuno. In altre parole, l’ordine implica il “porre in ordine” e quest’ultimo apre, nella logica umana, alla domanda circa il “chi pone…”.
È questo il modello proprio del pensiero antico, che ha il suo centro epistemico nella ricerca di un “Principio” ordinatore, come origine del mondo che si presenta all’uomo. È la tematica che ruota attorno a due termini filosoficamente complessi: Logos eDemiurgo, attraverso i quali l’uomo investiga il senso umano della “realtà” nella quale è immerso. Al tempo stesso, però, traccia una distanza incolmabile tra la sua umanità empirica e la dimensione di quel “Principio”, che è il Tutto comprendente: meraviglia ed enigma ad un tempo[ref]Cfr., su questa sconfinata tematica, il bel saggio di E. Berti, In principio era la meraviglia, Bari 2007; cfr., anche, il recentissimo F.Cavalla, All’origine del diritto – al tramonto della legge, Napoli 2011.[/ref].
Al pensiero “moderno” si attaglia propriamente il termine “sistema”, che connota quel meccanismo della ragione secondo il quale conoscere la realtà, significa scoprire laverità del mondo, che si traduce nel formalizzarne le “leggi” che consentono di stabilire in modo costante il succedersi degli eventi. Tale operazione cognitiva conduce alla determinazione della realtà come fenomeno, sintesi quest’ultimo di una relazione causale, razionalmente elaborata e stabilita, tra eventi empiricamente osservati.
In definitiva, il termine “sistema”, nel suo concetto, va posto in relazione al termine che lo precede: “ordine”. Entrambi i termini esprimono una idea di “verità”: conoscerla significa capire che le cose stanno proprio come devono stare o perché sono state disposte così a partire da un’idea di principio (“ordine”), o perché il pensiero umano ne coglie i nessi causali, sotto il profilo razionale e logico (“sistema”).
Tuttavia, nella continuità tra pensiero “antico” e “moderno” un differenza non va sottaciuta.
Se il pensiero antico manteneva la distanza, sopra accennata, tra la mente umana e la “Verità” del mondo, giocando sull’intersezione di “enigma” e “disvelamento” (aletheia); nella “modernità”, invece, la “Verità” diviene l’approdo di un percorso metodico della ragione sistematica. Essa è il prodotto di quell’operazione mentale che, a partire dalla esperienza empirica, elabora concetti, trasformando la mera successione di eventi in relazioni causali che la ragione si rappresenta come “necessarie”.
Si comprende, di conseguenza, come il concetto moderno di sistema svolga una funzione euristica ed epistemica: solo se si ricostruisce lo svolgersi degli eventi, o delle “cose umane” più in generale, secondo una forma sistematica, si può cogliere l’ “ordine” che al fondo regge il Tutto. La “Verità” dei moderni si realizza nel colmare, tramite la ragione, la distanza antica tra la mente umana e la “meraviglia” di fronte al “Principio”.
“Ordinamento” è il terzo termine, quello cui giunge, nell’ambito giuridico, la sequenza “moderna”.
Nella sua specificità concettuale, esso individua la compattezza e organicità razionali dell’attività normativa, posta in essere dallo Stato o da altri soggetti dotati legittimamente o legalmente di tale potere. Nella sua idea di fondo, esso si pone in continuità con due possibili direzioni speculative: da un lato, con una idea di diritto, secondo la quale il giuridico è la traduzione normativa dell’“ordine” che costituisce il mondo umano (la tradizione della scientia juris sia nella sua versione giusnaturalistica, sia in quella “storica”); dall’altro, con una definizione di ordine squisitamente “positiva”, che si realizza, tuttavia, secondo una sistematicità razionale della volontà normativa (la teoria del diritto nella sua versione principalmente novecentesca, nel suo insieme e nelle sue diverse e specifiche articolazioni).
Vi è un elemento, che contraddistingue la sequenza ordine – sistema – ordinamento, e che occorre mettere in luce al termine della sua spiegazione. Tale elemento è costituito dalla categoria “tempo”[ref]Su questa categoria, nella sua ampiezza ermeneutica, cfr. il bel testo di J. T. Fraser,Time. The Familiar Stranger, Amherst, 1987, tr. it. Milano 1992; per un assaggio assai gustoso cfr. anche il recentissimo M. Dorato, Che cos’è il tempo? Einstein, Gödel e l’esperienza comune, Roma 2013 .[/ref], poiché è proprio sul rilievo che assume tale categoria che può tracciarsi la differenza più evidente con la seconda sequenza: complessità – equilibrio – governance.
Anticipando qui, per mere ragioni di contrappunto espositivo, ciò su cui tornerò più avanti, dico subito che “complessità” è una nozione epistemologica di tipo meramente osservativo, per la quale il fattore temporale si fissa nella stabilità di una situazione di “equilibrio” attuale, la sola che può rendere osservabile una casuale disposizione di eventi. In altre parole, l’“equilibrio”, oltre ad essere un dato osservativi, funziona anche da categoria epistemologica che fa coincidere ciò che è “realtà” con uno stato denominato “complessità”. Se ne ricava un’idea di stabilità che, essendo fondata sulla contingenza dell’osservazione, rende insignificante l’immagine di una relazione causale tra eventi, che per definizione è meramente congetturale e non empirica.
E’ proprio la nozione di “stabilità” che mette in relazione temporalità e potere.
La stabilità infatti è il più evidente tra gli elementi costitutivi dell’effettività del potere; ciò che muta storicamente è la condizione alla quale si registra tale stabilità. In tutto l’arco della modernità essa consisteva nell’idea di “sistema”, come sintesi razionale di progetto politico e normatività legale: la figura della piramide, nella quale vertice e base si reggono reciprocamente, ne trasmette il senso.
Con il concetto di “complessità” la stabilità è, invece, l’esito dell’ “equilibrio”, che è una figura epistemologica strettamente dipendente dalla reiterazione di costanti osservative aventi ad oggetto un ambiente fisico. In altre parole, la stabilità, che individua l’esserci effettivo del potere, coincide con quell’espressione “tutto si tiene”, che indica la presenza materiale di un determinato stato di fatto, la cui permanenza si offre come tale alla possibilità di essere osservato. Lo stato di equilibrio, che fonda l’effettività del potere, tradotto nell’espressione pragmatica “tutto si tiene”, ha nella rete la sua immagine più incisiva, ma anche la sua differenza dal funzionalismo – sistemico luhmanniano.
3. Le anticipazioni svolte risulteranno maggiormente comprensibili attraverso la svolgimento della seconda sequenza: complessità – equilibrio – governance
Ciò da cui si deve prendere le mosse, per cogliere il passaggio dalla prospettiva dell’ “ordine” a quella dell’“equilibrio”, tipica delle società “complesse”, è costituito dalla svolta epistemologica novecentesca, per il fatto che essa mette gradualmente in discussione la onnicomprensività della valenza euristica del nesso di causalità e conseguentemente rende “impensabile” la categoria razionale di “sistema”.
In particolare, sul piano dell’accertamento empirico del fatto, le teorie della conoscenza contemporanee[ref]Cfr. alcuni testi da considerarsi “classici” per tale tema: H. Hahn-O. Neurath-R. Carnap, Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis, Wien 1929, tr. it. Bari 1979; M. Bunge, La causalità. Il posto del principio causale nella scienza moderna,Boringhieri, Torino 1970; P. K. Feyerabend, Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London 1975, tr.it., Milano 1981, in part. p. 30 e ss.; M. Baldini,Teoria e storia della scienza, Roma 1975, pp. 9-27; W. Heisenberg, Tradition in der Wissenschaft, München 1977, tr. it., Milano 1982; I. Prigogine-I. Stengers, La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science, Paris 1979, tr.it., Torino 1981; Idd., La fin des certitudes. Temps, chaos et le lois de la nature, Paris 1996, trad. it. Torino 1997.[/ref] hanno variamente dimostrato come nell’indagine scientifica non sia possibile astrarre dalla interazione, che diviene cognitivamente “costitutiva”, tra “osservatore” e oggetto osservato. Ciò significa che l’osservatore fa parte del sistema osservato e il metodo non può essere pensato separatamente dall’oggetto indagato. Si passa, insomma, dalla costitutività della ragione alla costitutività della osservazione. Ed è su questo passaggio che entra in gioco la categoria “tempo”, alla quale ho già fatto cenno.
L’equilibrio, infatti, è una dimensione “contingente” che è rilevabile nel momento dell’ osservazione; esso contiene quell’eccesso di possibilità fattuali, che individua la struttura paradigmatica della “complessità”, in generale, e di quella sociale, in particolare. In altre parole, il fatto, così come viene determinato nell’istante dell’osservazione, non può essere come tale oggetto di una pre-visione, essendo una possibilità tra le tante; sarebbe un fatto diverso, se osservato in un istante diverso.
La categoria della “complessità” richiama proprio quel contesto epistemologico caratterizzato dalla mera possibilità di interazioni in sospensione bilanciata, che è tutto il contrario, dal punto di vista epistemologico, della categoria della relazionalità causalistica.
Sicché l’ “equilibrio” nella interazione, che costituisce la condizione per l’osservabilità della complessità, coincide con una situazione strutturalmente imprevedibile, che si può soltanto constatare nel suo darsi materiale nella contingenza.
Il fatto, strettamente legato al momento della osservazione, al tempo stesso soggettiva e “contestuale”, non può essere più isolato nella sua purezza. Di qui la perdita di significato del nesso di causalità, a tutto vantaggio di quelle categorie epistemologiche della imprevedibilità ed incertezza, che sono il tratto comune su cui si fondano le teorie della complessità sociale.
Per comprendere, allora, “il sociale”, in quanto ambiente stabile, occorre svolgere, teoricamente, un’opera di “riduzione” delle possibilità, al fine pratico di contenere e gestire la complessità stessa entro i limiti della “contingenza”, la quale rimane sempre aperta, tuttavia, all’interazione con l’ambiente. Di conseguenza, l’equilibrio che deriva dalle operazioni di riduzione della complessità, dà luogo a punti di stabilità possibile entro un apparato di interazioni dal profilo piatto e orizzontale, radicalmente diverso da quella gerarchia verticale, che caratterizza l’ordine istituzionale tipico della Stato “moderno”.
Ho già detto come si debba a Niklas Luhmann l’applicazione della epistemologia della “complessità” alla comprensione delle dinamiche sociali e alla definizione di “ambiente sociale”. Ho anche aggiunto come ritenga, io, di dover sottolineare una differenza tra l’epistemologia luhmanniana degli anni ’70 – 80 del secolo scorso e l’attuale pragmatismo della globalizzazione.
L’epistemologia luhmanniana, infatti, ha il suo punto di forza, ancora, nell’idea razionalistica e storicistica di “sistema”, con una declinazione, però, del tutto inedita, che si riflette nella variazione semantica dell’aggettivo: da “sistematico” a “sistemico”. Significativa è proprio questa relazione tra continuità concettuale e variazionesemantica.
Sul piano puramente formale, la presenza del “sistema” nell’orizzonte di pensiero di Luhmann sta a dimostrare l’eredità hegeliana propria della sua formazione francofortese; tale profilo biografico-formale conduce ad una questione epistemologicamente sostanziale.
Sta a mostrare, cioè, come rimanga ferma l’idea che la comprensione di ciò che può definirsi “realtà” resti legata alla possibilità di ricondurre il molteplice all’unità, come appunto il riferimento concettuale al “sistema” certifica.
Il nuovo significato che rende ragione della variazione semantica: “sistematico” – “sistemico” è conseguenza del radicale abbandono di un qualsiasi riferimento non empiristico. Il nuovo modello per una comprensione unitaria non si realizza in una forma di trascendimento del molteplice nell’unità del “Tutto”, ma, più empiricamente, in una “riduzione” di variabili; ciò a beneficio della possibilità di abbracciare con un unico atto osservativo, con un unico sguardo dunque, la molteplicità degli eventi-forze, còlti nel loro contingente equilibrio.
Se questa è la lettura luhmanniana, che viene normalmente classificata come “funzionalistico-sistemica”, essa allora ha un esito epistemologico che mostra la sua differenza con l’attuale pragmatismo.
Il “mondo” di Luhmann aveva come orizzonte i confini dello Stato, che contenevano la politica e l’ordinamento giuridico; quello attuale della governance si svolge nello spazio privo di confini, dominato dai potentati economici, più forti della progettualità “ideale” della politica.
La differenza tra i due “mondi” si coglie attraverso l’esempio offerto dal rapporto tra potere e ordinamento istituzionale.
In Luhmann la permanenza categoriale della “dogmatica giuridica”, sia pure riletta nella sua “funzione” di confine semantico del “sottosistema” giuridico, realizza una autosufficienza di questo rispetto a quello politico. Ciò consente di tener ferma la funzione di controllo critico propria del giuridico nei confronti di una normatività, che sia manifestazione immediata delle pretese del politico[ref]Cfr. N. Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart 1974, tr. it., Bologna 1978.[/ref].
Nell’empirismo pragmatico contemporaneo, al contrario, la complessità non dà luogo a modalità di comprensione unitaria, ma conduce lo sguardo verso una situazione composta da una molteplicità di intersezioni, che fanno somigliare l’ambiente sociale, più che ad un sistema unitariamente comprensibile, ad un tessuto reticolare[ref]Negli ultimi anni l’applicazione della metafora, o del paradigma, della rete allo studio delle relazioni sociali e in particolare giuridiche è divenuta corrente: tra i testi fondamentali anche per un approccio filosofico-giuridico v., a titolo esemplificativo, M. Castells, The Rise of the Network Society (The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I), Cambridge-Oxford 1996, trad. it. La nascita della società in rete, Milano, 2002; A-L.Barabási, Linked: How Everything is Connected to Everything Else and What it Means for Business, Science, and Everyday Life, New York 2002, trad. it. Link. La scienza delle reti, Torino 2004; F. Ost-M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles 2002; P. Heritier,Urbe-Internet. La rete figurale del diritto. Materiali per un ipertesto didattico, vol. 1, Torino 2003; U. Pagallo, Teoria giuridica della complessità. Dalla ‘polis primitiva’ di Socrate ai ‘mondi piccoli’ dell’informatica: un approccio evolutivo, Torino 2006 (spec. pp. 135-171); A. Calbucci (a cura di), La complessità del diritto. Nuovi itinerari del pensiero giuridico contemporaneo, Napoli 2009. Molto in anticipo sull’emersione del fenomeno di Internet, Enrico di Robilant applicava al diritto il modello della rete già inIl diritto nella società industriale, “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, L, 1973, pp. 225-262.[/ref].
L’attuale, diversa comprensione della realtà conduce all’evaporazione della categoria della politica, storicamente e concettualmente legata alla forma della sovranità statuale, in favore della dominanza della categoria economica, che, in un’economia di mercato, è transnazionale e sovrastatuale.
E’ in quest’ultimo contesto che ritengo vada collocata la attuale nozione di governance, nella quale la visione di un ambiente sociale complesso in equilibrio deve essere rimodulata secondo una immagine di tipo puntistico-reticolare.
La governance implica, quindi, una considerazione, ancora diversa, sia del riferimento al funzionamento di fatto del complesso istituzionale, in generale, sia di quello, specifico, relativo ad un determinato ambito di regolazione normativa.
Il modello che si delinea, attraverso questa prospettiva “regolativa”, infatti, non solo non è verticale, ma neppure “sistemico” à la Luhmann; esso è orizzontale e aperto, come orizzontale e aperta è l’immagine di una rete composta da una molteplicità, a priori indeterminabile, di intersezioni tra eventi fattuali che realizzano un equilibrio compensativo.
La differenza tra i due modelli è tale da mettere in crisi la configurazione “classica” delle istituzioni rappresentative elaborate dalla modernità, che Luhmann (è bene sottolineare) non aveva messo in discussione, pur se rilette in chiave funzionalistico-sistemica[ref]V. Politische Planung, Opladen 1978; tr. it., Stato di diritto e sistema sociale, Napoli 1990. Peculiari sviluppi della teoria di Luhmann si trovano, come è noto, nel pensiero di Günther Teubner. A tal proposito cfr. il suo Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main 1989, tr. it., Milano 1996.[/ref].
4. Evaporato il nesso Stato – politica – diritto, ne segue, sul piano istituzionale, la problematica tenuta concettuale dell’idea di “Stato di diritto” e di democrazia rappresentativa e, su quello giuridico, della categoria di “ordinamento” e della gerarchia delle fonti.
In particolare, utilizzare, sul piano politico, i modelli di governance come equilibrio reticolare, dà luogo ad un esito paradossale, quale è quello costituito dalla contemporanea presenza di due fenomeni strutturalmente antitetici, che non riescono a disporsi in continuità tra loro e neppure a dialogare, sia pure secondo una modalità dialettica.
Da una parte, avanzano e chiedono spazio le prassi di democrazia immediatamente partecipativa, attraverso il diretto coinvolgimento, nei processi decisionali, di coloro che alle decisioni pubbliche dovranno attenersi. Dall’altra, emergono, con sempre maggiore capacità performativa, istanze “tecnocratiche”, espressione diretta degli “interessi” di soggetti che, per la loro struttura socio-economica, non hanno per proprio fine il perseguimento del “bene” pubblico[ref]Nel linguaggio comune si usa il termine “interesse” in modo promiscuo, in relazione, cioè, sia al “privato” che al “pubblico”. Nelle righe del testo, invece, ho volutamente utilizzato il termine “interesse” per la sfera dei soggetti “privati”, destinando il termine “bene” al fine “pubblico”. Questo perché l’ “interesse” è legato al concetto di “bisogno” e il criterio di valutazione è soggettivistico-utilitaristico, proprio della sfera “privata”; il “bene”, invece, evoca un ambito valutativo di tipo “oggettivistico” (per quanto ambigue ed epistemologicamente problematiche siano sia la categoria dell’ “oggettività” sia quella di “bene”), che mi appare più appropriato per soddisfare la sfera “pubblica”. Per questa ragione, la costituzione pubblica del soggetto-attore è una garanzia indispensabile, sia pure solamente “formale” (ma non potrebbe esserlo diversamente), rispetto alla plausibile finalità sociale degli atti performativi.[/ref].
Sul piano giuridico, la crisi della democrazia rappresentativa si traduce nella crisi della legge “democratica” come fonte privilegiata dell’ordinamento, e quindi nella crisi degli elementi strutturali della generalità, dell’astrattezza, della pubblicità. Ciò conduce all’esaltazione di modalità contrattuali e giudiziarie che, snaturate rispetto alla loro classica funzione ordinamentale, si presentano come le matrici del “nuovo” diritto. Con una formula sintetica, si può dire che al criterio giuridico-politico della soggettività legittima o, detta altrimenti, della legittimazione soggettiva, si sostituisce la presa d’atto della pressione fattuale di entità portatrici di interessi abbastanza forti da avere, nella competizione, una capacità di negoziazione.
Ciò trova riscontro, ad esempio, nel darsi di prassi di governance in cui soggetti, la cui originaria costituzione pubblica o privata diviene indifferente, entrano in una relazione contrattuale in quanto meri portatori di interessi, con il fine di produrre una “regolazione” idonea a comporre tali interessi, in una maniera che si ritiene più rapida e soddisfacente di quanto non possano fare gli strumenti ordinamentali.
La crisi della democrazia rappresentativa indotta dal modello di governance comporta la crisi della categoria del “politico”, poiché elimina la possibilità di ideare un progetto; e ciò non senza una ragione epistemologica, che riguarda quella categoria del “tempo” alla quale ho già accennato e che ora intendo approfondire.
La situazione di “equilibrio”, sulla quale si costruisce la governance, coincide, sotto il profilo temporale, con una osservazione puntuale, la cui stabilità si apprezza solo in quanto già così si offre all’osservatore. Proprio in quanto è solo osservabile, non è possibile progettarla. La temporalità è quella istantanea dell’ osservazione .
Qui risiede la differenza strutturale con la sequenza concettuale ordine-sistema, che si proietta nel concetto di ordinamento giuridico.
Tale sequenza, infatti, è attraversata razionalmente da una idea di tempo strutturata dalle categorie di “mutamento” e “durata”, da cogliersi epistemologicamente secondo la chiave della continuità. Come dire che la discontinuità dell’osservazione esperienziale viene trasformata in una continuità prodotta dalla elaborazione razionale[ref]Cfr., sul tema “continuità/discontinuità”, quale emerge in un contesto strettamente “scientifico-epistemologico”, E. Schrödinger, What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge 1944, tr. it. Milano 1995, p. 86 e ss.[/ref]. Basti pensare alla nozione, già messa in luce, di “relazione causale”, che dispone secondo continuità, a fini cognitivi, i diversi eventi del reale, per cui la conoscenza è il prodotto mentale di un percorso tra un prima e un dopo. Un tale modello di ragionamento consente mentalmente di stabile una funzione causale tra un “evento” ed un altro “evento”, che diviene un esito conseguenziale del primo; il presente diviene così lo snodo di una continuità causale tra passato e futuro.
La chiave della temporalità risulta evidente negli elementi strutturali del diritto concepito secondo una prospettiva ordinamentale. Basti pensare al concetto di “norma” che sintetizza semanticamente un nesso razional-causale, e quindi temporalmente dislocato, tra prescrizione, dovere e responsabilità.
L’esempio più facile e scontato è proprio nella struttura di quell’atto normativo denominato “legge”. Essa è un atto il cui fine è durare nel tempo: il “durare nel tempo” è il fattore razionale, che consente di emancipare l’atto dai soggetti fisici che lo pongono in essere, di considerarlo, cioè, un in sé, indipendentemente da quelli. La legge non esprime un equilibrio nell’istante, ma il suo fine strutturale è un dover essere nel tempo.
Il senso della transizione mi sembra che possa essere raccolto nella seguente sottolineatura: come l’ordinare era stato il fine pratico del diritto fondato appunto sul concetto di “ordine” come principio teoretico, filosofico e culturale; così l’equilibriorappresenta l’obiettivo pratico di una attività regolativa – la governance – conseguente al modello epistemologico della “complessità” sociale.
La governance, praticata con una disinvoltura pericolosamente ignorante della costituzione epistemologica della sua nozione, è la causa non contingente della crisi della categoria del “politico” ed è il mezzo che consegna il potere alla tecnocrazia economico-finanziaria, che per sua costituzione, è a- democratica. E’ il potere acefalo della rete.
5. L’iconografia della piramide e quella, opposta, della rete mettono in luce grafica qualcosa di sconcertante, destinato a riflettersi sulla vicenda umana in modo incalcolabilmente rischioso.
Il potere, dall’avere una testa, è divenuto acefalo. Il vertice della piramide è inscindibile dai suoi assi portanti, in salita ed in discesa, che sia un trono o un’aula parlamentare: in ogni caso quel vertice indica una precisa individuazione soggettiva. Esiste un “responsabile” del potere. Può farsi lo stesso ragionamento per i nodi e i fili che tessono e armano una rete? Ciò che è rilevante non sono i soggetti, quanto il loro annodarsi eriannodarsi: l’effettività del potere risiede proprio in questo tenersi in modo indefinitamente plurimo e diffuso.
Se la piramide ha reso spesso crudele il potere, la rete lo rende privo della umanità soggettiva del corpo. Ciò si mostra in tutta la sua inquietante portata se solo si presta attenzione alla circostanza della saldatura tra le tecnologie cibernetico-informatiche e la rete: la decisione umana visibile è sostituita dalla anonima performatività dell’algoritmo, in virtù del quale l’umano certamente non scompare – chi costruisce infatti gli algoritmi e il loro modo di operare? – ma diviene invisibile. L’uomo non vede neppure i dati che scatenano la performatività dell’algoritmo, così come i piloti americani che sganciarono la “bomba” non videro i corpi ardenti delle vittime, migliaia di metri sotto di loro.
L’algoritmo fa sentire la sua fredda, oggettiva, non-umana performatività dalle operazioni finanziarie a quelle belliche: un incrocio virtuale di dati è sufficiente a scatenare una tempesta monetaria o a far giungere un “drone” tra le montagne dell’Afghanistan.