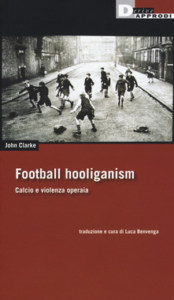John Clarke
Football hooliganism. Calcio e violenza operaia (a cura di L. Benvenga)
Deriveapprodi, Roma 2019, pp. 112, € 9,35
Intelligente operazione di scavo da parte dello studioso salentino Luca Benvenga, che offre un’ottima curatela dell’indagine storico-sociale di John Clarke sul fenomeno calcistico e sul tifo organizzato in Inghilterra (“Football Hooliganism. Calcio e violenza operaia”, per i tipi di Derive Approdi, 2018). Il tema del volume, così palesemente dichiarato nel titolo, non deve però ingenerare la sensazione che parlare del tifo organizzato significhi esclusivamente parlare della nascita delle curve, quali le conosciamo oggi in Italia, o, ancor più banalmente, discettare dei loro idoli sportivi di turno. La letteratura anglosassone alla quale, con apprezzabili profili di originalità, si rifanno tanto Clarke quanto a seguire Benvenga offre tutt’altro iter ricostruttivo. La dottrina italiana, eccezion fatta per pochi autori, come Valerio Marchi, Claudio Dionesalvi e Domenico Mungo, che però anche nell’approccio d’indagine rivendicano le loro appartenenze etiche, sociali, politiche e civili, ha all’opposto trattato del tifo sportivo secondo coordinate molto più esclusivistiche. Il campo dell’analisi penale ha, ad esempio, valorizzato, ma difficilmente giungendo a pubblicazioni di carattere monografico, le componenti delinquenziali del tifo estremo. Il contributo sociologico, per parte propria, ha o ricondotto il fenomeno ultras al folklore insito nelle ritualità di massa o esaltato una sorta di primato prospettico della curva sulla vita associata, quasi che la prima fosse il laboratorio preferenziale di ogni dispositivo che poi si sarebbe scaricato sulla seconda. Ne sono uscite, cioè, o letture declinanti, tendenzialmente superficiali e riduzionistiche, o letture mitizzanti che hanno avuto il merito di cogliere la disciplina del tifo sportivo come laboratorio sociale, ma poi hanno voluto farne – forse in errore – laboratorio esclusivo delle dinamiche concrete del potere di controllo.
L’analisi di Clarke, per come ce la restituisce Benvenga, ha un’ambizione (e un metodo in più): collocare la nascita di una specifica conformazione del tifo calcistico nella sua patria d’elezione (l’Inghilterra).
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pallone britannico inizia a dotarsi di una professionalizzazione diffusa che inevitabilmente genera sradicamento e alienazione. Il football non è più di tutti: resta di tutti, a quel momento non recintata e non recintabile, la fruizione dell’evento; la composizione e la direzione dell’evento vengono sottratti alle masse. Probabilmente, la polemica insita nell’hooliganismo contro la ramificazione governativa, gentrificata e perbenista del nascente indotto socioeconomico delle società calcistiche, più che la classe operaia, nel Paese della rivoluzione industriale, tende a riguardare e a coinvolgere ciò che la filosofia politica continentale chiama “sottoproletariato”. È anche vero che l’operaismo inglese è difficilmente districabile dal sottoproletariato: i sindacati non hanno lo stesso radicamento, né la stessa struttura, del sindacato europeo; il lavoratore di fabbrica non si sente parte dello stesso progetto di società che anelava l’operaio massa dell’operaismo italiano. In più, a quelle latitudini, la contrattualizzazione del lavoro ha raggiunto ancor prima che in Italia (dove oggi, però, impera una precarietà ben superiore) una messa in questione da parte delle forze produttive, datoriali e proprietarie. Fabbrica non è sicurezza, non è fonte di reddito idonea, in molti casi, a garantire entrate sufficienti – si vedano le forme di doppio lavoro a cavallo tra legalità ed extralegalità.
Il tentativo di riappropriazione degli spazi sociali che Benvenga ridescrive in retrospettiva, sulle profetiche orme del Marchi, tratteggia spaccati di vita urbana che scomodano il lascito intellettuale di una generazione insuperata, quanto purtroppo tramontata non solo nella bontà dell’analisi sociale, ma anche nell’anelito intellettuale che in essa riposava. Gli hoolingans, in altre parole, riscoprono una territorializzazione sociopolitica degli spazi metropolitani, per cui il loro operato, disorganico e scoordinato, prepolitico e forse antipolitico, altro non serve che a riavocare una piazza, un angolo di vita, un recinto della geografia imposta dalla normalizzazione dei poteri. È la ragione per cui nelle firm britanniche, a partire dagli anni Ottanta e crescentemente secondo le diverse coordinate geografiche, si diffonde l’idea del “casual”, del vestirsi indipendentemente dalle divise specifiche della squadra per cui si tifa: si occupa lo spazio, si preallarma una dimensione scevra dai vincoli del potere proprio perché mutevole, si crea un disordine indotto che non pesca in rivendicazioni politiche ma che consiste esclusivamente nella riaffermazione di uno spazio. Se si vogliono cogliere le dinamiche rivoltose dei banlieuesards di inizio millennio in Francia, più che alla prosa di Balibar e Ranciere, conviene rivolgersi al magma indistinto del tifo sportivo: non serve racchiudere la geopolitica della divisione urbana del lavoro sociale in un disegno di emancipazione politica (non pervenuta né invocata, né soprattutto conosciuta – il che è più grave – dai suoi agitatori). Serve immergersi, piuttosto, nell’irripetibile vocazione della fiumana popolare a pretendere l’agire collettivo di uno spazio scippato da dinamiche disciplinari incomprensibili alla bassa forza del vero vissuto.
Leggiamo perciò Benvenga, nella sua delucidante introduzione, e Clarke e a seguire, secondo un modus espositivo che sin troppo si abbevera alla metodologia neoaristotelica e neoempirista della filosofia analitica anglosassone, convinti che il vero problema non siano gli ultrà, quanto quella inevasa domanda di anti-regolamentazione egoistica degli spazi che essi postulano, talvolta senza saperlo.
Siamo abituati a ritenere che la violenza non lumeggiata da un ancoraggio dottrinale alla politica sia priva di interesse ecclesiasticistico, giusfilosifico e teoretico per lo studioso: è un’abitudine pigra, e ben se ne rendevano conto i classici del canone degli studi storico-confessionali. Rivendicare la violenza come istanza di partecipazione che implica il rovesciamento dei rapporti dialettici, per quanto affondi in un sentire che non si cura dei meccanismi di selezione democratica, non è un fenomeno alieno alle democrazie. Al contrario, ciò che è violenza immanentistica paradossalmente trascende le forme istituzionali della cosa pubblica e declama fortemente l’urgenza politica di un Carnevale dei matti, dove stavolta il momentaneo sovvertimento dei ruoli non è l’esperienza conclusa che garantisce la normalità del potere, ma la voce di un disagio profondo che impone alla neutralità del governo di credere a ciò che non crede: l’attualità del malessere, profondo e consustanziale all’organizzazione della polis, che aggredisce i confini legali e ad essi impone di ascoltare la minorità di chi appende una pezza o un drappo, perché in essi trova una costituzione, anch’essa minoritaria, del rapporto sociale che il diritto universale e astratto non ha mai avuto dono di recepire in norma. Un’antinomia settoriale e di nicchia che, però, legge il conflitto e ne prende la voce, perché articolare i fonemi è un’impellenza che nasce assai prima dell’obbligo dei significati. Per essi, al più, soccorre Wittgenstein: è l’uso a orientarli, e usi particolari contrari all’uso generale vivificano la partita di significazione di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato.
Domenico Bilotti