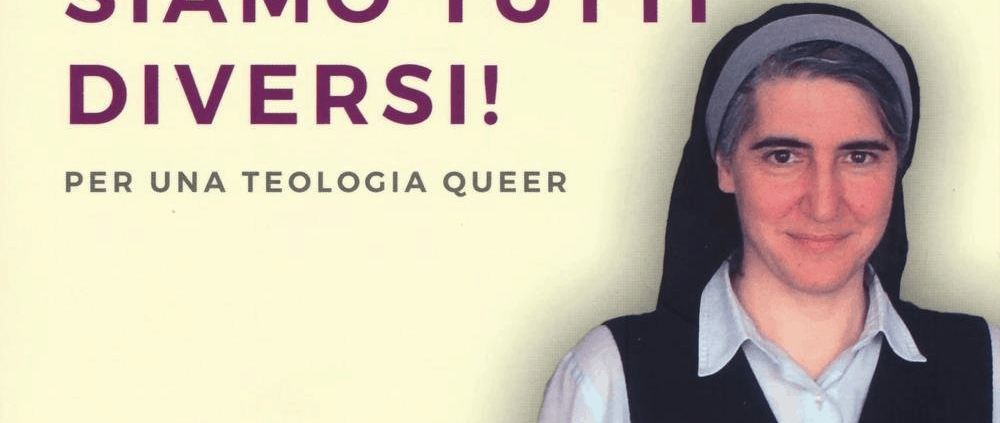IL SOCIALISMO DEL XXI SECOLO NON ESISTE
di Domenico Bilotti
Michael Walzer, teorico radicale e animatore di una delle riviste più importanti nel dibattito liberal statunitense, “Dissent”, rimproverava alla sinistra politica, in un saggio di qualche anno addietro, di aver espunto dal suo orizzonte conoscitivo e rivendicativo il tema della religione e delle religiosità nella sfera pubblica. Walzer, vicino alla cultura ebraica laico-umanista, di cui ne è in qualche modo continuatore, era a un tempo nel giusto e a un tempo in errore. È vero, la sinistra politica non aveva ragionato abbastanza sulla religione e sulle religioni, ma la direzione di quello scavo non doveva essere quella indicata dal filosofo. Si sarebbe dovuto (e il tempo non è finito) indagare piuttosto su come la secolarizzazione di principi e temi teologici si sia trasformata in norme giuridiche privatistiche, influenzando attraverso ciò l’approccio morale alle regole condivise.
Oggi Nancy Fraser rilancia non questa specifica direttrice di lavoro, quanto piuttosto il dibattito che la precede: cosa è mancato e cosa servirà al discorso sul socialismo per affermarsi nella sua contemporaneità? La Fraser lo fa con un pregevole saggio breve di peculiare raffinatezza argomentativa pubblicato, per i tipi di Castelvecchi, “Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo?”. Quel saggio, lo chiariamo indubitabilmente in premessa sì da procedere meglio in analisi, è un lavoro di grande importanza anche nella brevità, rilancia con grande qualità un percorso tematico vivido e ricco di spunti. Non stupisca perciò se la riflessione si incentrerà totalmente sui risvolti critici che il volumetto solleva: ciò vale del resto a rinfocolare il dibattito già proficuamente lanciato.
In primo luogo, l’entusiasmo di Fraser per la riscossa della sinistra socialista americana è troppo chiaramente territorializzato; si riferisce, salvo pochi inquadramenti di metodo, soprattutto all’ala del Partito Democratico statunitense che ha cercato negli ultimi anni di imporre un cambiamento di rotta al liberalismo centrista introiettato da parte importante di classe dirigente americana. Si può però dire che quella corrente non è novità di questi anni: esisteva, certo con minore efficacia e non creando il medesimo immaginario, al tempo della guerra del Golfo; esisteva negli anni scintillanti della Presidenza Clinton, quando il dominio americano sembrava aver definitivamente affermato se stesso; esisteva nei due mandati obamiani, nei quali, dialettizzando con autorevolezza, il presidente Obama era contemporaneamente un possibile alleato e non meno un leader da sferzare sul fronte della politica internazionale e della giustizia sociale. Per strano che possa sembrare, al socialismo del XXI secolo, che ancora non esiste, occorre una volta di più saper guardare con spirito “glocal”: tenere in gran conto lo sfondo analitico del contesto internazionale, ma sapere anche in quali concreti perimetri ci si muove. Manca, ad esempio e da parte nostra, una riflessione di sistema sulle possibilità dell’Europa nell’affermazione di un nuovo socialismo per il XXI secolo. Si era a lungo creduto, sino alla Third Way blairiana, che la vecchia Europa avesse un modello sociale (troppo) confortevole, ma lo si diceva in quegli stessi anni in cui si stava sfarinando, rinunciando a prestazioni sociali e dismettendo proprietà pubblica. Cos’è oggi l’Europa per il socialismo? Forse l’Unione Europea, nella sua strutturazione formale dopo il trattato di Lisbona e nel suo apparato decisionale sostanziale, non basta al socialismo, anzi lo avversa. L’Europa unitaria è tale solo se concretamente federalista, proiettata su politiche redistributive di economia reale, capace di favorire la mobilità orizzontale delle persone, senza irreggimentarsi nelle posizioni attuali – che pare dividano, in modo viepiù inconcludente, un continente già non unito in sottogruppi radunati per interessi regionali.
Nel volume della Fraser, altra issue latente è forse quella della formazione partitica. Il tanto celebrato funerale del partito, che ormai si gioca a retrodatare ad libitum, è una delle più pericolose auto-narrazioni che la sinistra si sia inflitta. Non v’è dubbio infatti che fosse necessario prendere atto di dove le liturgie e le burocrazie (per riprendere la bella intuizione di Galli) avessero definitivamente frantumato la ricchezza dialogica e relazionale della partecipazione politica resa attraverso i partiti. Ma aggregati stabili di interessi, principi, forme dell’organizzazione sociale, persino sensibilità etiche, ideologiche, comunicative, devono morire tutti insieme ai partiti? Ci si permette di formulare questo quesito dal momento che partiti e movimenti politici comunque denominati e denominabili continuano proficuamente a presentarsi alle elezioni, a fomentare campagne mediatiche, a gestire potere. Quel che è seppellito non è la salma del partito, ma la nervatura umana della sua esperienza individuale e collettiva dell’esistere.
Da Pareto in poi, con una peculiare enfasi in tutto il mutualismo socialista che precedette la formazione dei partiti marxisti novecenteschi, si elogiava la natura strutturalmente aggregativa e mediativa del partito, veicolo di interessi o, bordighianamente, peraltro, “cinghia di trasmissione”. Questa funzione è stata ampiamente equivocata e ha dato spesso vita, anche in Italia, a mere forme di welfare particolaristico. Quella funzione, tuttavia, epurata dalla sua ossificazione parassitaria, è coessenziale a un discorso sul socialismo: non per selezionare leader, non per irrigidire paradigmi organizzativi, quanto piuttosto per continuare a produrre, discernere e comporre conflitto. E qui l’analisi della Fraser trova il suo più diretto, radicale e forte, riferimento alla carne delle odierne intemperie: il socialismo del XXI secolo o realizza azione diretta sulle diseguaglianze sociali o non è socialismo.
Normalmente, il dibattito filosofico-politico degli ultimi decenni ha tenuto ontologicamente distinti i temi delle migrazioni e delle diseguaglianze sociali. Li ha ritenuti uniti sul piano funzionale (errore in parte reiterato dalla Fraser), come se a spiegare il movimento servisse il ricorso alle categorie della disparità e dell’iniquità. Ci pare che quel legame sia invece un po’ più stretto, un po’ meno contingente, un po’ meno transitorio. Alcuni tipi di crisi zonali (che siano – come dimostrato dai tempi – sanitarie, idriche, civili, di leadership religiosa o di costituzione politica), di imprevedibile gittata quanto agli effetti materiali, mettono in movimento intere generazioni di cittadini del mondo. O si attua e si agisce – cioè, si dispone e si pratica – una nuova regolamentazione anche formale del diritto migratorio, o le nostre capacità di lettura e di comprensione delle migrazioni saranno sempre e comunque aggredite e aggredibili dai corifei di presunti interessi particolaristici, inseguiti da sbandierate minacce altrettanto presunte.
Questa istanza nei movimenti sociali radicali e nelle correnti di opinione pubblica che la Fraser analizza, tematizza e perora, purtroppo non è ancora presente; l’approccio inclusivistico nei confronti delle lotte sociali dei migranti, nella odierna sinistra socialista europea e americana, non basta sfortunatamente ad assicurare la debita onda d’urto a una riscrittura complessiva della narrativa d’assalto sui fenomeni migratori. L’accoglienza senza il sussidio di istituti regolativi specifici – se non si vuole arrivare a parlare di dispositivi – è minacciata dal momento in cui il potere decisionale è preso da chi vuole reprimerla, o con leggi-vergogna chiamate un po’ ovunque “pacchetti sicurezza” o con zelante legalismo di giurisdizioni ormai abituate più alla dogmatica giuridica della condanna che a quella (d’esito invece aperto) del procedimento, la sede in cui la rappresentazione del fatto giunge a composizione nella distribuzione di ragioni di giustizia.
E forse questa è la mancanza più urticante nell’abbozzo di socialismo del XXI secolo che anche questo forum vuole attivamente concorrere a creare: una riflessione sulla giurisdizione, da intendersi soprattutto come garanzia di libertà fondamentali nella fase del giudizio. È sul giudizio e sull’esecuzione del dispositivo (ancora una volta!) che lo chiude, è lì, che si gioca una delle più importanti differenze tra democrazie e dittature, tra sistematiche socialiste di libertà e socialismi nazionalisti, tra equità e arbitrarietà. Un socialismo del XXI secolo senza garantismo non sarà socialismo, non certo quello che serve alla fase. Da troppo tempo la sinistra italiana, e di più l’opinione pubblica che vorrebbe riferirvisi, ritiene che le imperanti corruttele privilegiarie debbano essere aggredite in prima istanza dalla repressione giudiziaria. E siamo convinti che la qualità metodologica della funzione inquirente sia coessenziale al necessario equilibrio di quella giudicante, oltre che da esso non sempre per forza indivisibile. Ciò tuttavia non ha impedito affatto che i risultati pratici, oltre che la mentalità giustizialista alimentatavi, non avessero alcun riscontro reale sulla qualità dell’amministrazione e, più in generale, della vita sociale. E anche questo è tema globale, perché l’avvicendamento elettoralistico dei ceti dirigenti, quando parte dalla mera dichiarazione di boicottaggio delle malversazioni, produce esiti disastrosi: lo abbiamo visto in Brasile, negli Stati Uniti ben noti alla Fraser, persino nell’attuale riaffermazione neoconfuciana in Cina, che non ha sin qui allargato particolarmente spazi di libertà nella viva carne dell’esercizio dei diritti politici.
Siamo drastici e provocatori con la necessità che sia proprio questa la fase a richiederlo in onore della lucidità: un costituzionalismo democratico e plurale, esattamente quanto un socialismo per il XXI secolo, non potrà mai esistere senza formazione, federalismo, eguaglianza sociale, libertà di movimento, garanzie anche giudiziarie delle libertà. E se questi elementi ancora non consideriamo abbastanza, vuol dire che quel costituzionalismo e quel socialismo non esistono.