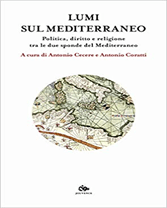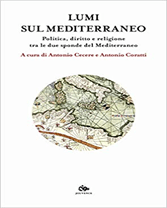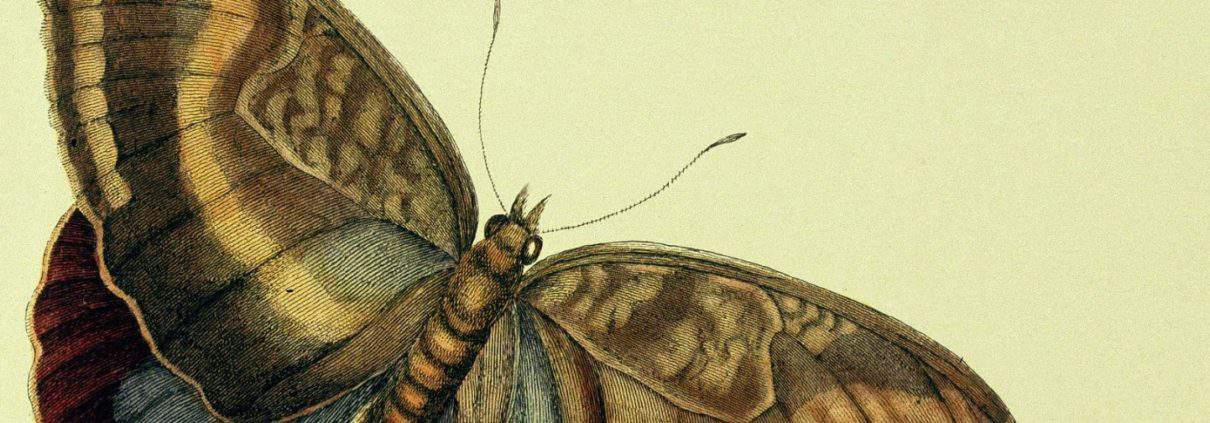“Femminismo e femminismi. Culture, luoghi, problematiche” è il tema della giornata di studio interdisciplinare svoltasi il 7 novembre presso la Macroarea di Lettere, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. L’associazione Filosofia in Movimento ha partecipato al convegno con Maria Chiarappa e Giulia Quinzi per condividere attraverso questo lavoro collettivo, le riflessioni di importanti studiosi che si sono confrontati sulla questione del femminismo, un tema oggi molto noto e per questo poco conosciuto, per dirla con Hegel.
Programma e scopo della giornata
Come suggerisce il titolo dell’evento, lo spirito trainante degli interventi intende affrontare la questione di genere come problematica trasversale analizzata attraverso una pluralità di posizioni teoriche che investono ambiti spazio-temporali diversi. La parola “femminismo” è infatti complessa, stratificata, densissima. Per farne un’analisi occorre in prima istanza intraprendere un percorso che viaggi alla ricerca dei vari nuclei tematici che la compongono, delle costellazioni di significato attraverso cui essa si articola; in secondo luogo è necessario tener conto, tracciando una mappa topologica, delle diverse regioni coinvolte, certamente distinte tra loro, ma interconnesse e complementari.
La giornata si è svolta in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, che ha ospitato i seguenti relatori:
– Marina Formica, Alle origini del femminismo: la “Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine”
– Diane Ponterotto, Feminist voices from the global South: tensions and intersections in Latin American gender scholarship
– Sandra Petroni, The representation of female identity through digital storytelling
– Simona Munari, Il femminile “in movimento”: Assia Djébar e les *Femmes d’Alger* di Delacroix
– Elisabetta Marino, Ecologia e femminismo in ‘The Madwoman of Jogare’ di Sohaila Abdulali
– Carlo Cappa, “Je n’ai de mérite que d’avoir su choisir mon maître et mes modèles”. Madame de Lambert e l’educazione femminile
– Carla Roverselli, Voci femministe dal Nord Africa: Fatema Mernissi, Assia Djebar, Nawal al Sadawi. Convergenze e divergenze educative
– Stefania Cavagnoli e Francesca Dragotto, Femminismo e femminismi: le parole dell’italiano e delle altre lingue
– Carla Francellini, Sylvia Plath ‘The Bell Jar’: un romanzo al femminile
– Donatella Caramia, Candace Pert pioniera delle Neuroscienze: sua la scoperta epocale del sistema delle emozioni
– Antonella D’Andrea, Donne e lavoro: il diritto alla non-discriminazione e alle pari opportunità
– Elvira Lozupone, Guardiamo in casa nostra: donne, università, carriere: una questione aperta Claudia Hassan, Femminicido, perchè?
– Simonetta Spiridigliozzi, Adolescenti orfane dell’identità femminile
– Gemma Errico, Il femminismo nel Risorgimento: le donne invisibili dell’Unità
Dal ‘femminismo’ ai ‘femminismi’
Per offrire una panoramica generale dei lavori, è possibile rintracciare due macro filoni di esposizione: uno storico-biografico e l’altro teoretico-pratico.
Il primo ricostruisce il percorso intrapreso da donne paradigmatiche volto all’acquisizione dei diritti politici, all’accesso all’istruzione e, in definitiva, a una parità di status civico e umano fra uomo e donna. Così, in un excursus segnato da personalità come Madame de Lambert, Olympe de Gouge e Cristina di Belgioioso, si restituisce al termine “femminismo” la specificità delle sue origini legate alle rivendicazioni politiche, economiche e sociali delle donne dal Seicento al Risorgimento italiano, passando dal Secolo dei Lumi. Tuttavia, intendiamo soffermarci sul secondo filone dal momento che diversi interventi hanno portato alla luce posizioni teoriche inaspettate e innovative, quasi “eretiche”, spesso sconosciute o mal comprese. Non a caso si parla di “femminismi”: a riprova dell’interdisciplinarità e dell’intento di analizzare “culture” e “luoghi”, la differenza si impone già in seno alla questione femminile stessa, sviluppandosi in contributi volti a differenziarsi dal “femminismo” come termine universale spesso dal significato nebuloso ed equivoco.
Donne bianche e donne nere
Diane Ponterotto è la prima ad offrire uno scenario di riflessione geograficamente trascurato: il Sud America come portatore della “southern theory”. Il suo intervento mira ad anteporre il punto di vista dell’America latina alle teorie classiche di matrice nord-occidentale intese come espressione di una cultura dominante che non riconosce la cultura del Sud. Questa visione effettua uno spostamento epistemologico che propone l’analisi delle condizioni e delle differenze della donna in base alla sua localizzazione nello spazio. In questo modo, come afferma la Ponterotto, si delinea una localizzazione del pensiero, delle “situated knowledges” e “views from somewhere” che si oppongono alla definizione della donna come concetto universale.
Le posizioni di genere delle bianche e delle nere, infatti, derivano da diversi tipi e gradi di sfruttamento; persino i problemi legati alla salute, la cura dei figli e la gravidanza, per citarne alcuni, sono vissuti e affrontati in maniera diversa. Ponterotto, inoltre, individua altri due concetti che definiscono l’originalità del pensiero sudamericano: la cosiddetta “Intersectionality” e la “Coloniality of gender”. Il primo esprime la necessità di comprendere le questioni di genere attraverso altre variabili, mostrando le differenze in base alle condizioni sottostanti alle stesse, che siano economiche, etniche o religiose; il secondo concetto intende osservare la questione di genere in un’ottica storica, la cui origine risale all’imperialismo europeo e all’economia capitalistica globale.
In particolare, in Brasile il movimento femminista si oppone a quello dominante delle donne bianche mostrando come il retaggio razziale e di genere abbia influenzato la riflessione femminista. Lo schiavismo, infatti, sottende una visione ipersessualizzata della donna afrobrasiliana, così che il corpo nero diventa schiavo sessuale del corpo bianco. La studiosa mette in evidenza come i risultati della riflessione teorica servano da supporto all’attivismo e come quest’ultimo sia di utilità per la teoria. Infatti, il gruppo di attiviste “Black women of Brazil” intende riscrivere la storia delle donne afrobrasiliane dal basso in una campagna di contrasto alla mercificazione del corpo femminile nell’industria del turismo. Inoltre, in Messico a Ciudad Juarez dal 1995 corpi di donne vengono trovati mutili delle caratteristiche fisiche femminili in prossimità di discariche e luoghi desolati. La messa in vendita del corpo femminile in Brasile e l’aspirazione a modelli corporei attraenti per il sesso opposto, simboleggiata nella famosa rincorsa alla perfezione del “lato B”, insieme allo smembramento, instaurano una dinamica scoperto-coperto e parziale-intero rispetto ad altri due interventi a cura di Simona Munari e Carla Roverselli, entrambi incentrati sul mondo islamico.
Munari prende spunto dall’interpretazione del quadro di Delacroix “Femmes d’Alger dans leur appartement” effettuata da Assia Djebar, donna algerina poliedrica e personalità di spicco dell’emancipazione della donna nell’orizzonte nord-africano. Il cambiamento di orizzonte geografico e culturale mette in evidenza due culture del corpo radicalmente opposte: dal corpo scoperto delle afrobrasiliane alla copertura delle donne islamiche dietro un velo; dalla mutilazione dei connotati femminili, riconoscibili come segno identitario della parte rispetto al tutto, al nascondimento di questi per restituire un intero che sottrae lo sguardo ai particolari. L’analisi della Djebar mostra come i veli dietro i quali la donna si nasconde possano essere costituiti anche da muri, dalle persiane delle case chiuse che generano un altro binomio dentro-fuori: l’isolamento domestico delle donne e il mondo degli scambi e degli affari di competenza maschile. Nel quadro di Delacroix le donne sono prigioniere in una “luce di serra o di acquario”, rarefatta, sono presenze più che persone, sullo sfondo di un ambiente sfarzoso e ricco di dettagli. Sono donne prigioniere in attesa del loro padrone. Quando le femmes d’Alger si mostrano per la prima volta a Delacroix, evocano il Marocco che il pittore francese portava in sé, affascinato dallo spaesamento, dall’esotismo e dall’altrove e non dalla comprensione del silenzio che portano le donne rappresentate.
Anche Carla Roverselli riporta il pensiero di Assia Djebar unito a quello di altre due donne nord-africane: Fatema Mernissi, marocchina, e Nawal al Sadawi, egiziana. Il loro obiettivo è quello di riscrivere la Storia con occhi di donna in direzione matrilineare, in opposizione alla tradizione delle narrazioni maschili e patriarcali. Inoltre, attraverso la scrittura intendono ridare voce alle donne arabe marginalizzate e poste sotto silenzio, rivendicando la parola scritta come strumento che superi l’oralità quale appannaggio della cultura femminile nel mondo islamico. Dunque, ancora una volta riappare la dinamica dentro-fuori ma stavolta in funzione riabilitativa. Dal chiuso delle case e del silenzio, l’invito al fuori della parola e del racconto. Come sostiene la Djebar, esiste una cultura di donne fatta di poesie e danze che sembra perdersi, bisogna farla uscire da un mondo autistico a cui era stata tolta la parola. La Mernissi, in chiave più spinta, si propone di reinterpretare il Corano e la tradizione sacra dell’Islam dalla prospettiva femminile, evidenziando la presenza di personalità di spicco vicine a Maometto. Essa, inoltre, nota quanto sia difficile parlare di sesso in lingua araba dal momento che il vocabolario, ispiratosi al linguaggio coranico, non dispone di termini che indichino l’impuro. Infine, Nawal al Sadawi da psichiatra usa la penna come un bisturi nel romanzo Firdaus, storia di una donna egiziana, nel quale la protagonista non tenta di difendersi sull’assassinio del suo magnaccia ma rivendica con fierezza il gesto commesso. Messaggio un po’ radicale che, lungi dal prendere alla lettera, tuttavia suggerisce la svolta da parte della donna di alzare il capo e affermare la propria posizione.
In terza analisi, l’esposizione di Elisabetta Marino riguardo il libro The madwoman of Jogare della scrittrice indiana Sohaila Abdulali sottopone all’attenzione un’altra particolare declinazione di femminismo che si distingue in maniera inequivocabile grazie alla sua fusione con l’attivismo ecologista. La scrittrice è stata vittima di uno stupro collettivo a 17 anni e ha scelto di denunciare scrivendo la sua testimonianza su carta, rinunciando a un silenzio carico di vergogna. La violenza, infatti, ha negli aggressori una valenza etica volta alla correzione dei difetti. Una donna “eretica” nei suoi costumi va quindi punita perché si corregga e ritorni sui passi che convengono.
Il libro mostra il clima dell’India degli anni ’90 del boom economico e sociale che vede da una parte l’inasprirsi del divario sociale fra un mondo ancora rurale, che in città prende posto nelle baraccopoli periferiche, e la prevaricazione della nuova classe economica; dall’altra lo sviluppo dell’industria nucleare solleva forti preoccupazioni circa il suo impatto sull’equilibrio naturale. La tesi fondamentale dell’ecofemminismo mostrato da Sohaila Abdulali è che l’idea di prevaricazione economica ed ecologica si confà alla logica patriarcale. Lo sfruttamento della donna e di Madre Terra è visto in un rapporto simmetrico, in uno scontro fra valori androcentrici legati al profitto e la visione olistica femminile legata al mondo rurale. La Madwoman of Jogare, infatti, è una donna tribale la cui danza si credeva portasse i monsoni e il ciclo delle stagioni. La sua morte è un presagio dell’interruzione del tempo e del prevalere dei disvalori della modernità. La cementificazione smodata e lo scavare delle ruspe sono raffigurati come la distruzione delle creature viventi del sottosuolo attraverso immagini di stupro e cannibalismo.
Donne e madri tra violenza e lavoro
Il secondo momento della giornata, quello conclusivo, si è dedicato all’analisi del rapporto tra il femminismo inteso largamente come orientamento assiologico – che riflette sulla differenza di genere ed è mosso dalla richiesta di inclusione, di riconoscimento e di non discriminazione della categoria femminile all’interno del tessuto sociale – e la società stessa, con le sue strutture, i processi e le problematiche concrete. In questo contesto la riflessione verte sull’Occidente e sull’attualità degli eventi attraverso tre approcci disciplinari diversi: sociologia, psicoterapia e giurisprudenza.
In primo luogo, Claudia Hassan si domanda il perché del femminicidio. Di questo delicato tema vengono rintracciate le cause all’interno delle pieghe del sistema simbolico culturale di riferimento. Paradigmatico è il fatto che in Italia, fino a meno di quaranta anni fa, la violenza sulle donne fosse non solo permessa, ma addirittura istituzionalizzata dallo Stato attraverso il delitto d’onore. Ricordando l’abrogazione di tale delitto nel 1981, che rendeva impunibile l’uomo dinanzi all’omicidio della “propria” donna, la sociologa mostra come il piano legislativo si sia trasformato in pratica subliminale. Hassan ritiene che la violenza di genere presupponga il corpo della donna come terreno di conquista da parte dell’uomo. Infatti, dall’analisi dei dialoghi dei “maltrattanti” nelle sedute riabilitative carcerarie, emerge che l’uomo soffre di una sindrome di persecuzione per cui la violenza commessa, e in extremis l’uccisione, sia stata la legittima difesa dinanzi a un attacco femminile che lo ha messo in discussione e reso vulnerabile, ritornando così al delitto d’onore.
La legittimità giuridica del femminicidio è non tanto la causa, quanto piuttosto il sintomo e il riflesso di un modo di pensare condiviso ed accettato che ritiene la violenza sulle donne lecita e in qualche misura accettabile. Andando a studiare nei casi di femminicidio la sua eziologia, attraverso un’indagine rivolta al colpevole piuttosto che incentrata sulla vittima, appare come nelle strutture psicologiche degli uomini troppo spesso la donna sia ancora considerata come un oggetto; essa sembra esser parte, in questo ordine, di quel possesso simbolico su cui l’uomo deve rivendicare il proprio dominio, il potere dato dalla sua superiorità. Ecco allora che la violenza nasce come reazione all’avvertimento di un rischio di perdita, per cui la proprietà deve essere riaffermata ad ogni costo, per comprovare la virilità minacciata.
È evidente la necessità di una ristrutturazione del sistema culturale che disarticoli il nesso simbolico uomo-dominio, donna-proprietà, e che riconfiguri l’agire ed il modo di pensare attraverso il riferimento a valori completamente diversi. La buona notizia è che sembra stia prendendo piede un cambiamento nel modo di pensare, e che ci sia maggior coscienza riguardo al ruolo, i diritti e le potenzialità sociali della donna, almeno per quanto riguarda le ultime generazioni. È quello che ha messo in luce Simonetta Spiridigliozzi, riportando i casi di alcune ragazze, che nella fase delicata dell’adolescenza in cui si realizza il processo di consolidamento dell’identità fino alla completa formazione della persona, adulta e matura, dimostrano una consapevolezza lucida e profonda della complessità, fatta di difficoltà e possibilità, dell’esser donne, anche rispetto al loro ruolo all’interno della dimensione sociale e di quella familiare.
Secondo l’approccio psicoterapeutico, infatti, si evidenzia la sclerotizzazione dell’ambiguità circa il ruolo sociale della donna. Quest’ultima si impone “fuori” come donna in carriera e “dentro” subisce e alimenta gli stereotipi della donna sottomessa. Il primo esempio a cui guardano le ragazze è quello della madre, modello d’ispirazione per il futuro; tuttavia, nonostante esprimano ammirazione nella considerazione delle loro madri, le figlie appaiono anche critiche nei confronti di alcuni loro comportamenti che ritengono sbagliati. Le donne infatti ricoprono due ruoli, due stereotipi; non accontentandosi di rivestire esclusivamente la funzione tradizionale di madri, di “casalinghe”, colonizzano anche lo stereotipo, tipicamente mascolino, della persona in carriera. Questo sembra aver accumunato solitamente le generazioni passate di donne che, a partire dai movimenti di emancipazione del secolo scorso, hanno cercato di affermarsi nel mondo del lavoro facendo valere lo spirito di orgoglio, dignità e rivalsa. Rivendicazione sana e giusta, anche se in questo modo il ruolo professionale si somma semplicemente a quello familiare e materno causando spesso un sovraccarico faticoso e difficile da gestire. Quello che le figlie allora lamentano è l’esigenza di una riconsiderazione della struttura sociale e interazionale complessiva, a partire dagli stessi nuclei familiari, che generi un generale mutamento di dinamiche relazionali.
Tuttavia, la lucidità delle osservazioni delle ragazze e la coscienza di un cortocircuito fra essere e dover-essere che vede le loro madri come protagoniste, indicano che la questione femminile abbia già influenzato in positivo la riflessione delle ultime generazioni.
Antonella D’Andrea esamina le problematiche di genere dal punto di vista giurisprudenziale prendendo in considerazione il diritto alla non discriminazione e alle pari opportunità lavorative, tematiche di interesse sempre attuale e dagli sviluppi continuamente imprevedibili. La promozione di azioni positive a livello internazionale, europeo e nazionale garantiscono il diritto ad avere le stesse chances lavorative e retributive di partenza, superando il binomio donna-maternità che funge da elemento che statisticamente incide maggiormente sulle possibilità di aspirare a un impiego o di mantenerlo.
Quello che è venuto alla luce nel corso di questa analisi, è l’esistenza di una ambiguità contraddittoria all’interno del contesto professionale, per cui palinsesto giuridico normativo e realtà effettiva appaiono muoversi secondo due diverse velocità. Mentre infatti la normativa italiana ed europea attesta l’uguaglianza e la parità di genere attraverso il riconoscimento del diritto alla non discriminazione e alle pari opportunità – e non solo per quanto riguarda il contesto lavorativo -, le analisi statistiche dimostrano al contrario una disparità di trattamento subita concretamente dalle donne all’interno del mondo del lavoro. In particolare, sono due le sintomatologie più palesi di questo fenomeno: la segregazione di genere, per cui sembra che ci sia una sorta di reclusione delle donne all’interno di alcuni settori specifici ritenuti adatti a loro, e le difficoltà nell’avanzamento di carriera che rendono difficile alle donne la rottura di quella campana di vetro che le divide dai vertici della scala carrieristica. In ogni caso, risulta positiva l’intuizione giuridica che riconosce che l’uguaglianza di genere debba essere sostanziale, e non puramente formale, e la conseguente formulazione di misure correttive che assicurino un equilibrio delle parti, tenendo conto degli svantaggi di partenza della parte sfavorita.
È pur vero che non si può correggere con espedienti puramente tecnici un problema di natura morale. Le rivoluzioni etiche e sociali più efficaci partono dal basso, e coinvolgono necessariamente la dimensione dell’educazione. Solo un cambiamento radicale del sistema assiologico di riferimento può garantire il raggiungimento dell’effettiva uguaglianza di genere. È su questo tema che si è sviluppata la relazione, tenuta da Elvira Lozupone, la quale ha evidenziato quanto sia fondamentale il ruolo che l’educazione e la formazione hanno per il superamento del gap di genere. La necessità è quella di una valorizzazione sociale non tanto quantitativa, ma piuttosto qualitativa del ruolo professionale delle donne, che sottolinei il contributo peculiare da esse apportato all’interno del mondo del lavoro grazie al loro modo diverso e arricchente di guardare il mondo, di conoscere e di agire. Per realizzare un cambiamento culturale effettivo, è necessario innescare un processo che cambi il modo di pensare delle persone, frantumi le categorie e gli stereotipi tradizionali. I valori di riferimento, da trasmettere in uno sviluppo educativo che parta dall’infanzia, devono essere quelli del rispetto, dell’inclusione, della valorizzazione delle differenze, il riconoscimento delle peculiarità personali in vista della convergenza e della cooperazione.
Quale possibile emancipazione per la donna?
L’emancipazione femminile non può essere realizzata esclusivamente attraverso un’opposizione orgogliosa che genera uno spirito di conflitto e di competizione con il genere maschile. La differenza è valorizzata e potenziata dalla cooperazione, dal buonsenso, dalla condivisione delle responsabilità. Non contraddizione, ma inclusione. Ma perché ciò si realizzi, il primo passo da compiere è una rivoluzione che animi il pensiero. D’altra parte, la stretta connessione esistente tra emancipazione femminile e trasformazione sociale è qualcosa che, come ha ribadito la Gemma Errico nell’ultimo intervento della giornata, era stata compresa e rivendicata già dalla prima generazione di femministe, durante il Risorgimento. Il movimento femminista era allora contrassegnato da una forte connotazione etica, per cui l’emancipazione era vista dalle femministe anche come un modo per apportare una concreta trasformazione all’interno della sfera pubblica, grazie all’’integrità morale che caratterizza le donne. Allora, la maternità, come modo di essere proprio di ogni donna, avrebbe arricchito il senso di cittadinanza di nuovi valori diversi e complementari rispetto a quelli propriamente maschili, dando alla democrazia un significato ed una realizzazione più completi e più pieni.
Maria Chiarappa e Giulia Quinzi