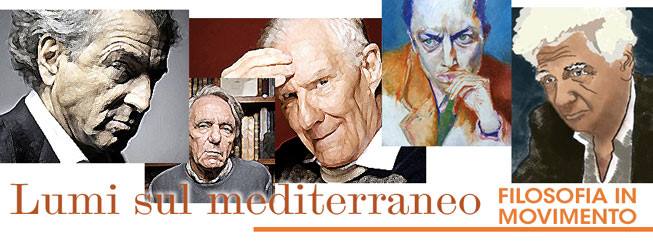Gianni Vattimo e Stefano Petrucciani dialogo alla fine del secolo
In una intervista per L’Unità a fine anni 90 del secolo scorso, Stefano Petrucciani discute con Gianni Vattimo di pensiero debole e della trasformazioni della filosofia italiana al tramonto del millennio. Una testimonianza che coglie i due filosofi a riflettere intorno alle grandi tematiche che saranno al centro del dibattito nei nostri tempi. Riproponiamo l’intervista per gentile concessione di Petrucciani che con questo ricordo intende rendere omaggio all’amico, al collega e ai rapporti umani e intellettuali che hanno alimentato la fortuna del nostro movimento. Per questo pubblichiamo la foto di Petrucciani e Vattimo a Roma durante un convegno di Filosofia in Movimento per ricordare uno dei momenti più belli per tutti noi.
Intervista:
«Io non mi sono mai sentito in senso politico e culturale remissivo o dimissionario», dice Gianni Vattimo, ironicamente risentito per il fatto che al pensiero debole sono state addebitate ogni tipo di colpe. Compresa, a suo tempo, quella di aver fatto perdere alla sinistra le elezioni. debole non vuol dire flebile; anzi, quello di Gianni Vattimo vuole essere un pensiero a ridosso del presente dei suoi mutamenti e delle sue inquietudini. Editorialista della stampa è oltretutto uno dei pochi filosofi italiani i cui libri si trovino anche a Parigi, a Londra e a Berlino. Un acuto commentatore del costume, nonché un intellettuale che non disdegna le battaglie politiche e per i diritti civili. Ecco il suo modo di raccontarsi come filosofo
La fede cattolica e la politica, le idee degli anni 60 e 70, quanto hanno contato nella formazione del filosofo Gianni Vattimo?
Le istanze degli anni 60 mi sono arrivate in un relativo ritardo, nel senso che io sono diventato
«maoista» solo nel Marzo del ’68; dal ’64 avevo già l’incarico di Estetica a Torino, e quindi sono arrivato al ’67, all’inizio del movimento studentesco, stando dalla parte sbagliata della barricata. L’atmosfera che si respirava nel mio istituto, con Pareyson, era quella di chi si sentiva molto poco solidale con il mondo moderno, borghese, ma se ne distaccava per ragioni, diciamo così, «heidggeriane».
E le sue radici cattoliche?
Io ero passato attraverso l’esperienza cattolica di Maritain, poi, di lì, ero approdato ai critici della modernità da Nietzsche ad Adorno, a Heidegger. E’ vero che ho trascorso due anni a Heidelberg, dove allora insegnava Habermas, però io, per ragioni puramente esteriori, non capivo il suo tedesco, quindi, anche se ce l’avevo a due passi non l’ho mai ascoltato. Quando sono tornato a Torino, E ho cominciato a insegnare, il mio primo approccio con il movimento degli studenti fu un po’ alla Pasolini. Mi sembravano troppo ricchi per essere dei rivoluzionari (Io ero meno ricco dei miei compagni di scuola) e tutto ciò mi teneva lontano. La fine del 67 fu per me un periodo di sofferenza, stette ma stetti male anche fisicamente e poi, mentre ero a letto convalescente per un’operazione, ho letto più intensamente Marcuse, Kostas Axelos, E mi sono reso conto che era possibile interpretare le ragioni di Heidegger contro la metafisica in modo simile alle ragioni di Marx e di Adorno contro il capitalismo e l’alienazione. I miei libri su Heidegger e su Nietzsche dei primi anni 70 sono un modo di leggere l’oltrepassamento della metafisica come oltrepassamento dell’alienazione capitalistico-reificante, che non era poi una cosa tanto inverosimile.
Poi, però, arriva il grande cambiamento di clima dopo la metà degli anni 70 e la svolta del «pensiero debole».
Il mio libro su Nietzsche, «Il soggetto la maschera», quello che è pubblicato da Bompiani nel ‘74, io lo pensavo come se dovesse diventare la filosofia del “Manifesto”, la sentivo come la filosofia dell’ultrasinistra, che invece se ne infischiava altamente. A un certo punto però il nichilismo diventa la moda culturale post marxista estremistica dell’epoca. Fino al 78 io mi sforzo di pensare insieme Heidegger, il marxismo, e Nietzsche. In realtà il pensiero debole nasce in realtà come conseguenza del terrorismo.
Che c’entra il terrorismo?
In quell’epoca uccidono Casalegno, io stesso nel ‘78 divento bersaglio di minacce abbastanza serie delle Brigate Rosse, mentre milito nel Partito Radicale, che a mia insaputa mi candida alle elezioni come rappresentante del Fuori, il movimento di liberazione omosessuale, cosa che mi turba abbastanza, perché pensavo: la mia carriera accademica è finita (anche se io ero uscito a 68, come Eco scherzando mi ricorda sempre, non solo maoista ma anche professore ordinario). Il passaggio del terrorismo fu fondamentale; non nel senso che io mi sia convertito perché mi hanno minacciato per telefono, ma insomma ho cominciato a pensare che non si poteva “prendere il potere” perché se si prendeva il potere si diventava dei rivoluzionari professionisti che erano ancora peggio dei burocrati borghesi. Io avevo degli allievi che erano veramente coinvolti col terrorismo, mi sembravano così impregnati di una retorica pauperistica, per cui, tutta l’idea che non dovevamo accettare il rinvio della soddisfazione ( come insegnavano Nietzsche e Marcuse) veniva smentita. Il leninismo era una forma di ascesi drammatica…il pensiero debole allora intende la liberazione come una mossa del cavallo, come una specie di scarto che ridistingue il destino dell’anima da quello della storia. Davanti alle degenerazioni dell’imperativo della presa del potere, unica risposta è l’idea che non si può pretendere di rovesciare l’ordine storico. Si può tuttalpiù seguirlo in certe sue derive di tipo frammentativo, distorcerlo, tirarlo da una parte.
Ma che resta del discorso filosofico se con il pensiero debole lo priviamo del suo elemento argomentativo e razionale?
Pensiero debole non significa solo fine della razionalità totale, bensì anche «ontologia». Il che implica, utilizzando Heidegger che è l’essere stesso che ha questa vocazione al «darsi-sottraendosi», all’indebolimento. Pensiero debole non è solo l’apologia di una ragione non universalistica, non argomentativa. Ma è anche la teoria di un filo conduttore ontologico di indebolimento. Proprio perché l’indebolimento è ontologico, credo che nel discorso della debolezza si trovino anche dei criteri di giudizio, dei criteri etici. Del resto, sono consapevole che la fase puramente decostruttivo-ironica della critica filosofica deve essere superata. Io stesso ho pubblicato non molto tempo addietro un saggio che ho dedicato proprio alla “Ricostruzione della razionalità”.
A proposito di criteri etici, la bioetica è una bella opportunità per i filosofi oppure un grosso pericolo?
Io la vedo anche come un pericolo, perché fatalmente chi domina oggi nella bioetica sono i preti. Cioè quelli che confidano in «essenze naturali». Per esempio, a me gli stessi «diritti della vita» in quanto tale, come essenza biologica, sembrano molto dubbi. Per me il problema non è il valore della vita, e non mi interessa il sopravvivere in quanto tale; la domanda è semmai: cosa possiamo decentemente fare, con le nostre possibilità tecniche, per non doverci vergognare difronte alle persone con cui stiamo? Il riferimento è a una comunità culturale, a una comunità di discorso, come insegna l’Ermeneutica, non a una qualche essenza naturalistica o principio metafisico. Mentre ho paura che finiscano per vincere, nei dibattiti, quelli che hanno una metafisica naturalistica più forte (“l’essenza della vita”, o della riproduzione). E’ per questo che il Papa è costretto a pareggiare la masturbazione con il genocidio, perché non riesce a non ragionare in termini di “uso naturale”.
Oggi molti filosofi (anche lei nel suo ultimo libro) sperimentano forme di comunicazione più personali, narrative, come mai?
Non so. O a lungo mi sono trattenuto da questa effusione individualistica. Il mio ideale del trattato filosofico resta ancora una saggistica argomentativa più neutrale.
Per inciso, a cosa sta lavorando adesso?
Sto finendo di scrivere un libro che uscirà prima in inglese, presso la Columbia University Press, intitolato «Dopo il cristianesimo», che deriva da lezioni americane. E poi ho sempre in cantiere un grande libro che ha già cambiato tante volte titolo e che ora si chiama «Ontologia dell’attualità», il mio «testo fondamentale», che non so mai se finirò. Ma non credo che mi manterrò fedele allo stile che più personale che ho usato in «Credere per credere». Quella è stata soprattutto una scelta polemica verso chi scrive di cose religiose, per esempio Cacciari con una specie di auto-sottrazione del soggetto in prima persona, per cui non si capisce mai bene se «ci crede o no». E possibile in religione fare un discorso così oggettivo, culturale? Io ho avuto troppa storia religiosa personale per potermi accontentare di “sta roba lì”.
La filosofia italiana è sempre un po’ colonizzata e arretrata rispetto alla filosofia europea, oppure no?
Ma no, io non ci ho mai creduto tanto a questa storia; è vero che noi scriviamo in una lingua che viene letta poco, però…ricevo adesso la quarta di copertina che Rorty ha scritto per l’edizione inglese di «Oltre l’interpretazione», che mi loda sperticatamente, sono gongolante.
Ma Rorty non è la brutta copia di Vattimo?
No (ride), per carità! Ma a parte questo la recettività del pensiero italiano rispetto alle filosofie straniere è parso sempre un vantaggio. Perché qui il problema non è l’esportazione del prodotto interno lordo, ma la vivacità intellettuale. Lo sa quanto c’è voluto per tradurre in inglese i «Minima moralia» di Adorno? Più di 20 anni! Ecco, quasi quasi, direi che c’è un “un primato morale e civile degli italiani” …
Viva l’Italia?
E perché no?