 Riccardo Roni
Riccardo Roni
Il flusso interculturale. Pragmatismo etico e peso della storia nella filosofia emergente
Mimesis, Milano 2017, pp. 172, € 16.
Ne “Il flusso interculturale”, Riccardo Roni si propone di riesaminare gli studi condotti sulle origini del flusso di coscienza, nonché il loro riscoperto legame con l’assunto jamesiano dell’interculturalità. Se le prime elaborazioni teoriche assumevano il flusso di coscienza quale espressione della vita interiore del soggetto, ora, invece, si può affermare che traccino il disegno di un flusso di relazioni eterogenee orientate all’apertura di nuovi orizzonti culturali e sociali. L’interculturalità, se rettamente intesa, risponde all’esigenza di una continua messa in discussione delle categorie occidentali, ma anche delle sue fonti e tradizioni. Entro questo quadro, è possibile comprendere come l’auspicato passaggio da una società verticale-piramidale ad una orizzontale, possa condurci in direzione di un modello di società aperta e a un nuovo universalismo inclusivo e plurale. In questo senso, si può rilevare come paradigmi concettuali quali quelli di emergenzialità, di interazione, di continuità delle esperienze, del racconto autobiografico e narrante del proprio Sé, fondino un’interpretazione psicologica dell’altro e del suo vissuto, attraverso una completa ristrutturazione dei principi democratici di convivenza, ma soprattutto mediante la riconfigurazione di linguaggi alternativi e di inedite caratterizzazioni dello spazio e del tempo vissuto. Questo volume è il risultato di una duplice operazione: da una parte, v’è una precisa rivisitazione storiografica e ermeneutica delle elaborazioni teoriche concernenti le origini del flusso di coscienza nella storia del pensiero francese tra ottocento e novecento, e dall’altra, la ricollocazione delle stesse entro il quadro concettuale del pragmatismo americano contemporaneo, in riferimento ad autori come William James e John Dewey. Ciò risponde all’esigenza di una rifondazione interculturale dei saperi e di un ripensamento critico delle categorie fondative del pensiero occidentale. Tali proponimenti assumono ancor più valore se considerati alla luce delle guerre mondiali e dei totalitarismi, germogliati sul terreno dei nazionalismi europei, che hanno posto la questione del riconoscimento dei diritti civili e politici in stretto legame con i diritti sociali.
Il primo capitolo del volume si muove nel tentativo di individuare le radici storico-filosofiche a partire dalle quali si può rilevare il motivo fondamentale dell’interculturalità in ragione delle trasformazioni che hanno segnato l’età moderna. L’autore intende qui determinare l’incidenza storica dell’interculturalità mediante un’opera di ricostruzione che, prescindendo dall’esito ultimo rappresentato dalla prospettiva unidimensionale del mondo globale, rianalizza l’origine dello Stato-nazione moderno, nel quale l’appartenenza etnica viene determinata riduttivamente come un fatto di natura, secondo cui «razza, lingua, territorio natio definiscono così l’identità delle nazioni moderne» (p.17). L’età moderna, come ci mostra l’autore, viene almeno inizialmente a costituirsi intorno ad un “concetto etnico” di nazione, poiché presiede alla formazione dei primi stati nazionali un impulso unificatore, ossia il tentativo di consolidare la mescolanza di sangue e razze intorno ad un nucleo essenziale che costituisce l’identità delle nazioni moderne. A tal proposito, Ortega y Gasset scrive: «Lo stato nasce quando l’uomo si sforza di evadere dalla società nativa in cui ha iscritto il sangue». Ancora Roni spiega come ciò nasconda, di fatto, l’affermarsi di una “egemonia europea”, la quale si muove su due direttrici fondamentali: da una parte, la Riforma e la Controriforma danno vivo impulso al movimento con cui le prime società massificate si dotano di una lingua standard; dall’altra, lo strettissimo intreccio che lega a doppio filo Stato e religione – e che attribuisce al primo carattere sacrale. Tuttavia, una serie di profonde trasformazioni storiche giungono, successivamente, a frantumare tale modello identitario e localistico di nazione: la prima è la Rivoluzione francese, nella quale l’individualismo moderno viene a crollare dinanzi all’ergersi del modello universalista. Ciò pone una lunga serie di questioni concernenti la determinazione assoluta del rapporto tra popolo e nazione; in tale contesto si afferma una concezione “etnicarchica” che vede la storia moderna come teatro di scontro tra razze, o come afferma Augustin Thierry, «la storia moderna è storia di lotta di razza tra conquistatoti e conquistati». L’intero Ottocento è segnato ancora dallo scontro tra lingue, razze e culture, laddove inizia ad affermarsi un modello di democrazia sociale che, però, troverà il suo compimento soltanto nella tarda modernità. Sorvolando, dunque, sul carattere ambivalente e “ambiguo” di democrazia espresso dall’intellettuale francese Alexis Tocqueville – in visita negli Stati Uniti – e magistralmente espresso ne “La democrazia in America”, ciò che va configurandosi in quei anni è un modello di Europa “unificato”; in altre parole v’è un’Europa, dal punto di vista valoriale, ancora interamente ancorata ad una concezione di “cittadinanza nazionale”, nei termini della definizione di un vero e proprio status socio-culturale che travalica gli stessi confini geopolitici (pp.19-20). La storia della tardo-modernità afferma, quasi in via definitiva, il passaggio verso una nuova realtà sociale, politica ed economica: v’è, cioè, una fase di sviluppo segnata dalle “lotte di classe” di marxiana memoria. Tale rilettura di Marx, ad opera dell’autore, consente di spostare il baricentro del conflitto dalla “lotta di razza” a quella di classe, che sorge in concomitanza del configurarsi di due nuove categorie sociali, borghesia e proletariato. Il fulcro decisivo di questo passaggio è riconducibile alla forte impronta cosmopolita apportata dalla borghesia alla produzione e al consumo di tutti i paesi, giacché «con l’idea che i proletari non hanno né lingua, né nazione» si assiste al progressivo e decisivo soppiantamento della rigida concezione dello stato nazionale e di alcuni dei suoi elementi identitari (la lingua, il territorio). Inoltre è necessario evidenziare, nella prima metà degli anni novanta, gli importanti movimenti di liberazione nazionale (si pensi alla lotta per le decolonizzazioni) e alle lotte contro la segregazione e la discriminazione razziale che, in quanto tali, segnarono la transizione da culture pre- e anti-liberali ad una autenticamente liberale, all’interno della quale è forse possibile rinvenire un mutamento di paradigma, maggiormente aperto a spazi di interculturalità; sebbene, una certa “sindrome colonialista” abbia portato, come ci ricorda l’autore, a rinforzare l’idea di “egemonia culturale”.
È interessante rilevare come, sulla scia della scuola pragmatista di G.H Mead e J. Dewey, la sociologa americana Jane Addams, abbia manifestato un certo orientamento interculturale, in particolare nel suo attento studio delle marginalità sociali. Ella rivolge le proprie ricerche alla giovane classe operaia nella grande metropoli (Chicago) e ai giovani dalle differenti etnie che la abitano. Lo spazio della metropoli deve essere necessariamente osservato a partire dalla doppiezza del suo abitare: da un lato, la metropoli intesa come luogo di aggregazione, come comunità nella quale il lavoro assume una funzione mediatrice tra il sé e la comunità stessa, dall’altro «la commercializzazione delle vite», mediante il riversarsi delle stesse nelle industrie del divertimento. Ma ciò che è più importante evidenziare è come la Addams assegni al soggetto la capacità di rivalorizzare le proprie esperienze e di conferire alle stesse un valore superiore, dato dalla capacità del soggetto di accordare la propria sensibilità all’immaginazione, e così facendo di convertire la spinta del desiderio in impulsi psichici qualitativamente superiori. La questione che ella pone rivela il proprio carattere etico nella misura in cui è posta in relazione ad una prassi educativa; v’è, infatti, un problema di adattamento dei giovani lavoratori al proprio ambiente. Sulla base di tali assunti, credo sia utile far riferimento al concetto di “società aperta”, teorizzato da una delle figure intellettuali più eminenti dei primi del Novecento, Henri Bergon. Nella sua opera, Le due fonti della morale e della religione, egli abbozza, per così dire, il disegno di un’inedita “società aperta”, la quale non si ispira alle società reali bensì ad una comunità “mistica”, che abbraccia una concezione più ampia di umanità; l’invito che egli muove alla società è di porsi ad un livello intermedio tra l’istinto animale e la volontà creatrice divina, ossia di innalzarsi al di sopra dell’obbligazione propria degli istinti animali senza, tuttavia, nutrire alcuna ambizione creatrice divina. Tale concezione mistica può essere compresa soltanto a partire dal bisogno connaturato «al sogno di espandere intorno a sé uno slancio d’amore, a cui ciascuno imprima la propria personalità», e in cui ciascuno possa sentirsi amato per se stesso, seppur nella propria intrinseca diversità. V’è quindi come Roni spiega, una certa preminenza dello spirituale sul manuale, che viene, appunto, anteposto al secondo. Come distinguiamo una società aperta da una società chiusa? Dalla capacità della prima di concepire la città, e i suoi membri, come un unico organismo vivente. La società aperta è, in tal senso, una comunità in cui mediante la continua inter-relazioni dei suoi membri, è possibile abbracciare l’intera umanità. Ora, Bergson individua nella democrazia la concezione politica più adatta ad un tale genere di società e, per l’appunto, ciò costituisce un processo decisivo, dal punto di vista interculturale, in direzione del superamento del conflitto religioso e dell’apertura ad un dialogo plurale tra le diverse religioni appartenenti a una stessa comunità. Per concludere, ciò pone in primo piano la figura dell’educatore nella sua fondamentale funzione emulativa, che sembra riallacciarsi all’apparato teorico-concettuale della Addams, e della sua capacità di avviare un processo di ritraduzione delle idee e una loro rielaborazione mediante la lettura dei classici. Questo non solo al fine di poter cogliere il magma incandescente del pensiero che giace sotto lo strato superficiale delle parole, bensì a quello di sottrarre il pensiero al suo nucleo dogmatico, introducendovi “la libera circolazione della vita”, ossia immettendovi un flusso di culture e vissuti declinati al plurale (pp. 28-29). Tali prospettive di pensiero hanno prodotto grandi mutamenti di senso, innanzitutto nella possibilità di innestare un rapporto con il mondo non solo da un punto di vista cognitivo, ma soprattutto etico. Ancor di più, esse hanno ritradotto le esperienze dei totalitarismi novecenteschi in spazi di maggiore autonomia per gli individui, realizzando, entro questa cornice, un passaggio epocale dall’identità alla differenza che ha aperto i confini di una vera e propria rivoluzione culturale e sociale. Questa apertura alla differenza, una categoria cardine del Novecento, intesa come pluralismo e diversità, ha favorito una nuova lettura dell’individualità secondo «modalità intersoggettive e sociali»; allo stesso tempo, tutto ciò ha incoraggiato una diverso orientamento da parte delle istituzioni nel predisporre politiche pubbliche che favoriscano l’integrazione.
Nel secondo capitolo, Identità, interculturalità e linguaggi inediti nel flusso di coscienza, Roni – dopo aver definito i principi teorici e alcuni dei possibili nodi problematici relativi all’interculturalità – chiarisce la stretta connessione che mette in relazioni identità, memoria e linguaggio da un lato, e i processi di interculturalità dall’altro. L’autore chiarisce come ciascun individuo sia legato a un sentimento di appartenenza a una determinata cultura, che ne struttura inevitabilmente la personalità, e come ciò lo ponga in un rapporto problematico con un’origine assai complessa. Può accadere, infatti, che tale origine non venga a sedimentarsi soltanto su substrati mitico-religiosi condivisi, ma anche su fenomeni negativamente intesi – come genocidi, segregazione razziali etc. Tali presupposti, spiega l’autore, possono portare alla formazione di vere e proprie “identità muro rovesciate”, laddove le dinamiche esclusive sorgano nello “straniero”, anziché nella cultura d’origine; il rapporto conflittuale che l’ospite instaura con la propria cultura originaria non concerne tale cultura per se stessa, bensì i suoi codici costitutivi. Ciò comporta, in una certa misura, l’istituirsi di un rapporto fortemente asimmetrico tra hospes e hostis, che può dare luogo persino a forme di fanatismo, data l’assenza di un spazio simbolico entro il quale poter gestire tale conflitto. L’autore, ancora, evidenzia come sia necessario trovare tale spazio simbolico di interazione, quindi uno spazio di prossimità. Giacché la creazione di un siffatto spazio può delineare un nuovo orizzonte trans-culturale, il quale però non può essere gestito dalle parti in causa, ma richiede l’ausilio delle istituzioni nel porre in essere una efficace azione educativa che miri a implementare il riconoscimento di valori come la legalità, la solidarietà e i diritti umani (p. 45).
La determinazione di un principio d’identità all’insegna dell’interculturalità non può in alcun modo prescindere dalla valorizzazione della memoria autobiografica, dal momento che ogni migrante si fa portatore di un insieme di narrazioni soggettive che ne costituiscono il nucleo identitario e che confluiscono, successivamente, in una memoria collettiva. Essendo tali memorie autobiografiche legate a vissuti profondi, non definiscono immagini inscritte in un passato ormai definito, ma costituiscono, per così dire, la prospettiva operante secondo cui è possibile interpretare il presente. Da tale prospettiva, è possibile notare come il passato giunga a fondersi con il dato presente, andando a rimodellare continuamente il significato che il migrante è in grado di attribuire alle esperienze presenti. Questa funzione semantica e mediativa del ricordo-memoria del passato consente, pertanto, di ridefinire gli abiti mentali e gli schemi già consolidati dando così forma a pratiche di legittimazione di cittadinanza solidale. Seguendo il filo conduttore che dall’identità conduce alla memoria, Roni definisce quell’”atto del narrare se stessi”, dal quale è possibile giungere alla conoscenza dell’altro, della sua alterità, mediante le narrazioni con cui questo è in grado di definire, innanzitutto, se stesso. Occorre, tuttavia, chiarire: cosa si intende con questo “raccontare a se stessi? «La narrazione di sé definisce lo spazio irriducibile della soggettività che apre intenzionalmente la propria storia al mondo mediante la memoria, i sentimenti, le idee e le credenze», in altre parole tale auto-narrazione di sé richiama un’esperienza di tipo intenzionale in cui tutte le nostre credenze e i nostri desideri (stati cognitivi) si fondono con gli stati disposizionali (le nostre emozioni). Ciò che qui importa comprendere è come il Sé, mediante questo atto di narrare se stesso, costituisca la storia personale e culturale, nonché la maniera con esso è in grado di riplasmare continuamente se stesso (pp. 49-50).
Dopodiché l’autore mostra, in relazione al Sé, come esso nel suo raccontare se stesso non sempre coincida con ciò che gli altri si aspettano che debba essere, cioè con la costruzione di un Sé pubblico. A questo punto Roni, nel richiamarsi ai dialoghi platonici, facendo particolar riferimento al Teeteto, riprende la definizione di Socrate secondo cui il pensare non sarebbe null’altro che parlare a se stessi: «l’anima non fa altro che dialogare, interrogando se stessa e rispondendosi da sé, affermando e negando». Quest’ultima citazione chiarisce come l’anima sia scandita sì dal dialogo silenzioso – menzionando, in tal senso, Victor Egger nel suo La parole intèrieure – con se stessi, ma anche dai suoni, quindi dalla “voce”; in essa si rivela tutta la sua potenzialità dialogica, poiché essa costituisce anche il tramite tra Sé e gli altri. Difatti, Roni scrive, nell’illimitatezza della voce sono presenti molte voci, come un dialogo polifonico tra più soggetti. Cosicché all’attività del linguaggio interiore, e alla sua modalità monologica, corrisponde il trasferimento di questa stessa identità in un contesto inter-culturale, in altre parole la narrazione di sé può diventare pratica donativa, attraverso il suo strutturarsi in diverse fasi: l’interazione dialogica, l’integrazione e, infine, il costituirsi di un dialogo plurale entro una molteplicità di voci che scorrono secondo un flusso di continuità (p. 60).
Nondimeno, il linguaggio – l’autore spiega – non deve essere inteso esclusivamente nella sua funzione logica poiché esso ottempera anche ad un’altra funzione, ossia esso è anche strumento sociale che, in quanto tale, rende possibile «partecipare delle idee e dei sentimenti degli altri». In tal senso, è importante tenere conto anche del contesto entro il quale si svolge il confronto dialogico tra le idee, dato che esso, a seconda della logica che lo anima, può rafforzare sentimenti di appartenenza in quanti tali escludenti, oppure favorire il multiculturalismo. Da ciò possiamo sicuramente ricavare l’idea che non sia possibile pensare all’interculturalità senza renderci conto di come tale identità debba reggersi su di un Sé di appartenenza, che purtuttavia, «può restare solo anche se in presenza di altri». L’interculturalità non rimanda ad un mero relativismo culturale, concepito in senso assai riduttivo, giacché l’appartenenza ad un contesto può aprire ad un orizzonte di interculturalità soltanto se è capace di sperimentare la propria soggettività e di aprire all’elemento trascendentale che lega ciascun soggetto al suo universo culturale. Inoltre, ogni pretesa di universalità della cultura può possedere un valore relativo o assoluto; mentre il primo mira a trascendere il dato culturale senza però smarrire il proprio limite (la propria soggettività), così includendo più punti di vista, al contrario il secondo nella sua pretesa di assolutezza e oggettività non è capace di conservare il proprio limite ma, anzi, deve essere inteso nella sua forza egemonica e assorbente. Di conseguenza, promuovere un dialogo interculturale vuol dire farsi carico di più universalità relative, la cui sommatoria non darà mai come risultato un’università assoluta. Tale limite di relativa universalità costituisce il dato costitutivo di ogni cultura, ma può anche avviare un processo di trasvalutazione reciproca, che crea le basi per l”oltre-culturalità”. Quest’ultima rappresenta la volontà prospettica di procedere verso un ignoto, verso un “oltre” che riconduce alla dimensione del viaggio; inteso in tal senso, esso riacquisisce il suo significato originario che è quello della conoscenza rivoluzionaria, della scoperta dell’ignoto e dello sconosciuto (p. 67).
Il terzo e il quarto capitolo devono essere intesi in ragione del loro stretto legame, che ruota attorno al declino della “post-modernità” e alla straordinaria, nonché ricca di stimoli riflessivi, figura del migrante, la quale deve essere obbligatoriamente intesa, come vedremo, nella sua “emergenzialità”, ma anche nella connotazione liquida con cui è possibile comprendere lo strutturarsi dinamico delle soggettività e delle loro inter-relazioni.
La seconda metà del secolo scorso – denominato “post-moderno”, come sottolinea l’autore – si è contraddistinta per una ricerca spasmodica di un criterio unico e normativo di verità attraverso il procedimento dell’interrogazione tra soggetto e oggetto; tale interrogazione ha, tuttavia, prodotto un insieme inesauribile di risposte prive di senso. Sebbene a tale paradigma interrogante potremmo contrapporre quel silenzioso linguaggio interiore di Eggeriana memoria, è ancora più importante evidenziare come ciò costituisca un campo aperto per il «paradigma rivoluzionario della vita nuda e migrante». È questo il paradosso della post-modernità: rilevare come al declino dell’attuale modernità corrisponda invece, l’ascesa della soggettività migrante. Si può, dunque, comprendere come il dialogare stesso costituisca l’unico dispositivo in grado di scalfire la logica autoreferenziale dell’impianto normativo questuante, assolutamente ingabbiato all’interno di rigidi schemi predefiniti; quindi, un dialogare capace di conformarsi in situazione e rimodulare per sé incessantemente nuove regole. L’autore, mediante l’analisi di tale rapporto dialogico, si focalizza sul passaggio fondamentale dal concetto autoreferenziale d’identità a quello di differenza, riscontrando come esso sia legato al concetto di emergenzialità in relazione alla soggettività migrante. Successivamente comprenderemo come tale concetto rivesta un ruolo fondamentale, in virtù della sua funzione disfacente nei confronti delle stesse fondamenta della società occidentale. A tal proposito, Roni scrive: «L’emergenza richiama un’esperienza di disvelamento la quale, a sua volta, si presenta come fonte di rischio e di pericolo», giacché l’identità del migrante può essere compresa soltanto a partire dal paradosso della sua alterità. Il migrante non possiede un’identità che non indichi, nel contempo, una fuoriuscita di sé; la sua identità coincide con un’assoluta alterità. L’emergenza del migrante è un riaffiorare in superficie «in un contesto senza contesto». L’assoluta “emergenza” del migrante si traduce, dunque, nell’esigenza non di comprendere, ma di essere compresi dall’altro, laddove tale comprensione equivale ad una richiesta disperata di sopravvivenza. L’autore rileva come sia null’altro che il bisogno (bedürfnis), il nucleo essenziale di tale condizione di “prossimità” emergenziale. In breve, l’autore suddivide il processo di accoglimento del migrante in diverse fasi: v’è un primo momento che, soprattutto a causa dell’assenza di una vera e propria cultura dell’accoglienza, coincide con atto di reificazione del migrante – motivo per il quale, esso diviene null’altro che oggetto, deprivato delle proprie qualità umane soggettive; dopodiché, v’è una seconda fase che coincide con la sua eventuale registrazione\espulsione, la quale si risolve in un mero funzionalismo, come appendice di un certo apparato tecnico del potere biopolitico – che identifica il migrante esclusivamente come un numero emergente, depredandolo dalla propria dimensione soggettiva, ovvero della memoria intesa come storia personale (p. 75). Esso diviene una figura generica, entro la quale esistenza giuridica e persona fisica vengono a scindersi indefinitamente, allorché questa sospensione della cittadinanza si pone al di fuori di ogni possibile prassi interculturale che consenta di partecipare al mito emergenziale, che rende possibile la comunione e la “convivialità”. Altresì ciò pone un problema di riconoscimento che, oltre a rappresentare una questione giuridico-normativa, racchiude aspetti di natura etica, e che rischia di generare un cortocircuito nei processi democratici di riconoscimento della cittadinanza, soprattutto in relazione alla loro stessa attuabilità. Questa radicale opera di de-soggettivazione del migrante, che passa attraverso le maglie del potere sovrano, può venire a rappresentare un momento di riscatto per lo stesso, in ragione della sua condizione di isolamento al di fuori dello spazio unidimensionale della cittadinanza. Attraverso un vero e proprio atto di resistenza, essa contribuisce a mutare il paradigma etico-politico e la sua struttura normativa, generando nuovi modelli di convivenza interculturale. Vorrei, ora, far riferimento alle soluzioni che l’autore offre all’indifferenza generalizzata di cui è vittima il soggetto migrante ma che, malgrado essa, possono dischiudere nuovi “corridoi” jamesiani di interculturalità; affinché l’emergenzialità costituita regga la prova dell’indifferenza e si tramuti in una ancora dischiudente possibilità, è necessario che il potenziale dialogico, in tutta la sua valenza inter-comunicativa, si costituisca in quanto ponte verso l’altro. In conseguenza di ciò credo che, a questo punto, occorra introdurre il concetto di solidarietà. L’autore ricostruisce, in via preliminare, l’etimologia dal lemma latino solidus, che rimanda, per l’appunto, a ciò che è compatto, solido, massiccio etc, ma è utile porre l’accento anche sulla sua valenza filosofico-interpretativa. Sembra che la solidarietà si realizzi come un’estensione dell’emergenzialità, poiché essa è in quanto tale «una relazione tra solidi che col tempo però si fanno sempre più liquidi»; affinché essa possa costituire una nuova identità come metissage, deve preservare la sua componente liquida, pena l’eliminazione della differenza.
Recuperando la rappresentazione etico-politica della modernità liquida di Zygmunt Bauman, Riccardo Roni ci introduce ad una nuova lettura della migranza, ora interpretata in termini di fluidità. Bauman, nel suo saggio Modernità liquida, propone questo concetto di fluidità in merito alla società contemporanea globalizzata, che è descritto nei termini di un processo di liquefazione dei corpi solidi, in cui il tempo giunge a divorare lo spazio e l’individualismo riafferma se stesso in tutta la sua ferocia nella dimensiona privata degli individui. L’autore, riproponendo tali questioni in relazione alla realtà della migranza emergenziale, chiarisce come essa non possa essere semplicemente, in via definitiva, liquefatta; tale processo di liquefazione rivela la presenza di un esercizio di potere esterno, che corrisponde alla volontà di rendere i soggetti quali “gelatine malleabili”. Rispetto a questo diktat del potere post-moderno che impone di «non essere come siamo», il migrante oppone, de facto, un’azione di resistenza: «attraverso la fluidità solidale che lega – impastandoli nel metissage – gli elementi solidi delle identità originarie, trasforma le scelte individuali in azioni e progetti collettivi […] viene rimesso al centro il diventare chi siamo». Se in Bauman, tale fluidità era tradotta in un quadro descrittivo delle società globalizzate assolutamente negativo, al contrario, viene ora a rivestire un significato assiologico di segno diverso, non più configurandosi come un limite storico: dall’impatto delle differenze, all’impasto delle differenze come metissage (pp. 83-84). Oltretutto, credo sia fondamentale sottolineare come la migranza produca un’essenziale evoluzione dello spazio nel tempo, dato che lo spazio viene ad essere occupato in funzione del tempo e non del consumo individuale: «la migranza è prima di tutto un viaggio nel tempo, prima che nello spazio, è una critica sociale permanente al tempo spazializzato». Essa deve, pertanto, seminare il terreno in cui far sorgere una nuova pratica educativa in cui spazio e tempo non siano più percepiti come limiti invalicabili e nemmeno uniformati secondo gli orientamenti e le prospettive proprie della globalizzazione. Se gli spazi detemporalizzati offrono un modello di comunità privativo delle differenze e dei conflitti, all’opposto, la connessione interculturale secondo uno spazio che si fa tempo e del tempo che si fa spazio possono favorire la riproposizione di una nuova elaborazione della territorialità, favorendo in tal mondo l’integrazione tra le culture: « Rimettere al centro il rapporto di reciproca connessione e implicazione tra lo spazio e il tempo consente di decentrare l’identità proprio dove avviene l’incontro con il diverso e lo smarrimento nell’altro […] in modo tale che lo spazio, da semplice non luogo, diventa il territorio globale e locale nello stesso tempo» (p. 89).
Per ragioni di spazio e opportunità, non approfondiremo lo stretto rapporto tra corpo e interculturalità in opposizione ai miti androcentrici. Il corpo, liberato da ogni sovrastruttura culturale condizionata, può finalmente divenire paradigma di una nuova mediazione interculturale, in altre parole possiamo altresì assistere alla riscoperta del corpo quale pratica identitaria e espressione della differenza, e dunque come centro operante di una futura rivoluzione etica e culturale. Credo sia tuttavia opportuno anche porre l’accento rispetto a come l’etica del desiderio, secondo il modello pragmatico, trasformi esperienze in quanto tali finite in «esperienze integrali» e più autentiche. Siffatto desiderio è ciò che propriamente contribuisce allo sradicamento essenziale del soggetto umano proiettandolo, in questo modo, verso altri mondi e religioni, senza che però esso smarrisca il proprio sé. Il desiderio, «così connotato dal flusso interculturale», costituisce la struttura fondamentale non soltanto delle esperienze storiche, ma finanche di quelle autobiografiche; sulla base di tale asserzione, v’è il determinarsi di un processo di autocoscienza che fa dell’altro non soltanto qualcuno contro cui lottare per il riconoscimento, bensì un soggetto con cui condividere le proprie esperienze. La spinta del desiderio, travalicando l’istanza egoica, fonda un vero e proprio principio di responsabilità nei confronti dell’alterità, dello scarto, nella misura in cui questi appartengono al flusso interculturale. Giacché nel desiderio, così come nella passione amorosa, noi possediamo «germe mistico di ciò che potrebbe significare un’unione totale di tutta la vita senziente», dacché questa responsabilità verso un mondo plurale ci apre ad un genere di esperienze integrali (p.118).
Il sesto capitolo è, a mio avviso, di fondamentale importanza, poiché ci introduce all’analisi di un modello dominante della modernità, la società signorile di massa. Si tratta, secondo l’autore, di individuare il nesso causale che, a suo modo, congiunge la definizione nicciana del modello signorile di massa e la questione interculturale «della continuità delle esperienze di mondi totalmente altri». L’immagine pragmatista della coscienza interculturale può essere compresa soltanto a partire dall’accentuazione dello “scarto”, o del passaggio interstiziale dove tutto accade e può dispiegarsi. In virtù del delinearsi di questo quadro concettuale, da tale scarto diviene possibile ritradurre il movimento verticale e gerarchico dei “signori” (inteso nei termini del dispiegarsi una scalata sociale verso l’alto) nell’orizzontalità propria del dispiegarsi interiore della coscienza. Diviene possibile, quindi, determinare il “tra”, “lo scarto”, nella direzione del compimento di un tempo interiore che trae la propria vitalità dal differimento e dalla durata temporale (p.123).
In ragione dell’esigenza di delineare i caratteri della società signorile, Roni esamina il graduale sviluppo delle condizioni di eguaglianza nel quadro di un regime democratico. Egli evoca, proseguendo in tale direzione, le riflessioni di un celeberrimo filosofo francese della tarda modernità, Alexis de Tocqueville, in riferimento alla sua opera, La democrazia in America (1835-1840). La riflessione del filosofo francese sulla democrazia si dipana a partire da due distinte espressioni della medesima: vi è, infatti, una democrazia senza educazione (priva di un’organizzazione politica ben strutturata) che tende a privilegiare le forze solipsistiche e gli egoismi individuali, a discapito dell’uguaglianza; cioè, un’espressione di democrazia che, anticipando le argomentazioni nicciane, si riduce ad un indiscriminato livellamento con cui i più deboli degradano i forti. Dall’altra parte vi è, invece, una diversa concezione di democrazia che trae il proprio seme di sviluppo dal possesso di un’idea di libertà: « Se il primo atteggiamento mostra che la libertà è più antica dell’uguaglianza, il secondo significa che prima di rendersi uguali non si è stati liberi».
E ciò spiega anche i differenti livelli di sviluppo democratico che hanno caratterizzato le società democratiche americane e quelle europee. Tocqueville riconosce nel primo sviluppo democratico il carattere “signorile” delle società di massa, dietro cui si cela l’instaurarsi di un vero e proprio sistema totalitario. Emergono, in questo modo, le condizioni per l’insorgenza di un dispotismo democratico, che segna il trionfo di un livellamento «in cui nulla sporge e nulla affonda».
Le democrazie pluralistiche occidentali covano, infatti, al proprio interno totalitarismi che trovano la propria espressione nella cultura di massa, la middle culture; laddove, il libero arbitrio del cittadino democratico si risolve nell’irriducibile contraddizione tra il bisogno di libertà e la necessità di piegarsi ad un’autorità per essere guidati. Nel contesto operante di queste società, il diritto di ciascuno alla felicità e la promessa insita nel raggiungimento di una sempre maggiore condizione di benessere hanno generato classi elitarie completamente asservite al sistema consumistico. Allo stesso tempo, l’autore ci spiega come ciò abbia contribuito alla formazione di un sistema verticale di tipo piramidale che costringe, appunto, coloro che sono posizionati alla base a sottomettersi, o adeguarsi a un modello di valori dominante. Si capisce, dunque, come tale modello asimmetrico renda impossibile raggiungere qualsiasi orizzonte di interculturalità. Nello scarto differenziale tra i due estremi della piramide sociale, è possibile individuare uno spazio multidimensionale di condivisione, che non si limiti a ricercare soluzioni “multiculturaliste a mosaico”, piuttosto orientate verso un modello sempre più assimilazionista. Roni chiarisce come tale spazio condiviso debba essere ricercato in una società di tipo orizzontale, che aspiri a riappropriarsi di quel “tempo residuale” come ciò che resta dalla totale assenza di vincoli temporali propria delle società elitarie. Questa ricerca, per così dire, della durata, consente di appropriarsi di queste esperienze dalla natura fluida, ossia di appropriarsi di quell’immediato flusso di vita che costituisce il materiale per la riformulazione e la messa in discussione di vecchie e nuove categorie concettuali. Ed a partire da questa prospettiva pragmatica diviene possibile tracciare il profilo pratico-ideale di un nuovo umanesimo interculturale. Quest’ultimo può essere, infine, definito grazie ad un atteggiamento critico che, nel medesimo tempo, si ponga il duro compito di rigettare le culture e le tradizioni egemoniche-dominanti, attraverso «un lento spostamento della prospettiva filosofica che osserva le cose da un nuovo centro di interesse o punto di vista». Seguendo queste premesse, è chiaro come questo progetto interculturale si determini entro una situazione di instabilità, o contingenza, la quale purtuttavia, contribuisce alla costituzione di molteplici varchi verso altre culture; in tal senso, simili varchi contribuiscono «alla corrente sociale di scorrere orizzontalmente verso il totalmente altro», opponendosi a quel modello piramidale e gerarchico che costituisce il più grande ostacolo all’integrazione culturale.
Inoltre, il configurarsi di questo modello verticale, e il suo estrinsecarsi nella forma simbolico-rappresentativa di una piramide sociale, sembra abbia prodotto come conseguenza un allargarsi indiscriminato delle diseguaglianze, nonché un accresciuto bisogno di separazione; allorché l’altro, tradotto all’interno delle logiche concorrenziali e competitive del mercato globalizzato, è soltanto “rivale nella grande corsa”, cioè un nemico contro cui concorrere all’interno della struttura piramidale. L’autore, a tal proposito, puntualizza come l’elemento signorile, intendendo favorire gli interessi appartenenti alla cultura dominante, abbia finito per estendere le basi del conflitto sociale e smorzare ogni tentativo di dialogo interculturale.
L’autore rimarca come il pensatore tedesco Friedrich Nietzsche abbia prodotto più di alcuni timidi richiami alla “trans-culturalità”. Il filosofo di Rocken, cogliendo con esemplare lucidità i motivi scatenanti della crisi europea, individua nell’assenza dell’elemento contemplativo il mancato passaggio ad una forma di cultura superiore. Avendo riconosciuto nella re-azione dei popoli esclusi dai “comfort”, l’attivarsi di una “volontà di potenza”, egli auspica un contro-movimento che progredisca al di là degli individui, in direzione di un’oltre-umanità, di «una specie più forte». Il nodo problematico resta quello di un’umanità capace di elevarsi soltanto in vista dell’affermarsi di una società aristocratica in un’epoca, quella nicciana, ancora interamente ingabbiata all’interno di una struttura chiaramente gerarchica, in cui si pongono differenze di valore da uomo a uomo. L’interculturalità deve fare qui i conti con un problema legato ai privilegi delle elité al potere, le quali hanno assai poco interesse a porsi a confronto con altre culture. Sarebbe, pertanto, auspicabile l’istituirsi di un modello anti-elitario che passi attraverso una ristrutturazione democratica interculturale delle istituzioni internazionali (p. 138). In considerazione di quanto scritto, resta da comprendere come si possa favorire un rapporto autonomo di inter-relazione con altre storie e vissuti, senza che quest’ultimi siano tenuti insieme forzatamente iscrivendoli nel perimetro delle idee regolative della ragione occidentale. La costruzione di queste nuove inter-relazioni può realizzarsi mediante la riscoperta di opere dimenticate, poiché ciò faciliterebbe l’innestarsi di processi di traduzione da una cultura all’altra, mettendo in contatto lingue, culture, vissuti e pratiche sociali tra loro differenti: «il rapporto con autore dimenticato è un disvelamento della differenza e un’apertura verso nuove prospettive, un lasciar apparire, un rivolgersi ad un dire originario che rende più attenti ai particolari di un certo discorso»; si tratta dunque di un autentico parlare, in grado di porsi dinanzi alla società signorile di massa allo scopo di metterne in discussione le categorie in essa operanti. Altresì, si può considerare l’interculturalità come il luogo dell’inespresso, in riferimento alla poesia come vera e propria categoria etica.
In conclusione, è fondamentale che tutto ciò si traduca in un’azione politica che permetta l’apertura di inediti spazi di interazione e connessione tra nuove soggettività. Uno spazio che, configurandosi come “una zona umbratile di democrazia radicale”, sappia dischiudere per quest’ultime le misure che ne consentano un adeguato riconoscimento. Tenendo conto di come esso abbisogni di norme di convivenza democratica che ne valorizzino l’esperienza limite del vivere ai margini, mi riferisco a quell’esperienza inscritta in ogni condizione di clandestinità. Certamente, si deve riflettere sulla possibile incidenza della politica proprio in quegli spazi pubblici che, molto spesso, sono esclusi dai processi economici e sociali. E, quindi, sul configurarsi di un’azione politica interculturale che non intenda occupare i spazi pubblici per adattarsi all’ambiente e alle pratiche diffuse, ma piuttosto che si muova al di fuori degli spazi di apparizione, ossia in spazi di “sottrazione” nei quali sia possibile interrompere il proprio flusso di appartenenza ad una cultura dominante e monolitica spostando, invece, l’attenzione su pratiche sociali, mondi religiosi e culture alternative, da ricercarsi in quegli spazi e tempi residuali. Infine, è ancor più di vitale importanza che ciascuno si senta interculturalmente responsabile di sé, dell’altro, di ogni altra forma vivente e, persino, del pianeta che abita, e che ciò si esplichi in una serie di azioni singolari e collettive, volte a porsi in ascolto dell’altro per rispondere ad un imperativo categorico che indica nella comprensione reciproca e nella costruzione di un «dialogo culturale complessivo» la chiave di volta per la fondazione di un nuovo umanesimo interculturale. Negli spazi oscuri della società signorile di massa sono, infatti, riaffiorate le persone, le cose, gli animali e gli eventi, come nuove soggettività sulle base delle quali intessere nuove relazioni culturali. Nella speranza che, tra questi detriti, sia possibile in un “futuro presente” scorgere i segni di una nuova forma “oltreumana” di convivenza, che non precluda nuove modalità di gestione e di “cura” heideggeriana della vita del pianeta.
Luigi Somma




 Jean-Pierre Vernant
Jean-Pierre Vernant





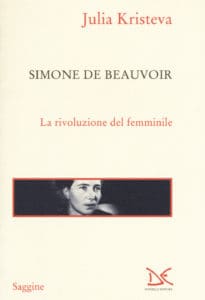
 Riccardo Roni
Riccardo Roni