Recensione al volume di L.Ventura, “Il diritto di resistenza”
Un disco di successo del musicista Sonny Curtis, pubblicato nel 1960, si intitolava “I Fought the Law”. Nelle traduzioni che circolavano all’alba della controcultura studentesca in Italia, nei primi Sessanta, si sarebbe potuto indifferentemente leggere “ho combattuto lo Stato”, “ho combattuto il potere”, “ho combattuto la legge” e a poco c’entra la dottrina anglofona, da Dworkin in poi, che ha specificamente lavorato sull’analitica distinzione tra i concetti richiamati. Il volume di Luigi Ventura, “Il diritto di resistenza” (pubblicato per i tipi di Rubbettino, Soveria Mannelli, nel 2014), è sostanzialmente percorso da una domanda che sorge spontanea leggendo le diverse traduzioni del testo di Curtis: cosa può fare il cittadino quando il potere agisce contro la stessa legge di uno Stato di diritto? Come può combattere?
Il saggio costituisce, per altro verso, la ripubblicazione di un estratto significativo di un lavoro più lungo, del medesimo A., risalente al 1981: sarà sorprendente, alla fine della lettura, riscontrare che ben poche rughe si inseguono tra le pagine del testo e, invece, molta, molta, sorpresa e sorprendente attualità. Ancor prima dei contenuti, preme del resto sottolineare l’intrinseca unitarietà stilistica del volume, messa in mostra dalle notazioni bibliografiche a piè di pagina. Molto dettagliate, e però sempre accessibili (rari entrambi i fenomeni nelle pagine di uno stesso volume, nella letteratura scientifica), quasi che, in effetti, il lettore possa volgere lo sguardo a due facce della stessa medaglia, più che a due libri diversi. Per Ventura il nutrito apparato bibliografico è usato o come esplicazione teorica puntuale e minuziosa delle intuizioni del volume o in quanto efficace aggiunta di particolari, rispetto allo svolgimento testuale della ricerca.
Nella prima parte del volume ci si occupa della genesi concettuale del diritto di resistenza, nell’alveo giusnaturalistico, anche nelle sue componenti più radicali (il tirannicidio). Un giusnaturalismo che, almeno per ovvie ragioni storico-culturali, ha avuto a propria volta origini cristiane. Prova ne sia che l’A., tra le molte, passa al setaccio le posizioni di Calvino – che propone l’istituzione di magistrature per la tutela del popolo – della Scolastica (filtrate da un’interpretazione di Tommaso che l’A. giustamente non ritiene sempre e del tutto soddisfacente), fino alla vitalità del diritto borghese rivoluzionario del XVII e del XVIII secolo. Interessante che questa parte della trattazione si concluda con l’analisi delle scelte costituzionali compiutesi in Germania e in Francia. Casi di studio che più facilmente vengono di solito utilizzati come metro di comparazione per l’ordinamento italiano, ma anche ordinamenti che di quel diritto rivoluzionario declinarono, per ragioni e in forme e tempi diversi, soprattutto lo strumento della codificazione. Persino in merito a quest’ultimo, può notare, ad esempio, Grossi, è palese l’influenza delle dottrine giusnaturalistiche, benché spogliate dalle connotazioni etico-politiche più apprezzabili. Una spoliazione che non riguarda, invece, la natura radical-collettivistica del diritto di resistenza e il cui mancato depotenziamento ideologico è verosimilmente causa dell’eclissarsi di riferimenti ad esso nella Costituzione francese del 1946 e dello sbrigativo dibattito (nota l’A., p. 56) che lo riguardò in Italia. Il senso etico non appartiene al governante iniquo.
Proprio il capitolo del volume dedicato alla trattazione in sede di Assemblea costituente della problematica in oggetto si rivela tra i più interessanti per saggiare l’effettiva contemporaneità della questione. Inizialmente, la costituzionalizzazione del diritto di resistenza veniva caldeggiata dalla sinistra democristiana (Dossetti), ma altre correnti del medesimo partito finirono per retrocedere dall’attuazione di quel principio teorico cui pure la vicenda storica del Cattolicesimo aveva dato un contributo non irrilevante. Come avverrà in Portogallo e in Spagna nei tre decenni successivi, la difesa del diritto di resistenza, nel novero dei diritti fondanti lo Stato democratico, diverrà principalmente istanza della sinistra marxista. E, stando al dibattito italiano, con maggiore incisività nella sinistra socialista, che non nel Partito Comunista, al quale (dati i tempi e i contesti in cui si consumava la discussione sul diritto di resistenza) la questione doveva sembrare l’ingenua legalizzazione di un momento rivoluzionario – l’illusoria clausola di continuità tra l’ordine costituito e l’ordine costituente.
È nei capitoli successivi che i richiami a temi dell’oggi si fanno, però, ancora più pressanti. Innanzitutto, l’A. ammette esplicitamente di guardare al contenuto del diritto di resistenza senza ritenerlo l’ipotesi manualistica e residuale che corrisponde a fatti particolarmente eclatanti (un colpo di Stato). La prospettiva percorsa sembra assai più equilibrata e concepisce la configurabilità di uno strumento siffatto anche nel caso di reiterata inattuazione del disegno politico-costituzionale. L’A., nel 1981, aveva ben chiaro che il volto morbido del dispotismo sarebbe stata la quotidiana svalutazione del dettato costituzionale – o, come sempre più e sempre peggio avviene, un utilizzo abusivo e non paradossalmente incostituzionale della medesima revisione costituzionale. In secondo luogo, è appena il caso di notare che l’elaborazione dell’A. si riferisce all’inizio degli anni Ottanta. Calate nel loro contesto genetico, queste pagine svelano dei tratti evidentemente coraggiosi. Nel decennio precedente, infatti, si era coltivata, forse, illusoriamente la possibilità di un momento rivoluzionario in Italia (stavolta, da parte della sinistra extraparlamentare, e non di quella parlamentare). Ed è sorprendente che la legislazione di quegli anni, riconosciuta reiteratamente incostituzionale da parte della Corte nei decenni successivi, si incaricasse di soffocare le tumultuosità dell’epoca, senza prendere in considerazione che proprio una più coerente legislazione attuativa del disegno costituzionale avrebbe disinnescato molte delle questioni sociali che avevano legittimato sul piano dell’opinione pubblica l’insorgenza dei movimenti extralegali. Il diritto di resistenza cui guarda l’A., forse anche per trovare sbocco costituzionalmente coerente alle istanze sociali che Egli pur riconosce (senza ovviamente avallarne gli incendiari di turno), non è cospirazione estemporanea, né archeologia giuridica dell’alba del costituzionalismo. È presa di coscienza della resistenza a sovrani illegittimi. Non sbocchi cruenti, prefigura tale impostazione giuridico-teorica, ma riscoperta ragionata e coerente delle più intime nervature della Carta.
Colpisce che l’A. affronti espressamente, nella verifica di ipotesi di resistenza per come poc’anzi chiarite e senza suggerire sovrapposizioni affrettate, il caso dell’obiezione di coscienza (più rapidamente) e dello sciopero politico (dedicandovi la parte più corposa della trattazione). Il primo, del resto, poteva sembrare avere trovato una prima, accettabile, soluzione con la legge n. 772 del 1972 (e, in misura diversa, con l’art. 9 della legge n. 194 del 1978, che non aveva ancora messo in luce le applicazioni abusive, in tema di obiezione, oggi osservabili). Ma è emblematico che l’A. dedichi grande attenzione allo sciopero politico. Ciò, al lettore di oggi, pare indicativo di almeno due istanze parimenti significative. Ex tunc (per “ieri”, quando l’A. scriveva di quei temi per la prima volta), avere intuito che stava per andare in scena nel Paese una complessiva trasformazione delle politiche salariali, sindacali e di gestione della spesa pubblica. La politica economica del governo Craxi di lì a poco avrebbe messo nero su bianco lo smantellamento della forza rivendicativa del movimento operaio e, d’altra parte, l’indebitamento come leva espansiva. Ex nunc (da “oggi” e per il futuro) l’A. nota pure il rilievo, nient’affatto consolatorio o astrattamente declamativo, dei diritti sociali nel novero della Carta costituzionale. Come a dire che solo una politica legislativa orientata compiutamente alla loro attuazione sarebbe conforme a Costituzione, non ponendosi al di fuori di quell’accezione di legalità, per cui è opportuna la difesa della resistenza. La Costituzione deve orientare le leggi. Le leggi vanno interpretate secondo Costituzione, non dev’essere l’interpretazione della Costituzione a venire strappata o tirata qua e là, per assecondare la pessima qualità della produzione legislativa, come letture sconcludentemente funzionalistiche vorrebbero imporre di fare.
Riprendendo, allora, le battute iniziali dell’opera c’è da chiedersi non già che ruolo abbia la resistenza nell’ordinamento (acclarato che essa vale ad assicurare istanze di giustizia sostanziale e principi fondamentali, questi si, non negoziabili), ma che mutevoli forme saprà prendere l’usurpazione del tiranno. Quali diavolerie ha in serbo nella sua raffinatissima borsa di coccodrillo.


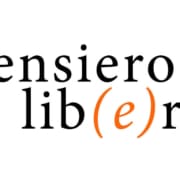




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!