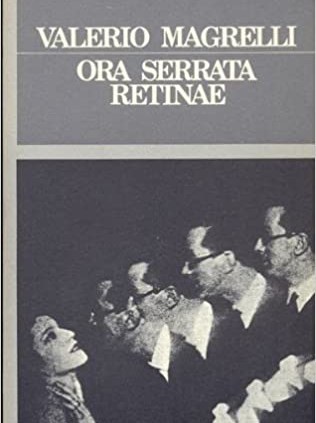1
Nel primo capitolo de La morte Ivàn Il’íč di Tolstòj, nel primo dei movimenti (in senso musicale) che compongono questo sottile e misterioso racconto, non sono presenti, a rigore, né la morte né Ivàn Il’íč. La morte del protagonista è già avvenuta e, di questi, è solamente esposta – solenne, pacificata – la salma. La morte, al più, in questa sezione del racconto, è una notizia, giunta attraverso il giornale ai colleghi dello scomparso. In quanto notizia, essa genera delle reazioni individuali che si conformano alla manifestazione mondana del lutto, alle regole da mantenere in questi casi: neppure i segreti pensieri di avanzamento di carriera, che i colleghi si aspettano dalla fine di Ivàn Il’íč, si sottraggono a questa legge di conformità, a questa prevedibile ritualità.
La morte è anche un apparato, un allestimento, una recita: prevede un sistema di frasi di circostanza, una chiave di lettura del senso implicito di alcune espressioni, tanto di quelle di pena quanto di quelle di conforto, uno scambio di gesti che corrisponde ai codici di comportamento concordati e a tal punto introiettati da apparire perfettamente naturali. L’evento della morte di qualcuno, di ciascuno, è il motore di una meccanica commedia funebre a parti fisse: i colleghi, la vedova, i familiari, la servitù; il posto libero, la pensione, il cordoglio, i costi delle esequie.
La morte è anche un odore, il più terribile, il più indecoroso, ma da cui ci si allontana con rapidità, una volta espletati i riti previsti. Questo racconto è anche un balletto di personaggi che si allontanano.
Si intuisce che la morte è un grande Altrove, eppure il brulicante tumulto dei sopravvissuti, degli eredi come dei conoscenti, è dominato da un piccolo altrove, dal desiderio di non esser lì: ma si intuisce che anche questo piccolo altrove (il gioco delle carte, il teatro, l’ufficio) sia un espediente provvisorio. Non si sa bene, a pensarci, dove vorremmo stare, dal momento che, prima o poi, ogni luogo viene a noia, ogni interlocutore è di peso, ogni distrazione è sopraffatta dallo scorrere del tempo.
Ma il motivo segreto di questo primo movimento non sembra essere, o almeno non sembra soltanto, quello di una satira di costume. Si avverte un’altra necessità strutturalmente connessa alle ragioni di efficacia e persuasività del testo. Questa necessità è la distanza: il procedere da un punto lontano, quando tutto è già compiuto e irreversibile. Il procedere su una materia già fredda, inerte, come il cadavere di Ivàn Il’íč. Un cadavere non parla, un cadavere non fa smorfie. “Dall’alba della sua giovinezza l’uomo sprofonda nelle parole e nelle smorfie” scriverà Witold Gombrowicz, cinquant’anni dopo, in Ferdydurke. La prima parte del racconto tolstojano inaugura una fenomenologia (o una semiologia) delle smorfie, delle parole e dei loro sottintesi; un lavoro di primi piani (volti, schiene, mani), di inquadrature ravvicinate, allo stesso tempo proiettato davanti agli occhi del lettore come se provenisse da una remota sorgente di luce livida. È necessario che sia così, perché da questo momento in poi il piano dell’azione e dello sguardo non può che scendere, non può che calarsi nel racconto di una vicenda e accompagnarsi all’umano che di questa vicenda è emblema.
2
Quello che si diceva del giovane Ivàn: la phénix de la famille.
La medaglia appesa alla catenella che decora il suo nuovo abito da funzionario: Respice finem, recita il motto inciso sopra.
Essere portatori di equivoci (e ironici) segni di appartenenza. Alla morte.
3
La vita di Ivàn Il’íč, ci viene detto, era stata delle più semplici e delle più orribili. È uno di quei procedimenti tolstojani che ci sembra a prima vista del tutto evidente, ma conserva (ed è bene che sia così) un fondo di ambiguità. Cosa vi è di veramente orribile in una vita comune? Da dove nasce e in quale punto di un’esistenza normale, come quella del quieto giudice istruttore, può dirsi che questo orrore germini e si manifesti? Un velo di calcolata incertezza è sospeso tanto per chi legga questo racconto per la prima volta quanto per chi lo abbia assimilato in più occasioni e ne abbia introiettato le valenze filosofiche e morali. Si intuisce che la cifra di questo orrore stia proprio nella normalità (e quindi nella sua esemplarità da Everyman in veste borghese) di Ivàn Il’íč, ovvero nel sistema fittizio di convenzioni su cui questa normalità poggia, ma non possiamo essere sicuri che l’orrore non si riferisca anche alla sua malattia, alle forme della sua sofferenza e alla sua conseguente iscrizione alla categoria dei reietti, se non alla definitiva disperazione e all’abisso spirituale in cui il protagonista precipita fino a pochi secondi dal suo estremo respiro. E se orribile fosse la condizione umana tout-court, determinata sempre e soltanto da scelte irrevocabili, da strade non prese, da occasioni perdute?
4
Il colpo subìto al fianco, perno narrativo che sconvolge la vita del protagonista e fa ruotare l’intera vicenda, raggiunge Ivàn Il’íč al culmine della sua carriera, di una carriera tutto sommato modesta che dà accesso a un tranquillo benessere e a un sistema di utili relazioni sociali. È probabile che l’ultimo (e insperato) avanzamento di carriera sia, più o meno, il traguardo professionale più alto a cui il protagonista possa aspirare. Anche la cura di Ivàn Il’íč nell’arredare personalmente l’ ambìto appartamento pietroburghese rivela che, per costui, questa non possa che essere la dimora definitiva. Ecco perché la sua angoscia è tanto più elementare e orribile. Se il protagonista avesse consapevolezza di poter aspirare a più alti successi, a una maggiore gloria, la sua disperazione sarebbe da attribuire al pensiero di quanto gli resti da fare: verrebbe proiettata così su uno sfondo quasi eroico. Ma il pensiero di Ivàn Il’íč è tutto rivolto a una posizione conseguita e, mano a mano che il decorso della sua malattia procede, i sentimenti del protagonista si orientano più al passato che al futuro. Al futuro è demandata la speranza di una guarigione. Possiamo chiamarla speranza ma anche superstizione: in entrambi i casi, si tratta di sentimenti ancorati alla duplice e ossessiva decifrazione degli arcani medici e dei segnali del corpo.
5
Di cosa muore infine Ivàn Il’íč? Neppure di questo abbiamo particolare certezza. Egli urta con violenza contro un mobile. Dai giorni successivi, che coincidono con l’arrivo e l’insediamento del resto della famiglia nella nuova abitazione, cominciano a manifestarsi i segni del malessere. Un colpo violento, uno stato morboso e i molteplici consulti dei dottori. Le contraddizioni dei responsi, i silenzi. Le analisi. Forse il rene mobile, forse l’intestino cieco. L’attenersi disincantato alle prescrizioni e all’ottimismo incontrovertibile della scienza medica.
Non è possibile sapere di cosa muoia. Non dobbiamo saperlo. Se lo sapessimo con certezza, saremmo portati a pensare che a noi non può accadere. Che potremmo morire in molti modi ma non di quella malattia. Attiveremmo dei meccanismi di difesa, ci sentiremmo affidati al mondo dei sani, confortati dal fatto di esserlo o di essere un po’ meno malati del protagonista. L’incertezza delle diagnosi è un espediente narrativo, certo un po’ crudele. È quell’opacità che frustra nel lettore il desiderio di trasparenza: quella trasparenza (è la malattia della letteratura contemporanea) che trasforma i lettori in moralizzatori con l’istinto dei voyeurs.
6
Si legge e si accredita un po’ ovunque che Gerasim, il servo che tiene sollevate le gambe di Ivàn Il’íč, per offrirgli un notturno sollievo, sia l’unico personaggio positivo del racconto. Di Gerasim sappiamo che è un servo contadino trasferito in città, è giovane, è sano, è ben pasciuto. Appare di sfuggita nel primo capitolo, si intrattiene con Ivàn Il’íč nelle fasi in cui la malattia isola costui dal contesto familiare e sociale, gli offre la propria opera con pazienza e gaia generosità. Non appare né è nominato nell’ultimo capitolo. Non sappiamo nulla della sua vita e della sua famiglia, non sappiamo come morirà, se anche lui in mezzo a brucianti sofferenze fisiche e morali o se accompagnato dalla stessa mitezza manifestata nei confronti del suo padrone. È un personaggio letterario, del resto. Vive per il tempo esatto in cui rimane in scena. Ci piace perché è giovane, perché è del popolo. Tolstoj arriva sull’orlo preciso di una descrizione di Gerasim venata di populismo (nell’accezione storica del termine), ma per fortuna se ne trattiene. L’idealizzazione appartiene più allo sguardo del lettore che dell’autore.
7
Philippe Ariès, in Storia della morte in Occidente, cita il racconto di Tolstòj come documento di storia della mentalità, come attestazione di un passaggio decisivo nella percezione di malattia e morte nella società occidentale moderna. A proposito della condizione del malato, illumina: “A poco a poco egli [Ivàn Il’íč] viene spogliato della sua responsabilità, della sua capacità a riflettere, a osservare, a decidere, è condannato alla puerilità.”
8
Capire il mistero de La morte di Ivàn Il’íč. Avvertire come ogni singola frase del racconto, ogni snodo, ogni dialogo, ogni personaggio compongano un emblema complessivo della condizione umana, ma senza intenzioni edificanti. Avere anzi l’impressione che, a coglierne tutte le implicazioni (ma dopo quante letture?), la coscienza di un lettore autentico non possa non comprendere qualcosa di necessario e terribile e trarne le inevitabili conseguenze. Ma comprendere cosa? Probabilmente che la morte eccede ogni elaborazione concettuale e ogni espressione linguistica. Probabilmente che anche un racconto perfetto, come quello che abbiamo sotto gli occhi, può arrivare sino a una soglia, farsi massa critica della soglia stessa ma non può riuscire a superarla. Ivàn Il’íč è vivo, fino al punto conclusivo del racconto. Poi comincia l’oltre della pagina bianca. Può la letteratura, può l’arte sottrarsi ai suoi stessi principi costitutivi? Per natura la rappresentazione non può accedere all’Irrappresentabile: deve accontentarsi di emblemi, metafore, finzioni. È come se il racconto avesse due lati, uno aperto verso la vita (e il morire che le è connesso) e uno verso la morte. Il primo brulica di parole, speranze, intenzioni, dolore, inconcludenza, successi, rimpianti. Il secondo è privo di immagini, di parole, di pensieri, eppure la sua semplice evocazione basta a mettere in scacco le pretese di autenticità del primo. Eppure, direbbe Vladimir Jankélévitch, “è la morte a dar senso alla vita, proprio sottraendole tale senso. Essa è il non-senso che dà un senso negando questo senso”.
9
Le prugne francesi, “crude e grinzose” dell’infanzia di Ivàn Il’íč. Verrebbe da associare quel ricordo al professor Isak Borg, al posto delle fragole e all’ultima sequenza dell’omonimo film di Ingmar Bergman. L’infanzia come radice di tutte le possibilità. E aggiungo: non di ciò che è dolce ma di ciò che è acerbo sono fatte le promesse dell’infanzia. La fresca asprezza di un frutto come nucleo originario di tutte le promesse destinate a fallire.
10
I quattro movimenti musicali di questo racconto. L’esordio con la notizia della morte e le esequie. Il riepilogo della tranquilla e convenzionale vita del nostro eroe. L’insorgere dei sintomi della malattia e la progressiva consapevolezza della fondamentale finzione dell’esistenza. E infine: i tre giorni (con evidente corrispondenza cristologica) dell’agonia.
Il suono di questa agonia è un ululato ininterrotto. Questo suono sgretola le strutture del linguaggio e dei suoi significati, è il correlativo fisico (ma di segno opposto) della voce interiore che ha interrogato Ivàn Il’íč nelle ultime settimane della sua malattia, smontandone convinzioni e illusioni. Dentro all’urlo dell’uomo parole e intenzioni si deformano (“Voleva ancora dire «perdonami» [in russo: prostì], ma disse «lascia andare» [in russo: propustì]”), subiscono una torsione dentro la quale non è escluso che sia nascosta la vera natura del linguaggio. Questo urlo è quanto di più lucido e vitale e sconveniente il malato possa compiere. È sconveniente perché non lascia in pace gli altri abitanti della casa, ne turba il decoro; è necessario perché guida il morente a una nuova e decisiva consapevolezza. Doppio è il viatico a questa consapevolezza: prima, la visione del figlio, disperato e inerme di fronte al dolore del padre, di quel figlio così simile a lui da adolescente. E poi, quell’ È finita, pronunciato da qualcuno sopra di lui, che dà luogo all’ultimo malinteso: quell’ È finita la morte, la morte non esiste, che Ivàn Il’íč pronuncia dentro di sé. Malinteso benefico, ma pur sempre malinteso, a conferma dell’inadeguatezza di quel linguaggio che è pure l’unico modo che l’individuo ha per testimoniare la sua presenza e la sua giustificazione al mondo.
11
Si possono portare alcune visioni verso estreme conseguenze. “È come una vita tra le quinte” scrive Franz Kafka in un frammento. E poi evoca la possibilità di un’evasione, attraverso fondali e attrezzi di scena, fino al vicolo adiacente al teatro “stretto, umido, buio”: il Vicolo del Teatro, appunto. Esso è reale e ha “tutte le profondità del vero”. Eppure, si può notare, esso è talmente vicino al Teatro da portarne ancora il nome. E chi ci può assicurare, aggiungo, che dal teatro non si sia evasi verso una finzione ancora più reale? O che dal vicolo non si possa evadere verso un’altra realtà ancora più profonda e da questa verso un’altra ancora?
12
Vi dovrebbe essere un quinto movimento, da qualche parte, oltre il punto finale del racconto. Ma già l’espressione “da qualche parte” risulta incongrua rispetto alla morte intesa come alterità assoluta e irrappresentabile. Bisognerebbe immaginarlo come il silenzio, mai udito da alcuno, che sovrasta una terra di nessuno dopo la furia del combattimento. Ma anche questa è solo una metafora.
Testo di riferimento utilizzato: Lev Tolstòj, La morte Ivàn Il’íč e altri racconti, a cura di Igor Sibaldi, Mondadori, Milano, 1999.
Altri autori citati
Witold Gombrowicz, Ferdydurke, a cura di F. M. Cataluccio, trad. I. Salvatori e M. Mari, Il Saggiatore, Milano 2020
Philippe Ariès, Storia della morte in Occidente, trad. Simona Vigezzi, Rizzoli, Milano 1978
Vladimir Jankélévitch, Pensare la morte?, a cura di Enrica Lisciani-Petrini, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995
Franz Kafka, Frammenti e scritti vari, trad. Italo A. Chiusano e Ervino Pocar, Mondadori, Milano 1989