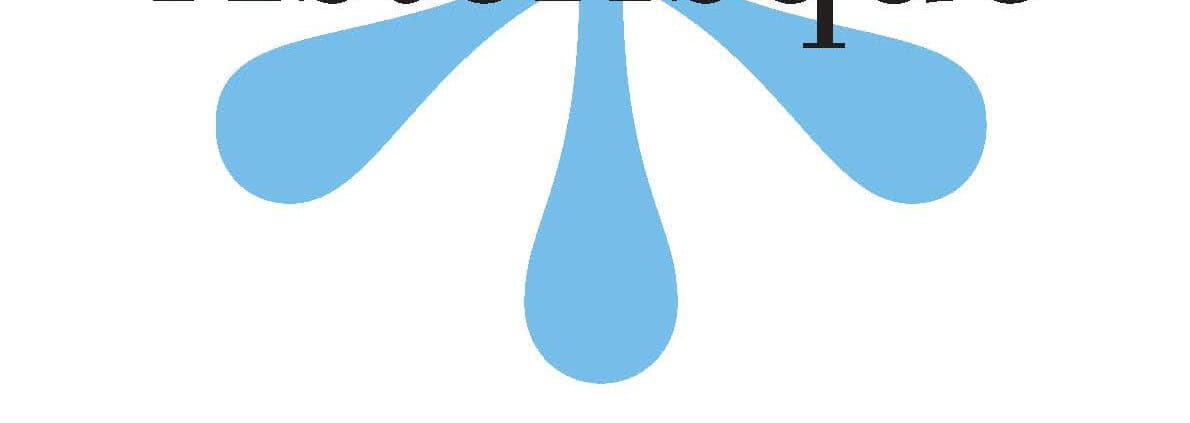LA DEMOCRAZIA DEL PERICLE DI TUCIDIDE
Dinanzi ai notissimi, mirabili e memorabili, Discorsi agli Ateniesi che Tucidide fa pronunciare a Pericle sulla Democrazia cittadina, colta in un certo tempo storico e attraverso modi originalmente determinati, è forse ancora non inutile cercar di circoscrivere, con tutte le cautele del caso e al di là di ogni più ricca e vasta precisazione, alcuni dei caratteri salienti e «generali» di un’esperienza storica, qual è quella delineata nel grande testo dell’acutissimo storico. Proverò qui di seguito a riassumere, secondo il mio parere, taluni di questi tratti, preceduti solo da due brevi avvertenze. La prima è che, per comodità, mi concentrerò soprattutto, ma non esclusivamente, sui capitoli centrali del secondo libro tucidideo (59-65); l’altra è che nell’esposizione terrò sempre presente la lezione di Machiavelli (seguirò più spesso la traduzione di Franco Ferrari). È noto come questi dioscuri, quello antico e quello «moderno», siano di frequente appaiati a formare, da soli, quasi l’intera sostanza di ciò che si dice «realismo politico» (una nozione che dovrebbe essere sempre ridiscussa). In particolare è la cultura tedesca tra la prima guerra mondiale e la nascita del nazismo – richiamo solo, con gli studi in proposito di Luciano Canfora, il libro del filologo classico Eduard Schwartz su Tucidide uscito già nel 1917 e ristampato dieci anni dopo – a soffermarsi spesso su Tucidide e, al tempo stesso, su Machiavelli, del resto in una sorta di larga e talora sofferta autobiografia, individuale e collettiva o nazionale.
Il primo rilievo è che in Tucidide c’è scarso interesse per una definizione formale della democrazia. Non si tratta, come tutti sanno, di una carenza legata al tempo precoce in cui cade la riflessione tucididea. A smentire ciò basta ricordare che già in Erodoto (III 79 segg.) si trova un notissimo testo – su cui ora non mi soffermo – circa le tre principali forme di governo, attraverso la personificazione di altrettante figure-simbolo di cui una critica le posizioni delle altre. Dunque, questa scarsa cura circa la democrazia come forma di governo non è casuale. Significa forse allora che il discorso di Tucidide è generico e sfocato? Nessuno oserebbe dir questo, perché il grande storico antico tenta effettivamente di determinare la democrazia ateniese del suo tempo, ossessionato dalla ricerca della «verità», dall’acribeia, dalla precisione e dall’esattezza.
La definizione e delimitazione avviene piuttosto opponendo a «Noi» ateniesi gli altri, attraverso i caratteri differenziali che connotano l’esperienza di Atene rispetto ad altre pratiche politiche e umane. Eppure, non bisogna scambiare questa specificazione comparativa con una semplificazione dell’intero quadro. Accanto infatti al disinteresse di Tucidide per la democrazia in quanto specifica forma di governo, si deve ricordare che essa costituisce per il grande storico un fenomeno complesso e, per così dire, «globale», capace di abbracciare, nel gioco tra pubblico e privato, quasi per intero le attività umane. Escludere la specificità della forma politica vuol dire infatti includere, per il rimanente, pressoché tutte le altre sfere vitali, all’insegna della democrazia come modo o stile di vita. Si discute ancor oggi se la politica debba riferirsi solo al suo specifico e delimitato campo, con i contenziosi che ne derivano rispetto ad altre sfere, o se, per attingere sé stessa, convenga ricavarla da una considerazione à part entière dell’uomo e della sua storia, che tocchi anche ambiti in apparenza molto lontani dalle questioni politiche. Quest’ultimo è il caso di Tucidide, che tira in causa, per esempio, anche il modo degli ateniesi di fruire del «bello» e di dedicarsi al «sapere», di conquistare e usare le ricchezze, di seppellire e rendere onore ai caduti in guerra, e così via (II 40). La celebre attribuzione ad Atene di «maestra» della «scuola dell’Ellade» (II 41) si deve intendere come un insegnamento a tutto tondo, fondato sul proprio modo di agire.
La democrazia, insomma, più che una dottrina politica, si configura per Pericle come una forma di vita le cui parti si rinviano tra loro con ampiezza e coerenza. Si può pertanto anche dire che rilevanti sono nei discorsi fatti dire a Pericle non tanto le leggi quanto i costumi. E se proprio vogliamo evocare le leggi, saranno piuttosto gli agraphoi nomoi ricordati, come indefettibili regole consuetudinarie, nell’Orazione funebre di Pericle (II 34 sgg.), entro un dibattito che si era intensificato tra VI e V secolo. Queste leggi, che abbracciano – com’è noto dalla figura di Antigone e segnatamente dalla lettura datane da Hegel – cielo e terra, sono le più indicate a esprimere il carattere globale della democrazia di Pericle, cui nulla di umano è estraneo, nel pregnante coinvolgimento di privato e pubblico, gli ambiti entro cui la vita si dipana.
Una conseguenza di quanto si è appena detto sta nel fatto che non c’è nei Discorsi di Pericle nessuna volontà di dimostrare qualcosa, di giungere, partendo da premesse logiche, a prove e a conclusioni che vogliano essere necessarie e stringenti. L’unica forma di persuasione di cui il testo si occupi è l’esibizione, la plastica ostensione della vita che si conduce in Atene: «Noi facciamo così», ecco come noi qui ci comportiamo. C’è nella grande e ricca città una vita «facile» e libera, multiversa, dove, fuor dalla guerra, vige qualcosa come il goethiano precetto di vivi e lascia vivere: un’intrinseca mobilità e una disponibilità a sperimentare ciò che è particolare, insieme a quel che è universale, alle esperienze che, riguardando comuni sentimenti, toccano ciò che è giusto e di «buon senso». Da ciò che oggi diremmo «società civile» nascono, in ogni campo, manifestazioni di eccellenza che hanno un rilevante peso nella vita politica, trasferendosi direttamente e con fluidità dall’ambito civile alla specifica selezione operata dalla politica.
Se c’è un modello da paragonare alla democrazia di Pericle, a me pare che potrebbe essere quello che sarà costituito dall’Etica Nicomachea, con i suoi «per lo più» e i «presso a poco». Contingenza, precarietà e pienezza di vita convivono felicemente. Il cuore della questione è che solo i veri pensatori «realisti», come vengon detti, hanno capito, con la larghezza di vedute e la liberalità dei grandi (mentre i modesti perseguono irraggiungibili traguardi «monastici», accrescendo sempre più le loro vane pretese), che la Politica non è, né può essere una scienza; ed è perciò paradossale ma profondamente vero che proprio Tucidide, il maggior storico antico, con la sua acribeia e la sua preoccupazione per la verità, si sia impegnato nel compito, solo all’apparenza limitato, di ricondurre i ragionamenti a più miti, fluide e dicibili pretese. Naturalmente c’è il problema prossimo della storia, ma qui ci vorranno i filosofi per appesantire e irrigidire questo campo, magari al coperto di imperiose e astratte «necessità», sostenibili solo in ambito filosofico o scientifico, ma capaci, per il resto, di essiccare ogni vivo senso della storia.
E tutto avviene, con Pericle, nella luce più sfavillante. È stato spesso avanzato il paragone tra Pericle e Cosimo de’ Medici il Vecchio circa l’eguale potenza politica dei due, priva in entrambi i casi di ogni riconoscimento formale nel governo. Ma che a Firenze ci fosse uso spregiudicato e ingannatore della complessa macchina burocratica da parte dei Medici è noto, mentre del tutto diverso è il nostro caso. All’origine si trovano i riconosciuti meriti di Pericle, esibiti alla luce del sole, a tutti visibili e da tutti, salvo che nei periodi di crisi, ammessi: qualcosa come una legittimazione originaria del suo «titolo» al potere. L’opera dell’egemon, del leader capace di «indicare la via», non si limita per altro a saper prendere le «buone» e «necessarie» decisioni, quasi agisse solo sulla subalternità del popolo e attraverso scelte calate dall’alto, ma altresì a illustrarne a tutti il senso e la direzione, dialogando tra uomini allo stesso titolo razionali. Come osserverà Machiavelli, acuendo la difficoltà, «sono molti i beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterli persuadere ad altrui» (Disc. I 11.11). Ma chi non fa questo, chi non illustra e spiega le proprie scelte, sta nella stessa condizione, dice Pericle, di chi non ha mai pensato alla cosa, o, peggio, di chi è ostile alla nostra città. Deriva da questo tacito patto tra eguali la feconda ambiguità del testo per la quale la parità è nello stesso tempo non servile differenza. E se voi aveste mai creduto, anche solo per un momento, dice ancora Pericle, che io possedessi «più di ogni altro» le qualità necessarie al comando, che fossi capace «più di ogni altro» di assolvere questo compito di guida, dovreste ora mantenervi fedeli a un simile vincolo.
Nel capitolo I 9 dei Discorsi, su Romolo, Machiavelli sembra affrontare in un punto la nostra questione, quando osserva che «se uno è atto a ordinare, non è la cosa ordinata per durare molto quando la rimanga sopra le spalle d’uno, ma sì bene quando la rimane alla cura di molti, e che a molti stia il mantenerla» (I 9.9-10). Perché non risponde alle nostre esigenze quest’equa spartizione dei compiti, per cui solo uno è «atto a ordinare», mentre solo i molti sono capaci di conservare a lungo la «cosa ordinata»? Perché solo uno, il grande legislatore, si deve rispondere, possiede straordinarie capacità virtuose, tali da configurare i molti del popolo, seppur atti a un importantissimo ed esclusivo compito di mantenimento, come subordinati all’azione del fondatore pleno iure, d’ incommensurabile prudenza e libertà. Anche in Tucidide si parla della differenza tra i pochi che sono in grado di dar inizio a una «Politica» e degli irresponsabili tentativi «populisti» che cercano, aprendo un’età di decadimento, di dare anche al basso popolo, funzioni di governo. Il senso realistico di Tucidide/Pericle fa cominciare l’Archeologia, la prima parte dell’opera, dalle grandi migrazioni e dai problemi del nutrimento dei popoli (I 2), mentre è troppo disincantato per seguire l’originario mito greco dei legislatori, tanto superiori agli uomini comuni. Quel che ne deriva è una maggior eguaglianza tra gli uomini, sempre esposta a farsi egualitarismo, come condizione che imprime un peculiare carattere al dialogo tra il popolo e il suo leader. Per un certo aspetto Tucidide e il popolo sono veramente eguali, fino a quando riescono a tenere insieme, paradossalmente, eguaglianza e differenza. Le decisioni di Pericle vengono apertamente contestate, e, viceversa, il grande stratego sa parlare con durezza al suo popolo. Tucidide accetta il principio della «discussione» come un «buon» carattere proprio ed eccellente della democrazia, sebbene servendosene spesso con una costante vena pedagogica, e innescando con ciò una sofisticata strategia dialogica, dove l’intesa è raggiunta attraverso la disparità e l’asimmetria di ruoli.
Abbiamo ora alcuni elementi per cominciare a vedere quale sia nell’insieme lo speciale rapporto che lega Pericle al «suo» popolo. Che si potrebbe dire quasi un «rapporto d’amore», comprendendo in ciò anche i momenti di crisi e di ira improvvisa, d’insofferenza e di rottura, mai per altro tali, finché l’esperienza non è interamente consumata, da impedire rapidi ritorni indietro alla primitiva relazione consenziente. Ecco per esempio il punto cruciale in cui il popolo ateniese, adirato e gonfio di odio verso Pericle per le sventure e lo sconforto in cui si trova, relativo soprattutto ai rapporti tra privati, ma riguardante peraltro così il popolo con i suoi pochi mezzi come i potenti con le loro ricchezze, arrivò a imporgli una multa in denaro. Del resto anche in questi casi è singolare l’accusa del popolo a Pericle: quello di essere stato «convinto» a compiere certe scelte. Né la realtà è qui mascherata, ché l’eguaglianza dinanzi alla legge non comportava sostanziale parità di fortune e il problema era semmai se si sapeva o no combattere per liberarsi dal peso della povertà.
Senonché ben presto, come il popolo suole fare – è un punto presente e tematicamente contrastato in Machiavelli – lo rielessero stratego, affidandogli «tutti gli affari pubblici», tornando a considerare Pericle «adattissimo» per quanto concerneva i «bisogni attuali della città». Era noto che Pericle guidava con abilità e moderazione la città, che sotto la sua guida si mantenne sicura nei periodi di pace, divenendo «grandissima»; e quando scoppiò la guerra, anche in questo frangente il «primo cittadino» ne previde la gravità, e la sua preveggenza poté essere ben misurata dopo la sua morte. La questione saliente e non poco problematica era che non si sapeva fino a che punto il nostro stratego conduceva altri o se fosse a sua volta condotto. Ma, d’altra parte, non bisogna gridare subito al dolo: i facili detrattori di Pericle sembra che abbiano tutti sperimentato situazioni di purissima democrazia, del tutto trasparente e senza alcuna zona oscura.
Ci avviciniamo qui, in questa breve nota, a un punto che mi pare importante quanto difficile. In una densissima e ben conosciuta formula si legge che: «vi era così ad Atene una democrazia, ma di fatto un potere affidato al primo cittadino». Nello stesso senso si dice poco sopra che Pericle – pieno di «dignitas, di saggezza e prudenza, incorruttibile dal denaro – «dominava il popolo senza limitarne la libertà» (II 65. 8,9). L’oscurità di questo rapporto complesso, o di metafisica relazione tra il tutto maggiore dell’insieme delle parti – dove il comando di uno era la reale espressione e traduzione dell’eguaglianza dei tutti, o dei molti, il «dominio» su un popolo che non vedeva, in ciò, limitata la propria libertà – è così patente che stupisce la sua stessa formulazione, quasi ingenua. Era veramente altra cosa questa che non voler «lusingare il popolo» per fargli piacere, quasi che il potere di Pericle fosse stato conquistato con «mezzi illeciti»; o altra cosa che cercar di ricucire il rapporto dopo che si era fatto proprio il contrario di ciò che Pericle aveva suggerito: quando il leader cercava di ricostituire una positiva relazione, riconducendo il popolo al timore se era tracotante e risollevandolo invece se era depresso e abbattuto senza ragione. Naturalmente, tutte le difficoltà di un testo possono essere appianate e, in apparenza almeno, «sollecitandolo» appena un po’, risolte. Così, si potrebbe ricordare come queste affermazioni di Pericle non fossero del tutto nuove, rinvenibili in altri testi e spiegabili perciò senza eccessivi ostacoli, o, come nella citazione di II 65, 9, bisognerebbe tener in gran conto l’inizio che specifica l’esserci quasi solo a parole della democrazia e non nella realtà delle cose. Ma non mi soffermo ora su ciò, preferendo assumere le dense e concentratissime parole di Pericle come qualcosa di problematico, che tocca (o può toccare), in un coerente contesto, il fondo o l’essenza stessa del fenomeno democratico.
Che vogliono dire allora i due passi di Tucidide sopra riportati? La prima impressione è quasi del tutto scoraggiante. Cosa vorrà dire che ad Atene vi era sì una democrazia, ma che di fatto governava un potere affidato al primo cittadino? o, ancor più, che Pericle «dominava il popolo senza limitarne la libertà (II 65.8,9)? Se la prima sentenza può ancora far pensare che nella democrazia ateniese vi fosse una funzione e un titolare che detenevano una sorta di potere esecutivo, il ragionamento è comprensibile: si tratterà solo di sottrarre al testo l’impressione che il primo corno del periodo contenga solo una mistificante apparenza di potere egualitario per tutti, più o meno sorretto da vane parole, ossia che la democrazia non fosse nelle cose, mentre «in realtà» il potere era detenuto tutto da un princeps, da un «primo cittadino». Tuttavia non è così: per Tucidide come c’è una reale autorità singolare di Pericle, così c’è parimenti un effettivo potere del popolo, com’è detto esplicitamente quando si ricordano decisioni prese in comune da entrambi i «contraenti»: «assieme a me decideste la guerra» (I 64.1).
Questo del comando è un potere in molti sensi «costoso» da cui tuttavia, avendone goduto i vantaggi, non si può recedere, quasi fosse divenuto un fatale destino. Certo, il comando procura molte inimicizie e non pochi fastidi, che devono però essere accettati per fierezza e fedeltà alla propria storia; e solo per infiacchimento morale, per ignavia, qualche anima bella vorrebbe ora, da «uomo onesto», sopprimere tutto il male che è connesso alla grande responsabilità di avere un Impero. Ma il punto è qui che sarebbe ridicolo pensare per Tucidide una sorta di costituzionalismo di poteri limitati, mentre in realtà pare che il problema sia piuttosto costituito dall’aggregazione delle funzioni, dal fatto cioè che esse idealmente, come per sommatoria, agiscano insieme, e si integrino contribuendo a definire un potere unitario. Ma com’è possibile allora che tutti abbiano un pari potere?
È nell’altra citazione che il discorso diventa esplicitamente ossimorico. In che senso si potrebbe dire infatti che è possibile «dominare il popolo senza limitarne la libertà»? Che libertà, e per di più intatta, è quella di un popolo su cui si eserciti «dominio»? Si scartino anzitutto soluzioni più facili: non si tratta di una forma di servitù volontaria, né di un mero condizionamento per ragioni tradizionali. Ma già infine più complesso è un rapporto in cui Pericle fornirebbe scelte elaborate, comprensibili contenuti, indicazioni e strumenti per la pratica della democrazia, che poi il popolo vota: una consulenza esterna da sottomettere sempre, come accade in Rousseau, alla «volontà popolare», ma che potrebbe avvenire persino in un moderno partito politico che svolga alcune delle stesse funzioni dello straordinario condottiero ateniese. Pure s’avverte subito che qui la relazione si avvia a essere troppo strutturata e rigida, mancando i tratti del rapporto in cui leader e popolo prendono «insieme» le stesse decisioni, per cui il «dominio» è semmai di tutti su tutti, la limitazione divenendo essa stessa condizione di libertà, di tutta la possibile libertà.
Questo costituisce il mysterium fidei della democrazia, entro un’aura quasi rousseauviana: là dove si pensi di dominare, non empiricamente, il popolo, là si riafferma la sua (possibile) libertà. Come in ogni buon atto linguistico, i messaggi scorrono da entrambe le parti. Gli Ateniesi, con la propria terra per la seconda volta devastata e l’infuriar della peste, mutato parere, si «misero ad accusare Pericle come colpevole di averli persuasi a fare la guerra» – al popolo non sfuggono le sue responsabilità – donde il seguito di un cumulo di sventure (II 59.1). La totalità non è mera somma delle parti: la città se è tutta prospera è più che la somma di benessere dei suoi cittadini. La limitazione di potere fa parte essa stessa della libertà, concerne una relazione in cui non si sa chi conduce e chi è condotto. L’alternativa sarebbe, in sostituzione di una «vera» politica, quale quella che Pericle dichiara di praticare, una sorta di inesausta e piatta o quantitativa affermazione di tipo liberale. Ma nel cuore e nell’enigma della democrazia lavorava ben altra complessità.
Il problema del rapporto tra i protagonisti di questa sorta di dialogo di cui abbiamo parlato, dove tutti, anche il condottiero, hanno da imparare qualcosa dall’altro, era quello di cercar di farsi uno, essendo in realtà due. Poiché l’impero era (ed è tale) quando ai suoi utili, pur nelle immancabili differenze quantitative, partecipano tutti i cittadini, come ricondotti a formare un singolo soggetto che sfrutta le innumerevoli occasioni di arricchimento e di potere, era facile trovar l’incontro su questa base. Senza toccar ora il complesso problema se, e in che misura, l’Impero comportasse una dimensione propriamente capitalistica, come riteneva Mommsen, o se si limitasse, come è probabile in Tucidide, solo al possesso e all’accumulo di ricchezze (ancora per Polibio sono notevoli a questo proposito gli studi di Domenico Musti), è necessario tener conto di una caratteristica circostanza. Ed è l’innovazione del «soldo» concesso, su istanza di Pericle, a tutti i cittadini che partecipassero alle Assemblee o ad altre funzioni pubbliche. Questi segni del benessere e della volontà di espandere la democrazia costituivano pur sempre la base per una maggiore intesa: qui il consenso, in qualche modo favorito «istituzionalmente», non poteva mancare. Ma quando i «vantaggi», come si dice nel testo, erano «lontani», mentre vicinissime stavano le sofferenze e i disagi, la sostanziale diversità di opinione fino all’aperta ostilità tra Pericle e il popolo non poteva che farsi aperta e stridente. Lo stesso Impero era non solo fonte di molte favorevoli occasioni, ma costituiva altresì un costo, un sacrificio che si doveva calcolare e che veniva pagato per esempio dai più duri vincoli cui, come ricordano i classici, erano costrette le città dominate da una repubblica popolare. A tal proposito Tucidide forniva sia il sostegno dell’illustrazione dei vantaggi, come quello di essere gli Ateniesi signori imbattibili del mare, sia il severo ammonimento che dall’Impero non si poteva ormai più recedere, che coraggiosamente, da esprits forts, bisognava mantenerlo, rinunciando alle facili e pure dissociazioni.
Nessuno meglio del grande stratego ateniese, sapeva, come sarà pensiero costante di Machiavelli, che tutte le cose umane sono destinate alla morte: le difficoltà di detenere il potere a due, il popolo e il suo leader, era tanto vessillo di gloria, tanto indizio di prossimo disfacimento. Accumulando il loro peso, i contrassegni di crisi si ponevano come cause del declino e della fine, forse provvidenzialmente in parte oscurate e nascoste dagli ultimi eventi. La peste, che colpì lo stesso Tucidide, e da un certo tempo in poi fa da sfondo al nostro quadro storico, raffigurata com’è tra la freddezza di un referto medico e una raffinata arte narrativa (II 48-54), esprimeva nella maniera più evidente il clima di decomposizione che si manifestava da tutti i lati nella società.
Il testo di Tucidide comunica una sorta di ineluttabilità ai fatti, che si susseguono in maniera serrata, ma suggerisce pure, magari in controluce, che nella comune tendenza all’accumulo di potere e nella necessità del dominio, vi possono essere molte forme di Impero. Un’ultima parola la dedicherò a questo problema, che abbiamo già in altra forma incontrato, come governo di due o a due. Questa è la configurazione propria a Machiavelli, ed è costituita dalle due «classi», nobiltà e plebe, diverse e conflittuali, ma anche solidali tra loro, alla fine, per giungere a leggi «in favore della libertà». Sembrerebbe, astrattamente, una situazione difficile per la formazione e il mantenimento di un impero, ma in realtà una situazione «pluriclasse» e non «monoclasse» è comune, e si direbbe persimo «propizia», a una realtà imperiale: dall’antica repubblica romana all’Impero britannico. Non c’è rischio qui che le forme che fondano e sostengono la democrazia, finiscano anche per ucciderla, tanto forte è l’humus prima sociale e poi politico delle «inimicizie» tra le due grandi classi. Anche Tucidide, come Machiavelli (al fondo dei suoi pensieri) prevede una costituzione mista ma, contro la costituzione o governo misto che riposavano su tre momenti, di due soli termini, aristocratico e popolare. Come osservò Carl Schmitt, se il tre del governo misto è una sorta di pacifico numero sacro, il due è invece espressione di aspra e irriducibile conflittualità.
Nascere dal polemos vuol dire mantenere, sotto l’equilibrio garantito da ultimo dal Senato, sia conflitto che, prima della crisi finale, superamento delle lotte sociali e politiche, a condizione che nessuna classe cerchi di annientare l’altra, nessuna stravinca in un conflitto sempre rinnovantesi. Il popolo di Roma riuscì per Machiavelli a costruire, attraverso l’emersione della plebe e il conflitto con il patriziato, un immane Impero, in sostanza esempio inarrivabile, che durò molti secoli, e che dovrebbe sempre costituire, in stretta continuità temporale, un termine di paragone ex post per l’Impero greco di Tucidide: una synkrisis ricca, come al solito, di molti insegnamenti e molte sorprese. La varia natura degli Imperi, di questa antichissima forma di potere che non accenna a veder consumato il suo ruolo (anzi!), rappresenta sia una ricchezza storica che una guida politica. Se proprio, come tutto sembra indicare, non si può fare a meno di imperi, che almeno non ce ne capitino le forme più maligne. E le più malvagie sono quelle dove più sia richiesto e persino imposto ai «cittadini» l’«allineamento», in forme umilianti, dove non vi siano varchi di aria liberale che possano aprirsi.
Da ogni parte c’è da imparare e per mio conto, vicino agli imperialismi di Tucidide, comincerei col tener conto della maggior liberalità e del buon uso dell’impero che, da un certo punto di vista, era a Roma più di quanto non fosse in Atene (come più volte argomentò la storica del diritto antico Eva Cantarella). Tacito racconta a proposito della proposta di Claudio, appena imperatore, di concedere ad alcuni Galli la possibilità di diventare senatori o magistrati. Alla prevedibile opposizione dei nobili senatori, toccati nel già ridotto potere, l’imperatore rispose con un mirabile discorso di apertura, secondo il costume romano, delle cariche da tempo concesse a tutti, anche ai «figli dei nostri schiavi». Già i miti di fondazione di Roma (a cominciare dal matrimonio del migrante Enea con la figlia del re laziale e dall’asilum di Romolo), testimoniavano ciò, e quindi mostravano la capacità di trattare «nello stesso giorno, e con gli stessi popoli, ora da nemici e ora da cittadini». È questa una singolare apertura, di contro alla feroce autoctonia di Atene, nata dal seme di Efesto, che non voleva in alcun modo esser «contaminata». Basti solo pensare qui alla politica ateniese verso i meteci, numerosissimi e «produttivi» commercianti per lo più, che avevano possibilità di essere «accolti» nella città solo a condizioni iugulatorie, che prevedevano l’iscrizione di essi in un apposito registro, sotto condizione altrimenti di pesantissime pene. Un cittadino doveva garantire per il meteco, che pagava una speciale tassa, la sua uccisione valeva poco e la sua testimonianza veniva presa solo sotto tortura, come si faceva con gli schiavi. A Roma, al contrario, da sempre luogo di commistioni e integrazione, di apertura etnica e sociale, gli schiavi, diversamente dai meteci, acquistavano con la libertà anche la cittadinanza, pronti ad adottare dai vicini (si pensi solo all’orgogliosa e discrepante affermazione degli ateniesi per cui nulla essi avevano da imparare, essendo solo «modelli») i migliori costumi e le migliori leggi. Con la sua saggezza ed esperienza (oltre che con la sua passione) Machiavelli riterrà del tutto improponibile, sotto ogni aspetto, il paragone tra il modo esemplare di fare «imperio» di Roma e quello «al tutto inutile» di Spartani e Ateniesi (II 4.11-12).