Dis-integrazione europea, dalla piramide alla rete
1. Terrorismo e nuovo slancio.
Dopo i recenti, drammatici fatti terroristici, si è visto qui e lì, un rinnovato slancio solidaristico nell’intesa fra popoli occidentali ed una maggiore solidarietà all’interno dei vari Stati europei. Ad esempio, mi risulta si sia offerto alla Francia qualche sforamento del patto di stabilità per spese legate alla sicurezza. Eppure, se è indubbio che questo costituisca un dato positivo, è altrettanto vero che tutto ciò è ben lontano dal rappresentare un rilancio dell’integrazione europea – e, del resto, nessuno è giunto a conclusioni tanto assurde. Non è, infatti, né sarà mai possibile fondare o consolidare un’unione sulla paura. Non deve essere necessario sentirsi aggrediti da qualcosa di esterno per percepire di far parte d’un ordine comune e nessun gruppo deve aver bisogno d’un nemico per nutrire amicizia al proprio interno.
2. Crisi.
Pertanto, riflettere sull’Unione europea – piuttosto che cantare le lodi a qualcosa di compiuto – comporta purtroppo la necessità di soffermarsi su un’integrazione chiaramente in crisi. La crisi economica scoppiata ufficialmente nel 2008, infatti, non è stata importante soltanto per sé, nella sua capacità cioè di abbattere sull’Occidente una sferzata tale da contrarre i consumi e determinare una significativa ristrutturazione sociologica delle classi sociali, insieme alle loro abitudini di vita. La crisi economica ha prodotto anche un altro effetto, non meno grave del precedente. Essa, cioè, più profondamente, ha fatto emergere le difficoltà politico-strutturali dell’Unione Europea. La stessa maniera in cui quest’ultima ha affrontato la crisi, inoltre, ha messo a nudo in maniera chiara la fragilità della sua struttura non soltanto istituzionale ma anche – parallelamente – simbolico-culturale. Infatti, ben difficilmente, a mio parere, la crisi di integrazione europea può esser fatta risalire a motivazioni esclusivamente finanziarie, legate alla crisi dell’euro o alla questione complessa del debito sovrano dei paesi più deboli all’interno dell’Unione – eclatante il caso della Grecia e del braccio di ferro fra AlexīsTsipras e le Istituzioni europee -, quanto piuttosto, e la faccenda è più seria, ad una crisi di coesione e di fiducia da parte dei cittadini, emersa in maniera abbastanza chiara – con l’unica eccezione forse del voto italiano – alle ultime consultazioni di voto europeo. Il dato più significativo emerso dalla crisi – ciò che non ha fatto altro che potenziare gli effetti negativi della crisi stessa – è stato l’incertezza legata alla maniera di tenere insieme le grandi capitali finanziarie europee con le cosiddette periferie. Un dato si è imposto con chiara evidenza: la distanza piuttosto grande fra paesi con abitudini culturali e capacità economiche decisamente importanti e paesi che invece arrancavano – anche perché soltanto recentemente affrancati da sistemi non completamente democratici, e con abitudini clientelari decisamente diffuse. Inoltre, dato anch’esso piuttosto sconfortante, è venuto al pettine il problema della maniera fortemente problematica – partendo dalle premesse dell’Unione europea – in cui le istituzioni europee dovessero trattare la relazione fra economia e solidarietà all’interno dell’Unione. Nei casi più eclatanti – come nella già ricordata crisi greca – si è arrivati ad un passo dalla fuoriuscita o espulsione di un paese (e, ovviamente, nel caso della Grecia la fuoriuscita avrebbe avuto un valore storico-simbolico altissimo) dai paesi dell’Unione stessa. Una delle risposte più significative alla crisi è stata la stesura di un trattato, nel marzo 2012, un cosiddetto fiscal compact che costituisce una versione più severa – anche perché accompagnato da un pacchetto legislativo che prevede severe misure punitive nei confronti dei paesi “inadempienti” – degli accordi precedenti. Il significato simbolico del fiscal compact, tuttavia, va ampiamente al di là della sua, pur rilevante, incidenza concreta. Esso infatti, nella percezione più diffusa, ha significato la segregazione degli stati più deboli inchiodati a manovre di bilancio improntate all’austerity e fortemente penalizzanti nei confronti di mansioni il cui pieno svolgimento era apparso imprescindibile per un normale vivere civile. Sono fioccati così tagli alle scuole, alle università, alla sanità, alle pensioni e agli stipendi pubblici e a tutto ciò che da diversi decenni seguiva l’onda lunga inaugurata dalle politiche espansionistiche del welfare state. Sul piano simbolico, inoltre, il fiscal compact ha dato un durissimo scossone alle sovranità nazionali soprattutto dei paesi più deboli, costretti a circoscrivere le decisioni politiche all’interno di un alveo di agibilità legislativa decisamente ristretto. Bastano allora forse questi brevi cenni per far maturare l’idea che la crisi dell’UE non sia destinata ad andare nella direzione di facili risoluzioni. La mia convinzione – peraltro piuttosto diffusa anche come sentire comune all’interno dei popoli dell’Unione – è che, per fondare organismi politici e portarli avanti, sia necessaria la condivisione non egocentrica da parte dei pochi e che certamente, inoltre, non bastino a tal fine le rigide regole dell’economia che guardano agli stati come “società di capitali”.
3. Ritorno agli Stati nazionali?
Una delle soluzioni alternative è quella che viene prospettata dai movimenti e partiti anti-europeisti, ossia la fuoriuscita dall’Unione europea. Io credo che non sia questa la strada da seguire. Se si pensa, infatti, alla conformazione attuale della geopolitica a livello globale, si comprende agevolmente che è impossibile – venendo da una delusione europeistica – ritornare alla politica delle sovranità nazionali integrali. In questo senso, non è immaginabile né auspicabile, a breve, un ritorno agli Stati Nazionali. All’interno di un mondo complesso, come quello connotato dalla globalizzazione, è fin troppo facile supporre che la “disintegrazione” dell’Unione Europea potrebbe provocare danni mortali a degli Stati che da soli poco sono in grado di opporre ai giganti presenti oggi in ambito globale e che promettono di essere ancora più numerosi e potenti domani. Tutto ciò, mi sembra impossibile sul piano storico e assolutamente sconsigliabile sul piano politico-economico. Sarebbe abbastanza autodistruttivo, infatti, in un mondo strutturato sulla sovranità politico-militare di paesi che costituiscono veri e propri continenti, ritornare a forme politiche vecchie di secoli. Io direi, perciò, che per uscire da una crisi – piuttosto che proporre soluzioni emotive, populistiche o particolaristiche – occorra invece anzitutto comprenderla nei suoi presupposti. Ed è proprio questa, temo, l’operazione più impegnativa, poiché mentre gli effetti della crisi sono sotto gli occhi di tutti, le sue cause sono spesso lontane e, ancora più spesso, appaiono enigmatiche.
4. La sovranità dell’economia.
Dopo la fine della lunga fase che convenzionalmente definiamo di “guerra fredda”, il reaganismo e il thatcherismo ci hanno catapultato in una stagione storico-politica che – è noto a tutti – definiamo neo-liberale. Ora, non è possibile risalire qui alle cause che hanno provocato l’avvento di questo genere di visione del mondo, tutto fondato sull’ipertrofia dell’individuo, fin all’individualismo più radicale, e sulla contrazione estrema della presenza e dell’importanza dello Stato, con la perdita consequenziale di significato di nozioni quali solidarietà e giustizia sociale. Ciò che conta, dal mio punto di vista, è sottolineare che l’Unione Europea così come noi la conosciamo si è sviluppata proprio all’interno di questo orizzonte culturale e non c’è dubbio che il contesto l’abbia seriamente condizionata se non addirittura integralmente strutturata. Si tratta, tuttavia, a mio parere, di un contesto piuttosto misero. Se guardiamo all’Europa contemporanea, infatti, l’Europa delle comodità borghesi, della tecnologia e della piccineria individualistica chiusa all’interno di gruppi escludenti, l’Europa che non va a votare e che si dichiara orgogliosamente estranea alla politica, si ha davvero la sensazione che, arrivando a questo punto, ci siamo persi per strada qualcosa di importante. Abbiamo smarrito tante virtù – diciamolo francamente – che erano tipiche dei nostri padri: la concretezza, il coraggio virile, il senso lucido ma volitivo della tragicità della vita, la capacità di affrontarne i disagi e di gioire per la bellezza che si accompagna all’etica civile e alla responsabilità verso se stessi e verso le istituzioni. Mi chiedo, pertanto, se non siano proprio questi (non)valori, portati oggi al punto di massima estensione pratica, a costituire il rischio maggiore (non soltanto) per l’Unione Europea. Temo inoltre che, in un tempo che si vorrebbe secolarizzato e libero da qualsiasi divinità, permanga invece, e con una forza che non ha precedente storico, un imperativo religioso che non trova alcun dissidente degno di essere considerato. La religiosità del contemporaneo rischia di costituire un nuovo monoteismo – ma non è quello del Dio medioevale cristiano, bensì quello triste e oligarchico del grande (e piccolo) capitale. Ed è proprio questa divinità che ha creato e crea condizioni di guerra e non di pace all’interno del mondo contemporaneo e che, venendo all’Unione Europea, ha contribuito fortemente a determinare la crisi dell’integrazione, rendendo peraltro più difficili le possibili soluzioni. Se questo è lo status questionis, io direi allora che occorra volgere lo sguardo altrove e cercare di cogliere almeno qualche indicazione generale per uscire dalle aporie che ci sono davanti.
5. Siamo davvero individualisti?
La scelta a me sembra, pertanto, fra un’Europa che considera se stessa come una molteplicità di stati sovrani isolati gli uni dagli altri, uniti soltanto dall’appetito compatto e monolitico di tipo finanziario, e un’Europa capace, invece, di rifondarsi sulla base di un nuovo inizio che, attenzione, non potrà che essere rinvenuto nel nostro passato e nelle nostre radici. Il passato, infatti, non è un serbatoio ma una fonte. Una fonte che dà vita ad un corso d’acqua storico che perviene fino a noi. Occorre dunque, anzitutto ricordarsi che quella fonte – sia nella sua origine greca, sia nella fondazione moderna della nostra civiltà – era connaturata all’idea di una incessante ricerca e da sentimenti di speranza, lontanissimi dall’immagine di una civiltà soddisfatta dell’assoluta “idiozia” dei propri desideri materiali. La nostra civiltà, inoltre, si è da sempre caratterizzata in virtù di una peculiarità decisiva. Essa, cioè, si è perennemente posta come una forma culturale “particolare” che ha in sé l’”universale”. Nel nostro Occidente, di conseguenza, non c’è nulla che non abbia avuto e non abbia la vocazione ad interessare – fin talvolta ad inglobarla in sé – qualsiasi realtà posta esteriormente. D’altro canto, è vero anche il contrario: non c’è alcuna realtà identitaria nel nostro mondo che non sia suscettibile d’essere frammentabile in diverse realtà antagonistiche. In altre parole, non riusciamo a concepire differenze che non trovino una chiave di lettura unitaria, proprio mentre qualsiasi posizionamento troverà certamente una forma decostruttiva capace di metterla in crisi. In fondo, ciò di cui stiamo parlando non è soltanto la matrice della prassi storica (e del divenire) ma è anche l’essenza stessa della libertà e della democrazia. La cultura occidentale è diventata la forma di vita più forte del pianeta non per il suo integralismo, oggi economicistico, ma per la sua libertà e – vorrei dire una parola molto forte – per la sua iconoclastia. È diventata forte, cioè, per la sua portata democratica e perfino “anarchica” – per la sua capacità di emancipare gli individui e di considerare tutti, a prescindere dal genere e dagli orientamenti religiosi, ugualmente preziosi per la comunità. Siamo figli dell’illuminismo – tutti – e l’illuminismo poneva la ragione e non una fede – laica o secolare che sia – a sostegno della politica. Siamo eredi di una cultura che trova la differenza nell’identità e l’identità nella differenza. Raccogliamo dunque noi tutti il testimone di una civiltà che è andata anche edificando nei secoli la convinzione che occorre dotare gli uomini e i gruppi politici di diritti personali inviolabili. Siamo una cultura pluralistica che scorge nell’altro quella “potenza” insopprimibile se si vuole creare un divenire storico pregno di produzione – di senso e di prodotti insieme. Dove il senso stesso non può fare a meno della materialità a cui si accompagna e dove la materialità è già di per sé nutrita di senso spirituale. In questo quadro, mi sembra allora necessario fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per emanciparci dal gretto provincialismo che sembra dettare legge ormai nelle egocentriche capitali (non solo) europee contemporanee. E lo dovremmo fare con la prudenza che sempre è richiesta quando le apparenze sembrano andare in direzione contraria, ma anche con la consapevolezza che la radice di ciò che oggi domina sul mondo è ancora ben strutturata nella pianta europea e che, se questo mondo non vuole inaridirsi fino alla distruzione, sarà destinato a ritornare inevitabilmente a nutrirsi nel terreno dal quale un giorno è germogliato. Del resto, mi sembra ovvio che non si possa soltanto fare affidamento su logiche di potenza economica. Se si vuole creare o consolidare un’identità politica, io credo, è assolutamente necessario indicare dei valori, un modo di vivere, una visione del mondo che valga la pena d’essere perseguita. E da questo punto di vista è proprio l’Europa io credo – entità che possiede da sempre una vocazione differenzialistica e universalistica insieme – che può offrire un contributo decisivo al mondo globalizzato. In questo senso, sono convinto che la politica, sia nazionale, sia internazionale, debba riprendere a praticare un valore come la lungimiranza. Senza la capacità di con-vergere su un fronte unico e guardando lontano, infatti, non c’è alcuna speranza di affrontare e vincere fenomeni che richiedono tutta la nostra attenzione e i nostri sforzi. Le politiche che, per inseguire il loro particolaristico interesse, mostrano una pervicace incapacità di guardare al domani e tengono conto soltanto della logica del consenso a breve termine sono viziate in partenza e gli effetti negativi non tarderanno a farsi sentire. È necessario perciò – ora più che mai – di pensare di nuovo ad una “grande politica” europea. E non c’è grande politica che non sia anche e soprattutto “lungimirante”.
6. Europa o America?
Un altro punto importante della mia riflessione fa riferimento direttamente alla nostra identità europea. Io penso che se volessimo creare un modello intorno al quale fondare una nuova “coesione” politico-culturale “continentale”, dovremmo smetterla di imitare le mode americane. Da numerosi decenni, ormai, non c’è costume americano – per non parlare dell’estensione pressoché generalizzata della lingua inglese – che non venga assunto ed applicato anche in Europa. Niente da dire: occorre sempre imparare dagli altri. Soprattutto da un popolo che può contare su una grande scienza, un’importante letteratura e un livello tecnologico di assoluta avanguardia. È il caso però di ricordare, io credo, che l’ansia di felicità – che in America è evidentissima – si basa su un eccesso di pragmatismo e di empirismo che, come tutti gli eccessi, non è condivisibile fino in fondo. E questo non soltanto per una questione – pure importante – di gusto. Sarebbe giusto, io credo, tenere conto del fatto che l’avversione tipicamente americana per le idee generali abbia contribuito a veicolare il mondo occidentale verso lo schiacciamento sul qui ed ora – uno schiacciamento al centro delle dimensioni storiche che ipertrofizza il presente e che, se non cancella, riduce fortemente il passato ed il futuro. In questo modo, tuttavia, l’umanità occidentale è andata via via decostruendo totalmente una visione della politica basata sugli “ideali”. Certo, esserci liberati dalle ideologie totalitarie, anche in Europa, soprattutto in Europa, è stato merito anche dell’America, ma questo non vuol dire che l’ideale in sé, che non è l’ideologia, debba essere cancellato – così come, purtroppo, vedo cancellata una concezione della politica davvero partecipata, all’interno di uno schema progettuale serio e capace di andare al di là della prossima campagna elettorale. Sulla distanza fra Europa e Stati Uniti ancora un altro punto. Se l’America è erede di lunghi secoli di multi-razzialità, va anche detto che il modello americano si basava comunque su un vettore culturale molto omogeneo che può essere identificato come un centauro con infinite braccia ma provvisto di un’unica testa mono-culturale. Inutile ricordare che tale testa era costituita dall’etnia WASP (White-Anglo-Saxon-Protestant). In vista delle pressanti necessità di integrazione culturale richieste dalla globalizzazione, mi chiedo pertanto se non possa essere maggiormente utile un modello quale quello europeo, da sempre differenzialistico, piuttosto che un modello americano tutto sommato “integralistico”. Se fosse vera quest’ipotesi, potremmo allora immaginare, un poco paradossalmente, l’Europa come il futuro dell’America.
7. Disintegrazione dal basso.
La crisi dell’Unione europea non è detto sia necessariamente una sciagura. Se la strada del ritorno agli Stati nazionali – come detto – non mi sembra praticabile, ciò non vuol dire che non vi siano altre possibilità. Per quanto mi riguarda, m’iscrivo all’interno di una koinè teorica che punta sulla ricostruzione di un contesto fortemente europeistico e tuttavia, questa volta, a partire non più da un centro verticale, collocato nelle grandi capitali europee, contrassegnate dalle frequenti derive anti-democratiche a cui siamo ormai abituati. L’Europa che verrà – io credo – dovrà essere orizzontale, democratica e partecipata. Piuttosto che costruita in maniera gerarchico-piramidale, essa dovrebbe avere pertanto la struttura di una fitta rete fatta di agenzie che si occupano di questioni concrete, collocate direttamente accanto ai cittadini, in maniera tale da ricevere dalle istituzioni sovranazionali soltanto indicazioni molto generali. In questa chiave, è chiaro che istituzioni come la Commissione europea o il Parlamento europeo dovrebbe andar via via perdendo il ruolo sovrano che, in qualche misura oggi detiene, per conservare soltanto funzioni non delegabili e che si tratta di andar progressivamente istituendo. Vorrei concludere, pertanto, il mio intervento con due citazioni da un autore che mi sembra collocato sulla mia medesima linea. È J. Zielonka che infatti scrive: “Una tale evoluzione non annuncia la fine dell’integrazione europea; in realtà, annuncia un rilancio dell’integrazione, ma in forma e con una portata diverse. Si abbraccerà la diversità e si ridurrà la struttura gerarchica. Si darà maggiore risalto alle associazioni funzionali di carattere volontario e si punterà meno sulla governance territoriale. Gli Stati non saranno più i principali motori dell’integrazione, anzi questo ruolo sarà svolto dalle città, dalle regioni e dalle ONG europee, sostenute o persino incalzate dalle imprese e dai cittadini. La struttura della governance europea non assomiglierà a una piramide, bensì a una «scatola di giunzione» con numerosi punti di intersezione e di interazione”[ref]J. Zielonka, Disintegrazione. Come salvare l’Europa dall’Unione Europea, Laterza, Roma-Bari 2015, pagg. 101-102.[/ref]. E ancora: “Un’Europa polifonica, priva di un centro forte, ma con una grande varietà di reti funzionali integrative, non avrà la possibilità di «corrompere» e punire gli attori recalcitranti, condurre negoziati segreti e manovrare le istituzioni internazionali. Questo rimarrà probabilmente appannaggio degli stati nazionali. Invece, un’Europa siffatta sarebbe particolarmente adatta a creare strutture istituzionali e stabilire regole di comportamento legittimo. Potrebbe agire da potenza modello e dimostrare ad altri attori che le norme europee possono funzionare per loro e offrire incentivi per promuoverne l’adozione”[ref]Idem, pag. 103.[/ref]. Inutile dire che, oltre ad essere un’indicazione teorica, quella di cui ho appena parlato, è per me anche e soprattutto un auspicio, consapevole delle grandi difficoltà che la sua realizzazione comporta.




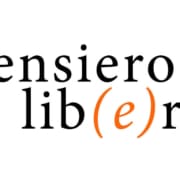



Il suo interessante intervento sul tema della dis-integrazione dell’Europa, ma ha fornito lo spunto per una riflessione (non compiuta) che mi permetto di segnalarle in estrema sintesi.
Il richiamo alle virtù tipiche dei nostri padri che lei afferma siano state perse e sostituite da non-valori e alla conseguente perdita di significato delle nozioni di solidarietà e giustizia sociale, mi ha rimandato classico contrasto tra virtù e commercio al centro delle discussioni politiche di fine ‘600 inizio ‘700, ed in particolare alla Favola delle Api di Mandeville.
E da qui, ai fisiocratici fino a giungere agli studi economici del Galiani e del Genovesi.
Così come siano eredi di una cultura illuminista, lo siamo anche di una cultura economica che fonda le proprie origini in un contesto illuminista.
L’economia, come scienza, nasce in ambito europeo. Quando il Genovesi e il Galiani scrivono non esisteva l’Europa e non esisteva l’Italia. Ma strettissimi erano i legami culturali tra il Regno di Napoli e la Francia e l’Inghilterra.
La critica, pur condivisibile, all’Europa del mercato e della finanza come ora la conosciamo, non può a mio avviso, prescindere dalla ricostruzione storica anche del pensiero economico.
Elena Campana