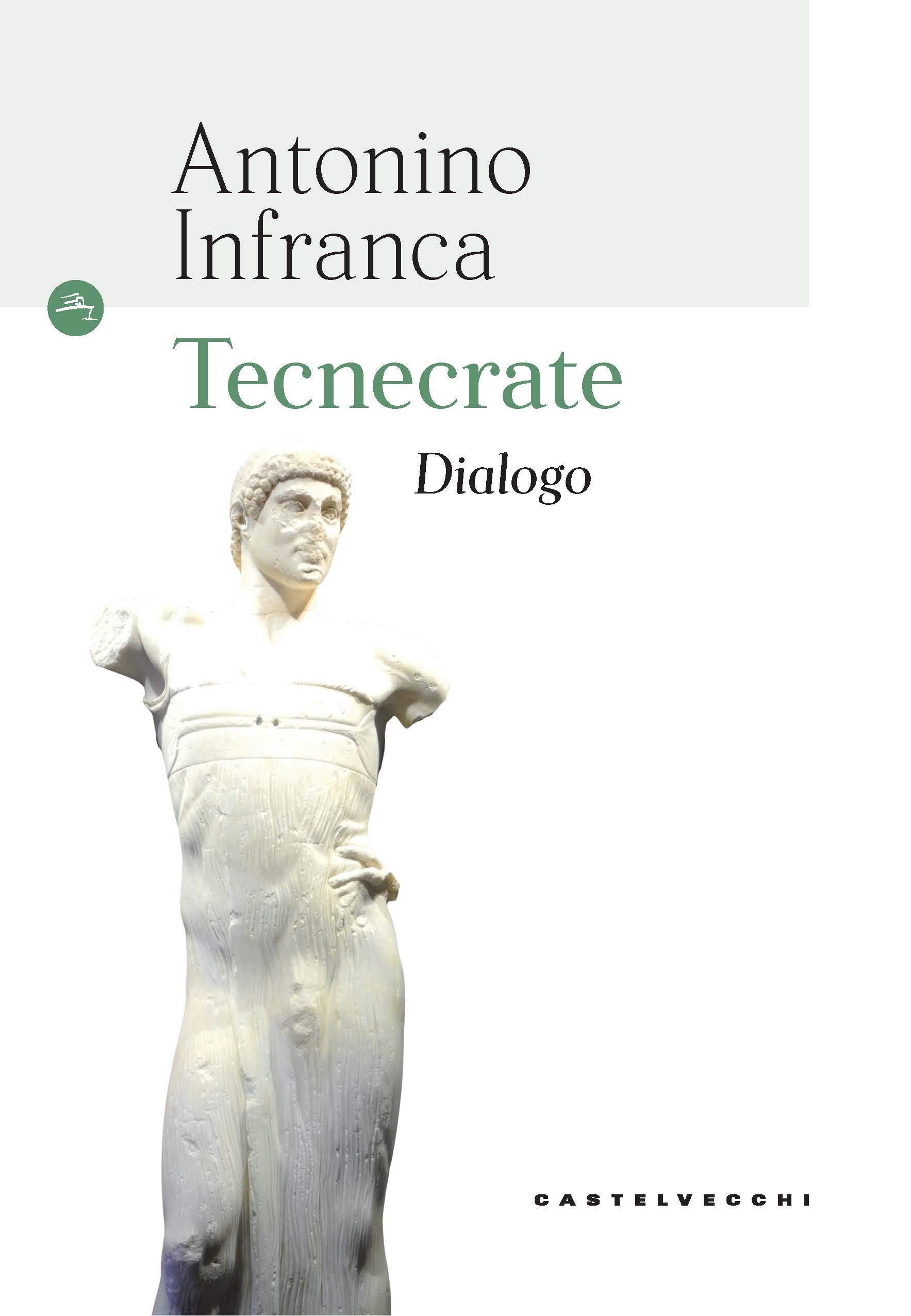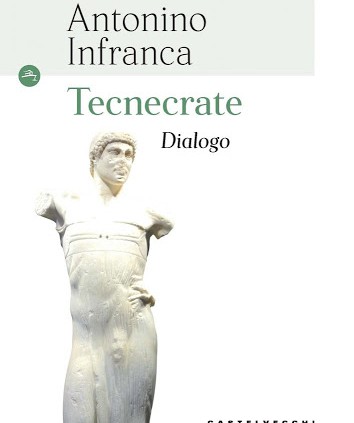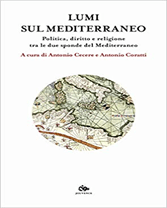di Miriam Borgia
È ancora utile e corretto utilizzare in filosofia politica le categorie della “modernità”? Quali sono le insidie della parola “laicità” nel dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo? Quali sono i paradossi dell’universalità dei diritti umani? E, infine, è ancora giusto difendere i diritti umani intervenendo in caso vengano violati?
Bruno Montanari alla prima domanda risponde che i concetti di “cittadinanza”, “sovranità”, “individuo” e lo stesso concetto di “uguaglianza” sono ormai insufficienti per affrontare le sfide attuali e, in continuità con il saggio di Fathi Triki, ritiene che la sfida sia incentrata sulla categoria “vivere insieme con dignità”: «per un’effettiva tutela dell’umanità dalla violenza, dal disastro ecologico e dalla miseria”, e d’altra parte, “delle diversità culturali su grande e piccola scala […] il termine uguaglianza è divenuto teoreticamente insufficiente». All’ “uguaglianza” va sostituita la “parità”, all’ “individuo” l’ “uomo”: la sfida allora si gioca sul terreno dell’esistenziale, con una collocazione planetaria, universale, ontologica. La politica, essendo ormai internazionale e mondiale, ha mostrato come siano insufficienti anche le categorie di “Stato” e “Nazione”; la spinta verso l’universalismo richiede categorie trans-epocali come “uomo”, traducibile in qualunque lingua, al contrario di “individuo” che è un’invenzione della modernità occidentale. La caratteristica imprescindibile di ogni uomo è quella di essere posto nel mondo, originato, ed è un dato puramente ontologico perché comune a tutti; da tale dato “ontico” deriva la parità ontologica, poiché tutti cadiamo sotto la categoria “uomo” inevitabilmente e simultaneamente e in ciò siamo pari. Facendo ciò si trascende – non si annulla – ogni differenza, mentre nella nozione di “cittadinanza” sono contenute anche le formule inclusione-in/esclusione-da. Terra, non Stato/Nazione, uomo, non cittadino. Ho accennato al carattere trans-epocale di questi concetti: J. J. Rousseau, spiega Montanari, si differenzia da Hobbes, Locke e Montesquieu perché recupera la dimensione ontologica dell’uomo (sul noto commento di Rousseau a Hobbes “parlavano dell’uomo selvaggio e dipingevano l’uomo civile” la questione è complessa: secondo l’analisi di N. Bobbio, anche Hobbes avrebbe pensato lo stato di natura senza una determinata collocazione storico-geografica, ma soltanto come un’ipotesi argomentativa su cui basare la sua riflessione sul contratto e sullo stato civile). Allo stato di natura si può solo alludere, poiché la condizione di essere-gettato dell’uomo, la sua prospettiva finita e limitata determina, appunto, un limes (Montanari ne sottolinea l’analogia con il noumeno kantiano), ma proprio ponendo lo stato di natura dalla prospettiva fenomenica dell’uomo si afferma tale prospettiva, scoprendola come l’essenza dell’uomo. Per Rousseau il problema è esistenziale: all’être essenziale dell’uomo si sovrappone il paraître della società civile, e l’uomo diventa individuo. Posto che il punto di partenza sia la parità ontologica e l’obiettivo il “vivere insieme con dignità”, il rapporto con l’altro deve basarsi sul rispetto: considerando che l’ipotesi di un Io assoluto sia controfattuale (se l’Io è assoluto ed è anche universale, ne deriva che ogni singolo Io sia assoluto, ma la pluralità di Io assoluti elimina il carattere assoluto di ciascuno), il riconoscimento dell’Altro non è un dovere etico – se fosse un dovere sarebbe possibile violarlo – ma è un dato auto-evidente, perché “negando il Tu, cioè l’Io dell’altro, si negherebbe al tempo stesso la possibilità del mio Io di essere un Tu per l’Io dell’altro”. La costruzione dell’intersoggettività a partire dalla soggettività è rappresentata proprio dalla filosofia kantiana: attraverso la ragione, la grande ratio dei Lumi, comune ad ogni uomo, ci si scopre in-relazione-a e si trascendono i limiti dell’esperienza sensibile entrando nel mondo della libertà. La libertà non può derivare da nient’altro che dal reciproco riconoscimento della parità ontologica ed è evidente, dunque, come rileggere Kant sia oggi, una forma di resistenza contro certi “sovranismi” che, al contrario di quanto propone Montanari, riaffermano le categorie di Nazione, Stato, identità nazionale e culturale, dimenticando che, per dirla con François Jullien, “l’identità culturale non esiste” e che prima del cittadino viene l’uomo.
Tuttavia, pur riconoscendo una parità ontologica, quindi fondamentale, universale, imprescindibile e che trascende ogni differenza tra popoli e tra individui, calandosi nelle singole realtà culturali emergono importanti incomprensioni che derivano da alcune ambiguità linguistiche. Ne tratta Paolo Quintilia proposito del termine “laicità”, il quale è il motivo della difficoltà del dialogo tra la cultura europea figlia dei Lumi e quella islamica. Occorre sottolineare, tuttavia, come ogni dialogo contenga strutturalmente delle difficoltà poiché l’Altro, fortunatamente, ci è sempre “altro” in qualcosa; il fatto che non si possa dare dialogo senza diversità, e che parimenti ogni di-versità di-verge sempre da qualcosa, ci dimostra come il dialogo non sia uno sforzo inutile e la difficoltà, che gli è appunto intrinseca, non deve spaventare. Occorre inoltre ricordare come le tre religioni del Libro si siano definite proprio grazie al dialogo reciproco a partire dall’età medievale, poiché difendere il proprio credo significava studiarlo, approfondirlo, cercarne giustificazioni, rafforzarlo. Dialogare con lo straniero non costituisce uno smarrimento della propria identità – nazionale, culturale, religiosa – ma, ed a qualcuno può apparire paradossale, un’occasione di rafforzamento della stessa. Nella riflessione di Quintili, il problema del termine “laicità” si incrocia con la storia dei diritti umani: la sostanziale differenza tra il significato che il termine assume nell’attuale Europa e nel Maghreb è il riferimento alla terza sfera di cui parla Michel Foucault, ovvero quella “priveé et personelle”, dove l’individuo deve essere libero. È nel 1791 che emerge l’importanza di questa sfera, quando i cittadini francesi di confessione ebraica vennero dichiarati liberi ed uguali, con la conseguente perdita di tutto ciò che li aveva resi finora una minoranza organizzata; nel 1794 viene anche abolita la schiavitù nelle colonie francesi; nel 1790 si era già costituita una Chiesa nazionale che s’impegnava ad essere fedele alla Costituzione e nel decreto del 92 lo Stato era stato laicizzato. Nel1795 vi è il Decreto sulla libertà di culto, ed ecco consolidarsi la sfera privata, dove si gioca tutta la posta politica del “vivre ensemble”. Le difficoltà, i paradossi, nascono quando alle istanze di uguaglianza e libertà si preferisce l’appartenenza comunitaria consolidata da una lunga tradizione religiosa e ne è prova il disaccordo sorto tra alcuni cittadini francesi ebrei proprio nel 1791. Non tutti erano d’accordo nel riconoscersi uguali agli altri, liberi come gli altri. La questione è evidente: come è possibile dialogare sulla “laicità”, la quale ha come premessa la considerazione della sfera privata e personale, con una cultura che non riconosce tale sfera? Gli stati islamici, tornando al Maghreb, semplicemente non capiscono il riferimento all’intimità: se noi europei oggi riconosciamo uno spazio al sacro fuori dal politico e fuori dall’ecclesiastico, che è appunto quello privato, e così definiamo i nostri Paesi “laici”, in lingua araba “eilmania”, cioè laicità, è pressocché sinonimo di ateismo, miscredenza, irreligiosità dunque lontananza dallo Stato. Secondo Quintili si tratta di spiegare la semantica del termine, ma allora sorge un’altra domanda: è legittimo pretendere un senso comune laico pressocché universalmente?
Stefano Petrucciani si concentra proprio sui rischi, le difficoltà e i paradossi di tale universalismo, collegandosi alla riflessione di Quintili. In nome della democrazia, contro la dittatura ed in difesa dei diritti umani si sono perpetrate “guerre giuste” e “interventi umani” – come analizza approfonditamente anche F. Triki -. Per Kant, condizione della pace perpetua tra popoli è adottare una costituzione repubblicana (laddove repubblicana, per Kant, può essere anche una monarchia, purché le leggi vengano fatte dal monarca come se derivassero dalla volontà generale); per Rawls, esponente del liberalismo progressista, è sufficiente che si rispettino degli standard di “decenza”, tra cui non aggredire altri popoli, possedere un sistema giuridico accettabile e rispettare i cosiddetti diritti umani. Le violazioni di quest’ultimi, per Rawls, legittimano l’ingerenza a farle cessare, provvedimenti punitivi (commerciali e finanziari), in una parola l’”ingerenza umanitaria”. Ma allora si auspica un ritorno a pratiche neocoloniali -oltre che imperialistiche-? Già Hobbes individuava tra i rapporti internazionali un ennesimo stato di natura, un campo di bellum omnium contra omnes, perché manca un giudice super partes e imparziale. Ma «di fronte all’umanità calpestata non si può voltare la testa dall’altra parte, aspettando che ci siano le giuste istituzioni internazionali», commenta Petrucciani, e «questo pessimo uso dei principi universalisti non è una buona ragione per rinunciare ad essi». Per dirla con Churchill, «la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le forme che si sono sperimentate finora».