Thomas More-Utopia
Paolo Quintili e Roberto Mordacci su Utopia di Thomas More

Paolo Quintili e Roberto Mordacci su Utopia di Thomas More
Cosa si intende per “diritto di resistenza”? Quali sono la sua origine e la sua attualità? Francisco Suarez pone per primo il tema di una disobbedienza orientata secundum principia iuris, avviando un discorso sulle possibilità del diritto di resistenza e la conseguente irrogabilità delle pene.
Discutono con l’autore Antonio Cecere e Antonio Coratti
Presentazione del libro “La democrazia divenuta problema – Città cittadini e governo nelle pratiche del nostro tempo” di Alessandro Corbino Intervengono: Bruno Montanari, Antonio Ruggeri, Angelo Costanzo, Alessio Lo Giudice, Giorgio Fazio, Antonio Cecere
di Barbara Petrone
Il buio di queste giornate ci consegna una realtà dinnanzi alla quale ciascuno di noi si trova profondamente impreparato: la compressione di alcune libertà fondamentali, seppur giustificata da motivi di sanità e sicurezza, – costituzionalmente idonei a limitare la libera circolazione dei cittadini (art.16) – pare oggi un sacrificio spropositato alla maggior parte dei suoi destinatari.
La quasi incontrollata diffusione del nuovo COVID-19 sorprende chi parlava di “semplice influenza”, paralizza i più anziani, gli immunodepressi e, infine, mobilita chi vive ogni giorno privato della libertà personale: le fiamme sul carcere di San Vittore sono il simbolo di un mondo sommerso che disperatamente si aggrappa alla rivolta, per non essere cancellato. Se le prime reazioni hanno avuto ad oggetto le misure adottate per prevenire la diffusione del contagio tra le mura circondariali (interruzione dei colloqui con l’esterno), i successivi – e in alcuni casi drammatici – sviluppi hanno riacceso la luce su un tema a lungo insabbiato. Il sovraffollamento degli istituti di pena italiani è da anni il cancro di una società civile sempre più innamorata del giustizialismo di narrazione mediatica e sempre più ansiosa di ingannare le emergenze – reali o fittizie – con nuove pene, nuovi processi, nuovi imputati. Non si tratta di slogan radicali, ma di una situazione di concreto pericolo per quell’umanità già costretta a pagare i propri sbagli con il prezzo altissimo dell’inadeguatezza del nostro sistema penitenziario. Lo stesso presidente dell’Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, avverte che: “Siamo di fronte al rischio di un’epidemia esplosiva, a un 130 per cento di sovrappopolazione carceraria di media. Significa che ci sono istituti penitenziari che hanno una sovrappopolazione del 150-160 per cento, e non ci sono strumenti sanitari adeguati interni alle carceri. E allora, rispetto ad un’epidemia occorre capire come prevenire l’esplosione di una bomba atomica sanitaria che ricadrebbe sull’intera comunità.”
E’ così che lo stato emergenziale dichiara guerra alle politiche del passato: da un lato si pagano le spese di una sanità pubblica violentata per anni, mentre dall’altro si cerca di capire perché, malgrado la sentenza Torreggiani, la sensibilità politica del nostro Paese non sia arrivata ad una rottura drastica rispetto ai “trattamenti inumani e degradanti”, di cui i nostri istituti di pena sono palcoscenico.
La lettura del libro di Colombo sembra, a questo punto, la chiave perfetta per non trascinarsi senza senso nel mondo chiuso delle nostre case e non distrarsi troppo da ciò che accade altrove. Il “Perdono responsabile” è qui assunto a simulacro di una cultura possibile, in grado di rimettere in discussione l’immaginario della retribuzione, ove la sanzione risponde alla devianza senza tuttavia proporsi di correggerla. E’ la cultura della riparazione, che, allontanandosi dal polo unico della proporzionalità tra reato e pena, si sviluppa più complessamente attorno all’idea di una “giustizia senza spada”. Quest’ultima offre al reo la possibilità di “ricucire” la frattura che le sue azioni hanno cagionato alle relazioni sociali, e lo fa attraverso un coinvolgimento attivo della persona offesa.
“Perché il carcere non serve a nulla” è un sottotitolo inequivocabile, che non lascia interrogativi tra parentesi e, al più, consegna alle pagine successive il compito – certo ostico, tanto più per un ex magistrato – di spiegare contraddizioni, storture e fallimenti veri e propri della pena detentiva. Un’indubbia provocazione, lanciata nel tentativo di ricondurre la dignità umana al centro della speculazione sulla giustizia.
Se dal punto di vista etico questa sensibilità incontra un pubblico ristretto, dal punto di vista linguistico, il pregio è quello di una fruibilità volutamente ampia: è attraverso una scrittura asciutta, spogliata di ogni infiorettatura, che queste pagine propongono una visione decisamente rivoluzionaria della pena e della responsabilità che il perdono esige, da parte di tutti i suoi interlocutori.
Passando attraverso le letture di Von Spee, Locke e Beccaria, Colombo analizza le tappe di un percorso giuridico che, per espungere dall’orizzonte metodologico torture e supplizi, ha dovuto attendere il pieno affrancamento dei concetti di “reato” e “peccato”. E neppure la sofferta affermazione dell’individuo “come dignità, e perciò come autonomo e originario portatore di diritti intangibili” (pag. 40) – epilogo delle tragedie umanitarie consumatesi nel corso delle guerre mondiali- era servita a stralciare la retribuzione, retaggio di una cultura incompatibile con la “nuova” funzione rieducativa della pena. Una funzione formalmente esistente, ma sostanzialmente tradita dall’impietosa realtà delle carceri.
L’ultima pagina lascia con sé la consapevolezza che il perdono esige non solo mezzi efficienti, ma anche recettori predisposti a compiere un gesto così laicamente rivoluzionario. Ma, in una società sorda persino al principio di civiltà giuridica insito nella prescrizione, quale speranza rimane a chi sta già scontando la propria pena? Siamo già troppo coinvolti da questo clima di disconoscimento dell’altro, o possiamo ancora tornare indietro?
“Si era alla fine percepito che tali terribili eventi erano dipesi da un generale disconoscimento dell’altro: non si può fare la guerra se ci si riconosce nello straniero; non si possono uccidere programmaticamente ebrei, zingari, disabili, omosessuali e avversari se non li si considera dissimili in radice, se non si disconosce loro di far parte dello stesso genere umano nel quale ci si identifica; non si può sganciare una bomba atomica su una popolosa città se prima non si disumanizzano i suoi abitanti.” (Pag. 40)
Abbiamo davvero bisogno di nuove tragedie, prima di essere pronti a perdonare responsabilmente? Certo, è lecito augurarsi che la sensibilità rieducativa abbracci ognuno di noi, quando riabbracciarsi sarà possibile, perché questa parentesi storica possa servire a non ripetere gli errori politici, economici ed umanitari del passato.
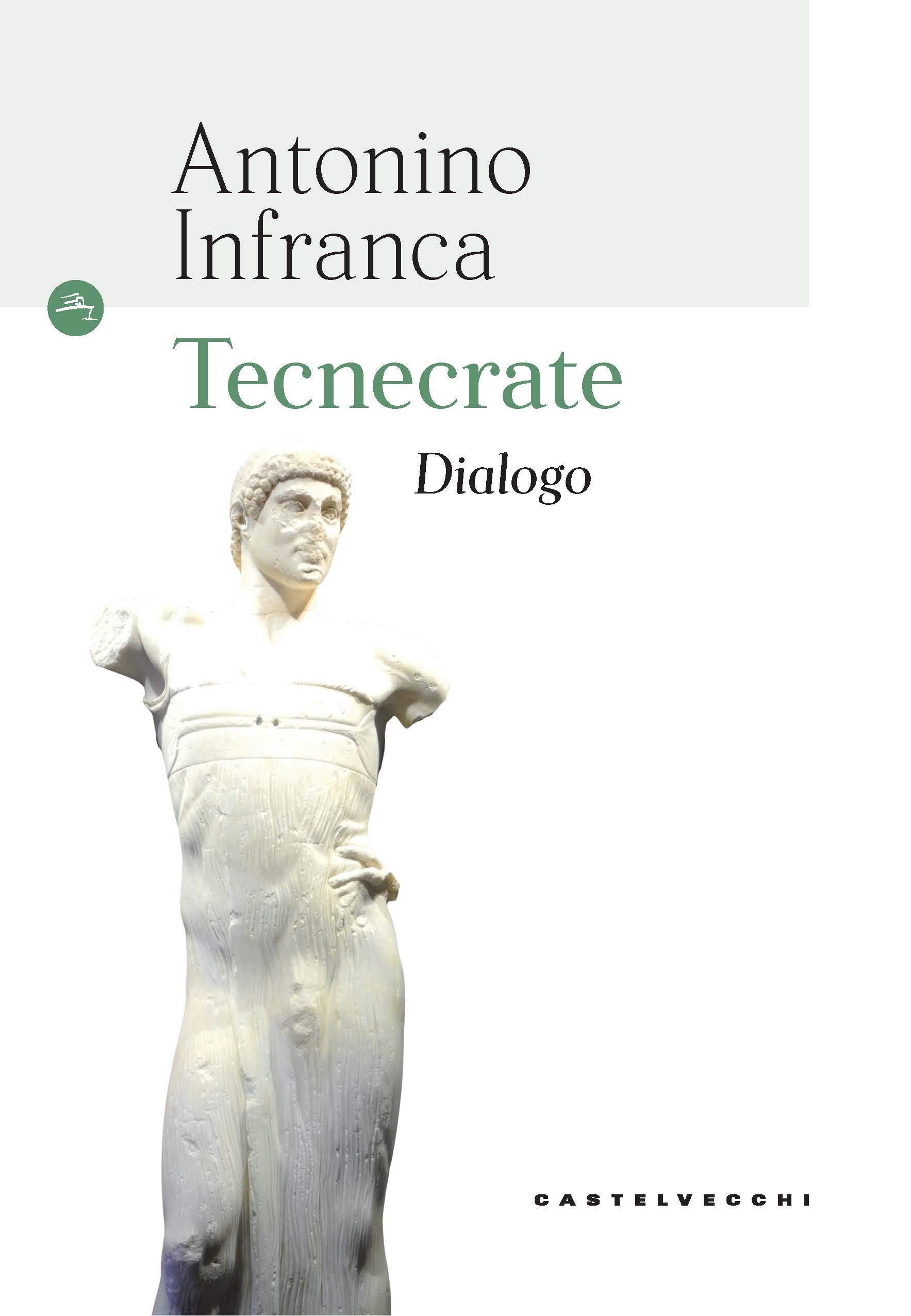
di Francesca Giammei
Siracusa, IV secolo a. C.
Ma anche qui e ora. O da qualche parte nel futuro.
Tecnecrate di Antonino Infranca (Castelvecchi, 2019) è la storia di un dialogo: Theoutimene (“ciò che rimane di Dio”), figlia del tiranno Dionigi, interroga e ascolta Tecnecrate (in greco “potere dell’arte”), vecchio mendicante cieco, desiderosa di conoscere la storia della sua vita (e però – scopriremo – della vita di entrambi): fenicio per nascita, greco per scelta, offende e si inimica gli dèi di ambedue le culture; si punisce togliendosi la vista al cospetto proprio del tiranno Dionigi, ma è così che diventa – e forse solo così che può – ciò che è e che vuole essere, ormai libero anche dal suo tragico destino, ribelle e rivoluzionario, con grazia e calma e in un’immobilità soltanto apparente.
Quanto tempo occorre per raccontare una vita tanto piena? E per quanto i due si intrattengono a parlare? Il tempo del racconto si fa via via quasi incomprensibile e si dilata avvolgendo il lettore nella dimensione e nel ritmo della storia: è un libro che si fa leggere più di una volta, prima tutto d’un fiato fino ad arrivare alla preziosa postfazione dell’autore stesso, e poi ripartire di nuovo da lì per cogliere le sfumature perse, oppure un po’ alla volta come è stato scritto e poi ancora a pagine sparse, non più per comprendere ma per sentirsi compresi.
L’opera – a metà tra la saggistica e la narrativa – consegna le chiavi di accesso ai tanti argomenti trattati come un buon saggio e però anche lascia i dubbi tipici di una riuscita narrazione: Tecnecrate è davvero anche il Tecnecrate che ci è sembrato di (ri)conoscere? Quando si incomincia o si finisce di essere Theoutimene? È possibile sentirsi entrambi? Le allegorie e le metafore sono tutte opera dall’autore o a tratti alcune sempre diverse di chi legge?
Tecnecrate è un libro che educa all’attesa, alla comprensione e – attraverso la cecità di lui – alla realizzazione e al superamento della nostra: è una climax ascendente verso l’emozione, la commozione e la sensibilità dell’autore, che maturano e si svelano insieme alla lettura e ai personaggi. Così, ad esempio, Tecnecrate non nasce omosessuale dalla penna dello scrittore né lo diventa per sua volontà, ma con naturalezza rivela la sua natura, attraversando le categorizzazioni e le tradizioni che lo costringono per la necessità di liberarsene, arrivando ad essere insieme maschile e femminile o nessuno dei due o essere e basta. Allo stesso modo Theoutimene compie la sua missione di personaggio e di persona, raggiunge la sua consapevolezza e fierezza di donna, e chiude il racconto adempiendo a sé stessa e mescolandosi con Tecnecrate come con la di lui terra natia prima di morire. In noi forse dunque insieme è, può essere o deve l’uomo e la donna, l’umano e il divino; in noi è il “potere dell’arte” e allo stesso tempo siamo però tutto “ciò che rimane di Dio”. E “custodi della bellezza”, in un’epoca storica che, pagina dopo pagina, fatichiamo a identificare come successiva o precedente a quel IV secolo a.C., e da quella piazza di Siracusa, vicini o lontani.
“- È giusto. Vado. Ma rispondi, Tecnecrate, a un’ultima domanda: perché secondo te, che sei stato spesso al centro del pensiero divino, gli dèi hanno scelto proprio me per conservare e tramandare la tua storia?
– Perché sei una donna, la lingua negata dagli dèi e dagli uomini. Tu, dunque, sei il greco e il fenicio e ogni altro idioma del mondo.”