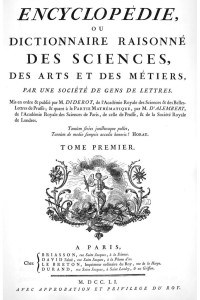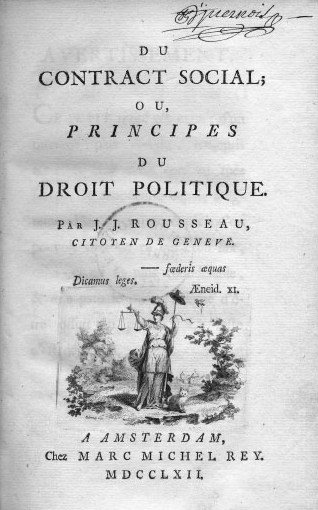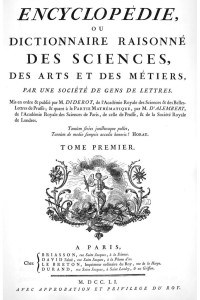 Pur condividendo il giudizio di Judith Shklar che considera Rousseau l’artefice della fortuna dell’espressione ‘volontà generale’ [ref]Judith N.Shklar, General will, in dictionary of the history of ideas a cura di Philip P.Wiener(New York, Charles Scribner’s Sons,1973) vol .2 pag 275.[/ref]ritengo però sia necessario tenere presente i debiti culturali e teoretici che il nostro filosofo contrasse con il dibattito filosofico in atto nel proprio tempo e nel proprio ambiente. Questa necessità mi pare chiara e doverosa proprio in virtù del modo attraverso cui lo stesso filosofo ginevrino mosse la propria riflessione a partire dal sistematico tentativo di confutare l’articolo di Diderot “Droit naturel” del 1755 , pubblicato sull’Enciclopedia, nel secondo capitolo del “ manoscritto di Ginevra”.
Pur condividendo il giudizio di Judith Shklar che considera Rousseau l’artefice della fortuna dell’espressione ‘volontà generale’ [ref]Judith N.Shklar, General will, in dictionary of the history of ideas a cura di Philip P.Wiener(New York, Charles Scribner’s Sons,1973) vol .2 pag 275.[/ref]ritengo però sia necessario tenere presente i debiti culturali e teoretici che il nostro filosofo contrasse con il dibattito filosofico in atto nel proprio tempo e nel proprio ambiente. Questa necessità mi pare chiara e doverosa proprio in virtù del modo attraverso cui lo stesso filosofo ginevrino mosse la propria riflessione a partire dal sistematico tentativo di confutare l’articolo di Diderot “Droit naturel” del 1755 , pubblicato sull’Enciclopedia, nel secondo capitolo del “ manoscritto di Ginevra”.
In questo capitolo, intitolato ‘della società generale del genere umano’ [ref]Si fa riferimento alla edizione a cura e con note di Maria Garin ed.Laterza 1994 “Rousseau scritti politici” volume 2 .[/ref], Rousseau riporta a scopo di confutarle, ben quattro proposizioni del suddetto articolo di Diderot. Sin dall’episodio di Vincennes, il rapporto di amicizia e il confronto intellettuale fra Rousseau e Diderot, ci dà l’idea del clima che nella Francia dell’enciclopedia si andava respirando.
Cap I: l’Encyclopédie[ref]“ L’Encyclopedie ou dictionnaire raisonnè des sciences , des arts et des metiers » titolo originale che noi rileggiamo nella traduzione e a cura di Paolo Casini ed.Laterza 2003.[/ref] di Diderot e d’Alembert come paradigma della modernità.
L’importanza di quest’opera non si misura nei ventotto volumi con 72000 voci, 2500 tavole redatte dai 160 collaboratori che Diderot scelse per le diverse materie fra gli intellettuali più diversi e ai quali lasciò completa libertà di espressione. Non si misura neanche nei 25000 abbonati e nel pubblico variegato fra cui borghesi di vari paesi europei. L’importanza di questa opera è da misurarsi entro il significato espresso dall’unione di uno studio sulle arti e sui mestieri a riflessioni sulla morale, sulla politica e sulle più alte questioni filosofiche. Tale significato coglieva in un opera a più voci la complessità del passaggio dal modello del filosofo o sapiente appartenente a determinate confessioni o stati a quella del filosofo militante che apparteneva a uno spazio europeo della cultura e della comunicazione letteraria, una sorta di “repubblica delle lettere”.
Laddove, come notò magistralmente Franco Venturi in “utopia e riforme nell’illuminismo”, il repubblicanesimo politico era ormai tramontato nelle istituzioni dei vari stati europei, grazie a questo esperimento culturale, l’etica e la morale repubblicana fondavano il cosmopolitismo e si ponevano come collante ideale per la nascente cultura riformatrice del vecchio continente.
Il ruolo essenziale che questi filosofi attribuiscono alle scienze e alle arti come motore del progresso dell’uomo, la predisposizione che il movimento tutto mostrava per la comunicazione internazionale, l’humus materialistico e razionalistico su cui basavano gran parte delle riflessioni sui disparati temi, rappresentano lo spirito di un tempo, il volto di un epoca.
Per capire quanto questa complessità fosse voluta e ricercata dai nostri autori e redattori, accennerò brevemente al famoso “discorso preliminare” di d’Alembert che proprio nella frase iniziale annuncia che: ”l’Enciclopedia, come suona il titolo, è opera di una società di scrittori”.
Unire le diverse esperienze e competenze per costruire dal basso l’edificio del sapere umano era entrato ormai nel vivo del dibattito culturale e l’enciclopedia doveva sancire la supremazia della filosofia che indagava la natura con i sensi e la ragione.
Questi assunti facevano emergere un sapere slegato da ogni dogma religioso, lontano da ogni dipendenza diretta dalle rivelazioni divine, eppure questo aspetto resta in secondo piano rispetto alle sottolineature sempre più marcate circa l’utilità che questo sistema culturale recava allo sviluppo e la crescita del genere umano.
Una filosofia empirista e proto-positivista faceva da sfondo a una riflessione sul metodo sperimentale e contestualmente venivano citati una pluralità di debiti teorici a una serie di padri nobili della filosofia occidentale. Tali riferimenti apparivano però sommari e tradivano da una parte una certa incoerenza nel discorso globale, da un’ altra ci danno la possibilità di gettare uno sguardo sulla complessità della sfida che gli enciclopedisti lanciavano al proprio tempo.
Nel “prospectus” Diderot pone in rilievo la volontà degli editori di porre in essere il grande progetto baconiano di fondere in un sol corpo le scienze, le arti e le tecnologie al fine di mostrare quali fossero gli strumenti della perfettibilità dell’uomo.
Le grandi polemiche e le contestazioni che questo passo di Diderot suscitò ci permettono un’ulteriore misurazione della centralità di questa opera nel dibattito intellettuale della metà del settecento.
Il prospectus uscì appena dopo il primo discorso di Rousseau e noi sappiamo quanto fu lo stesso Diderot a consigliare le linee guida del saggio del filosofo ginevrino.
Il punto in cui noi possiamo muovere un confronto serrato fra i due amici filosofi è nell’articolo “Diritto naturale” di Diderot che troviamo criticato da Rousseau nel manoscritto di Ginevra. In questo articolo Diderot espone i principi di un contrattualismo e giusnaturalismo laico, basandosi su una rilettura di Barberyac del famoso trattato di Pufendorf “De jure naturae et gentium” [ref]Secondo le indicazioni di R.Hubert così come riportato sul testo sopracitato di P.Casini.[/ref]; in questo passo il nostro editore contrappone al modello hobbesiano di uno stato di natura del modello del “bellum omnium contra omnes”, la teoria del diritto naturale di stampo giusnaturalistico con accenti a volte materialistici.
È in questa cornice che Diderot formula il concetto di Volontà Generale.
Nell’articolo che stiamo analizzando Diderot utilizza una proposizione in una forma solo apparentemente ipotetica sulla falsa sensazione di libertà che l’uomo avverte quando crede di essere lui a volere le cose che pensa e che sente.
Il determinismo che qui appare ancora non dichiarato apertamente è strumentale alla tesi che ogni nostra azione sia guidata dalla nostra natura che esula da “alcunché di materiale estraneo alla sua anima, la sua scelta non è l’atto puro di una sostanza incorporea”.
Per spiegare la propria posizione mette in contrasto il “raisonneur violent” di stampo hobbesiano e l’uomo di natura che ascolta il proprio lume razionale. La capacità di analisi razionale è patrimonio sia del buono che del cattivo, e ci fa vedere come in ogni azione umana, il singolo, può anche preferire sempre di seguire il proprio piacere personale a discapito di tutto il resto dell’umanità, ma non può non riflettere sulla propria condizione al contrario di quello che accade alle bestie che agiscono per necessità senza riflessione.
Grazie a questo raffronto il nostro autore afferma che l’uomo ha sempre la possibilità di scoprire in se stesso la verità, ovvero la strada razionale per agire in conformità della ragione nel rispetto dell’agire di ogni altro uomo.
“Non sono tanto ingiusto da esigere da un altro un sacrificio che non voglio fare per lui”.
Il salto teorico avviene proprio qui allorquando Diderot ci fa vedere che un uomo nella propria individualità può essere sia buono che cattivo quando deve compiere una scelta per se stesso, mentre si accorda facilmente con ogni altro quando si tratta di pensare la società generale del genere umano: la volontà del singolo è sempre sospetta, la volontà generale è sempre retta.
Alla volontà generale si deve rivolgere il singolo per comprendere ciò che è giusto o sbagliato per se, per comprendere i propri doveri di uomo, padre figlio e cittadino.
Ogni volta che ci si riferisce alla volontà generale, ogni pensiero che si accorda con essa, partecipa interamente all’interesse generale e comune.
Secondo Diderot l’uomo può trovare entro se stesso quella legge sublime che è la Volontà Generale quando fa tacere quella ferina volontà di opprimere il prossimo e al contrario ricerca l’accordo con una volontà che voglia l’interesse generale.
“Sono un uomo e non possiedo altri diritti naturali realmente inalienabili che quelli dell’umanità “.
Ma dove sta questa Volontà generale? Dove la troviamo?
“Nei principi scritti del diritto di tutte le nazioni civili; negli atti sociali dei popoli selvaggi e barbari” ; nelle tacite convenzioni strette dai nemici del genere umano ed anche nell’indignazione e nel risentimento due passioni che la natura pare aver dato perfino agli animali per sopperire alla mancanza di leggi sociali e di vendetta pubblica”[ref]Tutti i virgolettati di questo passaggio si riferiscono all’articolo Diritto Naturale di Diderot nella già citata edizione a cura di P.Casini.[/ref].
Dopo questa serrata dissertazione, il quadro che Diderot ha composto lo porta a concludere che l’individuo che ascolta solo il proprio interesse personale è un nemico del genere umano; che la Volontà generale, presente in ogni individuo, è un atto puro dell’intelletto che ragiona nel silenzio delle passioni, su ciò che l’uomo può pretendere dal suo simile e su ciò che il suo simile ha diritto a pretendere da lui; che questa considerazione sulla volontà generale è la regola aurea della condotta degli uomini nella società e nel rapporto simmetrico di ognuno con ogni altro.
Tutte le società si fondano sulla Volontà generale, perfino quelle che si basano sul delitto, ma le leggi devono essere fatte per tutti e non per uno, altrimenti torneremmo a basarci sul principio del “raisonneur violent” di hobbesiana memoria. La volontà generale non muta con il mutare delle generazioni in quanto il diritto naturale fa riferimento sempre alla specie umana nella sua generalità, per cui l’equità resterà sempre la causa della giustizia che fonda l’interesse generale.
Sia il discorso preliminare, sia l’articolo di Diderot, ci danno la misura del progetto degli enciclopedisti che si pongono come “summa” del dibattito filosofico di un epoca pronta a costruire dal basso una società che tenga insieme giustizia e utilità, dove il progresso dell’umanità si debba compiere grazie al contributo di tutti attraverso il lavoro e la ragione, l’arte e il pensiero.
Cap II: Rousseau e il processo di socializzazione.
Il nostro intento è quello di portare un contributo all’analisi del concetto di volontà generale, e i concetti non hanno ne una collocazione temporale ne possono essere riferiti come proprietà esclusiva di qualcuno.
Eppure, come già accennato nella brevissima introduzione, non possiamo trascurare gli effetti che l’articolo di Diderot suscitò nella riflessione di Rousseau, visto che a partire da questo confronto il concetto a noi tanto caro prende un significato che ormai non è più possibile trascurare se si vuole raggiungere una comprensione profonda circa l’aspirazione dei moderni nel rintracciare nell’uomo e solo nell’uomo quel principio di giustizia che è fondante la comunità politica.
Dove nasce la necessità delle istituzioni politiche?
Nel manoscritto di Ginevra, lavoro preparatorio a un opera che avrebbe dovuto intitolarsi “istituzioni politiche”, Rousseau comincia con il ribadire le sue considerazioni circa le modalità secondo le quali gli uomini sarebbero passati da un primo stadio di naturale solitudine individuale ad una progressiva socializzazione.
Soprattutto mette in risalto il rapporto fra particolare e universale e la connessione fra cittadino e società universale.
La necessità di condividere il proprio tempo con i propri simili nasce in ognuno allorquando mutano i bisogni; fino a quando l’uomo resta in uno stadio di autosufficienza, irrazionale e pacifica animalità, non avverte altro che il “amour de soi”, ovvero quel naturale amore per se stesso che lo spinge alla ricerca del cibo, riparo, sonno e sesso.
È nel momento in cui incontra gli altri uomini che nascono nuovi bisogni e avviene il mutamento dello stato umano dal “amour de soi” all’amour propre”.
L’analisi Roussoiana nasce proprio dalla capacità del ginevrino di mettere in luce l’importanza dei rapporti simmetrici fra gli individui che stanno alla base della fondazione della comunità politica, di mettere in risalto come questa comunità si formi, a quali regole è soggetta, e questo ci da la misura di come l’uomo è andato trasformandosi ed evolvendosi fino al momento della comprensione della necessità della instaurazione della società politica.
Abbiamo bisogno degli altri, ma le nostre passioni minano la possibilità di un unione spontaneamente pacifica.
“Una marea di rapporti, senza né misura, né regola, né consistenza, alterati e mutati di continuo dagli uomini”.
Se la società generale si fondasse sui bisogni degli uomini non riuscirebbe a corrispondere alla pluralità delle necessità dell’uomo trasformato dal confronto con gli altri;potrebbe solo esaltare e fortificare le nuove differenze fra gli uomini, quelle che si basano sui rapporti di ricchezza/povertà, che avvantaggerebbero di gran lunga i ricchi a scapito dei poveri.
Bisogna tener presente che l’uomo si unisce a gli altri per necessità, dunque è da escludere ogni riferimento a un eventuale principio che unisca in vista di una felicità o fine comune.
Utilizzare espressioni quali “il genere umano” , per Rousseau, vuol dire usare categorie collettive che nulla ci informano sulla reale composizione dei rapporti reciproci fra gli uomini.
L’uomo, inoltre, è un animale perfettibile, dunque in grado di migliorare se stesso e questo dipende in parte dal linguaggio e dalla cultura del tempo.
Laddove l’umanità viene valutata in un rapporto chiaro con la propria storia, è facile affermare che la perfettibilità risiede nel singolo tanto quanto nella specie, e si può misurare nello sviluppo della civiltà.
Ma quando si innesca il processo culturale, non solo grazie al linguaggio ma anche grazie all’evoluzione di categorie sociali quali la famiglia e piccoli gruppi sociali, inizia la preoccupazione dell’uomo non più solo per l’”amour de soi, ma anche dell’opinione degli altri e della propria posizione in seno alle gerarchie della propria comunità.
“L’interesse particolare e il bene generale non vanno affatto d’accordo, al contrario, nell’ordine naturale delle cose si escludono a vicenda”[ref] virgolettati di questo capitolo sono tratti dal cap II del Lib.I del manoscritto di Ginevra, ed Laterza 1994 a cura di Maria Garin, introduzione di Eugenio Garin.[/ref].
A seguito di questa affermazione, Rousseau attacca direttamente l’articolo di Diderot con una critica in quattro punti.
Il contrasto fra il “saggio” e “l’uomo indipendente” per Diderot si misura nel passaggio:” ma devo essere infelice o fare l’infelicità degli altri, e nessuno mi è più caro di me stesso”, mentre per Rousseau non vi è certezza per l’individuo che osserva la legge razionale che tutti gli altri lo rispettino allo stesso modo, inoltre non vi è assicurazione di trovare sempre persone più deboli su cui rifarsi.
In pratica per il Ginevrino “ o mi garantite da ogni ingiusto attacco o non sperate che , a mia volta, io me ne astenga”. Nessuna garanzia dunque da il rispetto della legge naturale mentre un alleanza dei più forti a scapito del debole garantisce una spartizione delle risorse più efficace , dal punto di vista dei vantaggi e di ogni discorso sulla giustizia. Un ritorno poi alle sanzioni divine non farebbe altro che inasprire i contrasti nel “genere umano” visto che ogni credenza nel divino risiede nelle ristrette aree delle diverse comunità, dove ognuno possiede un suo dio, sempre unico e sempre quello giusto. Se anche le religioni hanno fallito sempre nel garantire il “maggior bene di tutti”, chi mai potrà?
Per Diderot:” l’individuo, mi dirà, per sapere fino a che punto il suo dovere è di essere uomo, cittadino, suddito, padre, figlio, quando gli conviene vivere o morire, deve rivolgersi alla volontà generale”, per Rousseau invece anche se la regola è giusta da consultare non risulta adeguata per fornire un motivo di azione conforme in mancanza di una indicazione circa la convenienza ad essere giusti.
Ma se per il nostro editore “ la volontà generale , in ogni individuo, è un atto puro dell’intelletto che ragiona , nel silenzio delle passioni, su ciò che l’uomo può esigere dal suo simile e su ciò che il suo simile ha diritto di esigere da lui”, per Rousseau invece la regola della reciprocità non si attua al livello di legge che giustifica la comunità bensì come regola che garantisca la possibilità di una vita giusta e pacifica fra i partecipanti. Infatti il pensare leggi generali non garantisce all’individuo la possibilità di non ingannarsi negli innumerevoli casi particolari in cui si imbatte nei suoi simili.
Dove poi andrà rintracciata questa legge? Se per Diderot si trova “ nei principi di diritto di tutte le nazioni, il consenso tacito di tutti i nemici del genere umano”, per il nostro filosofo Ginevrino questa è eventualmente rintracciabile solo dall’ordine sociale che vige e a cui l’individuo è abituato a sottostare e dalla quale forse riesce, generalizzando, a proiettare un modello migliore.
La critica al cosmopolitismo dei “philosophe”, che espandendo il loro amor di patria all’amore per l’intero genere umano, “si vantano di amare tutti per essere in diritto di non amare nessuno”, è un analisi che parte da una nuova visione di quell’amor proprio, che nato dall’unione degli uomini in società, impedisce l’ascolto della legge razionale degli enciclopedisti, ma se bene inteso può offrire una chiave di lettura per correggere i difetti della associazione generale attraverso la creazione di nuove forme di associazione politica.
La critica severa che Rousseau rivolge all’articolo comincia a mostrare le differenze e le sfumature fra la diversa concezione dei due autori circa il concetto di Volontà Generale.
Per Rousseau questo concetto si rinnova continuamente e deriva direttamente dalla coscienza popolare, niente a che vedere con una statica ed imperitura legge giusnaturalistica depositata per sempre nei libri del diritto positivo dei giureconsulti.
Già nell’articolo “economia politica” scritto per l’enciclopedia, in un clima di sostanziale concordia con l’amico francese, Rousseau aveva posto un primo accenno alla distinzione tra sovranità e governo che svilupperà nel “contratto sociale” ma già viene inteso che la sovranità spetta al popolo, in una visione che appare organicista come pure in un accenno nel manoscritto quando parla della società generale come un essere morale diverso e superiore dalle parti che lo compongono.
Il rapporto fra questo corpo unico, questo essere morale e l’individuo sarà uno dei temi centrali della nostra analisi.
Dunque la genesi della volontà generale dipenderà più da un processo di socializzazione, nel senso di individui che si uniscono ad un corpo sociale, che da un diritto rintracciabile nella natura dell’uomo.
Cap III: l’amor proprio come chiave di lettura della socialità.
Se la volontà generale si rivela un paradigma così attraente, come io credo, certamente è dovuto alla promessa che sottende quando si pone come regola che lega i rapporti tra gli uomini in un piano di giustizia, libertà e rispetto reciproco.
Per Diderot abbiamo visto che essa si rivela ad ognuno che ragioni con calma in assenza delle passioni.
Questa visione razionalista ha il suo fascino e la sua presa teorica ma non spiega, a mio avviso, come questo principio possa incidere in presenza di individui irrazionali, mancherebbe, infatti la rassicurazione della reciprocità.
Questa come ricordiamo era pure la critica di Rousseau.
Il filosofo ginevrino aveva sottolineato come invece l’uomo avesse un bisogno naturale, una volta entrato in contatto con un determinato gruppo di altri soggetti, di essere accettato dagli altri come un simile, una sorta di preoccupazione per la propria posizione all’interno del gruppo in cui si inseriva. Questa preoccupazione di relazionarsi alla pari con gli altri è il bisogno che ognuno di noi sente di assicurare a se stesso un uguale livello di partecipazione, non solo alla vita del gruppo, ma anche alla condivisione delle risorse.
Questa condivisione sulla base di bisogni e aspirazioni impone a noi stessi e agli altri obblighi e limiti che saranno rispettati reciprocamente grazie alla possibilità che gli uguali bisogni sono riconoscibili naturalmente da ognuno.
Chiedere che il proprio bisogno venga accettato dagli altri ci predispone ad accettare spontaneamente lo stesso bisogno che è in ogni altro.
Su questo punto non vige una legge umana che bisogna comprendere ed aspettare che altri se ne convincano, qui Rousseau fa leva su una visione ampia dell’amor proprio che ognuno di noi sente in se stesso ed è spontaneamente capace di scorgerlo negli altri.
Dunque l’amor proprio ci spinge a riconoscere all’altro uno status di reciproca esistenza, un piano di reciprocità che più che analizzato razionalmente è sentito naturalmente e fatto proprio nell’agire in società. Se il principio di reciprocità è comunque decodificato dalla ragione, dalla coscienza ci muoviamo verso tale atteggiamento mossi da un sentimento.
Questa visione “ampia” dell’amor proprio non è quella classica seguita dalla letteratura sterminata su Rousseau, segue tuttavia la linea tracciata da John Rawls nella sua lezione all’università di Harvard nel 1994 di filosofia politica[ref]A pag. 210 dell’edizione Feltrinelli “lezioni di filosofia politica” John Rawls del 2009 è riportata un ampia spiegazione della visione ampia dell’amor proprio; Rawls nella nota 9 alla stessa pagina dichiara che questa visione è ripresa dagli studi di N.J.H. Dent, Rousseau, Blackwell ,Oxford 1988; e quello di Frderick Neuhouser in Freedom, dependance and general will, in Philosophical Review” luglio 1993 pp37 e seguenti. Neuhouser è il precursore di questa connessione fra l’amor proprio e la reciprocità.[/ref]. Se seguissimo la visione accettata da tutti dell’amor proprio e non questa di Rawls parleremmo unicamente di quel sentimento molto vicino alla vanità, che Rawls chiama amor proprio “perverso”, il quale come sappiamo è un desiderio di dominare l’altro nel confronto, di essere ammirati e onorati dagli altri.
Rawls per dimostrare la fondatezza di questa interpretazione chiama a testimoniare Kant, il quale nella Religione ( libro I, Sez. I, AK: VI : 27) si esprime così :”le disposizioni all’umanità possono essere collocate sotto il titolo generale dell’amore di sé, sempre fisico, ma tuttavia comparato (per cui si richiede la ragione); in quanto ci si giudica felici o infelici solo in confronto con gli altri. Da questo amore di sé deriva l’inclinazione dell’uomo ad acquistarsi un valore nell’opinione altrui ed originariamente , ad acquistarsi , senza dubbio,solo il valore dell’eguaglianza , per cui a nessuno permettiamo la supremazia su noi stessi, sentendo insieme la costante preoccupazione che altri possano aspirarvi.”
L’operazione che vuole fare Rawls è chiara: mettendo a confronto questo passo di Kant con il secondo discorso di Rousseau, ottiene un principio coerente per collegare il pensiero rousseiano fino al contratto in cui è un desiderio, l’amor proprio, che lega fra coscienza e ragione riflessa i cittadini del contratto sociale a un principio di uguaglianza che diviene prima di tutto un bisogno intimo e reciproco.
Un ulteriore confronto, a mio avviso, è da compiersi tra questa visione ampia di Rawls e il dibattito analizzato nel capitolo precedente tra Rousseau e Diderot.
Come ricordiamo Diderot aveva formulato il concetto di volontà generale come diritto naturale intrinseco alla natura umana, ogni individuo che nel silenzio delle passioni interroga la volontà generale può scoprire dentro se cosa è giusto e cosa è sbagliato nella società nel confronto con gli altri.
Rousseau aveva obiettato che anche qualora la legge fosse stata giusta non ci avrebbe dato certezze ne sulla convenienza a seguirla ne ci avrebbe tranquillizzato che gli altri, altrettanto razionalmente, avrebbero agito allo stesso modo verso di noi.
Dunque per Rousseau l’unico principio che potesse motivarci a cercare la comunità degli uomini sta nel bisogno che l’uomo ha del suo simile, quando non è più bastevole a sé e si sviluppa quel sentimento del confronto reciproco che ci accomuna in un istintivo relazionarsi sulla base di un uguale necessità.
L’uomo diventa qualcuno solo in relazione agli altri, in questa comparazione continua comprende il nesso della reciprocità e dunque dell’uguaglianza delle condizioni e dei bisogni che regolano la società umana.
Questi aspetti ci portano ad affermare che il passaggio dalla aggregazione di uomini al progetto politico, si fonda sulla convinzione che il bene di ciascun appartenente al corpo sociale, e così successivamente il bene di ogni sottoscrittore del contratto sociale, coincida con il bene di ogni altro.
L’interesse per se stessi una volta che è posto su un piano di simmetrica reciprocità e capacità di riconoscersi nell’altro diviene un interesse ben inteso, l’interesse per la vita della comunità.
Questo interesse che è comune a tutti fa divenire la volontà di ognuno, se bene intesa, la volontà generale . Il nostro è un ragionamento su come sia possibile la società, stiamo insomma cercando il movente dell’associazione, quel fondamento psicologico che Rousseau dichiarava nel manoscritto di Ginevra nel capitolo V del libro I: “l’utilità comune è dunque il fondamento della società civile”.
Ora però io sono pronto ad evidenziare anche una linea di continuità fra Rousseau e il contesto culturale della sua epoca, una sottolineatura che mi permette di vedere Rousseau allineato alle aspirazioni e prospettive dei lumi.
Infatti l’aver analizzato le differenze fra Diderot e Rousseau ci permette di condividere con quest’ultimo la preoccupazione e lo studio di una volontà generale che sia coerente con le passioni e i bisogni degli uomini veri, “così come essi sono”, ma nello stesso tempo ci mostra ancora una volta che Rousseau è perfettamente inserito nel progetto culturale della modernità posta in essere dagli enciclopedisti: porre l’uomo come unità irriducibile della deliberazione, dell’azione e della responsabilità di tutto ciò che è sociale, per cui i fini umani sono i motivi della nascita, dello sviluppo e del futuro dell’agire politico.
L’individuo umano è il principio della comunità pre-politica, il cittadino è il fine della società politica.
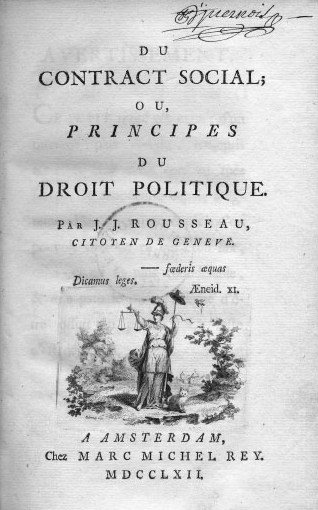 Cap IV: la Volontà Generale la genesi.
Cap IV: la Volontà Generale la genesi.
La distinzione più importante che concerne quanto detto fino ad ora è che Rousseau tiene sempre forte una divisione fra un popolo e un aggregazione di uomini.
La società politica che è espressione di un popolo, avrà possibilità di esistere solo qualora gli interessi particolari che spingono l’uomo ad aggregarsi ad un gruppo, possano essere superati o si possano evolvere nella direzione di interessi generali.
La prima definizione di Volontà Generale la troviamo nel libro primo, capitolo sei del contratto sociale:”ciascuno di noi mette in comune la propria persona, e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi in quanto corpo politico riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto”.
Ora ci porremo due domande a mio avviso essenziali, cosa significa volontà generale e qual è il suo ruolo, se ne ha uno, nella giustificazione dell’associazione politica.
Per capire come nasce la volontà generale abbiamo bisogno di muovere dei passi dall’analisi del momento aggregativo al momento dell’entrata di un individuo nel gruppo costituito.
Bisogna insomma fare dei passi all’interno della riflessione intorno al contratto sociale, in modo che se riusciremo a trovare delle risposte alle nostre due domande, certamente le avremo grazie alla nostra premessa circa il processo di socializzazione che in qualche modo prelude o già comprende il nesso con la possibilità della volontà generale.
Infatti la famosissima premessa capolavoro politico di Rousseau, uno degli incipit tra i più conosciuti nella storia della filosofia occidentale, se letto con attenzione già contiene in se tutte le domande e gran parte delle importanti questioni che attengono alla nostra riflessione:
“ voglio cercare se nell’ordine civile può esservi qualche regola di amministrazione legittima e sicura, prendendo gli uomini come sono e le leggi come possono essere. Tenterò di associare sempre in questa ricerca ciò che il diritto permette con ciò che l’interesse prescrive perché la giustizia e l’utilità non si trovino ad essere separate.”
Partire dalla reale natura dell’uomo, dai suoi bisogni e dalle sue passioni, per costruire una società che conughi giustizia e libertà è un progetto moderno, e illuminista, centrale nel dibattito dell’epoca in cui si trova il nostro autore, ma è anche un operazione che ha bisogno di un principio che funga da collante sicuro per non ricadere nell’utopia razionalistica dei philosophe che Rousseau aveva contestato.
Il punto resta che secondo Rousseau non avrebbe avuto senso parlare di leggi razionali per motivare l’uomo a lasciare lo stato di natura di relativa indipendenza e libertà per entrare in società senza mostrargli un vantaggio per questa scelta;invece c’ è la possibilità che il bisogno che nasce da una inadeguatezza delle possibilità dell’uomo , a un certo punto della sua storia, rispetto alle proprie necessità, fornisca il naturale stimolo alla accettazione della sottomissione alla volontà generale.
Tutti vogliono la società, è nell’interesse di ognuno ; comprendere questo sarà un equilibrio tra sentimento e ragione.
Il rispetto della comunità, nelle deliberazioni della società politica, sarà dunque un criterio normativo per fornire un fondamento alla società partendo appunto dalla comprensione che ogni singolo ha scelto liberamente di entrarvi in conformità al proprio bisogno di servirsi della forza comune in relazione alla propria condizione di uomo non più autosufficiente.
Ma è questa autosufficienza che va ricercando e la società dovrà dargliela e lui dovrà corrispondere altrettanto ai suoi simili, non perché una legge gli appare in se stesso, ma perché nel confronto l’uomo ha imparato a rivedere se stesso.
A questo punto posso azzardare un primo chiarimento su questo concetto a partire dal presupposto che per trovare il contenuto della volontà generale bisogna attendersi che l’individuo debba fare una distinzione precisa fra i suoi interessi al fine di poter individuare l’interesse ben inteso[ref]Per l’approfondimento di questa tesi faccio riferimento a:” eguaglianza interesse, unanimità” di Alberto Burgio ed bibliopolis 1989 napoli cap 6 “Volontè gènèrale e raison publique.[/ref].
Questa possibilità, io dico, è pensabile al momento che l’individuo che si trovi con una serie di necessità vitali non più soddisfabili nella sua ferina solitudine, compresa l’importanza che l’aggregazione con altri gli consente di superare questo handicap, sviluppi, prima ancora che una oziosa competizione con il proprio sodale, la capacità di leggere correttamente entro la propria coscienza l’uguale condizione di ogni altro che è la base di questa forza con cui l’aggregazione sopperisce alla propria condizione di inadeguatezza a restare indipendente.
La volontà generale è dunque una categoria trascendentale che nasce dalla riflessione che ogni uomo deve compiere per comprendere come l’interesse bene inteso al rispetto per la società è l’assicurazione al soddisfacimento dei propri bisogni; il riconoscimento che il proprio desiderio di essere accettati a pari condizioni in questa associazione passa per l’accettazione dello stesso diritto del proprio sodale, questa è la garanzia al successo dell’intera struttura.
È la convergenza degli interessi comuni che rende possibile la società politica, e l’interesse bene inteso produce quel legame sociale che fa nascere la volontà generale.
Ma fino a qui abbiamo analizzato l’entrata in società degli “uomini come sono”, proviamo ora a verificare se da questo presupposto si può passare alla comunità politica con le leggi come “dovrebbero essere”.
Il passaggio da una moltitudine a un popolo, e cioè da una aggregazione di uomini alla società politica, può avvenire allorquando il principio della volontà generale può essere innalzato a categoria generale e preso come contento valoriale per l’edificazione della società giusta ed uguale.
La mia ricerca è nata successivamente alla lettura del famoso saggio del prof. Mario Reale, “le ragioni della politica” che ancora oggi risulta essere una pietra di paragone per lo studio della teoria Rousseaiana , in considerazione che nel settimo capitolo, parlando del nucleo teorico del contratto sociale , il prof. Reale spiega che il punto più alto della teoria di Rousseau è : “quello che fa consistere la politica non già nella garanzia della coesistenza di interessi contrastanti, bensì in ciò che in questi stessi interessi è immediatamente comune, nel punto di unione dove essi si accordano e si fanno solidali”. Trovo questo passaggio essenziale per impegnarmi a comprendere a fondo come dal punto di vista della volontà generale, la politica, la società e tutto ciò che ne deriva possa essere inquadrata come un unione in vista del bene comune.
Ma questo bene comune non ha una accezione utilitarista, non è cioè un unione di uomini che agiscono per la massimizzazione dei loro interessi particolari anche se coincidenti; qui la convergenza degli interessi comuni rende possibile la società politica, la fonda e non crea uno strumento per la soddisfazione degli stessi, anzi questa convergenza, dovuta alla necessità che l’amor proprio genera, rende possibile la volontà generale che nell’atto di istituire la società politica, diviene il principio guida per formulare la regola su cui modellare quelle leggi “come possono”. Cosa vuole dunque la volontà generale se non che le leggi della società siano pensate esclusivamente su interessi comuni, e questi possono essere individuati solo in termini di interessi fondamentali quali la sicurezza della persona, la difesa della proprietà privata.
Questo è un punto evidente visto che l’uomo di natura indipendente ricerca il proprio simile, laddove nella propria originaria solitudine non riesce più a garantirsi quel cibo, quel riparo, quella difesa dagli altri predatori che invece l’unione con altri può garantire.
Dunque la sicurezza della persona è un interesse fondamentale coincidente e preesistente all’unione, che spinge verso essa e ci aiuta a comprendere che la volontà generale muove da questa ricerca e produce leggi che devono rispondere a questi presupposti.
L’uomo vuol restare libero come prima, ma ha bisogno di una forza che da solo non possiede, per ottenere un equilibrio fra queste due necessità bisogna almeno verificare che la società che scaturisce da questa unione sia legittima, ovvero mostri una coerenza tra la natura della volontà generale e la sua espressione, cioè le leggi che ad essa si ispirano.
Cap V La legge come espressione della volontà generale
Nel paragrafo precedente ho sottolineato come il bene comune, che se ben inteso possiamo indifferentemente chiamare anche” la convergenza degli interessi”, non ha una natura utilitarista, anzi, questa convergenza nega ogni massimizzazione della felicità intesa come somma della soddisfazione di tutti gli interessi dei singoli. La società che si fonda sulla volontà generale non può che esprimere l’interesse di tutti nel senso di ottemperare alle aspettative di ognuno.
Già nell’articolo “economia politica” Rousseau bollava come la più esecrabile tra le tirannie quella società pronta a sacrificare un singolo in vista del bene comune. L’ interesse fondamentale comune a tutti gli uomini è dunque il bene comune. Questa società retta dalla volontà generale è resa possibile qualora la cooperazione sociale sia tesa alla realizzazione dei presupposti per una corretta attuazione degli interessi fondamentali di ogni membro. La cooperazione sociale deve produrre una sistema che mantenga inalterate le possibilità di ognuno di soddisfare i propri bisogni fondamentali, questo significa che ognuno cooperando allo sviluppo degli strumenti che innescano i processi deliberativi deve agire con il fine di armonizzarsi all’interesse comune.
Tanto che il singolo sia deputato alla formulazione di una regola generale, tanto che il singolo sia chiamato alla scelta tra diverse opzioni deliberative in relazione alle regole della società, ciò che è sempre richiesto dalla volontà generale è che il singolo agisca e scelga sempre in conformità a ragioni dipendenti solo dagli interessi fondamentali che condivide con ogni altro membro della società politica.
Qui l’interesse generale prevale su qualunque interesse particolare. Questa osservazione è comprensibile alla luce di quanto da me sostenuto nei capitoli precedenti, infatti gli appartenenti a questa società politica sono uomini consapevoli della necessità della società politica come rimedio alla propria inadeguatezza rispetto alle necessità vitali. Questi uomini agiscono dunque in una consapevolezza simmetrica rispetto ad ogni altro individuo, che attraverso il sentimento dell’amor proprio hanno imparato a riconoscere al fine di essere essi stessi riconosciuti come uguali.
Solo quelle scelte che hanno un senso entro la realizzazione degli interessi comuni saranno da considerarsi espressione della volontà generale.
Ognuno deve riconoscere all’altro un posto legittimo nella comunità, ognuno lavorando per gli altri lavora in realtà già per se stesso.
I doveri nella società politica sono vincolanti solo se sono reciproci, questo è il punto focale su cui Rousseau fa perno per pretendere che la società costruita dalla volontà generale è legittima.
La volontà generale nasce in ognuno disposto ad unirsi a tutti gli altri in una reciproca cooperazione per un fine comune, allo stesso tempo essa si riferisce a tutti quando ognuno è disposto a vedere in ciascuno gli stessi fini che si ricerca per se stesso.
Se la nostra lettura non ci inganna la certezza di ciò che ho affermato poggia sulla naturale predilezione che ognuno conserva per se stesso.
La società politica ci garantisce quella forza che ci manca per l’autoconservazione, ognuno di noi è qui per attingere a questa forza comune, l’interesse comune è l’interesse di ognuno.
Tuttavia potremmo concordare con David Hume che non è irrazionale preferire la distruzione di tutto il genere umano piuttosto di soffrire per un taglio al dito di una mano, eppure laddove il singolo riesca a leggere l’interesse ben inteso e sappia riconoscere gli interessi fondamentali che lo legano alla cooperazione sociale, allora la deliberazione avverrà su un piano di uguaglianza e le scelte che ne seguiranno garantiranno la giustizia.
La volontà generale garantisce un fondamento all’idea che la sovranità coincida con la totalità dei cittadini; essa ci dice che le deliberazioni di questa totalità, vanno dal popolo intero su e per il popolo intero. Il popolo fa atto sovrano solo quando emana regole generali che riguardano la società nel suo insieme. Queste regole, chiamate leggi, saranno espressione della volontà generale per origine e per contenuto. La volontà generale come giustificazione del potere legittimo, la regola di amministrazione legittima prendendo gli uomini come sono e le leggi come possono essere. Alla fine di questa analisi possiamo affermare che la volontà generale nasce come risposta all’obiezione dell’uomo razionale che chiedeva, a fronte di un comportamento giusto, di essere protetto da un’eventuale comportamento ingiusto da parte degli altri. La volontà generale nasce quindi come risposta alla ricerca di una razionalità che giustifichi la forza dello Stato; gli individui si sottomettono non a un potere qualsiasi, ma solo a quello che garantisca ognuno dalle ingiustizie dell’altro.
L’uomo indipendente “pre-sociale” è disposto a entrare nella società politica a patto che le deliberazioni del potere costituito si applichino a tutti in egual misura nella direzione di moderarne le passioni negative. Questo ordine sociale è solo quello fondato sulla volontà generale. Ne troviamo una dimostrazione nel passo di Rousseau: “Ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi in quanto corpo politico riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto”[ref]Contratto sociale,cap III …[/ref]. Questo passo ci dice che la volontà generale guida le forze dello Stato nella direzione per cui gli individui lo hanno creato e cioè nella direzione del bene comune. L’istituzione del patto sociale è fatta da individui che si sottomettono attraverso un patto a un corpo sovrano che essi stessi istituiscono e di cui essi stessi fanno parte. Ogni individuo diventa così sia cittadino che suddito, questa è la scelta razionale che obbliga ognuno ad obbedire ai comandi di un’autorità sovrana formata da loro stessi e che è pensata per deliberare nel senso del bene comune. Come diceva lo steso Rousseau è impensabile che “il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri”[ref]Contratto sociale 1 Cap.7[/ref], ciò andrebbe in contraddizione con i motivi della fondazione; la garanzia della reciprocità degli obblighi è data inoltre dal fatto che tutti i membri si trovano in una stessa e simmetrica obbligazione rispetto al sovrano. La volontà generale garantisce l’equilibrio fra l’interesse privato del singolo, che per questo accetta di entrare in società, e l’interesse pubblico che per tutti è la salute della società politica ben ordinata. Per capire meglio come sia possibile questo equilibrio fra l’eguaglianza dei diritti individuali e la reciprocità degli obblighi basta pensare ancora una volta alla teoria della legge: la legge per Rousseau è il fondamento della giustizia e della libertà. Essa è una deliberazione del Sovrano che si applica a tutti ed è universale nel senso che il suo oggetto è indirizzato a regole generali e mai a qualcuno in particolare.