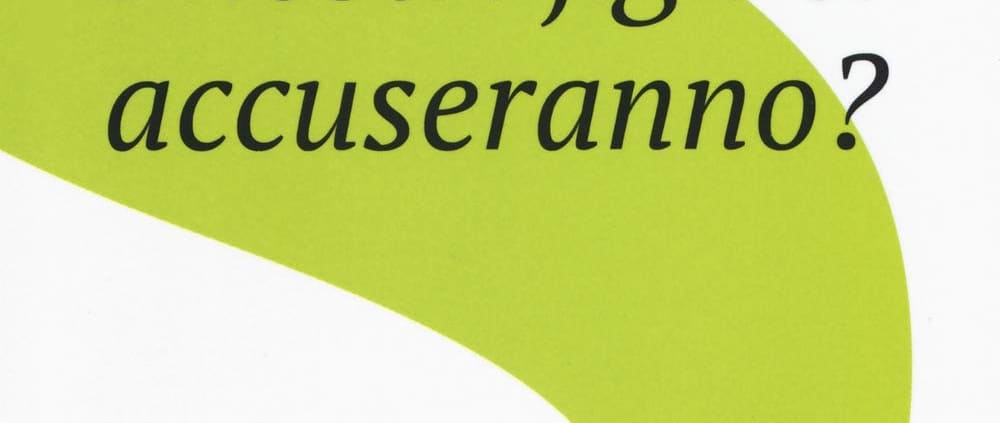Elogio della terra- di Byung-Chul Han
Un vettore collega la lettura offerta da Bacone del libro della Genesi, in cui Dio offre all’uomo la natura perché ne sia padrone e custode, la sentenza galileiana per cui la natura è un libro scritto nel linguaggio della matematica, e la moderna e contemporanea razionalità strumentale, che predispone mezzi per fini eletti eteronomamente riducendo, come ha ben visto Husserl, tutto a quantità misurabili e raffrontabili. Si tratta di un vettore che ci ha illusi di renderci sovrani della realtà, ora prevedibile e governabile, ma che, a ben vedere, ci ha in gran parte spossessati dell’esperienza piena che della realtà si può fare, a causa di una simulazione, una sostituzione della realtà nella sua complessità e nella sua pienezza con una messe di informazioni, rigorose o meno: unico antidoto, le parole provocatorie di Nietzsche, secondo il quale il non conoscere è la precondizione perché ciò che vive si conservi e prosperi.
Nel libro di Byung-Chul Han, Elogio della terra, pubblicato da nottetempo (192 pagine, € 17), il filosofo coreano ci consegna la sua esperienza di giardiniere, di cultore di piante e fiori nel proprio giardino, invitandoci a riprendere contatto con la natura e, così, a percorrere il tragitto opposto a quello ora appena accennato. Un libro che arriva dopo i numerosi altri in cui Han si è esercitato in una variegata e puntuta critica del digitale e del capitalismo cognitivo attuale: un libro che, quindi, si propone come una specie di pars construens, e che si nutre dell’amore di Han per la filosofia zen e per gli elementi che la animano, per la sua capacità di conservare un’aderenza con il qui e ora, lasciato essere, senza tuttavia intrappolare nella finitezza che limita la deriva moderna del pensiero occidentale. Han, nel contatto con la terra, con la natura nella metafora del giardino planetario, suggerisce una riscoperta intensiva di un altrove più profondo.
La forte spinta a riconquistare il contatto con la terra è la reazione alla digitalizzazione della nostra vita, a un processo, cioè, che ci fa smarrire ogni ordine terreno, ogni ordine naturale, ogni armonia. Sette anni fa, Han ha allestito un giardino, che chiama Bi-Won, giardino segreto, capace di comunicare una propria storia in ogni stagione: il libro si apre proprio con il racconto delle piante invernali, della loro sorprendente tenacia. Un’esperienza, quella del giardino, che Han descrive nella sua dimensione particolare e personale, che, tuttavia, apre già strutturalmente a un’universalità o, meglio, avvoca a un impegno collettivo. La chiama “coscienza planetaria” e la definisce come l’avvertenza che abitiamo un piccolo e rigoglioso pianeta, unico fra quelli noti a non essere buio e sterile; un equilibrio fragile, che trascuriamo, dal quale succhiamo ogni risorsa, interpretando come unico significato del lavoro quello di estrarre e trasformare la natura. Il lavoro sul suo giardino insegna a Han il senso del sacrificio, la fatica dello scoprire la realtà disvelarsi: una fatica benefica e conciliante, ben altra cosa rispetto a quella patologica del neoliberismo, che in altri libri Han ha così diffusamente trattato mettendola in connessione con la depressione. Anzi, il giardino, riallacciandoci alla realtà delle cose, alla natura e i suoi tempi, è un farmaco che dona la gioia più vera.
Per descrivere il suo percorso di sottrazione a un mondo ridotto al mero quantificabile, per restituire questo itinerario di reincantamento del mondo, Han parla di una “romanticizzazione”, in primo luogo nel senso di Novalis: «Nel momento in cui do a ciò che è comune un senso elevato, a ciò che è consueto un aspetto pieno di mistero, al noto la dignità dell’ignoto, al finito un’apparenza infinita io lo rendo romantico». Non una fuga verso un altrove, ma la riscoperta di un nuovo significato, di una irriducibile e ricchissima alterità in ciò che già c’è, così come è. È nella dimensione qualitativa, più che in quella quantitativa, che Han orienta le proprie parole, parlando di musica e musicalità, colori, poesia, come lacerti di una sacralità i cui riti abbiamo smarrito, di una vita che è sempre altra, che si rivela e ci sorprende.
L’impresa di Han è dunque quella di restituire mistero alla natura, contro l’assolutizzazione dell’azione umana e il suo effetto distruttivo. Inazione piuttosto che azione, indugiare piuttosto che agire strumentale, contemplare piuttosto che intervenire: queste le parole d’ordine per una salvezza ancora possibile per noi e la natura che ci avvolge; perché l’angelo della Storia di Walter Benjamin non abbia più a discendere a constatare le conseguenze dell’agire umano, macerie e detriti accumulati per un malinteso senso di progresso.
Ogni capitolo del libro di Han racconta una pianta, una scoperta, un’esperienza. E ogni capitolo è accompagnato da un disegno di Isabella Gresser, capace di ritrarre piante, fiori, rami, germogli per avvicinare il lettore quanto più possibile alla concretezza delle parole di Han.