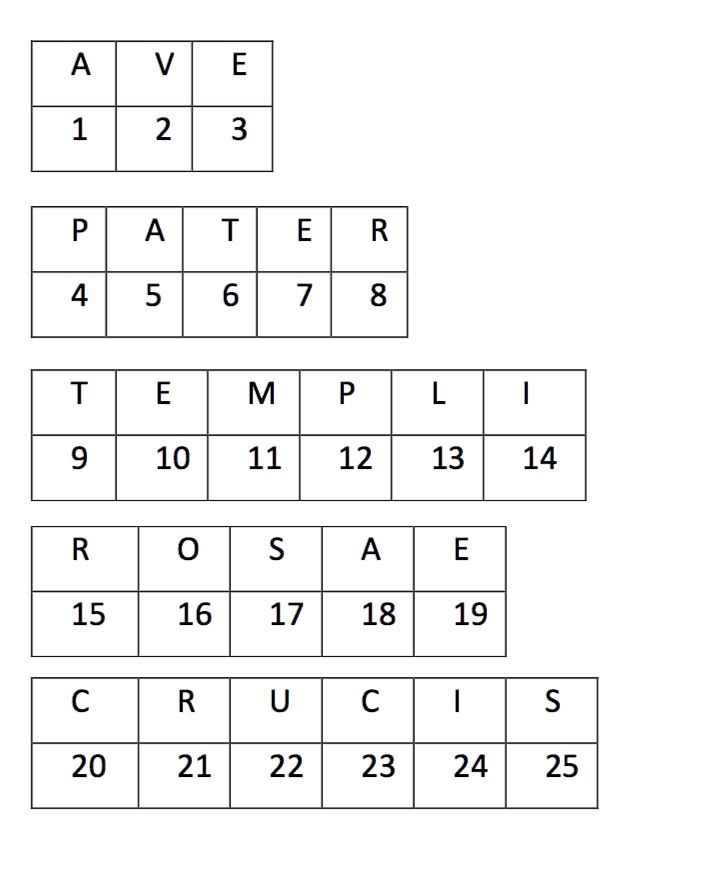ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNOR ABATE ANTONINO UGUCCIONI PATRIZIO FIORENTINO
[drop_cap style=”2″ bgcolor=”#dddddd” color=”#787882″]C[/drop_cap]oloro i quali del mio bene hanno invidia, e non potendola tenere in petto, la spargono dalle labbra e dagli occhi, ed empiono di veleno i fogli, nuovo avranno motivo di macerarsi e di fremere, allora quando sapranno avermi io in Firenze un altro Protettore acquistato, dotto, illustre e gentile, pieno per me di benignità e d’amore. Non vorrebbono i maligni, che io pubblicassi al mondo gli onori che dalle persone di rango mi vengon fatti, e il render grazie ch’io fo a chi mi benefica e mi protegge, viene interpretato dagli invidiosi vanità e ostentazione. Dican essi checché dir vogliono, retta io non do loro; vuò render palese al mondo il fregio, che novellamente acquistato mi sono, del patrocinio di V. S. Illustrissima, e se in ciò fare usassi della vanità, della ostentazione, sarei anche dagli Uomini di buon senno lodato, non che compatito, poiché delle cose che preziosissime sono, è lecito indiscretamente vantarsi. Chi ha la fortuna di conoscere e di trattare l’amabilissima di Lei persona, ha motivo certamente di rallegrarsi, trovando in Lei tante belle Virtù, e quelle precisamente che formano l’uomo gentile, il colto ed ottimo Cavaliere. Io non istarò qui a descrivere ad una ad una quelle belle Virtù, che al di Lei eccelso animo fan corona, poiché lunghissima e per me malagevole saria l’impresa; ma di alcune soltanto farò menzione, di quelle cioè che fanno risuonare il grido del di Lei nome. L’onestà de’ costumi, la massima sincerità di cuore, la generosità dell’animo, la dolcezza del tratto, l’affabilità, la moderazione, la cortesia, qualità sono in V. S. Illustrissima, che la rendono a tutti gli ordini delle persone oggetto di venerazione e di maraviglia; ma sopra tutto quella vivacità, quella prontezza di spirito, che brilla mirabilmente ne’ detti suoi e ne’ suoi pensamenti, dà a conoscere chiaramente, che i doni della natura corrispondono alla nobiltà originaria antichissima del di Lei sangue, e rende perfettamente a’ Maggiori suoi quell’onore che ha largamente ricevuto da essi. Ella ha l’ottimo gusto nelle migliori cose del mondo, le intende, le distingue, le ama. Ama i studi più seri e più interessanti dell’uomo, ed ama eziandio dell’uomo i più onesti, i più nobili, i più discreti trattenimenti. Fra questi Ella non dà al teatro l’ultimo luogo; lo crede oggetto degno non solo del suo piacere, ma anche delle sue applicazioni. Ella ha preso a proteggere una Compagnia di valorosi Comici suoi nazionali, de’ quali ho fatto altra fiata menzione, e sono, a dir vero, ornamento del Teatro Italiano. Indi alla di Lei protezione venne raccomandato il teatro medesimo in Via del Cocomero situato, governato da una onoratissima Società d’Accademici Fiorentini, il quale, sotto la savissima di Lei condotta, ve facendo progressi ammirabili, ed è ormai reso esemplare degli altri, per l’onestà, per il modo, per la condotta, alla quale corrisponde la città tutta con l’applauso e il concorso. Se dirò che le Commedie mie in cotesto Teatro si rappresentano quasi continuamente, mi verrà apposto dagli emoli, che io lo dica per vanità; ma quando anche ciò fosse vero, sarei compatibile, se di un sì grande onore invanissi, e se mi stimolasse la forza dell’amor proprio a rendere palese al Mondo, che delle Opere mie una sì colta Città si compiace, ed un Cavaliere dottissimo, e di sì fino gusto fornito, ne è il benignissimo promotore. A Lei, Illustrissimo Signor mio, cui tanto preme la riputazione delle opere mie e del mio nome, di che tante generose prove mi ha dato, a Lei raccomando questa Commedia, in particolar modo sotto la protezione Sua validissima pubblicata. La curiosità di alcune Donne somministratomi ha l’argomento, non già quelle virtuose e magnanime, che degne sono dell’amabilissima di Lei conversazione, e che costì e dapertutto ebbi anch’io la fortuna di conoscere e di ammirare; ma quelle alle quali un tal difetto è comune, per debolezza di animo particolare, non per natura del gentil sesso. Nell’atto però di raccomandarle quest’imperfetta Opera mia, intendo di raccomandarle assai più l’umilissima mia Persona, supplicandola concedermi benignamente lo specioso titolo, con cui ho l’onore di protestarmi Di V. S. Illustriss. Umiliss. Divotiss. ed Obbligatiss. Serv. CARLO GOLDONI
L’AUTORE A CHI LEGGE La curiosità delle donne è un argomento che viene dagli uomini considerato sì vasto, che a molte e molte Commedie potrebbe somministrare l’intreccio. Quindi è, che di questa mia alcuni contentati poco si sono, perché ad un oggetto solo ho diretto la curiosità di quattro femmine insieme. Questi però, che un così avido desiderio nutriscono di vedere in scena moltiplicati delle donne i difetti, mostrano di essere più curiosi di esse; ma si consolino, poiché non mancherà forse chi prevalendosi anche di questo mio argomento, darà loro continuazione, e accozzando insieme una moltitudine di fatterelli, farà una composizione, a cui darà il titolo di Commedia. Io che, per quanto posso, amo di conservare l’unità dell’azione, ho voluto ristringermi ad un solo motivo, e mi sembra bastantemente critico, per quell’idea che mi sono prefissa in mente.
PERSONAGGI OTTAVIO cittadino bolognese. BEATRICE sua moglie. ROSAURA loro figliuola. FLORINDO promesso sposo a Rosaura. LELIO bolognese. ELEONORA sua moglie. LEANDRO amico de’ suddetti. FLAMMINIO amico di Leandro. PANTALONE de’ BISOGNOSI mercante veneziano. CORALLINA cameriera di Beatrice e di Rosaura. BRIGHELLA servitore di Pantalone. ARLECCHINO servitore di Ottavio. Un altro SERVITORE di Ottavio, che parla. Servitori di Pantalone, che non parlano. La Scena si rappresenta in Bologna.
ATTO PRIMO SCENA PRIMA Camera con porte chiuse. OTTAVIO leggendo un libro, FLORINDO e LEANDRO giuocando a dama. LELIO a sedere. LEL. Amici, come va la partita? FLOR. In questo punto sono arrivato a dama. LEAN. Ed io non tarderò ad arrivarvi. LEL. La vostra è una partita di picca. FLOR. Sì; noi giochiamo veramente di picca. Si disputa l’onore, non l’interesse. LEL. Eh, già si sa. Qui non si giuoca per interesse. FLOR. E in questa maniera sussiste la nostra compagnia; altrimenti, o questa si saria disfatta, o si sarebbe alcun di noi rovinato. Dama. (giocando) LEL. Un’altra cosa bellissima contribuisce alla nostra sussistenza. FLOR. Sì, quella di non voler ammetter le donne. LEL. Ed esse hanno di ciò il maggior veleno del mondo. FLOR. Quello che più loro dà pena… LEAN. Soffio la dama. FLOR. Perché? LEAN. Perché non avete mangiato questa. FLOR. È vero. Avete ragione. Solamente per aver nominate le donne, ho perso il giuoco. LEL. Se venissero qui, ci farebbero perder la testa. FLOR. Spero ancora di rimettere la partita. (giocando) LEAN. Fatelo discorrere, che mi date piacere. Altrimenti non posso vincere. FLOR. Parlate, parlate, non mi confondo. (a Lelio) LEL. Che cosa dicevate voi che patiscono più di tutto le nostre donne? FLOR. Quel che più le tormenta, è la curiosità che hanno di sapere quello che noi facciamo in queste nostre camere. LEL. Sì, è vero. Eleonora mia moglie tutto dì mi tormenta su questo punto, e per quanto le dica non si fa niente, non lo vuol credere. FLOR. Lo stesso accade a me colla signora Rosaura, che deve esser mia sposa: non mi lascia aver bene. La soffro perché l’amo, ma vi assicuro che mi tormenta. LEL. Io, che sono poco paziente, ho dato più volte nelle furie con mia moglie, e ho paura, se seguita, di far peggio. LEAN. Dama. Una gran cosa con queste donne! Vogliono saper tutto. FLOR. È vero, fanno perdere la pazienza. Bisogna essere innamorato, come sono io, per soffrirle. OTT. Amici, sento un proposito che mi tocca, e non posso far a meno d’entrarvi. (alzandosi dal suo posto) LEL. Siete anche voi tormentato dalla signora Beatrice? OTT. Domandatelo all’amico Florindo. Mia moglie non tace mai. FLOR. Sì, madre e figlia ci tormentano a campane doppie. OTT. Rosaura mia figlia lo fa anche con qualche moderazione; ma Beatrice mia moglie è un diavolo. LEL. Darete anche voi nelle impazienze, nelle quali sono forzato a dar io. OTT. No, amico. Non do in impazienze. Non mi altero; non mi scaldo il sangue. Non voglio che le pazzie della moglie pregiudichino la mia salute. LEL. Bisogna poterlo fare. OTT. Si fa tutto quel che si vuole. FLOR. Non lo sapete? Il signor Ottavio è filosofo. LEL. Non basta esser filosofo per soffrire una moglie cattiva, bisogna essere stoico. OTT. Quando dite stoico, che cosa vi credete di dire? LEL. Che so io? Insensato. OTT. Poveri filosofi! Come vengono strapazzati! Gli stoici, che ponevano la vera felicità nell’esercizio della virtù, sono chiamati stolidi! LEL. Io non so di filosofia. Stimo più questo poco di quiete di tutte le massime di Platone. FLOR. (Alzandosi) Ciascheduno in questa nostra amichevole società soddisfa il proprio genio, e passa il tempo tranquillamente in tutto ciò che onestamente gli dà piacere. Io ho la mia passione per le operazioni ingegnose. Giuoco volentieri a quei giuochi dove non ha parte alcuna la sorte. Mi diverte assaissimo la matematica, la geometria, il disegno, e qui mi ristoro, se è la mia bella sdegnata. Mi consolo assai più, se ella mi ha fatto partir contento. Perdonate, signor Ottavio, se così parla uno che deve essere lo sposo di vostra figlia. Già lo sapete, tutte le donne hanno de’ momenti buoni e de’ momenti cattivi. OTT. Sì, e bisogna esser filosofi, come sono io, per burlarsi di loro. LEL. Cari amici, se volete parlar di filosofia, anderò a sedere in un’altra camera. Io vengo qui a sollevarmi un poco, dopo gli imbarazzi delle mie cariche e della mia famiglia. E quel poco che io ci sto, ho piacere di divertirmi. FLOR. Che cosa vi vorrebbe per divertirvi? LEL. Un buon pranzo, una buona cena. FLOR. Volete che questa sera ceniamo in compagnia? LEL. Per me ci sono. Che dice il signor filosofo? OTT. La filosofia non è nemica dell’onesto divertimento. FLOR. Ecco il signor Pantalone. Pregheremo lui, che ci faccia preparare. LEL. Gran galantuomo è questo signor Pantalone! Egli ha eretto questo nostro divertimento; egli regola assai bene la nostra compagnia; ci dà ben da mangiare, e credo vi rimetta del suo. FLOR. Gode assaissimo di questa compagnia da lui medesimo procurata. LEL. E non vuol donne, e fa benissimo! OTT. Così possiamo godere la nostra pienissima libertà.
SCENA SECONDA PANTALONE e detti. PANT. Patroni cari, amici cari. Amicizia. OTT. Amicizia. (si abbracciano e si baciano) PANT. Amicizia. FLOR. Amicizia. (fanno lo stesso) PANT. Amicizia. LEL. Amicizia. (fanno lo stesso) PANT. Amicizia. LEAN. Amicizia. (tutti dicono amicizia, e si abbracciano) PANT. Sali, patroni, che xe sonà mezzo zorno? FLOR. È ora che ce ne andiamo. OTT. Florindo, volete venire a pranzo con me? FLOR. Riceverò le vostre grazie. PANT. Patroni, quando se fa ste nozze? (a Florindo ed Ottavio) FLOR. Io dipendo dal signor Ottavio. OTT. Si faranno presto. LEL. Questa sera vorressimo cenare in compagnia; ci favorirete voi al solito? (a Pantalone) PANT. Volentiera. Quanti saremio? LEL. Qui siamo in cinque. PANT. Benissimo; provvederò mi, parecchierò mi. Se goderemo, staremo allegri. OTT. Oh, andiamo. Signor Pantalone, amicizia. PANT. Amicizia. (si abbracciano e si baciano) OTT. Amicizia. LEL. Amicizia. (come sopra) LEAN. Amicizia. FLOR. Amicizia. (come sopra) PANT. Amicizia. FLOR. Amicizia. LEL. Amicizia. LEAN. Amicizia. (Lelio, Ottavio, Florindo e Leandro partono)
SCENA TERZA PANTALONE, poi BRIGHELLA PANT. Mi, co son coi mi amici, vegno tanto fatto! Brighella, dove xestu? BRIGH. Son qua, sior padron. PANT. Stassera bisogna parecchiar da cena. BRIGH. Per quanti, signor? PANT. Per cinque, per sie, per otto. BRIGH. La sarà servida. PANT. Caro Brighella, fa pulito, me preme de farme onor coi mi cari amici; me preme de farli star ben, de farghe spender ben i so bezzi, e perché le cosse vaga pulito, me contento de remetterghe un zecchin del mio, e anca do, se bisogna. BRIGH. In fatti qua la gh’ha el so unico divertimento. PANT. Mi sì, vedè. No godo altro a sto mondo che i boni amici. Ghe n’ho scielto diversi, che me par a mi che i sia della bona lega, e con questi passemo el tempo propriamente, onestamente, lontani dai strepiti, e fora della suggizion. BRIGH. E pur, sior padron, se la savesse quanti lunari se fa per sta conversazion limitada, per sto logo dove no pol intrar chi no xe della compagnia! Chi ghe ne dis una, chi ghe ne dis un’altra, e specialmente le donne le se sente a morir de voia de vegnirghe, de véder, de saver. PANT. No le vegnirà assolutamente. Cussì xe i patti della compagnia. Chi no xe della lega, no pol vegnir, e donne mai. BRIGH. Me par impussibile. PANT. Vardè ben, vedè. No ve vegnisse voggia de far vegnir donne qua drento. Ve mando via subito immediatamente. BRIGH. Caro signor, la perdoni. L’è nemigo delle donne? La varda ben che ghe n’ho visto dei altri che no podeva véder le donne, e po i è cascadi drento fina ai occhi. PANT. No son nemigo delle donne; le vedo volentiera, e anca mi ai mi tempi gh’ho volesto ben; e se me trovasse in te l’occasion, no so cossa fasse anca al dì d’ancuo. Me par per altro, che l’amor dell’amicizia sia un amor più nobile, e manco pericoloso, e per coltivarlo no bisogna missiarlo con altri amori. Dove che ghe xe donne, no pol de manco che qualchedun no se scalda; al caldo dell’amor succede el freddo della gelosia, e in poco tempo el casin del divertimento el deventa el seminario della discordia. Tolè suso, v’ho dito anca el perché; siben che no savè più che tanto, intendème per descrizion. BRIGH. Qualcossa ho inteso. PANT. Me basta che intendè ste do parole: qua drento no voggio donne. (parte) BRIGH. Co nol vol che ghe ne vegna, no ghe ne vegnirà. Me preme conservarme un padron che me dà un bon salario, e me preme che vada avanti sta compagnia perché ghe la cavo, m’inzegno, e qualche volta la mia zornada no la darave per un zecchin. (parte)
SCENA QUARTA Camera di Beatrice in casa di Ottavio. BEATRICE e ROSAURA BEAT. Ecco qui al solito. È un’ora che è sonato mezzogiorno, e il mio signor consorte non torna a casa. ROS. Avrà qualche interesse da fare. BEAT. Sarà a quel maladetto ridotto. ROS. Può essere che vi sia col signor Florindo. Sogliono andarvi insieme. BEAT. Ma che diavolo fanno mattina e sera là dentro? ROS. Bisogna che vi abbiano un gran piacere, perché non lo lasciano mai. BEAT. Giocheranno a rotta di collo. ROS. Io ho paura, signora madre… BEAT. Di che? ROS. Che vi sia qualche donna. BEAT. Se donne là dentro non ne vogliono! ROS. Dicono che non ne vogliono, ma noi non vi vediamo. BEAT. Via, via, questo è un vostro pensier geloso che non ha fondamento. Per me dico che giocheranno. ROS. Ed io dico che faranno all’amore. BEAT. Basta, mi chiarirò. ROS. Come, signora madre? BEAT. Voglio andare a sorprenderli all’improvviso. ROS. Oh, quanto pagherei a venirci ancor io! BEAT. Alle fanciulle non è permesso. Vi andrò io, e vi saprò dir tutto. ROS. Voi non mi direte la verità. BEAT. Sì, vi dirò tutto. Vedrò chi giuoca e chi non giuoca. ROS. Vi saranno delle donne, e voi non me lo direte. BEAT. Eh, che i giuocatori non si curano di donne. ROS. Ma se non vanno per il giuoco, ma per le donne. BEAT. Voi non sapete cosa dite. ROS. Così non dicessi la verità. Quando il cuore mi suggerisce una cosa, non falla mai.
SCENA QUINTA ELEONORA e dette. ELEON. Chi è qui? Si può venire? BEAT. Venite, signora Eleonora, venite. A quest’ora? Siete venuta a pranzo con noi? ELEON. Son venuta a dirvi in confidenza, che ho saputo finalmente che cosa si fa dai nostri mariti in quel luogo segreto. BEAT. Io me l’immagino. Giocheranno da traditori. ELEON. Oibò. ROS. Sarà poi come dico io: vi saranno delle signorine. ELEON. No, v’ingannate. Io ho saputo ogni cosa. Sentite, ma in segretezza. Fanno il lapis philosophorum. BEAT. Sapete che si può dare? Mio marito sa di filosofia: sarà egli il capomastro. ROS. Come lo avete saputo, signora Eleonora? ELEON. Vi dirò tutto, ma… non parlate per amor del cielo. BEAT. Non dubitate. ROS. Per me non vi è pericolo. ELEON. Sono stata questa mattina a ritrovare la sarta, per vedere se mi aveva finito quel mio vestito verde… M’intendete quale ch’io voglio dire. BEAT. Sì, Sì, quello che avete fatto di nascosto di vostro marito. ELEON. Signora sì; la Caterina me lo aveva guastato, e così mia comare dice: Signora comare, dice, che peccato che vi abbiano rovinato quel bel vestito! Fatevelo accomodare. Insegnatemi una buona sarta, dico. Signora sì, dice, andate dalla tale, e così m’ho fatto insegnare dove sta di casa. BEAT. E siete andata stamattina, e avete saputo del lapis philosophorum. ELEON. Aspettate. Non mi confondete. Ho mandato a chiamare questa brava sarta. È venuta. Le ho fatto vedere il vestito, me l’ha provato, e si è posta le mani nei capelli quando l’ha veduto rovinato in quella maniera. Sì davvero! BEAT. Ma quando veniamo alla conclusione? ELEON. Subito. Lasci fare a me, dice, signora Eleonora, che glielo farò che le anderà dipinto. Ha preso il vestito, e l’ha portato via. Indovinate? Sono quindici giorni ora, e non me lo ha ancora portato. Queste sarte sono fatte così: promettono, promettono, e non mantengono mai. Mi fanno una rabbia terribile! BEAT. Ma via, veniamo al fine. Levatemi questa curiosità. ELEON. Quando mi ricordo della sarta, mi vengono i sudori. ROS. Non discorrete più della sarta, venite alla sostanza del fatto. ELEON. Sì; ora vi dirò come ho saputo del lapis. Questa sarta sta di casa… vicino… Conoscete quella donna che vende il latte? Quella che suo marito faceva il caciaiuolo? BEAT. Via, sì, sì, andiamo avanti. ELEON. Oh bene. La sarta sta tre porte più in là, verso la strada, prima d’arrivare al fornaio. ROS. In verità, signora Eleonora, voi mi fate venir male. ELEON. Ma le cose bisogna dirle per ordine. Sappiate dunque… COR. Uh signora padrona! (a Beatrice) BEAT. Che c’è? COR. Ho saputo ogni cosa. BEAT. Di che? COR. Della casa sì fatta… so tutto.
SCENA SESTA CORALLINA e dette. ELEON. Eh, lo sappiamo prima di voi. Fanno il lapis philosophorum. COR. Eh! per l’appunto! BEAT. E che sì che giuocano? COR. Signora no. ROS. Avranno delle donne. COR. Nemmeno. Ho saputo tutto. Ma… zitto. BEAT. Zitto. (alle altre) COR. Vogliono… ma per amor del cielo… ROS. Via, che occorre! COR. Vogliono cavar un tesoro. BEAT. Eh via! COR. E fanno un mondo di stregherie. ROS. Davvero? COR. È così certamente. Lo so di sicuro. ELEON. Ho sentito dire ancor io, che fanno l’oro disputabile[ref]Vuol dire potabile e dice uno sproposito.[/ref]. Vorrà dire cavar tesori. BEAT. Sì, sì, sarà vero. ROS. Oimè! Mi vien freddo. ELEON. Come lo avete saputo? (a Corallina) COR. Vi dirò; ma… zitto. È stato poco fa quel poveretto che viene tutti li venerdì… ELEON. Non andate per le lunghe. COR. Oh io non son di quelle. Sapete che questi poveri si cacciano per tutto. E così, dico, zoppo, dove sei stato, che sono tanti giorni che non ti vedo? Sono stato, dice, ad aiutare a cavare una certa fossa, vicino a una certa casa… Io subito sono andata al punto.
SCENA SETTIMA ARLECCHINO e dette. ARL. Presto. Andemo a tavola, che l’è qua el padron. BEAT. Dove è stato sinora? ARL. Oh bella! Al logo solito. BEAT. Ma che cosa fanno in quel maladetto ridotto? ARL. Domandeghelo a lu, che lo saverì. BEAT. Vieni qui, senti. (ad Arlecchino) ARL. Son qua. BEAT. (Giuocano?) (piano ad Arlecchino) ARL. Siora sì. BEAT. (L’ho detto io). (da sé) ROS. (Dimmi, si divertono con le donne?) (piano ad Arlecchino) ARL. Siora sì. ROS. (Ah, il cuore me l’ha detto). (da sé) ELEON. Galantuomo. (ad Arlecchino) ARL. Siora. ELEON. (È vero che fanno il lapis philosophorum?) (piano) ARL. Siora sì. ELEON. (Eh, io lo so). (da sé) COR. Dimmi, Arlecchino. ARL. Cossa volì? COR. (Lo cavano poi questo tesoro?) (piano ad Arlecchino) ARL. Siora sì. COR. (Dunque ho detto la verità). (da sé) ARL. (A dir sempre de sì, se dà gusto a tutti). (da sé) ELEON. Dite, Arlecchino. Mio marito l’avete veduto? ARL. Siora sì. ELEON. E ora è andato a casa? ARL. Siora sì. (Sempre de sì, finché vivo). (da sé, e parte) ELEON. Vado subito anch’io. Amiche, se saprò qualche altra cosa, verrò subito a confidarvela. BEAT. Ma quella del lapis non è poi vera. ELEON. Non è vera? Anzi verissima: dalla sarta vi era il fratello del garzone del muratore, e ha detto che il padrone di suo fratello è andato nel casino a fare dei fornelli, e poi hanno fatto una provvisione di tanti vetri; e ha detto il compare della sarta, che coi fornelli e coi vetri si fa il lapis philosophorum. E la sarta è una donna che se ne intende; e io, quando dico una cosa, non fallo mai. (parte) COR. Credetemi, non sa quello che si dica. Coi fornelli si cucina anche da mangiare, e coi vetri si dà da bere. Lo zoppo mi ha detto che cavano una fossa, e ho sentito dire da tanti, che vicino a quella casa vi sia un tesoro, e senz’altro lo cavano; e io, quando parlo, parlo con fondamento, e dico sempre la verità. (parte) BEAT. Io credo che non sappiano niente affatto. ROS. Vogliono che sia tutto quello che si figurano. BEAT. Mi par di vederli con le carte in mano. ROS. Ed io son tanto certa che fanno all’amore, quanto son certa d’aver da morire. (parte)
SCENA OTTAVA BEATRICE, poi OTTAVIO BEAT. Anch’ella è ostinata. Ma vedranno che io sola l’ho indovinata. Ecco il giocatore vizioso. OTT. Signora, fintanto ch’io faccio un certo conto, date gli ordini per la tavola. (siede al tavolino) BEAT. Volete fare il conto di quanto avete perduto? OTT. Vi è Florindo a pranzo con noi; fate qualche cosa di più. BEAT. Sì, sì, fate degli inviti? Avrete vinto. OTT. Quattro e sedici, dieci e quindici. (scrivendo) BEAT. So, so, che cosa si fa in quelle stanze segrete. OTT. Sì? L’ho caro. (scrivendo) BEAT. Voi rovinate la vostra casa. OTT. Eh, signora no. (scrivendo) BEAT. Il giuoco è il precipizio delle famiglie. OTT. Non si giuoca. (scrivendo) BEAT. Non si giuoca? OTT. No, da galantuomo; cinque e due sette. (scrivendo) BEAT. Dunque che cosa si fa? OTT. Niente di male. (scrivendo) BEAT. Se non vi fosse niente di male, vi potrebbe venire anche vostra moglie. OTT. Allora vi sarebbe del male. (scrivendo) BEAT. Sì, eh? Uomo indiscreto! OTT. Quattro via quattro sedici… (scrivendo) BEAT. Sia maladetto quando vi ho preso. OTT. È tardi. (scrivendo) BEAT. Come tardi? OTT. Dico che andiamo a pranzo, che è tardi. BEAT. Sono anche a tempo d’andarmene da voi, e lasciarvi solo. OTT. Oh, mi fareste la gran carità. (scrivendo) BEAT. La mia dote. OTT. Nulla via nulla, nulla. (scrivendo) BEAT. Che nulla? OTT. Io faccio i miei conti. Non vi abbado. (scrivendo) BEAT. Voglio sapere in quella casa che cosa si fa. OTT. Si sta bene, per servirla. BEAT. Siete una compagnia di gente cattiva. OTT. Le donne non ci vengono. BEAT. Le donne sono cattive? OTT. Oibò; dico che da noi non ci vengono. BEAT. Se ci venissero, ogni sospetto saria finito. OTT. Le donne sospettano sempre. BEAT. Ma ci vuol tanto a dire si fa questo e questo? OTT. Non ci vuol niente. BEAT. Dunque via cosa si fa? OTT. Sedici e sei ventidue, e otto… BEAT. Otto diavoli che vi portino. (gli dà nel braccio) OTT. Oh, me l’avete rotto… il numero. BEAT. Che siate maladetto! OTT. Anche voi. (scrivendo) BEAT. Bestia! OTT. Come lei. (come sopra) BEAT. Pensate di volerla durar così? OTT. Il conto è fatto. (s’alza) BEAT. Che conto avete fatto? OTT. Sì, l’ho finito. BEAT. Così mi trattate? OTT. A pranzo, signora. BEAT. Uomo indegno! OTT. A riverirla a pranzo. (parte) BEAT. Indegnissimo! Non si scalda, non risponde e mi fa rodere dalla rabbia… Ah, quel maladetto ridotto, quel maladetto luogo rinchiuso! Voglio andarvi, voglio vedere, voglio sapere, se credessi di dover crepare. (parte)
SCENA NONA ROSAURA e FLORINDO ROS. No, lasciatemi stare. (fuggendo da Florindo) FLOR. Fermatevi, non mi fuggite. ROS. Voi non mi volete niente di bene. FLOR. Ma perché dite questo? ROS. Se mi voleste bene, mi direste quel che si fa in quella casa. FLOR. Ma ve l’ho detto. ridetto e riconfermato. Non si fa niente. ROS. Se non si facesse niente, non vi anderebbe nessuno. FLOR. Voglio dire, non si fa niente che meriti la vostra curiosità. ROS. Sì, sì, vi ho capito. Vi è il segreto: avrete impegno di non parlare. FLOR. No, da galantuomo. Non vi è segreto veruno. ROS. Se così fosse, mi direste la verità. FLOR. La verità ve la dico. Si discorre delle novità del mondo, si leggono dei buoni libri, si giuoca a qualche giuoco d’ingegno, senza l’interesse d’un soldo. Qualche volta si pranza, qualche volta si cena, si passano due o tre ore in buona società, da buoni amici, e si gode il miglior tempo di questo mondo. ROS. Fra questi divertimenti avete lasciato fuori il migliore. FLOR. Che vuol dire? ROS. Quello di passar il tempo colle signore. FLOR. Oh, qui v’ingannate. Donne non ve n’entrano assolutamente. ROS. Io non vi credo. FLOR. Ve lo giuro sull’onor mio. ROS. Compatitemi, non vi credo. FLOR. Rosaura, voi mi fate un torto che io non merito. ROS. Volete ch’io creda tutto quello che dite? FLOR. Così vi converrebbe di fare. ROS. Introducetemi a vedere una volta sola, e vi prometto che allora vi crederò. FLOR. Sì, la vostra fede avrebbe allora un gran merito. ROS. Io non so altro; se non vedo, non credo. FLOR. Per me vi soddisfarei volentieri. ROS. Che obbietto avete per non farlo? FLOR. Il divieto de’ miei compagni. ROS. Questo divieto è un cattivo segno. FLOR. Perché? ROS. Se non vogliono che si veda, vi sarà qualche cosa di brutto. FLOR. Che vorreste mai che ci fosse? ROS. Donne a tutte l’ore. FLOR. Se ci entrassero donne, il mondo lo vederebbe. ROS. Le farete entrare vestite da uomo. FLOR. Voi ci credete affatto discoli e scostumati. ROS. Se foste gente dabbene, non vi nascondereste così. FLOR. Ma che non si possa fare una unione di buoni amici, senza ch’ella venga perseguitata? ROS. Questa gran segretezza eccita con ragione il sospetto. FLOR. Qual è questa segretezza? Io dico la verità, non vi è niente. ROS. Maladetto sia questo niente! FLOR. Via, cara, credetemi. Non vi alterate. ROS. Lasciatemi stare. FLOR. Non trattate così il vostro sposo. ROS. Voi mio sposo? FLOR. Come? Non lo sono? ROS. No; andate, che non vi voglio. FLOR. Ma perché mai? ROS. Perché non mi volete dire la verità. FLOR. Questa è una cosa da farmi diventar matto. Quel che vi ho detto, è vero; ve lo giuro per tutti i numi del cielo. ROS. Giuramenti da uomini! Non vi credo. FLOR. Dunque? ROS. Dunque non vi voglio più. FLOR. Ah Rosaura, per pietà. ROS. Non vi è pietà, non vi è misericordia, andate. FLOR. Oh cielo! Dov’è andato quel tenero amore che avevate per me? ROS. Non lo sapete il proverbio? Crudeltà consuma amore. FLOR. Io crudele? Io che vi amo più di me stesso? ROS. Vi pare poca crudeltà, tormentare una donna come fate voi? FLOR. Tormentarvi? In qual modo? ROS. Colla più fiera, colla più terribile curiosità che si possa dare nel mondo. FLOR. Vi soddisfarei, se potessi. ROS. Sta in vostra mano il farlo. FLOR. Cara Rosaura… ROS. Via, son qui: volete dirmi la verità? FLOR. Non vi direi la bugia per tutto l’oro del mondo. ROS. Che cosa si fa là dentro? FLOR. Niente. ROS. Maladetto voi ed il vostro niente! (parte)
SCENA DECIMA FLORINDO, poi CORALLINA FLOR. Io amo teneramente Rosaura; ma non per questo voglio disgustare gli amici miei. Là dentro non la introdurrò mai; piuttosto, per non perdere l’amor suo, tralascerò di frequentare la compagnia: dopo la cena di questa sera, per non disgustare Rosaura, non vi anderò. COR. Favorisca, in grazia, che cosa ha la padroncina, che la vedo turbata? FLOR. Ella tormenta me, tormenta se medesima senza ragione. COR. Povera fanciulla! Vi vuol tanto a contentarla? FLOR. Ma come? COR. Dirle la verità; dirle quello che fate fra voialtri uomini in quella casa sì fatta. FLOR. Lo dico, e non lo crede. COR. Se le diceste la verità, la crederebbe. FLOR. Orsù, anche voi non mi fate venire la rabbia. Non fomentate la sua curiosità. COR. Per me non ci penso; già so tutto. FLOR. Quando sapete tutto, saprete che non si fa niente di male. COR. Anzi si fa del bene. FLOR. Ma ditelo a Rosaura; ditele che non istia a sospettare. COR. Per contentarla, bisognerebbe fare una cosa. FLOR. Che cosa? COR. Condurla a vedere. FLOR. I miei amici non vogliono donne; e poi, pare a voi che a una fanciulla onesta e civile convenisse andare dove non vi sono che uomini? COR. È verissimo, ma anche a ciò vi è il suo rimedio. Potrei venire io in vece sua, veder tutto, e saperle dire la verità. FLOR. Ma se non entran donne. COR. Potrei venire travestita da uomo. FLOR. Io credo che siate più curiosa della vostra padrona. COR. Oh, pensate! se so tutto io; non ho curiosità. Faccio solo per metter in quiete la signora Rosaura. Quando le dirò: signora, ho veduto, la cosa è così; mi crederà, starà in pace e non tormenterà più nemmeno voi. FLOR. Questa cosa non si può fare. COR. E se non si può fare questa, non si potrà fare nemmeno quell’altra. FLOR. Che vuol dire? COR. Le vostre nozze colla signora Rosaura. FLOR. Ma perché? COR. Perché ella è impuntata così. Vi crede poco, e se io non l’assicuro della verità, non ne vuol più sapere. FLOR. E dovrei pormi a rischio di disgustar tanti galantuomini, per dar a lei una sì ridicola soddisfazione? COR. Eh signore, si vede che non le volete bene. FLOR. L’amo più di me stesso. COR. Quelli che amano veramente, farebbero altro per la loro bella! FLOR. Quando penso che per darle soddisfazione dovrei mancar alla mia parola, son un uomo d’onore, non ho cuore certamente di farlo. COR. Non so che dire, siete un giovine delicato, e vi compatisco; ma pure vorrei vedere di servire a lei, e servire a voi nello stesso tempo. FLOR. Via, pensate voi al modo… COR. Facciamo così: diamo ad intendere alla signora Rosaura che io sono stata, che io ho veduto, che io so tutto; e in questa maniera, confermandole tutto quello che dite voi, crederà, si acquieterà, sarete entrambi contenti. FLOR. Bravissima! Voi siete una giovine di giudizio. COR. Guardate se mi preme di farvi piacere! mi sottometto a dire delle bugie: cosa che non farei per mille scudi. FLOR. Non so che dire; quando le bugie tendono ad onesto fine, e non recano danno a nessuno, si possono anche tollerare. COR. Basta, mi sforzerò. FLOR. E per la fatica che voi farete, non sarete di me scontenta. COR. Sopra di ciò parleremo. FLOR. Corallina, addio. COR. Sentite. Non vorrei che la signora Rosaura mi potesse convincere di falsità. Vorrei poter sostenere, che veramente ci sono stata. FLOR. Si va fuori di casa, e le si dice di essere stata. COR. Per esempio, a che ora? FLOR. Che so io? Verso mezzogiorno. La sera ancora. COR. Questa sera vi è riduzione? FLOR. Sì, questa sera vi è. Questa sera si cena. COR. A che ora? FLOR. Si anderà alle due. Si starà sino alle cinque almeno. COR. Buono! Questa sera anderò da un’amica, e potrò dirle di essere stata lì. FLOR. Bravissima, ci rivedremo. (vuol partire) COR. Favorite: se mi domandasse, per esempio, la casa come è fatta? Vorrei saperle dir qualche cosa. FLOR. Che cosa le vorreste dire? COR. Per esempio. Alla porta si batte, si suona? Come si entra in casa? FLOR. Ciascheduno di noi ha la chiave. COR. Dunque anche il padrone avrà la sua chiave. FLOR. Sicuramente, il signor Ottavio l’ha come gli altri. COR. (Ho piacer di saperlo). (da sé) È maschia o femmina questa chiave? FLOR. È femmina, ma con gran quantità di ordigni, che non è possibile trovarne un’altra. Il signor Pantalone fa venir queste chiavi da Milano; qui non vi è nessuno che sappia farle. COR. Fa bene, per maggior sicurezza. Ma vorrei pur dirle qualche cosa di più. Per esempio, la scala è subito dentro della porta? FLOR. Non vi è scala. È un appartamento terreno, la di cui porta trovasi nell’entrata a mano dritta. COR. Anche la porta dell’appartamento sarà chiusa con gelosia. FLOR. Certamente, e anche di quella abbiamo le chiavi, le quali ordinariamente si portano unite a quelle dell’uscio di strada. COR. Quante camere vi sono? FLOR. Tre camere e la cucina. COR. Vi sarà qualche dispensa, qualche camerino. FLOR. No; non vi è altro. Ma voi volete saper troppo. COR. Niente. Domando così, per poter fingere di esservi stata. Per esempio. Camini ve ne sono? FLOR. Sì, ogni camera ha il suo camino. COR. Letti ve ne sono? FLOR. Letti? Non ci si dorme. COR. Ma dove pongono i loro ferraiuoli? i loro cappelli? FLOR. Oh, abbiamo i nostri armadi, dove si ripone ogni cosa. COR. Armadi grandi, di quelli dove si attaccano li vestiti? FLOR. Sì, di quelli; ma voi siete troppo curiosa. COR. Io curiosa? Non ci penso nemmeno. Fo per poter dire sono stata. Dove cenano? Nell’ultima camera? FLOR. Sì, nell’ultima. Addio. Non voglio che il signor Ottavio mi aspetti. (parte)
SCENA UNDICESIMA CORALLINA sola. COR. Vada pure, che per ora mi basta. Se posso buscar le chiavi al padrone, se posso introdurmi, nascondermi e non essere veduta, vedrò se cavano il tesoro, o se fanno qualche altra faccenda. Non vogliono donne! Bisogna che vi sia del male. Noi altre donne siamo il condimento delle conversazioni; e dove non possono entrar le donne, ho paura… ho paura… Basta, la cosa è strana, sono curiosa, e a costo di tutto, voglio cavarmi di dosso questa terribile curiosità. (parte)
ATTO SECONDO SCENA PRIMA Camera in casa di Lelio, con tavolino su cui evvi il di lui vestito. ELEONORA sola. ELEON. Oh che bestia è quel mio marito! Con lui non si può parlare. Subito alza la voce. Ma gridi, strepiti, faccia quanto sa e quanto vuole, mi ha da dire quel che si fa in quella casa, o me ne vado a star con mia madre. Mi dispiace che sul più bello è venuto il fattore! Non ho potuto dirgli l’animo mio; ma anderà via il fattore, e mi sfogherò. Frattanto, giacché qui è il vestito che Lelio aveva attorno questa mattina, voglio un poco vedere, se nelle tasche vi è qualche cosa, da fare qualche scoperta. Queste cose non le fo mai. Per natura io non sono curiosa, ma questa volta sono proprio impuntata. (visita le tasche del vestito) Questo è il suo fazzoletto… Vi è un nodo! Perché mai lo avrà fatto? Sarei ben curiosa di sapere che cosa voglia dir questo nodo. Chi sa? Può anche darsi che io lo sappia. E queste che chiavi sono? Non le ho più vedute. In casa certamente non servono. Oh, adesso sì che mi metto maggiormente in sospetto. Se Lelio non mi dice che chiavi sono, attacchiamo una lite. Questo è un viglietto. Leggiamolo un poco: vediamo a chi va, e chi lo manda. Al Signor Padron colendissimo il Signor Lelio Scarcavalli. Sue riverite mani. Vediamo chi scrive. Vostro vero amico Pantalone de’ Bisognosi. Sì, uno di quelli della conversazione segreta. Vi mando le due chiavi nuove, avendo per maggior sicurezza fatte cambiar le serrature, dopo che il mio servitore ha perse le chiavi vecchie. Dimattina all’ora solita v’aspettiamo. Addio. Oh bella! Queste sono le chiavi del luogo topico. Che bella cosa sarebbe rubargliele! e poi all’improvviso andarli a trovar sul fatto! Ma saranno le nuove, o le vecchie? Quando è scritto il viglietto? Ai 20. Oh, sono le nuove senz’altro. Eccolo, eccolo. Queste non gliele do più. (mette il viglietto in tasca di Lelio, e ripone le chiavi nelle sue) SCENA SECONDA LELIO e detta. LEL. Il servitore non è ancora tornato? ELEON. Se fosse tornato, lo vedreste. LEL. Che graziosa risposta! ELEON. A proposito della vostra domanda. Vedete che il servitore non c’è, e a me domandate se è ritornato. LEL. Domando a voi, per sapere se ve ne siete servita, se l’avete mandato in qualche luogo. Mi pare impossibile che non sia ritornato. ELEON. In quanto a quell’asino, quando si manda in un servizio, non torna mai. LEL. Ho d’andar subito fuori di casa. Ho bisogno d’esser vestito. ELEON. L’abito è qui, vi potete vestire. LEL. Aiutatemi. (si cava la veste da camera) ELEON. Potreste dirlo con un poco più di maniera. LEL. Favorisca d’aiutarmi. (con ironia) ELEON. Dove si va così presto? (gli mette l’abito) LEL. Vado dove mi occorre, signora. ELEON. Sì, sì, anderete a soffiare. LEL. A soffiare! Sono io qualche spione? ELEON. Bravo. Fingete di non intendere. Anderete a soffiare nelli fornelli. LEL. Che fornelli? non vi capisco. ELEON. Mi è stato detto che in quel vostro luogo segreto fate il lapis philosophorum. LEL. Che lapis! Siete una pazza voi e chi ve lo dice. ELEON. Ma dunque che cosa fate là dentro? LEL. Niente. ELEON. Assolutamente voglio saperlo. LEL. Assolutamente non ne saprete di più. ELEON. Farò tanto che lo saprò. LEL. Eleonora, abbiate giudizio. ELEON. Voglio saperlo, e lo saprò. LEL. Non fate che mi venga il mio male. ELEON. Oh se lo saprò! LEL. Signora Eleonora… ELEON. Padrone mio… LEL. Vuol favorire di mutar discorso? ELEON. Lo saprò. LEL. Se lo dite un’altra volta, ve ne fo pentire da galantuomo. ELEON. Voi non vorreste ch’io lo sapessi. LEL. E voi… ELEON. Ed io… lo saprò. LEL. (Vuol darle uno schiaffio, ella si ritira) ELEON. Sì, a vostro dispetto lo saprò. (allontanandosi) LEL. E che sì, che vi rompo le braccia. ELEON. Ma lo saprò. (come sopra) LEL. Giuro al cielo… (le corre dietro) ELEON. Lo saprò lo saprò, lo saprò. (si chiude in una camera) LEL. È meglio che me ne vada, sento che la bile m’affoga. (vuol partire) ELEON. (Apre la porta e mette fuori la testa) Sì, maladetto, lo saprò. LEL. (Prende una sedia per dargliela nella testa) ELEON. Lo saprò. (chiude) LEL. Bestia! Mi sento che non posso più. No, no, non lo saprai. No. (alla porta) No, diavolo, non lo saprai. No, bestia, non lo saprai, no. ELEON. (Da un’altra porta) Sì, sì, lo saprò. (e chiudendo parte) LEL. Non posso più. (parte)
SCENA TERZA Camera in casa di Ottavio. BEATRICE e CORALLINA COR. Presto, signora padrona, che se non parlo, mi viene tanto di gozzo. BEAT. Via, parla. COR. Ho trovato la maniera di saper tutto. BEAT. Di che? COR. Della compagnia, delle camere, del casino. BEAT. Davvero! Come? COR. Tutti hanno le chiavi in tasca; bisognerebbe procurare di buscarle a qualcuno. BEAT. E poi? COR. E poi, so io quel che dico; sono informata di tutto: e son capace all’oscuro, ad occhi chiusi, introdurmi, nascondermi e saper tutto. BEAT. Mio marito le avrà? COR. Le avrà sicuramente, e le avrà nelle tasche, perché se ne servono tutto dì. Bisogna studiar il modo di fargliele sparire. BEAT. Se le ha ne’ calzoni, sarà difficile. COR. Non può averle ne’ calzoni, perché le chiavi delle porte saranno grosse. BEAT. Questa mattina è venuto tardi, e non si è nemmeno spogliato, come qualche giorno suol fare; bisognerà aspettar questa sera, quando va a letto. COR. No! il bello sarebbe scoprirli questa sera. Ho rilevato che questa sera fanno una cena. BEAT. Oh, quanto pagherei di vederli! COR. Bisogna studiare il modo. BEAT. Eccoli che vengono qui. COR. Studiate voi, che studierò ancor io.
SCENA QUARTA OTTAVIO,ROSAURA,FLORINDOedette. ROS. Badate a’ fatti vostri. (a Florindo) FLOR. Signor Ottavio, vedete come vostra figliuola mi tratta? OTT. Caro amico, mia figlia è donna come le altre. Avrà de’ momenti buoni, avrà de’ momenti cattivi. Fate come si fa del tempo. Godete il sereno, fuggite dal tuono; e quando tempesta, ritiratevi, ed aspettate che torni il sole. ROS. Il signor padre sa dar dei buoni consigli. BEAT. Mio marito è fatto a posta per far venire la rabbia. OTT. Signora Corallina, signora cameriera di garbo, quest’oggi non ci favorisce il caffè? COR. Il caffè è pronto, signore, lo vuole qui? OTT. Giacché non ce lo avete portato a tavola, lo beveremo qui. COR. Subito. (Signora, portatevi bene. Se abbiamo le chiavi, siamo a cavallo). OTT. Rosaura, che cosa vi ha fatto il vostro sposo? ROS. Niente, signore. OTT. Non v’ha fatto nulla, e lo guardate sì bruscamente? ROS. Ho dei momenti cattivi. OTT. Amico, il cielo è torbido. Aspettate il sole. (a Florindo) ROS. Questo sole non tornerà così presto. OTT. Sì, ritornerà, quando sarà tramontata la luna. BEAT. Oggi perché non vi spogliate? Perché non vi mettete in libertà come il solito? Il signor Florindo è di casa, non è persona di soggezione. (ad Ottavio) OTT. Ho da uscir presto. Non voglio far due fatiche. BEAT. Avete da uscir presto, eh? Dove avete d’andare? OTT. Vuol anche sapere dove ho d’andare? BEAT. Mi pare che alla moglie si potrebbe dire. OTT. Sì, una moglie così compita merita bene che io glielo dica! Devo andare a render la visita a quel cavaliere che è stato ieri da me. BEAT. Pare a voi che quell’abito sia a proposito per una visita di soggezione? Dovreste metterne un altro migliore. OTT. Eh io non bado a queste piccole cose. BEAT. Sapete che questi signori mezzi gentiluomini ci stanno su questi cerimoniali. Dirà che vi prendete con lui troppa confidenza. OTT. Dica ciò che vuole: io non ci penso. BEAT. (Già; basta che io dica una cosa, perché non la voglia fare). (da sé) OTT. Florindo mio, voglio che presto si concludano queste nozze. BEAT. (Non faremo niente). (da sé) FLOR. Per me son pronto, ma la signora Rosaura non mi vuol bene. ROS. Vi vorrei bene, se foste un uomo sincero. BEAT. Vi mutate quell’abito? (ad Ottavio) OTT. Signora no. (a Beatrice) Le avete detta qualche bugia? (a Florindo) BEAT. (Ecco come mi abbada). (da sé) FLOR. Io le ho sempre detta la verità; ed ella non mi vuol credere. OTT. Eh, non è niente. Un poco di curiosità, mescolata con un poco di ostinazione, è il sorbetto che sogliono dare le mogli. Passerà, non è niente. ROS. (Mio padre mi fa crescer la rabbia). (da sé) BEAT. Almeno, se non volete mettervi un altro vestito lasciate che vi spazzi questo. È tutto polvere. OTT. Sì, brava la mia cara moglie amorosa. Spazzatelo, che vi sarò obbligato. BEAT. Date qui. Cavatevelo, se volete che ve lo spazzi. OTT. No, no, dategli una spazzatina in dosso, non voglio fare questa fatica. BEAT. Così non si fa bene. Cavatevelo. OTT. No, cara, non v’incomodate, che non m’importa. BEAT. Ecco qui. Mai vuol fare a modo mio. OTT. Cara figliuola, non siate così puntigliosa. (a Rosaura) BEAT. (Or ora perdo la pazienza). (da sé) ROS. Signor padre, vi prego a lasciarmi stare. FLOR. È irritata meco senza mia colpa. OTT. Niente, niente, dopo un poco di sdegno, par più buona la pace. BEAT. Non ve lo volete cavare? (ad Ottavio) OTT. Signora no. BEAT. Siete una bestia. OTT. Ah? che dite? Ho io una moglie che mi vuol bene? Queste sono tutte parole amorose. Quanto paghereste che la vostra sposa vi facesse una di queste finezze? (a Florindo) FLOR. Io non amerei ch’ella mi strapazzasse. OTT. Io penso diversamente. Piuttosto che veder le donne ingrugnate, ho piacer, poverine, che si sfoghino. BEAT. È una cosa, con questa sua flemma, da venir etiche.
SCENA QUINTA CORALLINA che porta il caffè, e detti; poi un SERVITORE COR. Ecco il caffè. OTT. Via, beviamolo in pace, se si può. COR. (Avete fatto niente?) (piano a Beatrice) BEAT. (No, non mi basta l’animo di fargli cavar il vestito. (piano a Corallina) OTT. Sediamo. Il caffè si beve sedendo. Chi è di là? SERV. Comandi. OTT. Dammi da sedere. COR. (Col caffè si accosta ad Ottavio, dopo averlo dato al altri) SERV. (Porta le sedie, e nel metterne una presso ad Ottavio, Corallina finge le abbia dato nel braccio, e versa il caffè sul vestito di Ottavio) COR. Uh! meschina me! Perdoni. Mi ha urtato il braccio, non l’ho fatto a posta. OTT. Pazienza! Non è niente. COR. Subito. Vi vuole dell’acqua fresca. OTT. Sì, fate voi. COR. Presto, presto, dia qui. (gli leva il vestito) (Il colpo è fatto). (parte col vestito) OTT. Datemi qualche cosa, che non mi raffreddi. BEAT. Portategli il vestito. (al Servitore, il quale va per esso) OTT. Via sì, sarete contenta. BEAT. (Ha fatto Corallina quello che non ho saputo far io). (da sé) OTT. Mi dispiace aver perduto il caffè. Che me ne facciano un altro. BEAT. Vedete che vuol dire non fare a modo delle donne? OTT. Se faceva a vostro modo, era peggio: mi macchiavo l’altro vestito, che è di colore. BEAT. Se facevate a modo mio, questo non succedeva. OTT. Sentite, Florindo? Le nostre donne son profetesse. Felici noi, che possediamo un tanto tesoro!
SCENA SESTA Il SERVITORE, poi CORALLINA e detti. SERV. (Coll’altro vestito; lo mette ad Ottavio) OTT. Signora Beatrice, siete contenta? BEAT. Non ancora. (Ho paura che domandi le chiavi). (da sé) COR. Ecco, signore, il fazzoletto, la tabacchiera e le chiavi. (ad Ottavio) OTT. Bravissima! (ripone il tutto in tasca) BEAT. (Anche le chiavi?) (a Corallina, piano) COR. (Non son quelle, le ho cambiate). (piano a Beatrice) BEAT. (Il gran diavolo che è costei!) (da sé) OTT. Cara Corallina, io non ho bevuto il caffè. Ve ne sarebbe un altro? COR. In verità, signor padrone, di abbruciato non ve n’è. OTT. Pazienza! Lo anderò a bevere fuori di casa. BEAT. Lo andrete a bevere al vostro caro ridotto. OTT. Florindo, volete venire con me? FLOR. Farò quello che comandate. (osserva Rosaura) ROS. Mi guardate? Andate pure; io non vi trattengo. OTT. Amico, è meglio che andiamo. Lasciate che il temporale si sfoghi. Domani sarà buon tempo. ROS. Né domani, né mai. OTT. Mai buon tempo? Mai? Sempre nuvolo? Sempre tempesta? Ragazza mia, e che sì, che s’io suono una certa campana, faccio subito venir bel tempo? ROS. Come, signore? OTT. Sentite. Vi caccerò in un ritiro. Ah! che dite? ROS. Io in ritiro? BEAT. Mia figlia in ritiro? OTT. Andiamo, andiamo. Campana all’armi. Fuoco in camino. (parte)
SCENA SETTIMA BEATRICE, ROSAURA, FLORINDO e CORALLINA ROS. Sentite? Per causa vostra. (a Florindo) FLOR. Signora, io non ne ho colpa. BEAT. Mia figlia in ritiro? Se non avrà voi, non le mancheranno mariti. FLOR. Lo credo. Ma io non merito né i suoi, né i vostri rimproveri. BEAT. Andate, andate, che mio marito vi aspetta. FLOR. Partirò per obbedirvi. (in atto di partire) ROS. Bella cosa! Lasciarmi così. FLOR. Ma signora… (torna indietro) COR. (Lasciatelo andare, che vi ho da dire una bellisima cosa). (a Rosaura, piano) ROS. (Che cosa?) (a Corallina, piano) COR. (Mandatelo via. Ho le chiavi). (come sopra) ROS. (Sono in curiosità). (da sé) Basta, se volete andare, non vi trattengo. (a Florindo) FLOR. Resterò, se lo comandate. BEAT. No, no, servitevi pure. Mio marito vi aspetta. FLOR. Che dite, signora Rosaura? ROS. Se mio padre vi aspetta, andate. FLOR. Non mi aspetta per alcuna premura, posso ancor trattenermi. COR. (Mandatelo via). (a Rosaura, piano) ROS. (Non vorrei disgustarlo). (da sé) Andate, e poi tornate. (a Florindo) BEAT. Oh, che non s’incomodi. COR. Tornerà domani. FLOR. Tornerò per obbedirvi. Ma vi prego, abbiate pietà di me. (parte)
SCENA OTTAVA BEATRICE, ROSAURA e CORALLINA ROS. Non vorrei che si disgustasse. COR. Eh non dubitate, che tornerà. ROS. Che cosa avete da dirmi? BEAT. Dove sono le chiavi? COR. Eccole. ROS. Che chiavi? COR. Zitto. Le chiavi della casa segreta. Una della porta di strada, l’altra dell’appartamento. BEAT. Andiamo, andiamo. (a Corallina) ROS. Voglio venire ancor io. BEAT. A voi non è lecito. State in casa, e vi diremo tutto. ROS. Cara signora madre… BEAT. No, vi dico. Andiamo, Corallina. (parte)
SCENA NONA ROSAURA e CORALLINA ROS. Cara Corallina… COR. Non dubitate. Andrò io, vi saprò dir tutto. ROS. Quelle chiavi, come le avete avute? COR. Le ho buscate a vostro signor padre. ROS. Quando? COR. Non avete veduto il lazzo del caffè? Allora… ROS. Voglio venire ancor io. COR. La signora madre non vuole. ROS. Corallina, se tu mi vuoi bene… COR. Via, non siate così curiosa. Abbiate pazienza. Questa sera saprete ogni cosa. ROS. Sappimi dir se vi sono donne. COR. Eh, altro che donne. Il tesoro, il tesoro. (parte)
SCENA DECIMA ROSAURA sola. ROS. Mai in vita mia ho avuto maggior pena nel desiderare una cosa. Pazienza! Esse anderanno, e io no. Ma perché io no? Perché sono una fanciulla? E per questo perderei la riputazione? Finalmente, se andassi a spiare che fa il mio sposo, nessuno mi potrebbe rimproverare. Se sapessi come fare! Mia madre è difficilissima da lasciarsi svolgere. Quando fissa una cosa, non vi è rimedio.
SCENA UNDICESIMA FLORINDO e detta. FLOR. Deh perdonate… ROS. Voi qui? FLOR. Sì signora. Il vostro signor padre è stato fermato in casa del forestiere, che doveva egli medesimo visitare. Discorrono d’interessi, ed io mi sono preso l’ardire d’incomodarvi di nuovo. ROS. Meritereste ch’io vi voltassi le spalle. FLOR. Perché, signora? Che cosa vi ho fatto? ROS. Non mi volete dire la verità. FLOR. E siam qui sempre! Pagherei assaissimo, che poteste cogli occhi vostri assicurarvi della mia sincerità. ROS. Potete farlo quando volete. FLOR. Come? ROS. Introducendomi di nascosto. FLOR. Voi ardirete di venir sola? ROS. No, verrò colla serva. FLOR. Per un simile luogo, la serva non è compagnia che basti. ROS. Verrà mia madre. Se voi la pregherete, verrà. FLOR. Rosaura, compatitemi. Ve l’ho detto altre volte. I miei amici non vogliono donne; ed io non deggio… ROS. E voi non dovete disgustarli per me. Vedo che di essi più che di me vi preme, ed ecco il fondamento di credervi un menzognero, un infido. FLOR. Orsù, Rosaura, per darvi una prova dell’amor mio, tralascierò d’andarvi. Così sarete contenta. ROS. Mi darete ad intendere di non andarvi, ma vi anderete. FLOR. No, vi prometto, non vi anderò. ROS. Non mi basta. FLOR. Vi confermerò la promessa col giuramento. ROS. Non voglio giuramenti, voglio una sicurezza maggiore. FLOR. Chiedetela. ROS. Mi promettete di darmela? FLOR. Sì, quando ella da me dipenda. ROS. Ditemi… Ma badate bene di non mentire. FLOR. Non son capace. ROS. Avete voi le chiavi, come hanno gli altri? FLOR. Le chiavi di che? ROS. Delle porte di quella casa, dove non possono entrar le donne? FLOR. Sì, le ho, non posso negarlo. ROS. Questa è la sicurezza che pretendo da voi. Datemi quelle chiavi. FLOR. Ma… queste chiavi… nelle vostre mani… ROS. Ecco la bella sincerità! Ecco il fondamento delle vostre promesse, dei giuramenti vostri! FLOR. Non vedete, che s’io volessi ingannarvi, potrei darvi le chiavi, ed unirmi poscia con un amico per essere non ostante introdotto? ROS. Non credo che vogliate mendicar i mezzi per essere mentitore. Mancandovi le chiavi, vi manca, secondo me, l’eccitamento maggiore. Florindo, se mi amate, fatemi la finezza di depositarle nelle mie mani. FLOR. Ah Rosaura, voi mi volete indurre ad una cosa, che per molti titoli non mi conviene. ROS. Avete voi intenzione di andar in quel luogo, sì o no? FLOR. Certamente, vi prometto di no. ROS. Che difficoltà dunque avete a lasciarmi le chiavi? FLOR. Vi dirò… queste chiavi… se passassero in altre mani, potrebbero produrre degli sconcerti. ROS. Vi prometto sull’onor mio, che non esciranno dalle mie mani. Siete ora contento? Mi fareste l’ingiuria di dubitare di me? Vorrei vedere anche questa. FLOR. Cara Rosaura, dispensatemi. ROS. No certamente. Ecco l’ultima intimazione ch’io faccio al vostro cuore. O fidatemi quelle chiavi, o non pensate più all’amor mio. Se mi pento, se vi perdono, prego il cielo che mi fulmini, che m’incenerisca. FLOR. Basta, basta, non più. Tenete: eccole, non mi atterrite di più. ROS. Nelle mie mani saran sicure. FLOR. Vi prego, non mi rendete ridicolo co’ miei amici. ROS. Non dubitate, son contenta così. FLOR. Guardate, se veramente vi amo! ROS. Sì, lo credo; compatitemi se ho dubitato. FLOR. Quando posso sperare di farvi mia? ROS. Quando volete voi; quando vuole mio padre. FLOR. Volo a dirglielo, se vi contentate. ROS. Sì, ditegli che la tempesta è finita, che torna il sole. FLOR. Cara, mi consolate. ROS. Io sono più consolata di voi. Queste chiavi mi danno il maggior piacere del mondo. FLOR. Per qual motivo, mia cara? ROS. Perché con queste mi assicuro del vostro amore. (E con esse mi assicurerò forse di quel segreto, che mi fa vivere in una perpetua curiosità). (da sé, parte) FLOR. Gran cosa è l’amore! Tutto si fa, quando si vuol bene. Quelle chiavi le ho date a Rosaura colla maggior pena del mondo. Ma se le ho dato l’arbitrio della mia vita, posso anche fidarle le chiavi di una semplice conversazione. (parte)
SCENA DODICESIMA Strada con porta, che introduce nel casino della conversazione. PANTALONE esce dalla porta, e chiude. PANT. Xe squasi notte, e Brighella no vien. Bisognerà che vaga mi a proveder le candele de cera, e che le fazza portar.
SCENA TREDICESIMA LEANDRO e detto. LEAN. Servo, signor Pantalone. PANT. Amicizia. LEAN. Amicizia. (si abbracciano) PANT. Questo xe el nostro saludo. No se fa altre cerimonie. LEAN. Va benissimo. Tutti i complimenti sono caricature. PANT. Sì ben; se usa dir per civiltà delle parole, senza pensar al significato, senza intender, co le se dise, quel che le voggia dir. Per esempio, servitor umilissimo vuol dir me dichiaro de esser so servitor; ma se ghe domandè un servizio che no ghe comoda, el ve dise de no; e po el sior umilissimo ve tratta e ve parla con un boccon de superbia, che fa atterrir. Patron reverito xe l’istesso. I dà del patron a uno che no i se degna de praticar. LEAN. Signor Pantalone, un mio amico vorrebbe essere della nostra conversazione. PANT. Xelo galantomo? LEAN. Certamente. PANT. A pian co sto certamente. Dei galantomeni de nome ghe ne xe assae, de fatti ghe ne xe manco. Che prove gh’aveu che el sia un galantomo? LEAN. Io l’ho sempre veduto trattare con persone civili. PANT. No basta. In tutte le conversazion civili, tutti no xe galantomeni, e col tempo i se descoverze. LEAN. È nato bene. PANT. No xe la nascita che fazza el galantomo, ma le bone azion. LEAN. È uomo che spende generosamente. PANT. Anca questa la xe una rason equivoca: bisogna véder se quel che el spende xe tutto soo. LEAN. Io poi non so i di lui interessi. PANT. Donca no ve podè impegnar che el sia galantomo. LEAN. In questa maniera, signor Pantalone, avremo tutti in sospetto, e non praticheremo nessuno. PANT. No, caro amigo, intendème ben. No digo che abbiemo da sospettar de tutti senza rason, e che no abbiemo da praticar se no quelli che conossemo galantomeni con rason; anzi avemo debito de onestà de creder tutti da ben, se no gh’avessimo prove in contrario. Quelli però che più che tanto no se cognosse, i se pratica con qualche riserva; no se ghe crede tutto, i se prova, i se esamina con delicatezza, e se col tempo e coll’esperienza se trova un galantomo da senno, se pol dir con costanza de aver trovà un bel tesoro. LEAN. Io questo che vi propongo lo credo onoratissimo, ma non posso essere mallevadore per lui. PANT. N’importa, lo proveremo: se el sarà oro el luserà.
SCENA QUATTORDICESIMA BRIGHELLA e detti. BRIGH. Èla ella, sior padron? PANT. Sì, son mi. Tanto ti sta? BRIGH. Son pien de roba, che no me posso mover. PANT. Astu tolto candele de cera? BRIGH. Sior no, non ho avù tempo. PANT. Adesso anderò mi a ordinarle dal nostro spizier. E vu, co podè, andè a torle. (a Brighella) BRIGH. Sior sì; metto zo sta roba, e vado subito. Son pien per tutto, no so come far a avrir. PANT. Caro sior Leandro, la ghe averza la porta. LEAN. Volentieri. (apre) BRIGH. Ho speranza stassera de farme onor. PANT. Distu da senno? BRIGH. La vederà che boccon de cena. PANT. Bravo, gh’ho a caro. BRIGH. Ma i se n’incorzerà in ti conti. (entra) PANT. N’importa. Co xe ben fatto, spendo volentiera. LEAN. Signor Pantalone, posso dunque dire all’amico che venga? PANT. Chi xelo? Cossa gh’alo nome? LEAN. È un certo Flamminio Malduri. PANT. Benissimo, lo proponeremo. Sentiremo cossa che dise i altri. LEAN. Vorrei condurlo alla cena. PANT. La lo mena; sul fatto se rissolverà. LEAN. Vado a ritrovarlo. Spero che resterete contento. Amicizia. (parte) PANT. Amicizia. Mi no gh’ho altra premura, che de véder in te la nostra compagnia zente onesta, de buon cuor, amorosa, che in t’una occasion sappia soccorrer un amigo. Tutti a sto mondo gh’avemo bisogno un dell’altro, e i xe tanto pochi quelli che fazza ben per bon cuor, che a trovarghene xe più difficile d’un terno al lotto. (parte)
SCENA QUINDICESIMA ELEONORA col zendale alla bolognese. ELEON. L’ora è avanzata. Voglio vedere se mi riesce il colpo. Quella è la porta, e queste sono le chiavi. Se posso entrare, nascondermi, e vedere senz’esser veduta mi chiarirò d’ogni cosa. E se sarò scoperta, che cosa mi potranno fare? Dove va mio marito, vi posso andare, ancor io; anzi tutti mi loderanno. Se vado, non vado per altro fine che per questo. Voglio bene al marito, e voglio sapere dove va e che cosa fa: sì, lo voglio sapere. Tante volte gli ho detto: lo saprò. Voglio poter dire una volta: l’ho saputo. Non sento nessuno, adesso mi provo. (mette la chiave nella serratura)
SCENA SEDICESIMA BRIGHELLA di casa, e detta. BRIGH. Chi è là? (apre l’uscio, ed Eleonora spaventata si ritira) ELEON. Povera me! Ho perduto le chiavi. (parte lasciando le chiavi) BRIGH. Una donna? Colle chiave? Corro dal me padron. (chiude la porta, leva le chiavi, e parte)
SCENA DICIASSETTESIMA CORALLINA vestita da uomo e BEATRICE col zendale alla bolognese. BEAT. Altro che dire non entran donne! Hai veduto? Quella che è uscita, è una donna. (avendo osservato Eleonora) COR. Assolutamente vi è qualche porcheria. BEAT. Presto, entriamo anche noi, e vediamo se ve ne sono altre. COR. Andiamo; ecco la chiave. Ma zitto… sento gente. BEAT. Non vorrei che fossimo scoperte prima d’entrare. Entrate che siamo, non m’importa. Quando abbiamo saputo ogni cosa, che ci scoprano pure, ma se ci vedono qui… COR. Ritiratevi. BEAT. E tu non vieni? COR. Io son vestita da uomo. È sera; non mi conosceranno. BEAT. Bada bene non m’ingannare. COR. Fidatevi di me. BEAT. Ti aspetto in questo vicolo. (si ritira) COR. (Ho del coraggio, ma tremo un poco). (da sé)
SCENA DICIOTTESIMA PANTALONE e dette. PANT. (Una donna colle chiave? la voleva andar drento? Coss’è sta cossa? Chi èlo el poco de bon, che colle donne vol ruvinar la nostra povera compagnia! Vedo uno là: che el sia dei nostri?) (osservando Corallina) COR. (Mi pare quello che chiamano Pantalone). (da sé) PANT. Amicizia. (forte verso Corallina) COR. (Che dice d’amicizia?) (da sé, non rilevando il gergo) PANT. (O che nol ghe sente, o che nol xe della compagnia). (da sé) Amicizia. (s’accosta a Corallina, ripetendo il termine) COR. Sì signore. (alterando la voce) PANT. (Nol xe della conversazion. Ma cossa falo in sti contorni?) (da sé) COR. (Non vorrei essere scoperta). (da sé) PANT. Cossa fala qua, patron? Aspettela qualchedun? (a Corallina) COR. Aspetto un amico. PANT. L’aspetta un amico? (fa il falsetto, imitando la voce di Corallina) (O che l’è un musico, o che l’è una donna). (da sé) COR. (È meglio ch’io me ne vada). (da sé) PANT. (Vôi véder cossa xe sto negozio). (da sé) La diga patron, chi aspettela? COR. Niente, signore, la riverisco. (vuol partire) PANT. Xela fursi anca ella uno de quei della compagnia de sti galantomeni? COR. Sì signore. PANT. Mo perché donca, co ghe digo amicizia, no me rispondela amicizia? COR. Ah sì, non vi avevo inteso. Amicizia. PANT. (Eh, la xe una donna; cossa diavolo xe sto negozio!) Perché no vala drento? (a Corallina) COR. Aspettava il signor Ottavio. PANT. Tutti gh’ha le so chiave. No la le gh’ha ella? COR. Oh sì signore, le ho ancor io. PANT. La lassa véder mo. COR. Che serve? le ho. PANT. Co no la le mostra, xe brutto segno. COR. Eccole. (fa vedere le chiavi) PANT. Via donca, la resta servida: la vaga in casa. COR. Andate voi, che or ora verrò ancor io. PANT. Mi gh’ho un pochetto da far. Vago in t’un servizio e po torno. La vaga ella. COR. Farò come comandate. PANT. (Vôi ben véder dove va a finir sto negozio). (da sé) COR. Va ella? o vado io? PANT. La vaga pur ella. Amicizia. COR. Amicizia. PANT. (Nell’accostarsele, afferra le chiavi in mano a Corallina) COR. Come, signore? (si difende) PANT. Chi v’ha dà ste chiave? Chi seu? Cossa voleu? COR. Amicizia. PANT. Colle donne no vôi amicizia. COR. Sono scoperta. Aiutami, gambetta. (parte correndo) PANT. A rotta de collo! Ti gh’ha rason, che no gh’ho voggia de correr. Come xelo sto negozio? Do mue de chiave fora de man? Ste chiave in man de do donne? Donne introdotte in te la nostra conversazion? A monte tutto; fogo a tutto; no ghe ne vôi più saver. (entra in casa, e chiude)
SCENA DICIANNOVESIMA OTTAVIO e LELIO LEL. Ho piacere d’avervi trovato. Ho perso le chiavi, e non so dove e non so dir come; appunto stavo in attenzione di qualche amico che aprisse. OTT. Vi servirò io. Ma, caro amico, tenetene conto di quelle chiavi. Il povero signor Pantalone di quando in quando, se si perdono, le fa mutare. LEL. Eh! ho un sospetto in testa. OTT. Di che? LEL. Ho paura che me le abbia prese mia moglie; se ciò è vero, da galantuomo, le do un ricordo per tutto il tempo di vita sua. OTT. Oibò, non v’inquietate. Soffritela, se potete, e se non potete, mandatela al suo paese. LEL. Se sapeste quanto mi ha fatto arrabbiare con un maladetto lo saprò. OTT. Oh via, andiamo.
SCENA VENTESIMA FLORINDO e detti. OTT. Oh, ecco un altro camerata. Amicizia. LEL. Amicizia. FLOR. Amicizia. Appunto veniva in traccia di voi. OTT. Sì, andiamo insieme. FLOR. No, cercavo appunto di voi per far le mie scuse, e pregarvi di farle col signor Pantalone. Questa sera non vengo. OTT. No? Per qual causa? LEL. Tant’e tanto, se non venite, pagherete la vostra parte. FLOR. Sì, pagherò: è giusto. OTT. Diteci almeno il perché non venite. FLOR. Ho un affar di premura. Questa sera non posso. OTT. Oh via, ho capito. Non viene, perché ha paura. LEL. Ve lo ha proibito la sposa? FLOR. Non me lo ha proibito: ma posso far meno per soddisfarla? OTT. Bravo, genero. Io vi lodo, che siate compiacente con mia figliuola, ma voglio darvi un avvertimento: non vi lasciate prender la mano sì di buon’ora, perché poi ve ne pentirete. Le donne dicono volentieri quella bella parola voglio; e quando si fa loro buona una volta, non la tralasciano più. FLOR. Non so che dire. Questa volta ho dovuto fare così; un’altra volta poi… OTT. Oh via, regolatevi con prudenza. Amico Lelio, andiamo, e lasciamo in pace questo povero innamorato. (cerca la chiave) LEL. Eh amico, quando sarete ammogliato, vedrete il bel divertimento! Se vi tocca una moglie come la mia, volete star fresco. OTT. Che chiavi sono queste? LEL. Non sono le vostre chiavi? OTT. Oibò. Ora me ne accorgo; Corallina, nel darmi le chiavi, ha errato. Questa è quella della cantina, e questa è quella della dispensa. Come diavolo le aveva io in tasca di quell’altro vestito? Non la so capire. LEL. Come faremo a entrare? Bisognerà battere. OTT. Ci favorirà il signor Florindo. Ci darà egli le sue. FLOR. Mi dispiace… ch’io non le ho. OTT. Oh bellissima! LEL. Che cosa ne avete fatto? FLOR. Sapendo che io non veniva questa sera, le ho serrate nel mio burrò. OTT. Vedete, egli è un giovine di garbo; custodisce le chiavi, non le perde come fate voi. (a Lelio) LEL. E voi le lasciate in balìa delle donne. OTT. Questo è un bel caso: tutti tre senza chiavi. LEL. Bisogna battere. OTT. Sì, battiamo. (battono)
SCENA VENTUNESIMA PANTALONE esce di casa, e detti. PANT. Coss’è, siori, no le gh’ha chiave? LEL. Io l’ho perduta. OTT. Ed io l’ho lasciata in casa. PANT. Le varda mo, ghe saravele qua le soe? LEL. Corpo di bacco! Ecco le mie. OTT. Oh bella! Ecco le mie. PANT. Le impara a custodirle. Le impara meggio a mantegnir la parola; e le se vergogna de prostituir el decoro alle lusinghe, alle curiosità delle donne. (entra) LEL. Come! Che dite? Cospetto! Cospettonaccio! Mia moglie l’ammazzerò. (entra) OTT. (Fa varie ammirazioni colle chiavi ed entra)
SCENA VENTIDUESIMA FLORINDO solo. FLOR. Che imbrogli sono mai questi? Fra quelle chiavi vi sarebbero mai le due che ho dato a Rosaura? No, perché essi due le hanno per le loro riconosciute; e poi Rosaura capace non sarà di tradirmi. Certamente queste donne ardono di volontà di sapere… Vedo gente… Colui colla lanterna è Arlecchino. Vi è una donna in zendale con lui; che sia forse la signora Beatrice, in traccia di suo marito? Vuò rimpiattarmi ed osservare. (si ritira)
SCENA VENTITREESIMA ROSAURA in zendale alla bolognese, ARLECCHINO con lanterna da mano, FLORINDO ritirato. ROS. Vieni con me, non aver paura. ARL. Ma mi, siora, in sta sorte de contrabbandi me trema le budelle in corpo. ROS. Insegnami solamente dov’è la porta di quella casa che già ti ho detto. ARL. La porta l’è quella lì. ROS. Tu ci sarai stato dentro più volte. ARL. Sigura. Ghe vago squasi ogni dì. ROS. Vorrei entrare ancor io. ARL. Oh, siora no; donne femene no ghe ne va. ROS. È notte; non si sente nessuno. Possiamo entrare con libertà; e poi sappi che vi è mia madre, e vi posso andare ancor io. ARL. Se batto, i vien a avrir, i me vede con una donna, e i me regala de bastonade. ROS. Senti. Ho le chiavi. ARL. Avì le chiave? Chi ve l’ha dade? ROS. Me le ha date mio padre: eccole. Apriremo da noi, senza che nessuno se ne accorga. Vi è niente colà da nascondersi? ARL. Gh’è un camerin… ma… no l’è mo a proposito. ROS. Presto, presto, andiamo. ARL. Corpo del diavolo… no vorria… ROS. Tieni le chiavi, apri. ARL. Basta. Avro, e me la sbigno[ref]È una parola in gergo, che vuol dire fuggo via[/ref]. (mette le chiavi nell’uscio) FLOR. Lascia a me queste chiavi. (le prende) ARL. La se comoda, che l’è padron. ROS. Come! Così mantenete la vostra parola? Mi promettete di non venire, e poi venite al casino? FLOR. Ah ingrata! Così voi mi serbate la fede? Mi carpite le chiavi, mi giurate di custodirle, e le impiegate in tal uso? ROS. Vi ho promesso che escite non sarebbero dalle mie mani. FLOR. Promesse accorte, con animo d’ingannare. Ma chi non sa che sia fede, non merita che a lui si serbi. Giacché voi mi avete insegnato ad operare a capriccio, mi valerò de’ vostri barbari documenti; ed ora sugli occhi vostri anderò in quel luogo medesimo, dove non volevate ch’io andassi. ROS. Ah no, caro Florindo… FLOR. Tacete; se non mi amate, non meritate di essere compatita; e se mi amate, vi serva di regola e di castigo la pena che giustamente provate. (apre ed entra)
SCENA VENTIQUATTRESIMA ROSAURA ed ARLECCHINO ROS. Oimè! Arlecchino. ARL. Signora. ROS. Mi vien male. ARL. Forti. Mi no gh’ho alter che un poco de moccolo de lanterna. ROS. Mi sento morire. ARL. Aiuto, gh’è nissun?
SCENA VENTICINQUESIMA BEA TRICE, ELEONORA, CORALLINA, da varie parti; e detti. ELEON. Che c’è? COR. Che cosa è stato? BEAT. Figliuola mia. ROS. Signora madre, veniva in traccia di voi. BEAT. Ed io veniva in traccia di te. ARL. E mi andava a scarpioni[ref]Dice che andava a caccia di scorpioni, per dire una facezia.[/ref].
SCENA VENTISEIESIMA BRIGHELLA colle candele di cera, e detti. BRIGH. Coss’è sto negozio? A st’ora? Coss’è sto mercà de donne? COR. Brighella, eccoci qui: una, due, tre e quattro. Siamo quattro femmine disperate. ARL. E mi che fa cinque. BRIGH. Ma desperade per cossa? Fursi per curiosità de saver quel che se fa là drento? COR. Non è curiosità, ma volontà rabbiosissima di sapere. BEAT. Mi preme di mio marito. ELEON. Voglio sapere di mio marito. ROS. Vo’ sapere che fa il mio sposo. COR. Ed io non ho né parenti, né amici, ma ho certo naturale, che vorrei sapere tutti li fatti di questo mondo. ARL. Da resto po, no se pol dir che le sia curiose. BRIGH. Signore, le se ferma un tantin. (Ste donne vol far nasser dei despiaseri; adesso ghe remedierò mi). (da sé) Vorle vegnir là drento? COR. Oh, il ciel volesse! BEAT. Pagherei cento scudi. BRIGH. Zitto. Le lassa far a mi, che da galantomo le voggio sodisfar. BEAT. Ma come? BRIGH. Se fidele de mi? COR. Sì Brighella è uomo d’onore. Fo io la sicurtà per lui. BRIGH. Arlecchin, ti ti sa dov’è la porta che referisse in cantina. ARL. Cussì no la savessio! Ho portà tante volte la legna. BRIGH. Tiò sta chiave. Averzi quella porta che va nella stradella; condusile drento con quella lanterna, e po serra, e vien per de qua, che te aspetto. BEAT. Ah Brighella, non ci tradire. BRIGH. Me maraveggio: le se fida de mi. COR. Finalmente siamo quattro donne; non abbiamo paura né di venti, né di trenta uomini. ARL. Le favorissa, le vegna con mi, che averò l’onor de far la figura de condottier. (parte) BEAT. Rosaura, andiamo. Già che ci siete, non so che dire. (parte) ROS. Non ci sarei, s’ella non mi avesse dato l’esempio. (parte) ELEON. O in un modo, o nell’altro, purché veda, sarò contenta. (parte) COR. Caro Brighella, fateci veder tutto: non già per curiosità, ma così per divertimento. (parte)
SCENA VENTISETTESIMA BRIGHELLA solo. BRIGH. Sta volta me togo un arbitrio, che no so come el me passerà, ma fazzo per far ben, e spero de far ben. Ste donne le son indiavolade; ognuna l’è capace de precipitar la casa, el marido, e tutti quei de sto logo. Se me riesce quel che m’è vegnù in tel pensier, spero che i mi padroni sarà contenti, le donne disingannade; e mi averò la gloria d’aver contribuido alla pase comun, al comun contento de tutti, e alla sussistenza de un logo, dove anca mi ghe cavo el mio profitto, e vivo da galantomo. Perché al dì d’oggi, co se g’ha un tocco de pan, bisogna sfadigarse, suar e strologar per mantegnirselo fin che se pol. (parte)
ATTO TERZO SCENA PRIMA Camera nel casino della conversazione, con varie porte. ROSAURA, BEA TRICE, ELEONORA, CORALLINA e BRIGHELLA BRIGH. Le vegna con mi, e no le se indubita gnente. Le metterò in t’un logo, dove senza esser viste le vederà. BEAT. Che luogo è quello dove ci volete mettere? BRIGH. Una camera scura dove no ghe va nissun. COR. Che sia la camera del tesoro? BRIGH. Siora sì, gh’è el tesoro da ingrassar i campi. ELEON. Vi sono i fornelli? BRIGH. No, la veda: i fornelli xe in cusina. BEAT. Qual è la camera del giuoco? BRIGH. Qualche volta i zoga qua colla dama. ROS. Colla dama, eh? Sì, sì, vi ho capito. Si divertono colle donne. BRIGH. Le vederà con che donne che i se diverte. Le so donne le son le bottiglie. COR. Le bottiglie, o le pentoline? BRIGH. Pentoline? Pignatelle? Da cossa far? COR. Per far le stregherie, per cavar il tesoro. BRIGH. Sì, sì, brava, la dise ben. Presto, presto, le se retira, che sento zente, e le varda ben, le staga zitte, no le fazza sussurro. ROS. (Se vedo donne, non mi tengono le catene). (da sé, entra) BEAT. (Se mio marito giuoca, vado a strappargli le carte di mano). (entra) ELEON. (Voglio rompere tutti i loro lambicchi). (entra) COR. (Se cavano il tesoro, ne voglio anch’io la mia parte). (entra) BRIGH. Per sincerar ste donne curiose, no gh’è altro remedio che farle véder coi propri occhi… Vien i patroni, vado a finir de parecchiar la cena. Se la invenzion va ben, son el primo omo del mondo. Se la va mal, pazienza. Co l’intenzion l’è bona, se compatisse chi falla. (parte)
SCENA SECONDA PANTALONE, OTTAVIO, LELIO e FLORINDO LEL. Ella è così senz’altro. Mia moglie mi ha levate di tasca furtivamente le chiavi. PANT. Chi sa che no la fusse quella che in abito da omo zirava qua intorno? LEL. Mia moglie da uomo? Non crederei. Abiti che le vadan bene, in casa non ve ne sono. PANT. La sarà stada donca quella in zendà, che ha trovà Brighella colle chiave, in atto de avrir. LEL. Se ciò è vero, se colei me l’ha fatta, giuro al cielo, la fo morire sotto un bastone. OTT. No, amico, non tanta furia. LEL. Siete qui voi colla vostra flemma. OTT. Lasciatemi dir due parole. Voi siete stato burlato da vostra moglie, io dalla mia, ed il signor Florindo da quella che sarà sua. Consideriamo un poco il motivo di questo loro trasporto. O provien dall’amore che hanno per noi, e non ce ne possiamo dolere; o proviene da un difetto di natura, chiamato curiosità, e dobbiamo compatire il loro temperamento. Chi nasce con dei difetti, merita compassione. L’uomo saggio deve procurar di correggerli senza scandalizzarsi. Ma sappiate, amico, che non è l’ira quella che produca le correzioni, ma la ragione. Battete la moglie dieci anni, vent’anni, diverrà sempre peggio. Onde una delle due, o correggerla con amore, o non curarla con indifferenza. PANT. Sior Ottavio dise benissimo, el parla da omo de garbo e da filosofo vero; ma mi gh’ho un’altra regola, che me par più segura, e che ho imparà a mie spese. Dalle donne ghe stago lontan, e in fatti ho procurà de far sta union de omeni senza donne, e donne qua no ghe n’ha da vegnir. E ve prego, cari amici, custodì le chiave; che se le donne ve tol le chiave, avè persa affatto la libertà. FLOR. Io sono stato il più debole, il più pazzo di tutti. Confesso la mia insensatezza. Ho date io medesimo le chiavi in deposito alla signora Rosaura, né mi sarei mai creduto ch’ella mi potesse tradire… OTT. Via, non andate in collera. Amore accieca. Ha acciecato voi nel dargliele, ha acciecato lei nel servirsene. Col tempo ci vedrete meglio. Verrà pur troppo quel tempo, che voi non le renderete conto dei vostri passi, ed ella non curerà saper dove andiate.
SCENA TERZA LEANDRO e detti. LEAN. Amicizia. (tutti fanno con lui il solito complimento) Signor Pantalone, avete detto nulla a questi signori di quel compagno che vi ho proposto? PANT. Cossa diseli, patroni, xeli contenti che recevemo sto nostro camerada? OTT. Chi è? Come si chiama? LEAN. Egli è il signor Flamminio Malduri. Lo conoscete? OTT. Io no. LEL. Lo conosco io. È galantuomo. Merita esser ammesso nella vostra conversazione. PANT. Bon. Co do lo cognosse, el se pol recever. Cossa diseli? OTT. Io son contentissimo. FLOR. Ed io pure. LEAN. Posso dunque farlo passare. PANT. Mo l’aspetta un pochetto. L’avemio da far vegnir cussì colle man a scorlando? Sto liogo ne costa dei bezzi assae; nu avemo speso, e avemo fatto quel che avemo fatto, xe ben giusto che chi entra novello, abbia da pagar qualcossa. Cossa ghe par? LEAN. Questi è un uomo generoso, soccomberà volentieri ad ogni convenienza. PANT. Femo cussì, che el paga la cena de sta sera. Ah? dighio mal? LEL. Dite benissimo. Può pagar meno per entrare in una simile compagnia? FLOR. Per me darò la mia parte. PANT. Gnente, sior Florindo, no femo miga per sparagnar la parte. Semo tutti omeni che un felippo non ne descomoda. Se fa per un poco de chiasso, per un poco de allegria. Cossa diseu, sior Leandro? LEAN. Va benissimo, ed ora con questo patto lo introduco senz’altro. (parte) PANT. Più che semo, più stemo allegri. Oh, m’ho desmentegà de domandarghe una cossa. LEL. Che cosa? PANT. Se sto sior el xe maridà. Da qua avanti no solo no voggio donne, ma gnanca omeni maridai. FLOR. Perché, signore? PANT. E gnanca sposi. FLOR. Ma perché? PANT. Perché no i sa custodir le chiave.
SCENA QUARTA LEANDRO, FLAMMINIO e detti. LEAN. Amicizia. PANT. Amicizia. Gh’aveu insegnà el complimento? (a Leandro) FLAMM. Servo di lor signori. PANT. Che servo? Amicizia. (abbracciandolo) FLAMM. Amicizia. (tutti fanno lo stesso) Mi ha detto l’amico Leandro, che lor signori si degnano favorirmi… PANT. Che degnar? Che favorir? Sti termini da nu i xe bandii. Bona amicizia, e gnente altro. FLAMM. Son qui disposto a soccombere a quanto sarà necessario. PANT. Gnente. Co l’ha pagà una cena, l’ha fenio tutto, e quel che stassera la fa ella, un’altra volta farà un altro novizzo, e cussì se se diverte, e se gode. FLAMM. Se mi credete abile a supplire a qualche incombenza, mi troverete disposto a tutto. PANT. Qua no ghe xe maneggi, no ghe xe affari, tutto el daffar consiste in provéder ben da magnar, ben da bever, e devertirse. FLAMM. Eppure si dice che qui fra di voi altri abbiate diverse inspezioni, diverse incombenze, alle quali si arriva col tempo. PANT. Oibò, freddure. Chiaccole della zente, alzadure d’inzegno de quelli che no volemo in te la nostra conversazion, i quali mettendone in vista per qualcossa de grando, i ne vorave precipitar. LEAN. Queste cose gliele ho dette ancor io, e non me le ha egli volute credere. OTT. Sì, tutto il mondo è persuaso che la nostra unione abbia qualche mistero. Questo è un effetto della superbia degli uomini, li quali vergognandosi di non sapere, danno altrui ad intendere tutto quello che lor suggerisce la fantasia stravolta, sconsigliata e maligna. LEL. A tavola questa sera vedrete tutte le nostre maggiori incombenze. Chi trincia, chi canta, chi dice delle barzellette, e chi applica seriosamente a mangiar di tutto, la qual carica, indegnamente, è la mia. FLOR. Saprete che qui non è permesso alle donne l’intervenirvi. FLAMM. È vero, ed esse appunto sono quelle che fanno assai mormorare di voi e dicono che vi è dell’arcano. PANT. Coss’è sto arcano? Qua no se fa scondagne, no se dise mal de nissun, né se offende nissun. Ecco qua i capitoli della nostra conversazion. Sentì se i pol esser più onesti, sentì se ghe xe bisogno de segretezza. 1. «Che non si riceva in compagnia persona che non sia onesta, civile e di buoni costumi». 2. «Che ciascheduno possa divertirsi a suo piacere in cose lecite e oneste, virtuose e di buon esempio». 3. «Che si facciano pranzi e cene in compagnia, però con sobrietà e moderatezza; e quello che eccedesse nel bevere, e si ubbriacasse, per la prima volta sia condannato a pagar il pranzo o la cena che si sarà fatta, e la seconda volta sia scacciato dalla compagnia». 4. «Che ognuno debba pagare uno scudo per il mantenimento delle cose necessarie, cioè mobili, lumi, servitù, libri e carta ecc.». 5. «Che sia proibita per sempre la introduzion delle donne, acciò non nascano scandali, dissensioni, gelosie e cose simili». 6. «Che l’avanzo del denaro che non si spendesse, vada in una cassa in deposito, per soccorrere qualche povero vergognoso». 7. «Che se qualcheduno della compagnia caderà in qualche disgrazia, senza intacco della sua riputazione, sia assistito dagli altri, e difeso con amore fraterno». 8. «Chi commetterà qualche delitto o qualche azione indegna, sarà scacciato dalla compagnia». 9. (E questo el xe el più grazioso, el più comodo de tutti). «Che sieno bandite le cerimonie, i complimenti, le affettazioni: chi vuol andar, vada, chi vuol restar, resti, e non vi sia altro saluto, altro complimento che questo: amicizia, amicizia». Cossa ghe par? Èla una compagnia adorabile? FLAMM. Sempre più mi consolo di esservi stato ammesso.
SCENA QUINTA BRIGHELLA e detti. BRIGH. Signori, co le comanda, è in tavola. (parte) PANT. Andemo. FLAMM. Favorite. (fa cenno che vada prima) PANT. Vedeu? Queste le xe freddure contra el capitolo ultimo. Chi xe più vicini alla porta va fora prima dei altri. Senza complimenti. Amicizia. (parte) FLAMM. Oh bella cosa! Oh bellissima cosa! (parte) LEL. Andiamo, amici. La rabbia che ho avuto con mia moglie, mi ha fatto venire un appetito terribile. (parte) OTT. Io mangio sempre bene ugualmente, perché rido di tutto, e non m’inquieto mai. (parte) FLOR. Io non posso dire così. Amo Rosaura, e peno rammentandomi d’averla disgustata. Ella lo ha meritato, ma il mio cuor mi rimprovera di averla troppo villanamente trattata. (parte)
SCENA SESTA BEATRICE, ROSAURA, ELEONORA e CORALLINA ELEON. Avete veduto? BEAT. Avete sentito? COR. In fatti, chi mi ha detto del tesoro, non ha fallato. ROS. Come non ha fallato? Il tesoro dov’è? COR. Ecco lì. (accenna la porta dove sono entrati gli uomini) Una buona tavola, allegra e di buon cuore, è il più bel tesoro del mondo. ELEON. Povero mio marito! Si diverte, non fa alcun male. BEAT. Mi pareva impossibile che Ottavio giocasse. ROS. Florindo è un giovane savio e dabbene, ma mi ha rimproverata con troppa crudeltà. COR. Vostro danno, signora, dovevate fidarvi di lui, e non mostrare tanta curiosità. ROS. Me ne ha fatto venir volontà la signora madre. BEAT. Io non l’ho fatto per curiosità, l’ho fatto per impegno. ELEON. Anch’io per un puntiglio. BEAT. E che sia la verità, andiamo a casa, che non vuò veder altro. ELEON. Sì, andiamo, signora Beatrice, che non paia che vogliamo vedere i fatti degli altri. ROS. Oh Dio! Chi sa se Florindo mi vorrà più bene! Vorrei vedere se mangia, o se sta malinconico. BEAT. Via, via, basta così. (s’avvia per partire) COR. Aspettate un momento, vedrò io se il signor Florindo mangia o non mangia. (va a spiare alla porta) ELEON. Eh via, che non istà bene spiare alle porte. BEAT. Andiamo, andiamo. COR. Oh che bella tavola! Oh che bella cosa! BEAT. In quanti sono? (torna indietro) COR. (Guarda) In sei. ELEON. Mangiano? (s’accosta) COR. Diluviano. ROS. Florindo mangia? (fa lo stesso) COR. Discorre. BEAT. Egli fa così. Mangia adagio, e parla sempre. ELEON. E mio marito? COR. Oh se vedeste! ELEON. Che cosa? COR. Che bel pasticcio! ELEON. Come? (corre al buco della chiave) BEAT. Pasticcio di che? (corre anch’essa per vedere) ELEON. Via, signora, ci sono prima io. (guarda dal bucolino) BEAT. Spicciatevi, voglio veder ancor io. (ad Eleonora) ROS. (E poi diranno ch’io son curiosa!) (da sé) ELEON. Oh bello! BEAT. Lasciatemi vedere. (fa andar via Eleonora, e guarda) COR. Questa fessura non la do a nessuno. BEAT. Oh bella cosa! (guardando) ROS. Ed io niente. BEAT. Bevono. ELEON. Chi? Voglio vedere. ROS. Voglio veder ancor io. BEAT. Venite qui. (a Rosaura, dandole luogo) ROS. Florindo beve. ELEON. E Lelio? ROS. Taglia un pollo. ELEON. Voglio vederlo. (tira via Rosaura con forza) COR. Presto, presto, ritiriamoci. (si scosta) ELEON. Perché? COR. Arlecchino viene verso la porta. BEAT. Che cosa fa Arlecchino? COR. Serve in tavola. BEAT. Voglio vederlo… (s’accosta all’uscio)
SCENA SETTIMA ARLECCHINO dalla porta, con un tondo in mano con delle paste sfogliate; e dette. ARL. (Entrando s’incontra in Beatrice, e resta sospeso) BEAT. Zitto. (ad Arlecchino) ARL. Cossa feu qua? ELEON. Zitto. ARL. Se i ve vede, poverette vu. COR. Bada bene, non dir nulla. ARL. Per mi no parlo. Vag a metter via ste bagattelle, e po torno. COR. Che cosa sono? ARL. Quattro sfoiade: i mi incerti. COR. Lascia un po’ vedere. (ne prende una) ARL. Bon! Comodève. COR. Oh com’è buona! BEAT. Lascia sentire. (ne prende un’altra) ARL. Padrona. ELEON. Con licenza. (ne prende anch’essa una) ARL. Senza cerimonie. ROS. Ed io niente? ARL. Se la comanda, la toga questa. ROS. Per sentirla. (prende la pasta sfogliata) ARL. Cussì ho destrigà el piatto presto. Torno a oselar[ref]A uccellare, a buscar qualche cosa.[/ref]. COR. Portami qualche cosa di buono. ARL. Andè via, siora, che se i ve vede… BEAT. Non dir niente. ARL. Non parlo. (entra e chiude la porta) BEAT. Andiamo via, prima d’essere scoperte. ELEON. Sì, sarà meglio. ROS. Andiamo, che il signor Florindo non abbia motivo un’altra volta di rimproverarmi. COR. Un’occhiatina, e vengo. (corre alla porta) BEAT. Via, curiosa! COR. Oh bello! (guardando) BEAT. Che cosa c’è di bello? (torna verso la porta) COR. Il deser. ELEON. Il deser? (verso la porta) ROS. Con i lumi? COR. Bello, di cristallo, coi fiori. Pare un giardino. BEAT. Voglio vedere. ELEON. Voglio vedere. ROS. Ancor io. (tutte s’accostano e sforzano per vedere, onde si spalanca la porta ed escono)
SCENA OTTAVA PANTALONE, OTTAVIO, LELIO, FLORINDO, LEANDRO, FLAMMINIO, alcuni con salviette, alcuni con lumi; e dette. PANT. Coss’è sto negozio? LEL. Eh, giuro a Bacco… (contro Eleonora) OTT. Fermatevi: prudenza, moderazione. (a Lelio) PANT. Come xele qua ste patrone? Chi le ha menade? Chi le ha introdotte?
SCENA ULTIMA BRIGHELLA e detti. BRIGH. Sior padron, son qua mi. Siori, son causa mi; le abbia la bontà de ascoltarme; se merito castigo, le me castiga, se merito premio, le fazza quel che le vol. OTT. V’ho capito. Brighella le ha introdotte per disingannarle, perché non sospettino male di noi: è egli vero? BRIGH. Signor sì, le ho introdotte per questo. Una diseva che qua se zoga, e se rovina le case; l’altra che vien donne cattive, e se maltratta la reputazion; una voleva che se fasse el lapis philosophorum; l’altra, che se cavasse un tesoro. Ste cosse in bocca delle donne le impeniva in poco tempo el paese, e per levarghele dalla testa, el dir no bastava, el criar giera gnente e no remediava. Bisognava sincerarle, bisognava che co i so occhi, colle so orecchie le vedesse, le sentisse, e le se cavasse dal cuor sta maledetta curiosità. Le ha visto, le ha sentìo, no le sospetterà più, no le sarà più curiose. Mi l’ho introdotte, mi l’ho fatto per ben, e spero che da sta mia invenzion ghe ne deriva del ben. PANT. No so cossa dir. Ti t’ha tolto una libertà granda; ti ha disobbedio el mio comando; ti meriteressi che te cazzasse subito via de qua. Ma se xe vero che sincerade ste donne le abbia da lassar in pase i so omeni, e lassar in quiete sto nostro liogo, te perdono, te lodo, e te prometto un regalo. BRIGH. Cosa disele, patrone, èle sincerade? BEAT. Io non aveva bisogno di vedere, per assicurarmi della prudenza di mio marito. OTT. Perché dunque siete venuta? BEAT. Per contentare mia figlia. FLOR. La signora Rosaura non mi crede? ROS. Le male lingue mi facevano dubitare, ma io era certissima della vostra fede. LEL. E voi, signora consorte carissima, l’avete voluto sostenere quel vostro indegnissimo lo saprò. ELEON. Via, marito, non vi è più pericolo ch’io dica lo saprò. LEL. Perché avete saputo. COR. Cari signori, compatiteci: alfin siamo donne. Quel sentir a dire: là dentro non possono andar le donne, è lo stesso che metterci in desiderio d’andarvi. E per me, se dicessero: in fondo d’un pozzo vi è una cosa che non si ha da sapere che cosa sia, mi farei calar giù sin alla gola, per cavarmi una tale curiosità. PANT. La curiosità ve l’avè cavada. Seu contente? ELEON. Per me son contentissima. Caro marito, non vi tormenterò più. LEL. Se avrete giudizio, sarà meglio per voi. BEAT. Siete in collera, signor Ottavio? OTT. Niente, consorte mia, niente. Conosco il sesso, lo compatisco. Niente. ROS. E voi, signor Florindo? FLOR. Scordatevi de’ miei trasporti, ch’io mi scorderò di ogni vostro vano sospetto. OTT. Le mie chiavi come diavolo le avete avute? COR. Niente, signore, con una chicchera di caffè. OTT. Ah galeotta! Ora me ne ricordo. E voi che volevate ch’io mi levassi il vestito? (a Beatrice) BEAT. Compatitemi. PANT. Via, a monte tutto. Sarale più curiose? BEAT. Non v’è pericolo. ELEON. Io no, sicuro. ROS. Né men io certamente. COR. Oh, mai più curiosità, mai più. PANT. Donca le se quieta, le se consola, e le vaga tutte a bon viazo. Qua no volemo donne. Le ha sentìo el perché. Le ne fazza sta grazia, le vaga via. BEAT. Andiamo? ELEON. Che dite, signora Rosaura? ROS. Bisognerà andare. PANT. Mo via, cossa fale che no le va? COR. Io vi dirò, signore, muoiono di volontà di veder quel bel deser. ELEON. Sì, e tutte quelle belle camere. BEAT. Via, giacché ci siamo. ROS. Questa volta, e non più. PANT. Da resto po no le sarà più curiose. Andemo, sodisfemole, femoghe véder tutto. E po? no le sarà più curiose. Questo xe un mal, che dalla testa no gh’el podemo levar. Basta ben che de nu le sia sincerade, che el nostro modo de viver el sia giustificà, e che le ne lassa gòder in pase tra de nu, senza pettegolezzi, la nostra onoratissima conversazion. Amicizia. TUTTI Amicizia, amicizia. Fine della Commedia
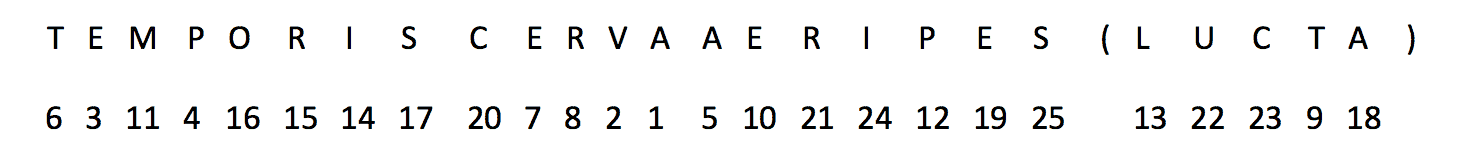 anagramma per:
anagramma per: