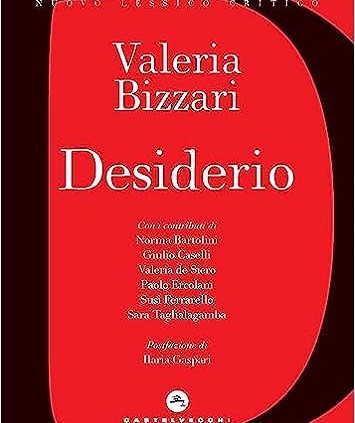di Susi Ferrarello
(California State University – East Bay)
traduzione di Miriam Borgia
tratto dal blog psychologytogay.com
“Sesso” – una parola che si trova ovunque e può indicare qualunque cosa.
Pochi giorni fa mi trovavo un bar e ho sentito un ragazzo dire al suo amico “Hmmm…il tuo caffè è proprio sexy”.
Un caffé, sul serio?
Da italiana, rimango sempre colpita dall’uso esteso di questo termine. Ricordo ancora la sensazione di panico che ho provato quando un mio collega l’ha utilizzata durante un mio intervento ad una conferenza: descriveva il mio articolo come “sexy”. Cosa? Ho pensato, arrossendo e sorridendo nervosamente.
Ora lo capisco. Questa parola è oggi sinonimo di tutto ciò che è piccante, intrigante, vitale, dinamico.
L’etimologia
Ma se ripercorriamo le sue origini, questa parola così “sexy” è nata in un polveroso ufficio burocratico. “Sex”, dal latino sexus, deriva dal verbo secare, cioè “dividere o tagliare”, ed è correlato a “sezione”, ovvero a ciò che è diviso. Il latino utilizzava questa parola per indicare la qualità dell’essere maschio o femmina per suddividere la popolazione e censirla.
Tuttavia, l’uso contemporaneo di questa parola è piuttosto recente. D. H. Lawrence, nel 1929, fu il primo ad averla utilizzata in tal senso.
1000 modi per dire “ti voglio!”
Quindi, quali sono le parole che i Greci e i Romani utilizzavano per riferirsi all’amore sessuale?
Di certo, i Greci, più che i Romani, non erano a corto di parole quando si trattava di dire “ti amo” o, in questo caso, “ti desidero.”
Il verbo agape indicava un amore spirituale e incondizionato; stergoto indicava l’affetto; phileo, invece, un tipo di amore mentale relativo piuttosto all’amicizia; erao, infine, per l’amore intimo – quel tipo di amore accompagnato dal desiderio passionale.
È così affascinante! Nel mondo greco Eros indica la natura, è quel potere naturale che si impone sull’esistenza umana e ci richiama verso ciò di cui il nostro corpo necessita per stare in armonia con la natura, o meglio per essere un tutt’uno con la Natura.
Un esempio calzante: il satiro
Il satiro, metà umano e metà animale – stando alle descrizioni di Aristofane – era dotato di un’energia sessuale illimitata che cercava di soddisfare in qualunque modo e con “partners”, per così dire, animati e inanimati. Se ti capita di aggirarti in un museo sbadigliando e provato dal dolore alla schiena, osserva meglio i dipinti: sono come una doccia fredda.
Quei vasi erano le riviste per adulti dell’antichità. Piacevano così tanto ai Greci che su uno di questi vasi, custodito a Palermo (V, 651), si può notare un gruppo di satiri che si accoppiano con anfore e persino i vasi stessi. Il filologo Lissarague spiega questa scelta piuttosto discutibile sostenendo che l’anfora del vino era l’accessorio necessario del kōmos (un rituale per bevuta) e del simposio. Vino e sesso sono ciò che rende felice un satiro! Così il famoso detto “Afrodite kai Dionysos met’allelon eisi”, “Afrodite e Dioniso sono insieme”.
Certo, i satiri amavano anche le donne; quest’ultime, però, non ricambiavano affatto (il che spiega le anfore.) Come scriveva MacNally, il rapporto tra satiri e menadi (le seguaci di Dioniso, che erano, per definizione, un po’ eccentriche) iniziò amichevolmente tra il 550 e il 500 a.C., e poi, come molti rapporti amichevoli, “mutò” tra il 500 e il 470, diventando palesemente ostile dopo il 470. Le menadi, secondo Plutarco (Virtuous Women 12.249 sgg.), erano inviolabili – soprattutto, immagino, se si trattava di un branco di mezze capre che si avvicinavano a loro.
Ebbene, nonostante ciò, i satiri non si scoraggiavano: amavano anche gli uomini, naturalmente, e in questo caso avevano più successo. A differenza del resto della società greca, la differenza di età non li preoccupava affatto. Non importava se il ragazzo, l’amato, era più giovane (in effetti, di regola, lo preferivano così). C’è una tazza a Berlino (1964.4) – un’altra “rivista per adulti” – che mostra un gruppo di cinque satiri in piena frenesia erotica.
A loro difesa, i satiri non erano soli in questo desiderio travolgente. C’erano esseri umani che ne condividevano quella fame, e i più noti erano filosofi e poeti: entrambi disprezzavano Eros ma al contempo lo trovavano irresistibile. Nel suo Saggio erotico Pausania chiamava questa raffinata classe di gentiluomini “mostri di appetito”.
Socrate e il sesso
In particolare, la cricca di Socrate e dei suoi seguaci ha avuto molto da dire sull’argomento. Senofonte, il secondo più famoso discepolo di Socrate, racconta una conversazione che il filosofo ebbe con lui su un ragazzo particolarmente sexy. Socrate era irritato con lui perché stava usando la sua bellezza per sfruttare le persone, e per di più il giovane Critobolo, il suo discepolo preferito. Il ragazzo gli aveva infatti rubato un bacio e Socrate ne rimase così “filosoficamente” arrabbiato che lo invitò calorosamente a lasciare la città per un anno. Il suo bacio, borbottò Socrate, era velenoso come il morso di un ragno e ordinò a Senofonte di evitarlo ad ogni costo.
Socrate, d’accordo con Platone e Aristotele, considerava il piacere erotico divertente e necessario, ma occorreva maneggiarlo con cura. Il sesso puro è per le bestie, o per le mezze-bestie – i satiri –. I satiri sono stati inventati proprio per mostrare alla gente quanto fosse strambo un uomo completamente convertito alla natura. La passione bestiale – come scrisse Aristotele, il pensatore super equilibrato che si innamorò perdutamente del virile re Alessandro Magno (Plutarco, Le vite parallele) – è “serva e brutale”.
Il sesso, qualcosa di insidioso
Saffo – poetessa meravigliosa – definiva l’eros una “cosa insidiosa”. Conosceva benissimo l’amore erotico. In Afrodite immortale dalla mente scintillante scriveva:
“Se corre ora, seguirà più tardi, / Se rifiuta i regali, li darà. / Se non ama ora, lo farà presto Amore contro la sua volontà. ”
“Amore contro la sua volontà”. Mi sembra chiaro: ami qualcuno? Aspetta. Nessuno può resistere alla passione di essere amato. L’amore è più forte di qualsiasi cosa. Alcuni secoli dopo in Inferno, V, 103, Dante scriverà “Amor ch’ha nullo amato, amar perdona” aggiungendo, tre righe dopo, “Amor condusse noi ad una morte certa” (v. 106). “L’amore è natura e la natura è morte. Questa è l’equazione. Non puoi resistere alla tua natura, ma in qualche modo devi trovare un modo per farlo.”
La metafora dei due cavalli contenuta nel Fedro di Platone è una sorta di manuale d’istruzione per riuscire in questo tentativo. Per Platone, la nostra vita è sempre guidata da due cavalli, il bianco e nero, corrispondenti alla nostra passione e la nostra ragione. Non possiamo guidare solo uno dei due cavalli, o la nostra traiettoria sarebbe zoppicante. Il nostro compito è trovare il giusto equilibrio, o come diceva Aristotele, “il giusto mezzo”.
“Il desiderio raddoppiato è amore; l’amore raddoppiato è follia”
Come disse Prodico (un sofista del V secolo): “Il desiderio raddoppiato è amore; l’amore raddoppiato è follia”.
L’amore tra animali era ancora considerato “cool”, e l’amore per i vasi era ancora accettabile, ma quando si tratta di donne, attenzione! Folle, distruttivo, pericoloso. “Il disastro memorabile”, scriveva Esiodo.
Sai qual è stata la punizione degli déi per gli uomini dopo che Prometeo ha dato loro il dono del fuoco, rubato agli immortali? La creazione della donna e dei suoi desideri! Sto ancora ridendo. Penso che questo possa darci un’idea di quanto i Greci fossero terrorizzati dalle donne!
Secondo Esiodo, dopo che Prometeo rubò il fuoco agli déi, Zeus diede inizio alla sua terribile vendetta: la creazione della donna a “somiglianza di una fanciulla timida”. Altri tre déi presero parte al complotto: Atena le insegnò l’arte domestica del ricamo e della tessitura (che noia); Afrodite le diede la persuasione e il potere di suscitare “desiderio crudele e cure divoratrici” (ora inizia a diventare interessante!); alla fine, Hermes, il dio del furto e dell’inganno, le ha dato una “mente da puttana e un carattere ingannevole… bugie e parole astute”.
L’incubo era confezionato. Questa bella creatura spaventosa, questa “trappola pura”, Pandora, fu pensata come l’antenata della “razza delle donne”, la “piaga degli uomini che mangiano il pane” (Esiodo, op. 105-120). Pandora, il prototipo delle donne, è la Natura pura, indomabile e attraente. Esiodo scrive che la sua bellezza sessuale (che ricorda il paradiso perduto) ritorna ogni primavera e che le sue passioni (distruttive come le forze inumane della natura) richiedono la “tecnologia” (sì, questa è la parola che usa!) del matrimonio per controllarla.
Insieme a Pandora c’era Helene, simbolo dell’essenziale ambiguità della donna e della bellezza sessuale divinamente incarnata nella sua protettrice Afrodite, e altrettanto distruttiva quanto la sua. Byron la chiama “l’Eva greca”, la causa della “caduta” della Grecia maschile. Homer la definisce per ben due volte “faccia da stronza”, aggiungendo anche l’onorevole aggettivo di “complotto malvagio”. Come mai? Il suo appetito sessuale non poteva essere facilmente soddisfatto e controllato dagli uomini. A volte succede…
La sua sorellastra, Klytaimestra, era un altro personaggio interessante. Incarnava – come scrive Eschilo (Oresteia) – “l’incessante scempio della passione femminile scatenata che attacca dall’interno degli ordini della famiglia e dello stato”. Era “il leone allevato come un animale domestico in casa… amante dei bambini e gioia per i vecchi”, quando era ancora giovane, ma poi contaminava la casa con il sangue, un “sacerdote della distruzione”, non appena la sua natura selvaggia affiorava.
Ti risparmierò il numero di volte che Homer la chiama “faccia da puttana”. Questa donna, guidata dalla forza più potente della femmina, un’energia sessuale amplificata da un senso di ingiustizia e disonore, ha ucciso la sua rivale Cassandra e il suo sposo Agamenone con un “cuore umano”, scrive Eschilo. Ed è persino più terribile di altre donne perché è una donna-maschio, la combinazione della “mente guidata dalla volontà dell’uomo” e della “passione sessuale della donna” che colludono per portare distruzione e morte.
Forse “la tecnologia del matrimonio” non ha funzionato così bene nel suo caso.
Tuttavia, l’elenco degli esempi spietati del potere erotico femminile è lungo. Mi fermo qui per scoraggiare ulteriori sentimenti misogini.
La parola “sesso” ha percorso una lunga strada, dall’ufficio polveroso dei burocrati assonnati fino al sangue che scorre nelle nostre vene umane.