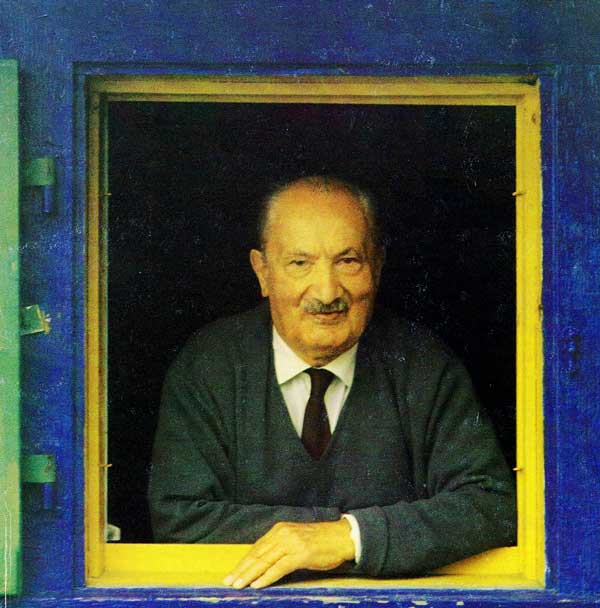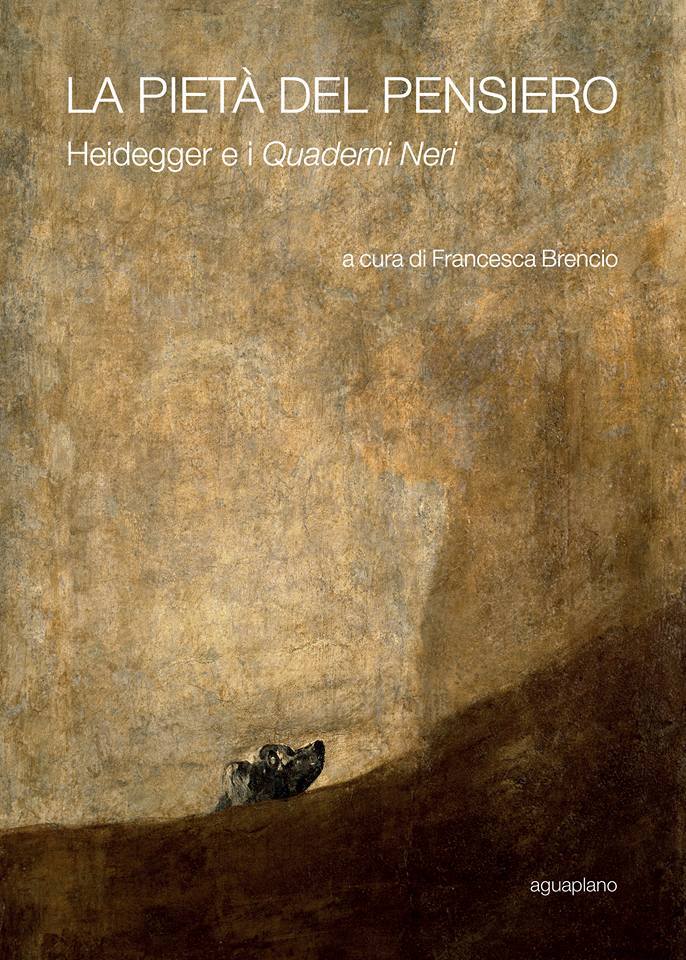Heidegger interprete di Hölderlin
La contemporaneità di un poeta non è nel contenuto, ma talvolta è malgrado il contenuto, quasi a suo dispetto
M. Cvetaeva Il poeta e il tempo
I. “Il più grande lirico tedesco dopo Goethe”
Il XIX secolo ha partorito una generazione ardente,
audace e focosa, sorgendo dalle zolle aperte d’Europa, fa impeto contemporaneamente da tutte le direzioni incontro all’aurora della libertà nuova […]. Uno, uno solo della sacra schiera, il più puro, rimane ancora a lungo sulla terra senza più Dei: Hölderlin; ma la sorte lo ha trattato nel modo più strano. Il suo labbro fiorisce ancora, il suo corpo che invecchia brancola ancora sulla terra tedesca […] ma i suoi sensi […] si annebbiano in un sogno senza fine […]. Gli Dei gelosi non hanno ucciso colui che ha spiato i loro segreti, ma si sono limitati ad accecargli lo spirito […]. Un velo s’è steso a oscurargli la parola e l’anima […]. E quando, un giorno, egli si stende pianamente e muore, questa morte silenziosa non suscita nel mondo tedesco maggior rumore d’una foglia d’autunno che scenda incerta a terra […]. Il messaggio eroico di quest’ultimo, di questo puro tra i più puri della sacra schiera, resta non letto, non ascoltato per una generazione intera [ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, trad. it. a cura di A. Oberdorfer, Sperling & Kupfer, Milano 1934, pp. 25 e ss.[/ref].
Con queste suggestive parole Stephan Zweig racconta rapidamente la vita di Friedrich Hölderlin (1770-1843), “il più grande lirico tedesco dopo Goethe, un romantico che visse fuori dei confini del romanticismo vero e proprio”[ref]L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1971, vol. II, tomo III, p. 707 s.[/ref], colui che ha avuto la presunzione di servire soltanto l’arte e non vita, gli Dei e non gli uomini; un poeta che ha sperimentato la sofferenza tipica di una grande anima che geme e si sdegna di fronte alla brutalità spirituale che la sua epoca nutriva: “Ombroso, angosciato, tormentato, conscio della forza del suo spirito solo per soffrirne imponentemente […]. Diffidente, suscettibile[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 38 s.[/ref]”, egli sceglie di ‘dar gloria a ciò che eccelle’, nella consapevolezza che questa missione lo priverà di molte gioie: “Hölderlin è della razza di coloro cui non è dato di posare in un luogo […]. Incomincia, inavvertito, il “mirabile desiderio dell’abisso”, quell’attrazione misteriosa che cerca la sua propria profondità”[ref]Ivi, p. 84 s.[/ref]. In una lettera del 1798 Hölderlin scrive:
Vorrei vivere per l’arte alla quale appartiene il mio cuore, e invece debbo faticare tra gli uomini, tanto che spesso sono assai stanco di vivere…non sarei il primo che naufraga; molti, nati per essere poeti, ne sono periti. Non viviamo nel clima della poesia[ref]Lettera di Hölderlin in K. Jaspers, Genio e follia, trad. it. a cura di U. Galimberti, Rusconi, Milano 1990, p. 135.[/ref].
Hölderlin è un poeta ‘moderno’: in lui lo sradicamento esistenziale convive con quello intellettuale. È un poeta che non fa del suo “poetico” la conquista dell’autonomia estetica romantica, piuttosto consegna a questo “poetico” la dimensione religiosa, facendone la sua missione:
Nessun poeta tedesco ha creduto mai come Hölderlin nella poesia e nella divina origine di essa, nessuno ne ha difeso con tanto fanatismo l’incondizionatezza, l’incontaminatezza da ogni cosa terrena […]. La poesia […] è per Hölderlin il senso della vita […]. Essa colma l’abisso che c’è tra il sopra e il sotto dello spirito, fra gli dei e gli uomini[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 49.[/ref].
È intorno al 1930 che Martin Heidegger si avvicina alla poesia di Hölderlin, incontro questo che durerà per tutta la vita del filosofo. In una lettera del 31 Dicembre 1934 all’amica Elisabeth Blochmann, Heidegger scrive:
Nella mattina in cui Lei leggeva Hölderlin (6. XI) ho iniziato il mio corso, e ho letto dei passi proprio dalla lettera dell’1.I.1799. E ieri ho chiuso il corso con quella impressionante lettera del 4. XII. 1801 […]. Hö[derlin] ha pre-istituito la miseria – che ha un rinnovato inizio – del nostro esserci storico, affinché essa ci attenda. E la nostra miseria è la mancanza di miseria, l’impotenza a un’esperienza originaria della problematicità dell’esserci. E l’angoscia di fronte all’interrogare giace sull’Occidente; esilia i popoli in sentieri invecchiati e li ricaccia in fretta in dimore ormai decrepite[ref]M. Heidegger/E. Blochmann, Carteggio 1918-1969, trad. it. a cura di R. Brusotti, Il Melangolo, Genova 1991, p. 135 s.[/ref].
Nel 1936 egli è a Roma, su invito di Giovanni Gentile, con una conferenza su Hölderlin e l’essenza della poesia, in cui si dedica ampiamente all’interpretazione delle tesi capitali che animano la concezione poetica del lirico e che diverranno tema privilegiato della riflessione sul pensiero poetante: il dominio della poesia come luogo del linguaggio, la poesia come fondamento dell’essere e come suprema necessità del pensare. Su questo scenario di indagine ermeneutica si inseriscono i chiarimenti sulle liriche di Hölderlin: del 1939 è l’esegesi di Come quando al dì di festa, in cui il tema privilegiato è il rapporto che lega la Natura al poeta; del 1943 sono invece i testi nati dalle “delucidazioni” intorno alle poesie Rammemorazione e Ritorno a casa, i cui motivi di fondo tornano ad essere quelli del rapporto tra il Sacro e il poeta, della reciproca implicazione tra il linguaggio e il poeta, e della rammemorazione. Sarà proprio attraverso le meditazioni su Hölderlin che Heidegger approfondirà il suo congedo dall’estetica in vista dell’ontologia dell’arte.
Hölderlin gode di un primato indiscusso sugli altri poeti che Heidegger prende in esame (Hebel, Rilke, Trakl e George)[ref]Sul senso dell’interpretazione heideggeriana dei poeti sopra citati si rimanda a L. Amoroso, Quando domandare è (cor-)rispondere, in “Teoria”, n. 1, 1982, pp. 75 e ss.; L. Amoroso, Lichtung. Leggere Heidegger, Rosenber & Sellier, Torino 1993; f. de alessi, Heidegger lettore dei poeti, Rosenberg & Sellier, Torino 1991; e. mirri, La resurrezione estetica del pensare, Bulzoni, Roma 1976; e. oberti, Lineamenti di un’estetica di Heidegger in un saggio su Rilke, in “Rivista di filosofia neoscolastica”, n. 46, 1954, pp. 555 e ss.; g. vattimo, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Marietti, Casale Monferrato 1989; g. vattimo, Heidegger e la poesia come tramonto del linguaggio, in Aa. Vv., Romanticismo, esistenzialismo, ontologia della libertà, Mursia, Milano 1979, pp. 290 e ss. [/ref]; il suo avvicinamento alla figura del lirico tedesco sorge da una necessità del pensiero heideggeriano che è quella di ricevere una parola adeguata per dire ciò che il linguaggio metafisico non è in grado di nominare. Proprio come colui che ricerca, Heidegger accoglie le sollecitazioni, gli aiuti hölderliniani per riscattare l’esperienza del linguaggio di Sein und Zeit[ref]Cfr. L. Amoroso, Nuovi movimenti del “colloquio” Heidegger-Hölderlin, in “Rivista di Estetica”, n. 5, 1980, pp. 97 e ss; E. Landolt, L’essere come ritmo o poesia nell’interpretazione heideggeriana di Hölderlin, in “Sicolorum Gymnasium, 1967, pp. 32 e ss.[/ref]. In questa ambiziosa operazione di ricerca ed accoglienza dell’aiuto proveniente dalla parola poetica, Heidegger sembra “utilizzare” il poeta, asservendo le intuizione filosofiche di questo alle maglie dell’ontologia; così, si staglia sullo sfondo della meditazione heideggeriana il merito hölderliniano di aver saputo intuire l’esito della metafisica occidentale nei termini di estremo oblio dell’essere e di erramento del pensare, presagendo la fine di un’epoca ed inaugurando l’aurora di un secondo inizio, quello del pensiero poetante: “Hölderlin, poetando è arrivato più lontano di tutti nell’epoca in cui il pensiero ancora una volta mirava a conoscere in modo assoluto l’intera storia accaduta”[ref]M. Heidegger, Contributi alla filosofia (dall’Evento), trad. it. a cura di F. Volpi e A. Iadicicco, Adelphi, Milano 2007, p. 213.[/ref].
Il senso ed il limite dell’interpretazione heideggeriana di Hölderlin è stato oggetto dibattuto a lungo da tanta parte della critica filosofica, sotto il duplice riguardo sia di una considerazione limitante dell’esegesi heideggeriana, sia di una considerazione tesa ad evidenziarne i meriti. Proprio alla luce dell’abbondante letteratura critica sul tema e da un ripensamento della prospettiva heideggeriana intorno ad Hölderlin, è evidente che Heidegger costruisca intorno al poeta una cornice ermeneutica che risulta forzata dalle necessità imposte dalla domanda sul senso dell’essere. A beneficio di un recupero ontologico della Seinsfrage, Heidegger non esita a mettere quasi in secondo piano quegli elementi che sono essenziali invece per comprendere tutta la portata estetica e teoretica insieme del lirico tedesco. Così prende forma nel “poetico pensare” del filosofo un’immagine di Hölderlin carente di elementi essenziali, come il romanticismo tedesco e l’idealismo, quali fonti privilegiate per la sua formazione lirica. Non solo: portando a compimento la riflessione romantica sul simbolo e sull’allegoria, Heidegger ne coglie il legame con il linguaggio mitopoetico[ref]Cfr. S. Givone, Heidegger e la questione romantica, in “Aut Aut”, 1989, n°. 234, pp. 59 ss.; P. Chiodi, L’estetica di Heidegger, in “Il Pensiero Critico”, 1954, n°. 9-10, p. 11.[/ref], e proprio in tal senso non si allontana molto dal progetto romantico dell’ideale poetico, né riconosce i suoi debiti nei confronti dell’idealismo tedesco[ref]In merito alla questione di un possibile debito del pensiero heideggeriano nei confronti dell’idealismo tedesco, si rimanda a V. Verra, Heidegger, Schelling e l’idealismo tedesco, in “Archivio di Filosofia”, 1974, pp. 51 ss.; P. Chiodi, L’estetica di Heidegger, cit., p. 11 s.[/ref].
II. Hölderlin fra filosofia e religione
Tutta l’opera di Hölderlin e il suo itinerario poetico devono essere considerati alla luce della formazione dello Stift di Tubinga; in quel contesto culturale, Hölderlin integra la considerazione di Kant con le intuizioni fichtiane alla luce di uno spinozismo dal sapore platonico, permettendo così di flettere l’Uno-Tutto spinoziano attraverso una fantasia mitica che ricomprenda in unione e in armonia la vita. Di Kant egli riconosce l’essenzialità del metodo critico come momento preparatorio per il pensiero, una sorta di propedeuticità al sistema, evidenziando come essa trascenda ogni forma di sensismo[ref]Suggestiva la lettura che fornisce Stephan Zweig della frequentazione kantiana da parte del poeta: “A Weimar questo bambino va alla scuola di Fichte, di Kant, s’ingozza così disperatamente di dottrine filosofiche che lo Schiller stesso deve metterlo in guardia” (S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 72 s.) e poco oltre: “Il desiderato incontro con i Grandi si trasforma in pericolo e danno, e il libero anno di Weimar, da cui aveva sognato il compimento delle sue opere, passa quasi invano. La filosofia, ‘ospedale per poeti mancati’, non gli ha giovato” (Ivi, p. 79).[/ref]; di Fichte apprezza la profondità del suo pensiero tale da definirlo “un titano che combatte per l’umanità”[ref]G. W. F. Hegel, Epistolario, a cura di P. Manganaro, Guida, Napoli 1983, vol. I, p. 111.[/ref] e riconosce l’estrema importanza che l’opposizione Io e Non-Io riveste nel contrasto tra natura e libertà; di Spinoza, la cui conoscenza gli proveniva soprattutto dall’allora diffusa circolazione delle Lettere sulla dottrina di Spinoza di Jacobi, rileggeva nell’elemento dell’Uno-Tutto non tanto la sostanza infinita onnicomprensiva, quanto piuttosto il sentimento di fondo che lo legava sin dalla giovinezza alla natura ed alle sue potenze; di Platone apprezza le riflessioni sul bello, che tuttavia assumono in Hölderlin il sapore del tragico, e sull’importanza del mito all’interno della sua speculazione: il platonismo che egli abbraccia non è più quello della scissione tra idea e realtà, ma quello per il quale l’idea permea tutta la realtà. Proprio ciò lo sollecita a pensare a una fondazione della “mitologia della ragione”, in cui il mito diviene il punto di unione tra logos e poiesis; elevandosi oltre la simbologia allegorica, il mito produce una forma di spiritualità nuova, in cui persino gli dei stessi sono chiamata ad esistere come potenze originarie e non come semplici concetti. Potenze mitiche e mistiche ad un tempo, di cui tuttavia i poeti non sanno più riconoscerne l’identità:
Freddi ipocriti, non parlate degli Dei. Non siete voi intelligenti? Dunque non credete nel Dio del sole, in quello delle tempeste o del mare. La terra è una cosa morta: come dirle “Io ti ringrazio”? Rassicuratevi o Dei! Voi date la bellezza al canto anche se del vostro nome l’anima è fuggita e si è dispersa. Quando si richiede un grande nome si pensa a te, Natura madre[ref]F. Hölderlin, I poeti ipocriti, in Le Liriche, trad. it. a cura di E. Mandruzzato, Adelphi, Milano 1993, p. 409.[/ref].
Gli dei hölderliniani vivono con il poeta in una profonda intimità, al pari della Natura. Nell’Iperione, “il sogno fanciullesco d’un mondo ultraterreno, dell’invisibile patria terrena degli dei”[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 90.[/ref], egli svilupperà la sua concezione della Natura che riesce a superare la morte restituendo alla vita un’armonia perduta, redimendola dalla sua finitudine:
O felice natura! Non mi so render conto di ciò che avviene in me quando levo lo sguardo verso la tua bellezza, ma tutte le gioie del cielo sono nelle lacrime che io verso per la tua bellezza, come l’amante per la sua amata. Tutto il mio essere ammutolisce e sta in ascolto quando le delicate onde del vento giocano intorno al mio petto. Perduto nell’ampio azzurro del cielo, levo lo sguardo su verso l’etra e giù verso il mare sacro e mi sembra che uno spirito fraterno mi apra le braccia e che il dolore della solitudine si sciolga nella vita della divinità. Essere uno con il tutto, questo è il vivere degli dei; questo è il cielo per l’uomo. Essere uno con tutto ciò che vive e ritornare, in una felice dimenticanza di se stessi, al tutto della natura, questo è il punto più alto del pensiero e della gioia, è la sacra cima del monte, è il luogo dell’eterna calma, dove il meriggio perde la sua afa, il tuono la sua voce e il mare che freme e spumeggia assomiglia all’onde di un campo di grano[ref]F. Hölderlin, Iperione, trad. it. a cura di G. V. Amoretti, Feltrinelli, Milano 1981, p. 29.[/ref].
L’animo di Iperione vive in piena sintonia con la Natura, partecipando delle gioie e dei dolori del protagonista. Di questa immagine della Natura gli dei sono presenze reali, che partecipano anch’esse alle vicende del giovane:
Diotima è morta […]. E tu, mio caro Bellarmino, domandi quale sia il mio stato d’animo, mentre ti racconto tutto questo. Ottimo amico, sono calmo perché non voglio avere nulla di meglio di quanto hanno gli dei. Non deve ogni cosa soffrire? E tanto più soffrire quanto più uno eccelle? Non soffre la natura sacra? O mia divinità! Per tanto tempo non mi fu possibile comprendere che tu, beata come sei, potessi soffrire. Ma la voluttà che non soffre è sonno e, senza morte, non c’è vita […]. E ora dimmi, dove troverò ancora rifugio? Ieri salii lassù sull’Etna. Mi ricordai del grande siciliano che, un giorno, stanco di contare le ore, fidandosi dell’anima del mondo e pieno di ardimentoso desiderio di vita, si precipitò nelle splendide fiamme; e un freddo motteggiatore lo irrise dicendo che il freddo poeta aveva dovuto scaldarsi al fuoco. Quanto volentieri avrei preso su di me il peso di questa derisione[ref]Ivi, pp. 168 e ss.[/ref].
La consapevolezza di questa Natura porta il poeta a vivere lo spazio come manifestazione della sua sacralità: “Tutto ciò che può essere nominato si trova all’interno di essa. Essa è l’autentico e l’essenziale, il sacro Tutto al di là di cui non vi è più nulla”[ref]R. Guardini, Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, trad. it. a cura di L. Tieck e G. Colombi, Morcelliana, Brescia 1995, vol. I, p. 179.[/ref]. In questa dimensione della Natura, la Jonia e Jena non sono poi così distanti: la Germania è davvero il luogo in cui si compie e si consuma l’esistenza del poeta, o se si vuole, la patria più immediata rispetto alla amata Grecia. E proprio la Grecia per lui non è soltanto terra, popolo, cultura, dei, quanto la realizzazione dell’attesa del futuro avveniente. È dalla Grecia che si attende il compimento della promessa del ritorno degli dei, è dalla Grecia che si attende la nuova aurora. In ciò risiede l’appartenenza di Hölderlin alla grecità, “non meno di Esiodo e di Pindaro”[ref]A. Caracciolo, Prefazione in W. F. Otto, Theophania. Lo spirito della religione greca antica, trad. it. a cura di A. Caracciolo e M. Perotti Caracciolo, Il Melangolo, Genova 1983, p. 17.[/ref].
Hölderlin così riattiva il legame con la Natura, quella “corrispondenza d’amorosi sensi” di cui la sua anima è interamente pervasa. Tuttavia, questa “religione della Natura”, in cui gli dei sono il baricentro da cui si espande il luminoso, gradatamente inizia ad abbracciare ed includere in sé anche l’elemento cristiano, dapprima rimosso e poi presente attraverso la mediazione della figura centrale di Cristo: “Quanto alla religione, si rese sempre più chiaramente conto dell’abisso che divideva la sua poetica religione della natura dal cristianesimo; ma al cristianesimo e in particolare alla figura di Cristo rimase poi sempre disperatamente attaccato”[ref]L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, cit., vol. II, tomo III, p. 709.[/ref].
III. La figura di Cristo nell’estetica hölderliniana e la missione del poeta
Hölderlin fu educato dalla madre al pietismo, ma non visse le dottrine e le figure cristiane come espressione immediata della sua vita religiosa, poiché non erano da lui considerate sufficientemente valide ed idonee per realizzare la sua missione di poeta attraverso la loro mediazione. Il pietismo esercitò una certa influenza sulla formazione spirituale del poeta[ref]A. Giannatiempo Quinzio, Influssi pietistici e istanze escatologiche nella poesia di Friedrich Hölderlin, in “Bailamme”, 1993, n°. 14, pp. 143 e ss.[/ref], in particolar modo quell’isolamento spirituale che lo condusse a vivere la religione in solitudine. Il Dio della tradizione cristiana non era in grado di raccogliere entro sé gli elementi che Hölderlin riteneva essenziali per la Volksreligion: il religioso, il popolo e il mondo. Egli “prende le distanze dal messaggio cristiano, trovando l’adeguata espressione della sua esperienza nell’antico mondo degli dei o in numi di creazione originale”[ref]R. Guardini, Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, trad. it. a cura di L. Tieck e G. Colombi, Morcelliana, Brescia 1995, vol. I, p. 243. Seguendo l’intuizione di Guardini il rapporto di Hölderlin con il cristianesimo conosce tre fasi articolate in un iniziale periodo di religiosità giovanile, a cui segue la crisi per poi tornare ad appropriarsi della figura del Cristo.[/ref]. Solo in un secondo momento avvertirà l’esigenza di introdurre la figura di Cristo, che acquisterà progressivamente una potenza di sintesi sempre maggiore fino ad entrare in conflitto con gli dei olimpici. Così, dopo un periodo di rifiuto e di distanza dal cristianesimo, la figura di Cristo affiora nella poetica e si staglia in tutto il suo spessore.
Ma chi è il Cristo di cui parla questo romantico? Sin dal tempo di Tubinga, Hölderlin – insieme a Schelling e Hegel – vede nella figura di Cristo una possibile flessione dell’Uno-Tutto attraverso la quale leggere l’avvento del “Regno di Dio” e della “Chiesa invisibile”. Seguendo l’articolato e complesso itinerario del poeta, dalla formazione teologica dello Stift fino alle ultime liriche in cui il suo spirito era ancora presente a se stesso, il Cristo di cui egli parla non è semplicemente il Gesù storico, dal momento che Hölderlin gli riconosce gli attributi di “Dio” e di “semidio”; attraverso l’uso di questi attributi il suo intento non è quello di sottolineare la kenosis del Dio fatto uomo, quanto piuttosto differenziarlo dal Dio padre. Il poeta riconosce in Cristo una divinità e tuttavia lo colloca nello “splendido trifoglio”, accanto a Eracle e Dioniso; egli è l’ultimo dio, il dio a venire, “colui che visse presentemente in mezzo agli uomini, lasciò a coloro che sono abbandonati nella notte la consolazione e la promessa del ritorno”[ref]H. G. Gadamer, Interpretazioni di poeti, trad. it. dei cap. I e II a cura di M. Bonola e dei cap. III e IV a cura di G. Bonola, Marietti, Casale Monferrato 1980, p. 17.[/ref]. Cristo è il signore dell’epoca futura[ref]Cfr. M. Frank, Il dio a venire. Lezioni sulla nuova mitologia, trad. it. a cura di F. Cuniberto, Einaudi, Torino 1994, pp. 238 ss.[/ref], Egli ha dei tratti che rimandano alla seconda potenza schellinghiana come termine che permette il ritorno alla pienezza dell’unione tra il Padre e lo Spirito[ref]Cfr. F. W. J. Schelling, Filosofia della rivelazione, trad. it. a cura di A. Bausola, Rusconi, Milano 1997, pp. 928 ss.[/ref]; nella terza stesura de L’Unico, Hölderlin scrive:
Cristo però si destina da solo. Ercole è come i prìncipi, Bacco è spirito di comunione. Cristo però è la fine[ref]F. Hölderlin, L’Unico, in Le liriche, cit., p. 965. Cfr. anche R. Guardini, Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, cit., vol. II, pp. 716 ss.[/ref].
Cristo è il momento di passaggio, è “presenza nel destino storico dell’Occidente”[ref]H. G. Gadamer, Interpretazioni di poeti, cit., p. 16.[/ref].
Il fatto di essere la fine lo distingue dai due fratelli. Eracle è nel tempo primo; è lottatore, vincitore di potenze avverse, ordinatore del caos, fondatore, sofferente e dominatore allo stesso tempo. Dioniso supera le divisioni dell’esistenza attraverso la potenza che tutto unifica dell’ebbrezza e della trasformazione. Cristo, invece, viene quando il giorno del mondo volge al termine e “si fa sera”. Indica la notte che incombe e vi istituisce una “promessa”: la celebrazione della “gratitudine”, l’Eucarestia, affinché dia forza ai disposti a credere, li educa a intendere finché viene la soluzione […] la mondanizzazione del Regno di Dio biblico[ref]R. Guardini, Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, cit., vol. II, p. 719 s.[/ref].
Cristo entra nella poesia di Hölderlin proprio come assenza, come colui che deve tornare, come “presenza dell’assente nella sua assenza”. Come la intende Hölderlin, la poesia è il risolversi della materia in spirito, una sorta di sospensione della legge di gravità della materia. La sua poesia “non vuole essere mai plastica, ma sempre soltanto luminosa […], non vuole far vedere, descrivendo, qualche cosa di reale sopra la terra, ma portare intuitivamente nei cieli qualche cosa di non sensibile, qualche cosa del sentimento spirituale”[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 110 s.[/ref]. La poesia diviene in tal senso una sorta di specchio per la filosofia e ciò segnerebbe il confine che divide Hölderlin dall’idealismo tedesco, quello spartiacque per il quale la sua opera non può far parte dell’idealismo tedesco in toto. Egli vuole risignificare in profondità la poesia, vuole riconferirle una dignità superiore, riconducendola alla sua funzione originaria: educatrice dell’umanità[ref]Cfr. F. Hölderlin, Il più antico programma sistematico dell’idealismo tedesco, in Scritti d’estetica, trad. it. a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996, p. 162.[/ref]. In questa grandiosa operazione di restituzione del proprium alla poesia, Hölderlin compie un vero itinerario filosofico all’interno del poetare, che lo porta a vedere nella poesia l’essenza di ogni sapere, non in ultimo l’essenza stessa della religione, compiendo un itinerario speculare e nel contempo differente a quello hegeliano – come si vedrà più oltre – per il quale “ogni religione sarebbe per sua essenza poetica”[ref]F. Hölderlin, Sulla religione, in Scritti d’estetica, trad. it. a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996, p. 61.[/ref]. È in tal senso che la poesia acquista una dimensione fondativa rispetto al reale e alla religione, dimensione che proprio Heidegger ha avuto il merito di sottolineare. Come osserva Cornelio Fabro,
se l’essenza dell’arte è la Dichtung, l’essenza del Dichtung è la fondazione [Stiftung] della verità, la quale va intesa nel triplice senso di donare [Schenken], fondare o radicare [Gründen] e iniziare [Anfangen]. È anzitutto donare, perché se la verità e la realtà dell’arte è opera, non è deducibile da ciò che già è e precede ma è profusione [Ueberfluss], e quindi una donazione. È radicare, perché il progetto poetizzante della verità che si pone in opera non è lasciato nel vuoto, ma è rivolto all’umanità futura, cioè storica secondo il duplice orientamento del Mondo e della Terra, è un prendere e un creare, non nel senso del soggettivismo moderno, ma in quello del porre il fondamento fondante ed in questo senso si può dire anche del nulla, perché trascende ciò che è dato. È iniziare, in quanto non è mediato da altro, e quindi comporta un salto [Sprung]: così è sempre l’origine [Ursprung] in cui precisamente si pone il fondamento della nuova opera e si mantiene in qualche modo nascosta anche la fine: quindi non va scambiato con la primitività nel senso abituale[ref]C. Fabro, Ontologia dell’arte nell’ultimo Heidegger, in “Giornale Critico della Filosofia Italiana”, n.° 31, 1952, p. 354[/ref].
Nel verso “ciò che resta lo fondano i poeti” è racchiuso tutto il senso della missione hölderliniana: i poeti fondano ciò che è destinato a durare nel quadro della dialettica tra l’eterno e l’effimero, lo fondando a partire dal poetare che dona fondamento all’ente. In base a questa determinazione del poetare, Heidegger scrive:
La poesia è istituzione attraverso la parola e nella parola. Che cos’è che viene così istituito? Ciò che resta stabile. Ma ciò che è stabile può mai venir istituito? Non è già sempre presente? No! Proprio lo stabile deve essere fissato, lottando contro il travolgimento; il semplice deve venir strappato alla confusione, la misura deve venir preposta allo smisurato. Deve venir all’aperto ciò che regge e pervade l’ente nel suo insieme[ref]M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, cit., p. 49.[/ref].
Cos’è che resta alla cura del poeta?
Il poeta nomina gli dei e tutte le cose in ciò che esse sono. Questo nominare non consiste nel fatto che qualcosa di già noto prima verrebbe soltanto provvisto di un nome, ma, invece, quando il poeta dice la parola essenziale, l’ente riceve solo allora, attraverso questo nominare, la nomina a essere ciò che è. Così viene riconosciuto in quanto ente. La poesia è istituzione in parola (worthaft) dell’essere. Ciò resta non viene perciò mai attinto da quanto è caduco […]. Il dire del poeta è istituzione non solo nel senso della libera donazione, ma anche al tempo stesso nel senso della fondazione dell’esserci umano sul suo fondamento[ref]Ivi, p. 50.[/ref].
È legittimo intendere questo primato della poesia come atto di fondazione del reale rispetto alla filosofia proprio nei termini di una flessione del problema del fondamento verso la direzione individuata dall’ontologia dell’arte. Heidegger aveva già affrontato tale tema nel corso delle lezioni tenute durante il semestre invernale 1955/1956 all’Università di Friburgo, lezioni confluite poi nel bel testo Il principio di ragione, dove il tema del fondamento, oltrepassando l’esito metafisico, può essere salvaguardato nell’orizzonte della poesia[ref]Cfr. M. Heidegger, Il principio di ragione, trad. it. a cura di G. Gurisatti e F. Volpi, Adelphi, Milano 1991, pp. 72 e ss.; M. Heidegger, Dell’essenza del fondamento, in Segnavia, trad. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987, pp. 93 e ss.[/ref]. Egli suggerisce di pensare la fondazione operata dalla poesia anche in rapporto alla temporalità dell’esistenza del Dasein, realizzando tuttavia uno svuotamento dell’eternità a favore dell’accadere esistentivo. Ciò sembra essere distante dalla effettiva volontà di Hölderlin che nell’atto di fondazione del reale consegna alla poesia altresì la possibilità di eternizzare il mondo rispetto ai limiti dell’esistenza. La parola del poeta fonda qualcosa che è destinato a rimanere, poiché essa è trascendente. La parola che fonda è così consegnata dal poeta/vate alla storia proprio nel passaggio che va da un’epoca all’altra, in quanto essa risiede nella stabilità, nello stesso perdurare che legittima la fondazione di ciò che resta. Mi sembra corretto vedere in questa volontà da parte del poeta tedesco l’annunciarsi di un itinerario speculativo che vuole affidare alla poesia il compito fino ad allora assolto dalla religione, proprio come ciò che dà esistenza al mondo. Questa volontà prende forma fin dagli appunti giovanili ed è contenuta ne Il più antico programma sistematico dell’idealismo tedesco; qui infatti si legge:
Monoteismo della ragione e del cuore, politeismo dell’immaginazione e dell’arte: è questo di cui abbiamo bisogno! […] Se non daremo alle idee una forma estetica, cioè mitologica, esse non avranno interesse per il popolo, e viceversa: se la mitologia non è razionale, il filosofo ne deve provare vergogna. E così alla fine coloro che sono illuminati e coloro che non lo sono, si uniranno: la mitologia deve diventare filosofica, così da rendere il popolo razionale, e la filosofia deve diventare mitologica, così da rendere sensibili i filosofi […]. E potremmo sperare allora in un armonico sviluppo di ogni capacità, nel singolo come nella totalità degli individui. Nessuna capacità sarà più repressa; finalmente regnerà una grande libertà e uguaglianza degli spiriti! Uno spirito superiore inviato dal cielo dovrà fondare tra noi questa nuova religione; sarà l’estrema, la più alta opera dell’uomo![ref]F. Hölderlin, Il più antico programma sistematico dell’idealismo tedesco, in Scritti d’estetica, trad. it. a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996, p. 162 s.[/ref]
Mentre gli amici degli anni dello Stift (Schelling ed Hegel) avvertono fondamentale sanare la scissione, il dissidio, la lacerazione, quella che Hegel chiamerà “l’infelicità della coscienza”, Hölderlin invece sa che tale scissione è insanabile poiché essa è ciò che caratterizza l’anima stessa dell’uomo. Il poeta non accetta nessuna mediazione concettuale, nessuna Aufhebung, e rinuncia dapprincipio ad ogni forma di mediazione dialettica[ref]O. Pöggeler, Hölderlin, Schelling und Hegel bei Heidegger, in “Heidegger Studien”, vol. 28, 1993, pp. 320 e ss.[/ref];
Hölderlin incontra i concetti fondamentali dell’idealismo filosofico e se ne impossessa; ma poiché questi concetti in lui si radicano in altre premesse spirituali, essi assumono per lui un altro significato e per così dire un altro colore, rispetto a quelli che possiedono per i fondatori della speculazione idealistica[ref]E. Cassirer, Hölderlin e l’idealismo tedesco, trad. it. a cura di A. Mecacci, Donzelli, Roma 2001, p. 30.[/ref].
IV. La bellezza che accoglie la scissione
È all’interno di questa “infelicità consapevole”, di questa accettazione del dolore e della lacerazione come termini inconciliabili, che nasce la categoria estetica del bello, la quale trova la sua più compiuta formulazione nell’Iperione, a cui Hölderlin lavora tra il 1792, nella forma di abbozzo preliminare, e il 1797. Proprio in questo romanzo il poeta scrive una delle pagine più belle e ricche di spunti filosofici per comprendere la sua derivazione dall’idealismo e nel contempo il suo oltrepassamento:
La prima creatura della bellezza umana e della bellezza divina è l’arte. In essa l’uomo divino si ringiovanisce e si rinnova. Vuole prendere coscienza di sé, per questo egli si colloca di fronte alla propria bellezza. In tal modo l’uomo si creò i suoi dei. Perché in principio l’uomo e i suoi dei erano una cosa sola, quando ignota a se stessa, esisteva l’eterna bellezza […]. La seconda creatura della bellezza è la religione. Religione è l’amore della bellezza. Il saggio ama proprio lei, l’infinita che tutto contiene; il popolo ne ama le creature, gli dei che gli appaiono sotto varie forme[ref]F. Hölderlin, Iperione, cit., p. 99 s.[/ref].
E nella prefazione alla penultima stesura del romanzo scrive:
Noi tutti percorriamo una traiettoria eccentrica e non vi è altra via che possa condurre dalla fanciullezza al compimento. La divina unitezza, l’essere nel significato autentico della parola, è per noi andato perduto, e doveva essere perduto per poterlo poi desiderare, riconquistare […]. Spesso per noi è come se il mondo fosse tutto e noi nulla, però anche come se noi fossimo tutto e il mondo nulla. Anche Iperione era lacerato tra questi due estremi. Porre fine all’eterno contrasto tra il nostro essere e il mondo, ristabilire la pace di tutte le paci, che è superiore a ogni ragione, riunificarci alla natura in un tutto infinito, questo è il fine di ogni nostra aspirazione […]. Non avremmo però alcun presentimento di quella pace infinita […] se quell’unificazione infinita, quell’essere, nel significato autentico del temine non fosse già presente. È presente come bellezza[ref]F. Hölderlin, “Prefazione” [alla penultima stesura dell’ ”Iperione”], in Scritti d’estetica, trad. it. a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996, p. 54 s.[/ref].
L’ideale hölderliniano della bellezza racchiude in sé il tragico da cui non può esserne scisso. La bellezza non è serafica, non è consolatoria, bensì è conciliazione “entro la discordia stessa”[ref]F. Hölderlin, Iperione, cit., p. 178.[/ref], è ciò che rende possibile l’unione pur mantenendo la distinzione degli elementi opposti e il loro conflitto, è sottrazione della coscienza rispetto al dominio estetico, è segno del negativo. La bellezza hölderliniana sembra avere quello stesso sapore amaro scoperto da Rimbaud, se pur nella totale ed esclusiva diversità della scoperta e dell’accettazione del proprio sé: mentre Rimbaud ha dovuto sperimentare il fallimento e la dissoluzione, ha dovuto “farsi pieno di deserto” per scoprire la desolazione delle albe, Hölderlin ha dovuto “farsi pieno di dei” per riscoprire il volto mistico della natura, ha dovuto in definitiva scoprire nella bellezza il segno di un’assenza. Questa bellezza, così prossima alla soglia del nulla[ref]Cfr. L. Chiuchiù, Soglia della bellezza. Hölderlin, in “Davar”, n. 3, 2006, pp. 73 e ss.[/ref], ha in sé il tratto distintivo di questa vicinanza abissale, una porzione di negativo che forse, nemmeno nella più alta speculazione di Hegel riesce a mostrare tutta la sua portata fino a s-fondare il campo dell’estetica. Infatti, nella riflessione del pensatore di Stoccarda il negativo è pensato attraverso un alto sforzo speculativo nell’orizzonte di fondazione della dialettica, costituendone il nerbo logico oltre che reale; il negativo assume, in un primo momento, la forma della disuguaglianza dell’Io con la sua propria sostanza e, in un secondo momento, la disuguaglianza della sostanza con se stessa. All’interno dello sviluppo dello Spirito, solo nella veste del concetto il pensiero riesce a formulare un’adeguata comprensione del negativo, e tale veste è anche quella che nelle lezioni di estetica porta Hegel a parlare di Auflösung: “dissoluzione”, “risoluzione”, proprio per esprimere l’esigenza dialettica del sistema per la quale l’arte, come primo momento della filosofia dello Spirito, deve essere superata, e quindi deve dissolversi, in una forma più adeguata per esprimere la vera forma dell’Assoluto. Quindi, in Hegel la portata del negativo è pur sempre funzionale alla Aufhebung che non tollera la dissoluzione, la “conciliazione entro la discordia” e che per realizzare la marcia trionfante dell’Idea assoluta è pronta a lasciare il negativo al di fuori dell’estetica. Hölderlin sembra muoversi nella direzione opposta: egli pensa il negativo interno alla bellezza proprio a partire dal tragico, il quale è la categoria più propria a determinare la doppia appartenenza che la bellezza ha verso il nulla e verso l’essere. E’ in tal senso che Hölderlin s-fonda l’estetica poiché pensa il negativo contenuto nella bellezza come sua dimensione più originaria. Egli porta la coscienza alla consapevolezza che la bellezza è estranea all’Aufhebung, che al suo posto vi è solo conciliazione entro discordia. Questo è il senso del seme tragico della poetica hölderliniana che trova la sua rappresentazione più compiuta in Empedocle. Il progetto per la stesura de La morte di Empedocle è già contenuto, in filigrana, nell’Iperione, proprio nel periodo francofortese. Empedocle sintetizza i due stati d’animo già presenti in Iperione: la venerazione per la divinità della Natura e la fuga da una vita insoddisfacente per l’uomo:
Empedocle è figlio del suo cielo, della sua epoca, della sua patria, figlio delle forti opposizioni tra natura e arte, con cui il mondo si mostrò ai suoi occhi. È l’uomo in cui quegli antagonismi si conciliano così profondamente da divenire in lui unità, abbandonando e invertendo la loro forma distintiva originaria […] Il suo destino si rappresenta in lui come conciliazione momentanea, che tuttavia è costretta a dissolversi per accrescersi[ref]F. Hölderlin, Fondamento dell’ “Empedocle”, in Scritti d’estetica, trad. it. a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996, p. 84 e ss.[/ref].
Rispetto ad Iperione, la novità di Empedocle risiede nel fatto che la sua anima è coinvolta all’interno del dissidio, di questa dialettica inconciliabile tra l’Io e il Non-Io. Forse non è errato considerare Empedocle come un eroe tragico in senso moderno poiché in lui si manifesta una lacerazione non solo morale ma anche psicologica. Di fronte a questa lacerazione egli sceglie la morte, ma non come un personaggio della tragedia greca, non come una maschera eschilea che sopporta la morte tragicamente sofferta, piuttosto egli sceglie la morte liberamente, con consapevolezza gioiosa: “La morte sola può salvare quel che c’è di sacro del poeta. Il suo intatto entusiasmo non contaminato dalla vita; solo la morte può eternare la vita in un mito”[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 103.[/ref]. La morte non è il semplice avvenimento che chiude un ciclo biologico, ma un evento che si compie in riferimento al Tutto e che, se da un lato priva l’uomo di ciò che è dato, dall’altro lo riconsegna a ciò che all’uomo è sottratto.
Empedocle non può, o forse non vuole ulteriormente, essere parte della tensione verso l’Uno-Tutto. Empedocle è l’eroe tragico che non si accontenta della logodicea hegeliana; piuttosto, egli permane, parafrasando Hegel, all’interno della potenza del negativo. Attraverso questo personaggio Hölderlin accetta e si fa carico del travaglio del negativo, rinunciando ad ogni soluzione che tenti di conciliare gli opposti, di oltrepassare il negativo. Piuttosto, egli resta nel negativo, sperimentandolo fino in fondo come dolore, limite, assenza, portando a compimento la dialettica del sentimento, opposta ed opponentesi alla dialettica del concetto. È in questo ordine di trame emotive che forse il limite di Empedocle, quel limite per il quale egli ha scelto la morte, risiede nel fatto di non poter rendere ragione esteriormente dell’unità interiore intessuta tra il suo Io e la Natura:
sempre più si avvicina la mia ora e dai dirupi giunge sino a me il fido araldo della notte, il vento della sera, messaggero d’amore. È maturato il tempo. Palpita, giacché lo spirito sta sopra di te come astro luminoso, mentre in cielo trasmigrano le nubi senza patria, sempre in fuga. Che sento? Mi stupisco come se la mia vita cominciasse, perché tutto è diverso e solamente ora io sono… […] e tu, Natura, mi porgi il calice tremendo e spumeggiante, affinché il tuo cantore possa bere l’entusiasmo supremo! Sono felice, non cerco altrove il luogo della fine[ref]F. Hölderlin, Empedocle, trad. it. a cura di E. Pocar, Garzanti, Milano 1998, p. 127 s.[/ref].
V. Heidegger e Hölderlin
Nell’intervista rilasciata a Der Spiegel Heidegger affermava:
Il mio pensiero sta in un rapporto inaggirabile con la poesia di Hölderlin. Io non considero Hölderlin come un qualunque poeta, la cui opera gli storici della letteratura prendono in considerazione accanto a quella di molti altri. Per me Hölderlin è il poeta che indica verso il futuro, che attende il Dio[ref]M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, trad. it. a cura di A. Manni, Guanda, Parma 1987, p. 147.[/ref].
Proprio in qualità di colui che indica,
Hölderlin non è stato scelto perché la sua opera, come fra le altre, realizzi l’essenza generale della poesia, ma unicamente perché la poesia di Hölderlin è poeticamente determinata e destinata a poetare espressamente l’essenza stessa della poesia. Hölderlin è per noi in un senso eminente il poeta del poeta[ref]M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, trad. it. a cura di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1988, p. 42.[/ref].
Egli è per Heidegger il termine necessario che fa del fondamento un tema intimo alla poesia e alla filosofia, snodo concettuale essenziale attraverso cui rendere ragione della flessione della Seinsfrage dopo l’incompiutezza di Sein und Zeit. Il poetare è in questa direzione il continuamento e l’inveramento delle posizioni contenute nell’opera del ’27. Forse il maggior merito dell’interpretazione heideggeriana è quello di aver compreso come l’essenza della poesia di Hölderlin sia storica in sommo grado. La filosofia della storia che soggiace alla sua produzione è tutta tesa a mettere in evidenza come la storia sia estrinsecazione del divino. La storia è historia signa temporum ma sotto il segno del negativo, cioè della mancanza del divino nel presente, quindi tempo di povertà; ma anche storia dei segni della presenza del divino nel tempo che viene, cioè storia dell’epifania del divino a partire da una dialettica di assenza/presenza. La storia ha un significato provvidenziale ed è storia escatologica: questo senso religioso della storia destina tutte le cose ad una loro trasformazione:
Questa dottrina è applicata da Hölderlin al compimento che deve realizzarsi nel corso della storia quando quest’ultima è giunta in un vicolo cieco. Ciò che ritorna non è più Cristo, ma la Grecia. Colui che manda non è il Padre, ma l’Etere, la forza operativa non è più lo “Pneuma di Cristo”, ma la pienezza dionisiaca dello spirito. Il nodo da sciogliere non è il peccato dell’umanità, ma l’intrinseca mancanza di sbocchi della storia[ref]R. Guardini, Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, cit., vol. I, p. 220 s.[/ref].
La fiduciosa attesa per la realizzazione dell’eschaton e il compimento non solo dell’idealizzato “Regno di Dio” di provenienza degli anni giovanili ma anche della venuta degli dei dell’età matura, e più in generale della Grecia, sono il sigillo con cui al poeta è concesso di cantare il tempo dell’attesa, il “venerdì santo poetico”. Come giustamente afferma Romano Guardini, Hölderlin non è più un’artista, ma diventa un vate[ref]Ivi, p. 7.[/ref] che vede e si commuove, in cui l’elemento visionario non va “inteso come “fenomeno psicologico”, bensì come “processo di donazione”, attraverso cui possono emergere fenomeni e connessioni altrimenti nascosti”[ref]Ivi, p. 10.[/ref]. Come vate, egli pretende fede, che si creda cioè al ritorno della Grecia, alla trasformazione della vita che “si ricolma di senso divino”. Il concetto di futuro che sottende a questa concezione della storia contiene in sé il riferimento all’eternità, a ciò che deve prepararsi per venire in eterno. Non si tratta di chiliasmo, ma di fiduciosa attesa del momento in cui “il non terreno entra nel terreno, l’eterno nel temporale, ma in modo tale di mantenere il terreno terreno ed il temporale temporale. Questo significa però che la storia e la non-storia, la terra e il cielo, l’economia escatologica e il decorso dell’esistenza si ritroveranno in uno”[ref]Ivi, p. 227.[/ref]. Proprio alla luce di questa esigenza così stringente del pensiero e della poetica di Hölderlin è allora possibile comprendere tutta la portata della missione poetica, del canto come rammemorazione, come ricordo delle promesse: “Custodire la memoria è da sempre la missione del poeta. Questa sua missione assume qui il significato di risvegliare e suscitare ciò che è assente”[ref]H. G. Gadamer, Interpretazioni di poeti, cit., p. 18.[/ref]. Nella stesura aggiuntiva della lirica L’arcipelago Hölderlin scriveva:
Ma poiché così prossimi sono gli Dei presenti debbo essere come se fossero lontani, e oscuro tra nubi deve esserci il loro nome , solo prima che il mattino splenda, prima che arda la vita del mezzogiorno li nomino per me in silenzio, perché il poeta abbia ciò che è suo, ma quando la luce celeste discende volentieri penso al passato e dico – fiorite intanto[ref]F. Hölderlin, L’arcipelago, in Le liriche, cit., p. 950.[/ref].
Come osserva Remo Bodei, “nella lontananza massima del dio dall’uomo, traspare quasi per absentiam l’unità dell’essere e la presenza del divino”[ref]R. Bodei, Hölderlin: la filosofia e il tragico, in F. Hölderlin, Sul tragico, trad. it. a cura di G. Pasquinelli e R. Bodei, Feltrinelli, Milano 1989, p. 18.[/ref]. In Vocazione del poeta si legge:
No, non la sorte e non l’ansia dell’uomo o nella casa o sotto il cielo aperto, anche se egli si adopera e se si nutre più nobilmente della belva – altro conta, cura e missione dei poeti. È l’Altissimo, a cui apparteniamo, perché nuovo nel canto e più vicino l’accolga in amicizia il cuore umano[ref]F. Hölderlin, Vocazione del poeta, in Le liriche, cit., p. 449.[/ref].
La mancanza non è solo privazione ma è anche destino storico, nominato dal poeta sulla soglia del compimento della promessa, “la sacra Memoria che serbi desta lungo le notte”[ref]F. Hölderlin, Pane e Vino, in Le liriche, cit., p. 521.[/ref]. Tutta la poesia di Hölderlin è una teofania vespertina:
Romantica è la poesia hölderliniana della natura, perché la teofania, che ne è il fulcro ed il senso, vi costituisce un breve momento, un momento che nella sua brevità appare quasi illusorio. Essa si compie sempre nell’ora del crepuscolo […]Prima che la luce svanisca del tutto, per un attimo, per un attimo solo, il nume scende misteriosamente sulla terra, sembra toccare i vertici degli alberi più alti e chi sotto gli alberi giace in mezzo ai fiori, è colmo della certezza inebriante che è scomparsa ogni distanza tra la terra e il cielo, fra gli uomini e gli dei, tanto che la lieve aura vespertina che avvolge e compenetra i sensi dei mortali, ravvivandoli dopo l’arsura meridiana, sembra concreta emanazione dell’anima invisibile e pur sempre presente dell’universo[ref]L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, cit., vol. II, tomo III, p. 713.[/ref].
Quando si avverte di nuovo la luce sulla terra, il dio abbandona il mortale e torna nel numinoso spazio dove egli abita. Gli dei vivono nell’eterna gloria che pur non avvertono: per questo si fanno vicini agli uomini, affinché essi attestino il rapimento che la gloria olimpica esercita su di loro. Gli dei hanno bisogno del cuore degli uomini, poiché attraverso questo essi sanno il loro eterno splendore. Nel tanto noto Perché i poeti Heidegger prende le mosse proprio povertà spirituale e intellettuale dell’epoca contemporanea, pur inserendola nel solco della già tracciata critica alla metafisica:
Con la venuta e il sacrificio di Cristo ha avuto inizio, secondo la concezione storica di Hölderlin, la fine del giorno degli dei. È caduta la sera. Da quando i “tre che sono uno”: Ercole, Dioniso e Cristo, hanno lasciato il mondo, la sera del tempo mondano va verso la notte. La notte del mondo distende le sue tenebre. Ormai l’epoca è caratterizzata dall’assenza di Dio, dalla “mancanza” di Dio. La mancanza di Dio, come venne sentita da Hölderlin, non nega la persistenza di un atteggiamento cristiano verso Dio […]. La mancanza di Dio significa che non c’è più nessun Dio che raccolga in sé gli uomini e le cose […]. Ma nella mancanza di Dio si manifesta qualcosa di peggiore ancora. Non solo gli dei e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale. Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà perché diviene sempre più povero. È già diventato tanto povero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza[ref]M. Heidegger, Perché i poeti?, in Sentieri interrotti, cit., p. 247.[/ref].
Il compito del poeta si colloca all’inizio di un’apertura storica: il poeta si fa solo esecutore del processo storico a cui l’essere lo chiama a partecipare con la funzione di nominare questa mancanza originaria. Nell’adempimento di questo compito egli deve anche mantenere il mistero dell’origine che determina il rapporto tra essere ed uomo, facendosi carico di una vera e propria missione: egli deve fare epoca, nominando l’epoca della povertà a cui esso presiede e la modalità con cui l’essere si disvela. Suggestivamente Heidegger scrive: “Il poeta, come semidio, è l’opera degli dei e degli uomini, cioè il frutto della festa nuziale”[ref]M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, cit., p. 135 s.[/ref]. Per questa vicinanza che egli ha con il divino, il poeta può apparire simile ad un profeta:
I poeti possono dire ciò che, prima del loro poetare e per esso, è la poesia, solo se dicono ciò che precede ogni reale: ciò che viene [….]. I poeti, se sono nella loro essenza, sono profetici. Ma non sono “profeti” nel significato giudaico cristiano del termine […]. Essi predicono subito il dio come sicura garanzia di salvezza nella beatitudine ultraterrena. Non si sfiguri la poesia di Hölderlin con “il religioso” della “religione”, la quale è e rimane un modo romano d’interpretare il rapporto fra gli uomini e gli dei. Non si prostri l’essenza di questa missione poetica facendo del poeta un “veggente” nel senso dell’indovino. Il sacro annunciato primieramente nella poesia non fa che aprire lo spazio-tempo di un’apparizione degli dei ed indicare la località dell’abitare dell’uomo storico su questa terra[ref]Ivi, p. 136 s.[/ref].
Nella sua prossimità con il divino, il poeta rende ragione anche del Sacro. Hölderlin adopera tre distinte espressioni per nominare il Sacro: das Heilige, das Höchste ed infine der Abgrund, tre parole che vengono usate dal poeta quasi indifferentemente, sebbene l’ultima assuma un’accezione più ampia in quanto rimanda all’abisso che si cela dietro al Sacro. Nello heil risuona
quell’idea di vigore, vitalità, impeto […]. È attributo di venti, cavalli, uomini, città […] ma anche di cose […] colte […] in un istante culminante della loto potenza […]. Heilig conserva intatto questo significato in Hölderlin; etimologicamente, dunque, esso si oppone ad ogni idea di sacralità[ref]M. Cacciari, Il problema del sacro in Heidegger, in “Archivio di filosofia”, n. 1, 1989, p. 205 s.[/ref].
Questo termine assume il senso che conosciamo dalle parole del poeta a seguito di una trasformazione che lo colpisce e lo suggestiona; deve esserci qualche elemento che rapisce Hölderlin e che lo spinge a parlare di Sacro. Il Sacro non è il divino: essi sono distinti; il Sacro è ulteriore al divino, è “ ‘ciò’ da cui ek-siste”[ref]Ivi, p. 206.[/ref], ciò che rimanda ad un’apertura originaria fondativa. La fedeltà alla verità che il Sacro rappresenta è il tratto più caratteristico della poetica di Hölderlin; in Come al dì di festa si legge:
L’attesi, l’ho veduto venire. Quello che vidi, il Sacro, sia la mia parola. La Natura più antica delle età, sopra gli Dei d’oriente e d’occidente, si è ora destata con un suono d’armi, e dall’Etere alto ai fondi abissi secondo leggi ferme, come un tempo quando la generò il sacro Caos sente in sé nuova quella che tutto crea, l’estasi ardente[ref]F. Hölderlin, Come quando al dì di festa, in Le liriche, cit., p. 571.[/ref]
Nella fedeltà alla parola di Hölderlin, il riconoscimento del Sacro conduce alla sua conservazione, la quale avviene nella rammemorazione, rimedio che lenisce l’assenza e la fuga degli dei.
Il luogo a partire dal quale il poeta deve nominare gli dei deve essere tale che coloro che vanno nominati gli restino lontani nella presenza del loro venire, restando, proprio in questo modo, coloro che vengono. Affinché questa lontananza si apra come lontananza, il poeta deve ritrarsi dalla vicinanza angustiante degli dei e “nominarli solo quietamente”[ref]M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, cit., p. 226.[/ref].
In questa visione del mondo, il canto è inno all’avvenire e speranza del compimento, narrazione di una promessa che dice il ritorno.
Nessun poeta tedesco ha mai creduto come Hölderlin nella poesia e nella divina origine di essa, nessuno ne ha mai difeso con tanto fanatismo l’incondizionatezza, l’incontaminatezza di ogni cosa terrena […]. Perfino per Goethe la poesia non è che una parte della vita, mentre per Hölderlin essa è, incondizionatamente, il senso che per lui sta al di sopra della sua persona, è una necessità religiosa[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, trad. it. a cura di A. Oberdorfer, Sperling & Kupfer, Milano 1934, p. 49.[/ref].
Come suggerisce Heidegger sulla scia delle considerazioni di Bettina von Arnim,
il dio si sarebbe servito del poeta come freccia per scoccare il suo ritmo dall’arco e chi non lo percepisca e non vi si adegui non avrà mai né destino né virtù atletica da poeta e sarà troppo debole per potersi dare una forma, sia nel materiale, sia nella visione del mondo degli antichi, sia nel modo moderno di rappresentarci le nostre tendenze, e nessuna forma poetica gli si rivelerà. I poeti che riprendono scolasticamente forme date possono poi soltanto ripetere lo spirito già dato: essi si collocano come uccelli su un ramo dell’albero della lingua e vi si cullano e secondo il ritmo originario che esso ha nelle radici; ma un poeta di tal sorta non prenderà mai il volo quale aquila dello spirito, covata dalla spirito vivente della lingua[ref]M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, cit., p. 185.[/ref].
Forse proprio l’incondizionatezza della poesia, il vivere per la poesia, l’adempiere fino in fondo la sua “vocazione di poeta” fu una delle cause della follia che colpì Hölderlin, di quella follia “che doveva rinchiuderlo per anni come un sepolcro […] nel più puro linguaggio sofocleo e in una inesauribile ricchezza di profondi pensieri”[ref]F. Nietzsche, La mia vita, trad. it. a cura di M. Carpitella, Adelphi, Milano 1977, p. 106.[/ref].
Le tracce della malattia si manifestarono già a partire dal 1801. Nella sua patologia non c’è un crollo netto o un offuscamento della propria conoscenza di sé: tutt’altro. Se trova corrispondenza clinica l’analisi di Karl Jaspers per la quale la malattia di questo poeta è scandita da due fasi – una, intorno al 1801 che segna il passaggio dalla salute alla malattia, e un’altra, intorno al 1805-1806, per la quale si assiste allo sviluppo morboso della stessa – , proprio nel passaggio da una fase all’altra Hölderlin lotta contro l’ “accecamento” dello spirito, disciplinando se stesso per evitare che la frantumazione del sé prenda il sopravvento. Gradatamente la sua sensibilità diventa malata, “gli slanci della sua anima diventano esplosioni del corpo”[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 120.[/ref]. In una lettera del 1796, scritta al fratello, egli si paragonava ad una vecchia pianta in un vaso, caduta già una volta sulla strada e che avendo perdute le gemme, ferita alla radice, trapiantata ora in un terreno nuovo, a fatica, con attente cure, è stata salvata dal rinsecchire pur rimanendo ancora in parte avvizzita. E in un’altra missiva del 1799 scriveva: “I miei atti e le mie parole sono così spesso maldestri e assurdi, perché al pari delle oche sto con piedi piatti nell’acqua, sbattendo le ali impotenti verso il cielo greco”[ref]Lettera di Hölderlin in K. Jaspers, Genio e follia, trad. it. a cura di U. Galimberti, Rusconi, Milano 1990, p. 136.[/ref]. Questa conoscenza di sé nel periodo a cavallo della manifestazione evidente della malattia sarà sempre più chiara, così come sarà sempre più chiara la sua prigionia nella realtà. Per quarant’anni Hölderlin sarà trascinato nel vortice della pazzia, il suo sé diventerà Scardanelli; parlerà confusamente usando parole senza forma; eppure le liriche di questo periodo sono semplici, chiare, strofe brevi, generose nella descrizione; il tema privilegiato la Natura e le stagioni:
Talvolta siede al pianoforte e suona per ore e ore; ma non trova più sequenze, non ne cava una piena serie di suoni: solo un morto armonizzare, una ripetizione testarda, fanatica della stessa melodia povera e breve; e le unghie delle dita, cresciute selvaggiamente, battono spettralmente sui tasti scordati […]. Se qualcuno fa imprudentemente il nome di Hölderlin, Scardanelli scatta in un impeto d’ira. Se il colloquio si prolunga troppo il malato diventa a poco a poco inquieto e nervoso, perché lo sforzo del pensare e la tortura dell’intendere sono troppo grandi per il suo cervello stanco: e allora il visitatore lo lascia, accompagnato fino alla porta tra uno spavento d’inchini e di riverenze[ref]S. Zweig, La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, cit., p. 135 s.[/ref].
* Il presente contributo è stato pubblicato per la prima volta in Estetica 2/2008, pp. 77-95 con il titolo “Ciò che resta lo fondano i poeti”. Fondamento e poesia tra Heidegger e Hölderlin. In questa sede si ripropone con delle lievi modifiche.
Bibliografia delle opere citate e di studi sul tema
M. Heidegger, Sentieri interrotti, trad. it. a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1997 M. Heidegger, Contributi alla filosofia (dall’Evento), trad. it. a cura di F. Volpi e A. Iadicicco, Adelphi, Milano 2007 M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, trad. it. a cura di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1988 M. Heidegger, Il principio di ragione, trad. it. a cura di G. Gurisatti e F. Volpi, Adelphi, Milano 1991 M. Heidegger, Segnavia, trad. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987 M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, trad. it. a cura di A. Manni, Guanda, Parma 1987 M. Heidegger/E. Blochmann, Carteggio 1918-1969, trad. it. a cura di R. Brusotti, Il Melangolo, Genova 1991
F. Hölderlin, Le Liriche, trad. it. a cura di E. Mandruzzato, Adelphi, Milano 1993 F. Hölderlin, Iperione, trad. it. a cura di G. V. Amoretti, Feltrinelli, Milano 1981 F. Hölderlin, Empedocle, trad. it. a cura di E. Pocar, Garzanti, Milano 1998 F. Hölderlin, Scritti d’estetica, trad. it. a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996 F. Hölderlin, Sul tragico, trad. it. a cura di G. Pasquinelli e R. Bodei, Feltrinelli, Milano 1989
F. W. J. Schelling, Filosofia della rivelazione, trad. it. a cura di A. Bausola, Rusconi, Milano 1997, pp. 928 ss.
G. W. F. Hegel, Epistolario, a cura di P. Manganaro, Guida, Napoli 1983
F. Nietzsche, La mia vita, trad. it. a cura di M. Carpitella, Adelphi, Milano 1977
Aa. Vv., Romanticismo, esistenzialismo, ontologia della libertà, Mursia, Milano 1979 Amoroso L., Lichtung. Leggere Heidegger, Rosenber & Sellier, Torino 1993 Amoroso L., Nuovi movimenti del “colloquio” Heidegger-Hölderlin, in “Rivista di Estetica”, n. 5, 1980 Amoroso L., Quando domandare è (cor-)rispondere, in “Teoria”, n. 1, 1982 Bodei R., Hölderlin: la filosofia e il tragico, in F. Hölderlin, Sul tragico, trad. it. a cura di G. Pasquinelli e R. Bodei, Feltrinelli, Milano 1989 Bodei R., L’estetica del bello, Il Mulino, Bologna 1995 Cacciari M., Il problema del sacro in Heidegger, in “Archivio di filosofia”, n. 1, 1989 Caracciolo A., Prefazione in W. F. Otto, Theophania. Lo spirito della religione greca antica, trad. it. a cura di A. Caracciolo e M. Perotti Caracciolo, Il Melangolo, Genova 1983 Cassirer E., Hölderlin e l’idealismo tedesco, trad. it. a cura di A. Mecacci, Donzelli, Roma 2001 Chiodi P., L’estetica di Heidegger, in “Il Pensiero Critico”, 1954, n°. 9-10 Chiuchiù L., Soglia della bellezza. Hölderlin, in “Davar”, n. 3, 2006 Cvetaeva M., Il poeta e il tempo, trad. it. a cura di S. Vitale, Adelphi, Milano 1984 De alessi F., Heidegger lettore dei poeti, Rosenberg & Sellier, Torino 1991 Fabro C., Ontologia dell’arte nell’ultimo Heidegger, in “Giornale Critico della Filosofia Italiana”, n.° 31, 1952 Frank M., Il dio a venire. Lezioni sulla nuova mitologia, trad. it. a cura di F. Cuniberto, Einaudi, Torino 1994 Gadamer H. G., Interpretazioni di poeti, trad. it. dei cap. I e II a cura di M. Bonola e dei cap. III e IV a cura di G. Bonola, Marietti, Casale Monferrato 1980 Giannatiempo Quinzio A., Influssi pietistici e istanze escatologiche nella poesia di Friedrich Hölderlin, in “Bailamme”, 1993, n°. 14 Givone S., Heidegger e la questione romantica, in “Aut Aut”, 1989, n°. 234 Guardini R., Hölderlin: immagine del mondo e religiosità, trad. it. a cura di L. Tieck e G. Colombi, Morcelliana, Brescia 1995 Jaspers K., Genio e follia, trad. it. a cura di U. Galimberti, Rusconi, Milano 1990 Jaspers K., Genio e follia, trad. it. a cura di U. Galimberti, Rusconi, Milano 1990 Landolt E., L’essere come ritmo o poesia nell’interpretazione heideggeriana di Hölderlin, in “Sicolorum Gymnasium, 1967 Mirri E., La resurrezione estetica del pensare, Bulzoni, Roma 1976 Mittner L., Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1971, vol. II, tomo III Moretti G., Il poeta ferito. Hölderlin, Heidegger e la storia dell’essere, La Mandragora Editrice, 1997 Moretti G., Introduzione all’estetica del romanticismo tedesco, La Nuova Cultura 2007 Oberti E., Lineamenti di un’estetica di Heidegger in un saggio su Rilke, in “Rivista di filosofia neoscolastica”, n. 46, 1954 Otto W. F., Theophania. Lo spirito della religione greca antica, trad. it. a cura di A. Caracciolo e M. Perotti Caracciolo, Il Melangolo, Genova 1983 Pöggeler O., Hölderlin, Schelling und Hegel bei Heidegger, in “Heidegger Studien”, vol. 28, 1993 Vattimo G., Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Marietti, Casale Monferrato 1989 Vattimo G., Heidegger e la poesia come tramonto del linguaggio, in Aa. Vv., Romanticismo, esistenzialismo, ontologia della libertà, Mursia, Milano 1979 Verra V., Heidegger, Schelling e l’idealismo tedesco, in “Archivio di Filosofia”, 1974 Zweig S., La lotta col demone. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, trad. it. a cura di A. Oberdorfer, Sperling & Kupfer, Milano 1934