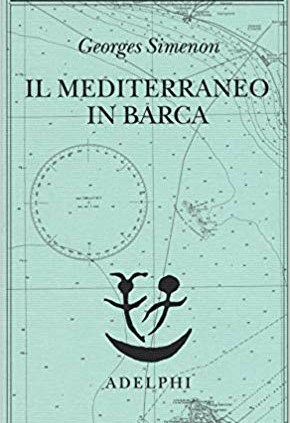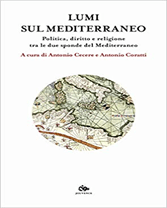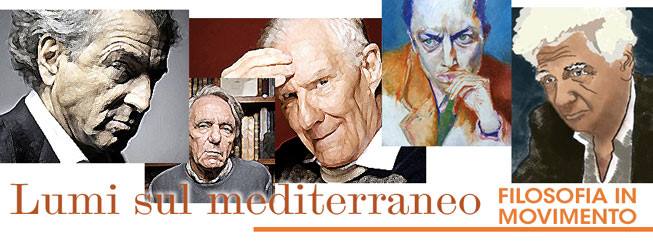Tag Archivio per: Lumi sul Mediterraneo
Dalla società tollerante alla società ‘rispettosa’
di Francesco Coniglione
Per capire il senso del discorso che vorrei qui non tanto svolgere, ma almeno abbozzare, è utile partire da quanto sostenuto da Fathi Triki nel suo contributo incluso nello stimolante volume Lumi sul Mediterraneo (a cura di A. Cecere e A. Coratti, Jouvence, Milano 2019). Qui viene fatta la distinzione tra Ensemblisme identitario e “vivere-insieme nella dignità”. Il primo non ammette la differenza, lo scarto e quindi finisce per governare gli uomini attraverso la dittatura, la violenza e la guerra; esso esclude il non familiare e quindi genera l’estremismo e l’identitarismo totalitario: «Detto in altri termini, la prossimità partecipa, in un modo o nell’altro, all’annientamento dell’individuo e rafforza il peso della comunità. È il motivo per cui uno scarto, una distanza sono necessari perché l’individuo recuperi la propria dignità, la propria ragion d’essere e la propria rispettabilità» (ivi, p. 26). Ad esso si contrappone la teoria del “vivere-insieme nella dignità”, la quale esige la liberazione dell’individuo dall’imperium della comunità e si fonda sul concetto islamico di mahabba cioè la socialità e la filìa, l’amore, che conduce a una forma di ospitalità, tratto comune delle culture del Mediterraneo. Questo “vivere insieme” rifugge all’uniformizzazione ed evita di cancellare le differenze, ma piuttosto è una «forma d’essere al mondo aperta ai cambiamenti di civiltà che abitano la sua [del Mediterraneo] storia: atteggiamento volontario di lottare contro ogni chiusura e ogni tentativo di distruggere i valori che hanno forgiato la sua fisionomia» (ivi, p. 27).
A prima vista si potrebbe pensare che tale concetto di “vivere-insieme nella dignità” sia una sorta di indicazione meramente postulatoria dallo scorso contenuto propositivo ed operativamente poco efficace, una sorta di appello ai buoni sentimenti che evita di affrontare le questioni cruciali che stanno al centro di quello che si è indicato – con efficacia propagandistica, ma con scarsa presa reale – come “scontro di civiltà”, che vede coinvolte in prima istanza le due sponde del Mediterraneo. Ma questa è una impressione che può permanere solo in un lettore superficiale; ed è la lettura dei saggi che accompagnano quello di Fathi Triki a dare delle importanti indicazioni per intendere in modo adeguato tale nozione, sviluppandone il contenuto in essa non sempre pienamente esplicitato.
Infatti, già il fatto che nel “vivere insieme” si rivendichi la «liberazione dell’individuo dall’imperium della comunità» pone in essere una significativa sintonia con quella “terza sfera” della laicità e della libertà di coscienza indicata da Foucault, cioè quella che si riferisce alla dimensione privata e personale (e che si aggiunge a quella temporale legata alla storia e a quella spirituale legata all’appartenenza comunitaria). È in sostanza l’esigenza che Paolo Quintili presenta nel suo contributo (“Politica e diritti tra Europa e Maghreb. Alle origini della nozione di ‘laicità’”, pp. 97-117): «Il problema della costituzione della laicità e del suo spazio inviolabile si esprime, a mio avviso, in questi termini. Come lasciare libertà di costituzione, nei diversi ambiti e contesti geo-storici determinati, a questa terza sfera, in ogni individuo, anzi, di più: come favorire, a livello culturale e istituzionale, la sua costituzione? Ciascuno di noi – uomini e intellettuali del XXI secolo, emancipati grazie all’operazione storico-culturale dell’Illuminismo – ha una propria “religione personale”, anche inconsapevole, taciuta, che s’esprime nell’intimità del dialogo con sé e prende poi corpo nell’agire quotidiano» (Quintili, p. 115). È una importante indicazione su come sia possibile “rileggere” e ritradurre nella nostra lingua dei concetti che per un islamico si pongono in modo diverso, appunto nella misura in cui è difficile, a sua volta, tradurre nella sua concetti che sono correnti nel nostro mondo intellettuale, come quello di “laicità”, del resto non sempre presente in tutti gli ambiti storico culturali in cui di fatto esso viene praticato. Ed infatti, come ci avverte sempre Quintili, nel contesto geo-storico arabo-islamico parlare di “laicità” avendo appunto come riferimento questa “terza sfera”, che pure abbiamo visto è implicita nel “vivere-insieme nella dignità”, fa correre il rischio dell’incomprensione, in quanto il suo equivalente arabo – eilmania – si confonde con l’ateismo e quindi con l’irreligiosità, la miscredenza e di conseguenza anche con l’immoralità, analogamente a come veniva intesa la parola “ateo” nel periodo di dominanza religiosa cristiana, cioè tra Sei e Settecento.
Il “vivere-insieme” riconquista tuttavia il contenuto del concetto di laicità (e quindi, vedremo, di democrazia) attraverso una manovra ad aggiramento: già l’esigenza posta della liberazione dell’individuo dall’imperium della comunità funziona da esigenza critica affinché si eviti che tale vivere insieme si trasformi nel criticato “ensemblisme identitario”. Ma, ancor più, Fathi Triki si approssima al contenuto concettuale della laicità nel momento in cui fa scendere in campo la nozione – ripresa esplicitamente da Derrida – di “ospitalità”, quale antidoto alla possibile violenza del “vivere-insieme”; infatti, «ogni umanismo è fondato sull’ospitalità» (Triki, p. 36), giacché (come ha intuito Terenzio) «appartenere all’umano implica rivendicare la sua pluralità» (p. 37) nel fare il bene e nel fare il male. Per Derrida l’ospitalità è l’essenza dell’umano e Triki afferma che essa è «una condizione necessaria per ogni filosofia del vivere-insieme, perché essa permette alla dignità di compiersi e all’umanità di diffondersi» (p. 39). L’ospitalità è quindi il fondamento di ogni “vivere-insieme nella dignità” e può realizzarsi solo mediante la regola d’al-karam, ovvero la generosità (dell’accoglienza – karam al dhiafa) fondatrice della dignità, che si apre alla condivisione assoluta e senza condizioni della vita. Insomma «la dignità come karamah designa uno statuto onorevole, che l’altro deve riconoscere e che impone certi atteggiamenti coerenti con il senso dell’umano» (p. 41), offrendo una nuova dimensione dell’umanità, un «vivere insieme armonioso, ragionevole e confortevole».
In fondo – come avverte Mario Reale nel suo intervento (“’Vivere-insieme con dignità è un altro nome di ‘democrazia’”, pp. 67-96) – si potrebbe sostenere che tale nozione proposta da Fathi Triki non sia altro che un equivalente della democrazia, una forma istituzionale che farebbe uscire il “vivere-insieme” dalla sua “levità culturale e poetica”, dandole corpo organizzativo concreto, operatività politica. E ciò perché la democrazia sarebbe la soluzione della domanda fondamentale su come può l’individuo conservare la propria autonomia impegnandosi al tempo stesso a costruire “uno spazio di convivenza”, promuovendo diritti e unità, individualizzazione e socializzazione. Ma giustamente non può non nascere la domanda che Reale non evita di porre: è la democrazia in grado di soddisfare l’esigenza del vivere-insieme, cioè quella «socialità intensa, tramata di philia o di “disposizione affettuosa”»? (ivi, p. 59). È in sostanza questa la dimensione della ‘fraternité’, la cui esigenza si è espressa anche come “religione civile”. Una domanda a cui non si può che rispondere negativamente, giacché la democrazia da noi praticata «non consente […] un’irruzione di “socialità” nel suo ambito proprio di espressione» (ib.), anche se questa socialità si trova nei momenti in qualche modo rivoluzionari che preparano l’avvento della democrazia, «nel vigore del suo stato nascente» (p. 61), dove è implicito il riferimento alle riflessioni Francesco Alberoni (specie nel suo Movimento e istituzioni, Il Mulino, Bologna 1981).
Tale richiamo alla esigenza della socialità e di conseguenza alla ‘fraternité’ è importante in quanto è proprio in tale sentimento o forma di legame sociale che s’è visto, in molti teorici ma anche in diversi movimenti istituzionali, il modo per compensare e riequilibrare il tipico universalismo illuministico. Al senso di anomia che ne potrebbe derivare viene contrapposto un momento, un ambito, un ‘tempo’ nel quale possa vigere un nuovo senso di comunità, in cui sia possibile ricreare un sentimento di appartenenza, ritessendo quel legame sociale che in una società sempre più frammentata, universalistica e atomizzata tende ad attenuarsi. È questa appunto l’esigenza posta dal terzo termine del motto della Grande Rivoluzione: appunto la ‘fraternité’ mette in luce l’insufficienza di un’etica laica, quale quella implicita nell’universalismo illuminista e nella separazione tra sfera religiosa e sfera pubblica, che si differenzia da quella religiosa per il fatto di rivolgersi e argomentare sulla base della sola ragione, a differenza delle etiche religiose in cui è essenziale il riferimento ai testi sacri o alla rivelazione. Tale etica laica si esprime, ad es., in modo paradigmatico e quasi ‘puro’ nelle recenti parole di un grande scienziato, Richard Dawkins: «La mia utopia è un mondo nel quale le credenze sono basate sull’evidenza e la moralità è basata su una intelligente progettazione – una progettazione effettuata da umani intelligenti (o robot!). Né le credenze né la morale dovrebbero essere basate sui sentimenti della pancia, o su antichi libri, rivelazioni private o tradizioni clericali» (“Richard Dawkins Offers Advice for Donald Trump, and Other Wisdom”, in Scientific American Daily Digest, August 10, 2017).
Col far appello solo all’intelletto, questa etica dimentica però quelle che Blaise Pascal ha chiamato “le ragioni del cuore”, quelle medesime ‘ragioni’ che nell’epoca del trionfo dei lumi, Chateaubriand lamentava fossero assenti dai nuovi templi eretti dalla Rivoluzione francese, dedicati solo a un astratto concetto di Vero: «questi stessi templi, dove in altri tempi si contemplava un Dio conosciuto in tutto l’universo o le immagini di una vergine che consolavano tanti infelici, questi templi dico, erano dedicati a quella Verità che nessuno conosce e alla Ragione che non ha mai asciugato una sola lacrima» (Le génie du christianisme, 1802, Alfred Mame et Fils, Tours 1848, p. 21). Di converso, l’etica religiosa infiamma innanzi tutto il cuore e solo successivamente si trasforma in analisi razionale, la quale getta però un velo di freddezza sulla fede, come aveva ben capito un giovane Hegel. Ecco perché l’etica laica è così difficile non solo da rendere universalmente condivisa, ma anche di diventare forza motivante e propulsiva dell’agire per le grandi masse; essa è inevitabilmente aristocratica, condivisa e perseguita da pochi spiriti eletti che fanno del culto della ragione il faro della propria vita, così come è stato rimproverato alla proposta morale di Kant. Tuttavia, anche nelle religioni edificate sulla base di una forte adesione emotiva a principi di fede, l’amore predicato universalmente perde di forza, si illanguidisce e finisce per scolorare in un generico imperativo etico che lascia spesso freddo l’agire quotidiano del singolo. Sicché, a fronte del declino delle grandi strutture istituzionali – politiche come religiose – è sempre nata nella storia l’esigenza di rivalorizzare le comunità di base, di attaccarsi al campanile, alla “piccola società”, in cui il legame interpersonale viene ri-creato in un senso assai prossimo al re-ligare religioso, grazie alla prossimità fisica, alla stretta coesistenza. È quella esigenza propria alla “culture comunitarie” che si esprime in una sorta di ‘tribalismo mirante a una sorta di “reincantamento del mondo”, come ha messo in luce Michel Maffesoli (“Le culture comunitarie”, in G. Finis, R. Scartezzini, a cura di, Universalità & differenza. Cosmopolitismo e relativismo nelle relazioni tra identità sociali e culture, FrancoAngeli, Milano 1996, pp. 257-65).
In ciò si esprime il bisogno di rinsaldare, di ritessere, i rapporti che si sfilacciano, tanto più in società nelle quali vengono a cessare gli antichi legami comunitari. E se in passato erano stati gli ordini monastici a fungere da punto di accumulazione della solidarietà cristiana, successivamente sono state le varie associazioni confessionali tra laici ad adempiere questa funzione, come accade oggi con gruppi quali Comunione e Liberazione, i focolarini, l’Opus Dei e sul piano non religioso club quali i Lions, Rotary e tante altre forme di aggregazione in cui si cerca di mettere in atto e di vivere nel concreto, all’interno di un forte legame comunitario, la ‘fraternité’, in modo da riattualizzarla e continuamente confermarla.
Questa esigenza motiva la richiesta della ‘fraternité’, ad integrazione e completamento di liberté ed égalité. Con una importante differenza da queste ultime: se è facile dare un significato e un contenuto alla libertà, come anche alla eguaglianza, che sono concetti per molti aspetti anche normativamente definiti o definibili attraverso leggi e principi costituzionali, invece la ‘fraternité’ sembra essere, ad un superficiale sguardo, più un generico appello a un sentimento di reciproco ben volere, che un termine cui sia assegnabile un preciso contenuto concettuale. Esso tuttavia riceve una sua prima ragion d’essere dalla circostanza di fatto che libertà ed eguaglianza possono entrare tra loro in tensione: la rivendicazione della prima spesso è contraria all’esigenza della seconda, così come insistere eccessivamente sulla seconda può voler dire una limitazione della prima. Ecco allora che la ‘fraternité’ assume quasi una funzione mediatrice tra quei due opposti, mitigandone l’applicazione unilaterale e mortificante: grazie ad essa la libertà non può trasformarsi in assoluta licenza a danno degli altri e l’eguaglianza non può disconoscere l’autonomia e la personalità altrui, in quanto accomunati da un legame condiviso.
La ‘fraternité’ così intesa, pertanto, non si esercita in generale, non concerne tutti gli uomini, non è un principio universalistico che bisogna solo riconoscere e a cui è necessario semplicemente aderire con la forza dell’intelletto. Ciò fa sì che essa sia qualcosa di più della semplice adesione ad un’etica laica, in quanto fornisce quelle motivazioni interiori che altrove sono tipiche della fede religiosa. Essa scaturisce dalla necessità di “riunire ciò che è disperso”, che, in antitesi alle società complesse ed atomizzate, si preoccupa di riconnettere le persone, di farle sentire nuovamente solidali, di dare loro il senso della comunità, di farle uscire dall’anomia tipica di individui eterodiretti formanti la cosiddetta “folla solitaria” (come ha detto David Riesman, La folla solitaria, il Mulino, Bologna 1999). Tale esigenza è stata condensata nel concetto di ‘reliance’ – di ricollegamento, ritessitura, riconnessione – che è stato forgiato dal sociologo belga Marcel Bolle de Bal (cfr. “Reliance, déliance, liance: émergence de trois notions sociologiques”, Sociétés 2013/2, 2003, pp. 99-131) ed è stato quindi messo alla base del suo modo di concepire la ‘fraternité’, in contrasto a quella ‘deliance’ – la dissociazione, la frattura, la disaggregazione atomistica – che invece caratterizza le società contemporanee. Come ha scritto Edgar Morin (La méthode, t. VI, “Ethique”, Seuil, Paris 2004, p. 114), la ‘reliance’ è alla base degli altri imperativi etici, come tolleranza, libertà, fedeltà, amicizia, amore, rispetto, cortesia, e quindi tende naturalmente a rivolgersi agli altri, alla comunità, alla società, ed infine all’umanità. Ecco perché l’etica che deriva dal senso della fratellanza non contraddice quella laica, non contrasta con quella che può essere motivata religiosamente, ma si aggiunge ad esse, le tonifica, le rende vigorose e salde, le sostanzia con una forza emotiva che viene rinnovata continuamente.
Quanto detto da Morin mette in campo un concetto che ci sembra fondamentale, anzi il perno attorno a cui l’esigenza del “vivere-insieme con dignità” di Fathi Triki assume la sua piena pregnanza significativa: il “rispetto”. Lo introduciamo attraverso le parole che vi dedica – quasi per inciso – Bruno Montanari (“Per vivere insieme con dignità: riflessioni sul pensiero moderno”, pp. 67-96), ma che a nostro avviso costituiscono anche uno degli assi fondamentali intorno ai quali si svolge il suo argomentare: «Il rispetto è la concretizzazione pratica, nell’agire, della reciprocità: rispettare non vuol dire “tollerare” o “omologare”; non vuol dire agire come se le differenze non fossero significative. Al contrario, il rispetto implica il riconoscimento della differenza dell’“altro”, poiché essa è reciproca differenza. Nell’atteggiamento del “rispetto” non vi è un soggetto sociologicamente, culturalmente o politicamente dominante, come nella tolleranza: un soggetto tollerante ed uno tollerato. Nel rispetto c’è la presa d’atto di un come me originario e dunque strutturalmente reciproco. In sintesi, il rispetto è la traduzione pratica dello svolgersi individuale della strutturale e reciproca relazionalità dell’io di ciascuno» (p. 92).
È questo un punto nevralgico: il richiamo al rispetto è importante in quanto pone il proprio fuoco sulla circostanza che nel trattare con gli altri – verso i quali si deve avere del ‘rispetto’ – le azioni o comportamenti che possono essere intrapresi verso di essi non debbono essere suscettibili a venir commisurati con un metro oggettivo, che possa essere normato in maniera positiva. Quando si ha rispetto si deve innanzi tutto prendere in considerazione quello che è il riflesso soggettivo, interiore che un dato atto può avere in un altro soggetto, sicché la medesima azione può suscitare una lesione o una gratificazione maggiori o minori a seconda dell’individuo che viene da esse attinto. È la rilevanza di questa lesione o gratificazione che deve essere la ‘misura’ del ‘rispetto’: non si è rispettosi perché ci si comporta in un certo modo verso un individuo, che potrebbe anche essere indifferente alla ritualità di quel comportamento, ma solo nel caso in cui si è consapevoli del riverbero interiore che quel comportamento potrebbe avere in un soggetto; e ci si astiene o meno dal metterlo in atto, per quanto lo si ritenga secondo il metro dell’agente di lieve o trascurabile importanza. Solo in questo caso si ha ‘rispetto’. Ne deriva da ciò che il ‘rispetto’ è sempre contestuale e non può prescindere dalla storia dell’individuo, dal modo in cui la sua persona si è formata, onde non può essere dettato da una norma astratta di comportamento. La famosa regola aurea viene a ricevere una sua particolare accentuazione che la piega a una più profonda comprensione: non solo “non fare agli altri ciò che vorresti non fosse fatto a te stesso”, bensì “fai agli altri ciò che essi si aspetterebbero venga loro fatto, in modo da rispettare la loro interiorità”. Si ha una re-inversione della rivoluzione soggettocentrica di Kant: l’etica del rispetto non ha come perno la volontà legislatrice dell’Io, bensì l’oggetto verso cui è diretto, ovvero l’altro.
Solo in tale quadro l’ospitalità riceve una sua piena motivazione, in quanto questa è una delle forme in cui si manifesta più propriamente il rispetto. Nei confronti dell’ospite si assume un atteggiamento di ‘cura’ verso i suoi sentimenti, ci si industria per farlo sentire a proprio agio, capendone le esigenze e persino le idiosincrasie: gli si offrono pietanze che corrispondono ai suoi gusti, stanze che si conformano ai suoi modi di vivere, non si esibiscono forme di comportamento o manifestazioni di cultura che gli possano essere sgradevoli (ci si astiene, ad es. dal fare la croce e di ringraziare il signore prima dei pasti se l’ospite è di religione o sensibilità diversa). Come ha affermato recentemente Nunzio Galantino, «il rispetto è, in fondo, un prendersi cura in maniera viva e consapevole dell’altro, sia esso una persona, una legge o la natura nella quale viviamo e dalla quale siamo circondati» (“Accorgersi degli altri”, in Il Sole 24 Ore 13-10-19, p. 29). E questo avviene perché è la dignità il valore che si riconosce all’altro, in quanto solo verso chi è dotato di dignità, così come noi pensiamo di esserne, si può avere ‘rispetto’ e lo si può trattare con ospitalità. È questa quella dimensione ‘orizzontale’ che – da una prospettiva cristiana quale quella di Mons. Galantino – unisce alla dimensione verticale la dimensione orizzontale «che si fonda sull’uguale dignità delle persone, al di là della funzione e del ruolo» (ib.). Da questo triplice nesso – rispetto, ospitalità dignità – trova a nostro avviso tutto il suo pieno valore il “vivere-insieme nella dignità”.
Il ‘rispetto’ impedisce anche quell’atteggiamento che è tipico in ciò che Fathi Triki chiama “nuova colonialità”, caratterizzata dall’uso di ‘nobili’ nozioni tipiche della cultura occidentale – diritti umani, democrazia, guerra ai dittatori, intervento umanitario, diritto di ingerenza, missioni di pace ecc. – per poter intervenire in situazioni di crisi: la creazione artificiale di guerre perpetue (il Medio Oriente ne è un esempio quasi esemplare) è finalizzata a «distruggere l’edificio delle istituzioni statali, in nome, evidentemente, dell’ideale “democratico” e contro la dittatura, facilitando così lo sfruttamento a oltranza di tutte le ricchezze di questi paesi» (Triki, p. 31). Al cosmopolitismo e all’utopia di libertà illuminista viene sostituita la globalizzazione imperialista: l’ospitalità degli stranieri che vanno coi flussi migratori nei paesi occidentali avviene all’insegna del razzismo e della colonialità, con islamofobia, paura, accuse di terrorismo ecc., dimostrando quanto sia difficile il “vivere-insieme” in Occidente. Di tale colonialità fa parte integrante una strategia culturale fondamentale: la inferiorizzazione: «L’intellettuale del Sud è sempre inferiorizzato, raramente ascoltato e citato dai suoi pari del Nord […] questo rapporto di inferiorizzazione non tocca soltanto l’intellighènzia: esso è presente in tutti i tipi di rapporto fra le due sponde del Mediterraneo. È il motivo per cui, d’altronde, il vivere-insieme, in queste condizioni, non può che essere violento» (ivi, pp. 35-6). Il “vivere-insieme” non è nella dignità, in quanto tra coloro che partecipano di questo rapporto non v’è rispetto, ma si richiede solo l’ossequio formale a delle norme che di solito sono quelle del paese ricevente, ‘accogliente’.
Questo dimostra perché il laicismo possa essere visto con diffidenza dagli intellettuali che non si sono formati nella cultura occidentale, assorbendone sin dall’infanzia i valori, come anche, tra le righe, da Fathi Triki. Infatti esso, in ambito politico è un atteggiamento solo negativo: ci si astiene dal fare o esibire atteggiamenti di carattere religioso negli spazi comuni, e quindi si separa autorità civile e religiosa, in nome di una comune appartenenza a una entità sopraindividuale che – ecco l’accusa che viene fatta – spossessa delle identità le singole comunità. Donde uno dei paradossi o aporie della laicità: «nelle società chiuse o di lunga e grande tradizione religiosa, l’appartenenza comunitaria – con tutti i suoi segni, simboli e pratiche – è sentita, in molti casi, come avente un valore superiore alla stessa uguaglianza e libertà. In questi casi, perché si affermino i “diritti dell’uomo” (uguaglianza e libertà), occorre cambiare anzitutto il senso comune, operare cioè per quel cambiamento in un modo pacifico, attraverso i mezzi di formazione e di educazione delle coscienze, prima di affermare o rivendicare ogni possibile primato della laicità» (Quintili, pp. 108-9). Tuttavia questa aporia può essere aggirata solo se eguaglianza e libertà sono esercitate nell’ambito del rispetto, cioè quando si intende e si ha cura del riverbero interiore del nostro comportamento nell’altro; esso ha per questo aspetto uno statuto diverso dalla mera affermazione dei cosiddetti diritti umani, che sono l’estrinsecazione pratica dell’universalismo illuministico: il diritto all’esistenza, alla libertà e alla proprietà, diritti oggettivamente e positivamente configurabili. Il rispetto, invece non lo è: esso richiede, per così dire, una capacità ermeneutica di interpretare il sentimento altrui, una sensibilità che si può alimentare solo con cultura e formazione. Esso richiede una maturazione interiore che deve essere il frutto di un processo educativo lungo e arduo, implica «il bisogno di doversi prendere del tempo per accorgersi degli altri, per conoscere chi o cosa si ha di fronte, cosa pensa e cosa di conseguenza ci domanda» (N. Galantino, cit.). Ecco perché il rispetto è difficile da mettere in atto. Ne consegue la necessità dell’educazione, che non è solo quella esplicita, ma soprattutto la implicita, che si acquisisce nella pratica comunitaria, nelle comunità in cui il rispetto viene già esercitato. È, come avviene nella scienza, una conoscenza tacita: come l’uomo morale non è fatto dall’apprendere i precetti di un qualche catechismo o trattato delle virtù (lo sapeva bene Wittgenstein, che per questo disprezzava i preti moralisti), analogamente il bravo scienziato non è quello che apprende i principi della scienza nei manuali e nei trattati di metodologia, ma solo a contatto dei grandi scienziati, nei laboratori dove si fa scienza, nel concreto del suo esercizio. Per utilizzare due belle espressioni il rispetto è inscritto in una “forma di vita”, come direbbe Wittgenstein, o è come l’essere ‘iniziati’ a uno stile di pensiero, per dirla con Ludwik Fleck: ad esso «non v’è la possibilità di accedere […] per mezzo di una qualche strada genericamente umana, ovvero grazie a una cosiddetta strada “logica” o “razionale”. Tutti gli educatori sanno che l’introduzione a un qualsiasi ambito di pensiero deve sempre passare per un periodo di “apprendistato” nel quale opera solo l’autorità e la suggestione, e non una qualche generale e “razionale” spiegazione. Queste introduzioni hanno in tutti i campi il valore del sacramento iniziatico noto dall’etnologia. Ad ogni disciplina non è possibile accostarsi attraverso lo studio del suo compiuto sistema concettuale, bisogna che sempre vi sia una “introduzione” in parte storica, in parte aneddotica e dommatica. È questo un esercizio di sottomissione allo specifico stato d’animo del collettivo» (Stili di pensiero. La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di F. Coniglione, Mimesis, Milano-Udine 2019, p. 196). Solo grazie a questa educazione, a questo peculiare ‘apprendistato’ (del resto segnalato pure da Thomas Kuhn), che ha il vero e proprio carattere di un percorso esoterico, è possibile ‘vedere’ ciò che prima era invisibile; in particolare è possibile sentire e rendersi conto dei possibili riflessi delle nostre azioni nell’altro, sviluppare quell’esprit de finesse da Pascal ritenuto non meno importante dell’esprit de géométrie.
L’approccio qui delineato permetterebbe anche di vedere in una diversa luce quello che è stato indicato da Stefano Petrucciani come il paradosso dell’universalismo, insito nel proclamare il principio dell’eguale rispetto per tutti gli uomini e le loro culture, basato sulla loro dignità. Infatti, «il paradosso dell’universalismo sta nel fatto che esso per un verso riconosce la pari dignità di tutte le persone, le idee e le culture, mentre per altro verso implica in qualche modo l’idea che le culture che non si riconoscono nei principi dell’universalismo hanno un valore inferiore rispetto a quelle che invece lo fanno» (“I diritti umani e il paradosso dell’universalismo”, p. 119). Tale paradosso viene meno se l’universalismo è filtrato secondo l’etica del rispetto ed è sovraordinato a quei “diritti umani” che sono il tipico portato della cultura occidentale, in quanto solo questi ultimi di fatto comportano una “inferiorizzazione” dell’altro e quindi delle altre culture. Il rispetto invece richiede solo la reciprocità, è sempre bilaterale, scambiato, così come l’ospitalità, ponendo in campo quell’esigenza di socialità e ‘fraternité’ senza la quale l’universalismo, come anche i diritti umani restano morte impalcature che possono facilmente assumere un carattere vessatorio e un atteggiamento inferiorizzante.
Il che non vuol dire che si possano mettere da parte l’esigenza insita nell’idea di democrazia e i valori incarnati nei cosiddetti “diritti umani”, ma solo che queste non possono essere il modo esclusivo con cui si possono rapportare le culture, con cui si può interagire con l’altro, portatore di una storia e di una cultura autonoma e spesso assai lontana da quella occidentale. In fondo la proposta del “vivere-insieme con dignità” non solo non si contrappone ad essi, ma si propone come una necessaria integrazione che risponde a un bisogno fondamentale, ad un’esigenza che ha percorso tutta la storia delle società umane e che si è espressa storicamente in forme diverse (solidarietà, ‘fraternité’, stato nascente, legame fusionale, comunitarismo, “spirito tribale”, ecc.), pur essendo del tutto dimenticata nelle società secolarizzate, rette da una ragione strumentale se non addirittura mercantile, come quelle occidentali nella loro declinazione neo-liberale degli ultimi decenni. In fondo la proposta di Fathi Triki suggerisce di sostituire – con il concetto di “vivere-insieme nella dignità” – alla globalizzazione economica-finanziaria e al dominio neoliberista dei mercati, un’altra e più importante globalizzazione, quella culturale e politico-civile, attenta all’ecologia planetaria e ‘rispettosa’ della sensibilità degli altri. È la transizione dalla società tollerante alla “società rispettosa”.
Credere da laici: sacro e laicità nell’opera di Simone Weil
di Giulia Ceci
Finché la laicità rimane subordinata alla sovranità dello Stato è ancora incompiuta, troppo debole nel rivolgersi a cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, «come se si trattasse di piccole frazioni territoriali del paese, come se si dicesse: «Marsigliesi, lionesi, parigini, siamo tutti francesi»
A dispetto dell’antica origine etimologica, la laicità è un concetto decisamente giovane dal punto di vista storico-filosofico, nonché ancora problematico nella sua espressione attuale. Si potrebbe dire, anzi, che quanto più il mondo contemporaneo si secolarizza e perde i suoi confini nel corrente mutamento della globalizzazione, tanto più il concetto di laicità diventa concreto.
Come mostrato da Paolo Quintili in Politica e diritti tra Europa e Maghreb. Alle origini della nozione di “laicità”[1], la laicità nasce in seno all’illuminismo, attraverso un processo di portata epocale che riesce a ricostruire le fondamenta dell’istituzione sociale sui diritti dell’uomo, passando dalla verticalità dell’autorità di ispirazione divina all’orizzontalità del vivere insieme. Tale processo culmina in quella versione della laicità che oggi si conosce come la sua primaria accezione, ossia la separazione dello Stato dalla Chiesa. Così sancisce il Décret sur la libertè des cultes, il 21 febbraio 1795[2].
Tuttavia, sebbene la laicizzazione dello Stato sia parte integrante della laicità, evidentemente quest’ultima non si esaurisce nell’estromissione della religione dalle leggi dell’apparato statale. Oggi più che mai, il concetto di laicità rilancia una domanda essenziale: citando ancora Quintili, «(…) quale spazio lasciare al senso del sacro ‒ come coscienza e sensibilità privata e individuale del divino ‒ fuori di ogni discorso o di posizione ecclesiastica istituzionale?[3]
Proprio sul senso del sacro come esperienza inalienabile dell’esistenza umana e irriducibile a qualsiasi posizione istituzionale, verte la riflessione di Simone Weil in merito allo spirito laico introdotto dai Lumi. La scarsa considerazione dell’opera illuminista da parte dell’autrice francese ha indotto più di qualcuno alla facile accusa di anti-laicismo. In realtà, come per molti altri temi, anche in questo caso il pensiero weiliano risulta piuttosto controverso. Occorre chiarire subito che il punto in discussione non è la laicità in sé, ma il suo successivo adattamento, coincidente con una svalutazione di quel sentimento religioso che pure precede la religione, cioè il bisogno pre-religioso di credere, una sensibilità al mistero del sacro che trascende la fede quanto a fedeltà a una determinata dottrina. Infatti: «La religione è stata proclamata cosa privata. Secondo le attuali abitudini mentali ciò non vuol dire che risiede nel segreto dell’anima, in quel luogo profondamente nascosto dove non penetra nemmeno la coscienza di ognuno di noi. Vuol dire che è oggetto di scelta, di opinione, di gusto, quasi di fantasia, qualcosa come la scelta di un partito politico o persino come quella di una cravatta»[4]. Ciò di cui Simone Weil non si accontenta ‒ e che, anzi, prevede ‒ è una svendita della laicità a quel relativismo un po’naïf delle collettività odierne. In altre parole, seguendo Quintili che adotta il linguaggio del semiologo e filosofo Tzvetan Todorov[5], la terza sfera della libertà di coscienza, privata e personale, deve sfuggire al dogmatismo religioso senza cadere, per questo, in una traduzione superficiale e relativistica della laicità.
In tal senso, l’alternativa della
visione weiliana si riferisce a una “civiltà
mistica”, dove il termine mistico non deve trarre in inganno; esso designa
una forma di spiritualità impossibile da affiliare, radicalmente estranea alla
realtà naturale in tutte le sue declinazioni politiche e religiose. D’altra
parte, solo in quest’ottica l’autrice francese riesce a concepire a pieno una
civiltà europea. Non basta una somma di Stati sovrani: è necessario un dialogo
interreligioso. La grande svolta dei Lumi,
dunque, non ha centrato l’obbiettivo, laddove il suo scopo principale sarebbe
stato esclusivamente quello di assicurare l’unità dello Stato nazionale.
Secondo Simone Weil, essa rappresenta un’altra tappa di quel folle “rovesciamento dei mezzi nei fini” in cui
può essere inquadrata la storia occidentale, ossia un relativo ‒ lo Stato-Nazione
‒ viene fatto assurgere ad assoluto
cui si deve la stessa osservanza che si dovrebbe a un obbligo incondizionale. Finché la laicità rimane subordinata alla
sovranità dello Stato è ancora incompiuta, troppo debole nel rivolgersi a cattolici,
protestanti, ebrei, musulmani, «come se si trattasse di piccole frazioni
territoriali del paese, come se si dicesse: «Marsigliesi, lionesi, parigini,
siamo tutti francesi»»[6].
[1] Nel volume Lumi sul Mediterraneo, a cura di Antonio Coratti e Antonio Cecere, pp. 97-117, Editoriale Jouvence, Milano 2019.
[2] Ivi, p. 110.
[3] Ivi, pag. 115.
[4] S. Weil, La prima radice, pag. 118, trad. it. di F. Fortini, SE Edizioni, Milano 1990.
[5] T. Todorov, Lo spirito dell’illuminismo, trad. it. di G. Lana, Garzanti, Milano 2007.
[6] S. Weil, op.cit., pag. 119.
Paolo Quintili, “Laicità, cittadinanza e nuovi processi di universalizzazione” (in “Lumi sul Mediterraneo, Mimesis, 2019)
La “qualità di cittadino” presuppone una società di cui ogni privato conosca le vicende, della quale si prenda cura, sentendo inoltre di poter raggiungere le “prime dignità”.
degli studenti di 4 A del Liceo Scientifico L. da Vinci di Terracina
Nel suo saggio, “Laicità, cittadinanza e nuovi processi di universalizzazione”, Paolo Quintili evidenzia le difficoltà linguistiche e semantiche nell’utilizzo in lingua araba di concetti come “illuminismo” o “laicità”, che assumono una connotazione per lo più spregiativa. Per parlare di un concetto in maniera appropriata è infatti necessario tener conto di come quell’idea possa “migrare” da un contesto culturale ad uno diverso. Il termine “laicità”, ad esempio, è indicato in arabo con la parola “eilmania”, che letteralmente significa ateismo. Nella cultura occidentale, “ateismo” indica piuttosto la negazione esplicita e consapevole dell’esistenza di Dio, mentre la laicità riguarda semplicemente l’operazione di presa di distanza dai valori religiosi in rapporto alle norme dello Stato, ovvero la scissione tra la sfera politico-sociale e quella religiosa. Nell’articolo Quintili affronta anche il tema della cittadinanza, evidenziandone le radici storiche e filosofiche per chiarire come questo concetto si sia evoluto nel corso dei secoli. Per cittadinanza si intende il rapporto di appartenenza che si viene a stabilire tra individuo e Stato che ha assunto forme diverse in base alle differenti configurazioni dello Stato stesso. In particolare, all’inizio dell’articolo l’autore fa riferimento alle guerre di religione avvenute in Europa tra il Cinquecento e il Seicento, che evidenziano come l’appartenenza ad uno Stato fosse fortemente caratterizzata dalla confessione religiosa, che condizionava la libertà del cittadino. Tra gli esempi riportati c’è quello delle persecuzioni degli ugonotti in Francia e dei cattolici in Inghilterra. Per arrivare a compiere un passo avanti nella civiltà, verso uno Stato laico in cui l’appartenenza alla comunità non fosse condizionata in modo determinante dalla religione professata, sono servite lunghe guerre, seguite da dure persecuzioni, che si conclusero nel 1648 con la pace di Westfalia, con la quale si stabilisce la possibilità dei sudditi di scegliere la propria religione tra quella cattolica, luterana e calvinista e la libertà di culto in privato per le altre confessioni religiose. Nel mondo islamico questo passaggio non è invece avvenuto, generando difficoltà nell’interazione con le altre civiltà. Anche Rousseau viene citato all’interno dell’articolo in quanto non tollerava gli atei nel suo ideale di società, presentato nel “Contratto sociale”. Quest’opera è fondamentale per la creazione del concetto moderno di cittadinanza: cittadino è colui che cede parte dei suoi diritti e della propria libertà personale a favore di una “volontà generale” in grado di garantire il bene comune; questa detiene il potere legislativo e rappresenta a pieno titolo tutti i cittadini, mentre il governo diventa un semplice braccio esecutivo ed è per questo che l’autore è considerato il padre del principio moderno di “sovranità popolare”.
Quintili cita l’Encyclopedie di Diderot e D’Alambert per chiarire come i concetti di borghese, cittadino ed abitante venissero concepiti nell’ambito del pensiero illuminista: il borgheseè colui che ha residenza ordinaria in una città; il cittadinoè un borghese ma considerato relativamente alla società di cui è membro; l’abitante è un privato considerato relativamente alla residenza pura e semplice. Si è abitante della città, della provincia o della campagna: si è borghese di Parigi. Il borghese di Parigi che prende a cuore gli interessi della sua città contro gli attentati che la minacciano, ne diventa cittadino. «Le città pullulano di borghesi; ci sono pochi cittadini tra questi borghesi». La “qualità di cittadino” presupponeuna società di cui ogni privato conosca le vicende, della quale si prenda cura, sentendo inoltre di poter raggiungere le “prime dignità”. La distinzione tipicamente francese tra borghese e cittadino, introdotta da Bodin e condivisa da Rousseau e Diderot prima della Rivoluzione, poggiava sull’analisi della società in termini di ceti o stati. La dichiarazione del 1789 dell’Assemblea francese, per unificare aristocrazia, clero e terzo stato in una ‘nazione’ che desse diritti giuridici a tutti i citoyens (dal francese ‘’cittadini’’), rendeva irrilevante la distinzione ed in questo modo ci si avvicina alla concezione moderna di cittadino. Quintili cita inoltre Molière perché fu uno dei primi ad anticipare il processo di laicizzazione con ironia nell’arte, ad avere un approccio razionalista nei confronti della realtà e critico verso le religioni. L’opera citata nell’articolo è Tartufo, messa in scena il 12 maggio 1664 che suscitò l’avversione del partito devoto di corte che faceva capo ad Anna d’Austria e aveva come personaggio di spicco l’arcivescovo di Parigi, ex precettore del re. Si unì al coro la Compagnia del Santo Sacramento, una confraternita segreta che si proponeva la difesa della religione e dei buoni costumi tanto da spingersi ad invocare per Molière il rogo, vista la sua natura diabolica. Inizialmente, la commedia di Molière non trovò il pieno plauso del pubblico: dopo la censura del testo teatrale originale, Molière fu costretto più volte a rielaborare la sua opera fino al 1669. Tuttavia, per il suo enorme potenziale scandaloso, agli occhi dello spettatore contemporaneo la censura della prima versione non risulta immotivata: il primo protagonista era un chierico ipocrita, un uomo religioso che sfruttava l’ingenuità di un onorevole cittadino per motivi egoistici. Nella seconda e la terza versione, invece, il personaggio misterioso dell’impostore Tartufo non è un ecclesiastico né un rappresentante istituzionale della Chiesa. Uomo apparentemente credente, Tartufo è laico impegnato come “direttore di coscienza” (una professione molto diffusa nel Seicento) nella casa dell’abbiente borghese Orgon.
Quintili cita inoltre la “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” del 1948 per chiarire come i diritti debbano essere universalizzati e non limitati ad un gruppo ristretto di persone, perché si rischierebbe di arrivare ad una minaccia degli stessi dovuta alla presenza di forze aggressive all’interno della società. Alla fine del Settecento i diritti umani vengono affermati come universali, cioè propri di ogni uomo, nelle due grandi Dichiarazioni: la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata dall’Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789. Esse sanciscono l’affermazione della nuova cultura borghese e cominciano ad apparire, con Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, le prime rivendicazioni dei diritti delle donne.
Nonostante i continui progressi, sanciti anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani emanata il 10 dicembre 1948, l’universalizzazione dei diritti rimane altalenante, sempre pronta a compiere passi indietro: come ribadisce lo stesso Quintili «a fine dell’ultimo secolo ha segnato una regressione comunitarista, nel senso non-universalistico, verso una direzione opposta a quella indicata da Marx nel 1843, che ha messo in discussione i processi di universalizzazione dei Diritti. […] Questo regresso antro-patologico è stato volutamente provocato (bisogna dirlo, senza mezzi termini), dai politici bellicisti e aggressivi dei paesi egemoni dell’Occidente, compresi la Francia e l’Italia».
Dinanzi alle sfide poste dalle nuove migrazioni degli uomini e delle cose, Quintili ritiene necessario che la linea ascendente borghese-cittadino-uomo (che era ancora quella di Marx) si modifichi in senso discendente: dignità umana-cittadinanza universale (che non è legata all’idea di nazione)-borghesia, implicando, così, l’inserimento nella società del lavoro che rappresenta la condizione necessaria per garantire ad ogni essere umano quella dignità affermata nella Dichiarazione universale dei diritti del 1948. In questo modo, si arriverebbe ad un “illuminismo trans-storico”, applicabile a tutto il Mediterraneo, in grado di consentire il dialogo tra diverse culture. Quintili prende le mosse dal concetto di “terza sfera” di Todorov «che l’individuo gestisce autonomamente senza che nessuno possa avere niente da ridire». Tale dimensione si riferisce alla presenza (in ognuno di noi) di una sfera personale, circoscritta unicamente alla propria interiorità, che può coincidere o meno con quella spirituale, ma che non deve in alcun modo sentirsi condizionata o minacciata dal contesto politico,sociale,economico e culturale nel quale l’individuo è inserito. Essa permette di sviluppare dei valori, delle idee, un mondo interiore in cui credere, indipendentemente da tutto e tutti. Essere laico significa esercitare in un certo modo la propria libertà di coscienza, in base all’esperienza e alla sensibilità, che variano da individuo a individuo. Quindi risulta inutile l’imposizione di una determinata religione da parte dello Stato poiché ogni individuo ha una concezione propria di spiritualità. Un legame sociale non è basato sulla professione della medesima religione, né sull’appartenenza allo stesso Stato, bensì è qualcosa di più profondo, fondato sulla condivisione di valori in nome della quale, individui diversi per origine, cultura e mentalità (migranti o meno) potranno sentirsi tutti parte di una comunità civile in grado di evolversi, arricchirsi e trasformarsi.
Questa prospettiva illuministica in senso transtorico potrebbe condurre allo sviluppo di luoghi socio-culturali condivisi (non alternativi alla religione) in grado di divenire “luoghi di liberazione della terza sfera «ossia della coscienza collettiva degli uomini e delle donne del nostro continente euromediterraneo».
Riflessioni e altre erranze intorno a “Lumi sul Mediterraneo”
di Davide Fischanger
C’è una parola che segue un tracciato preciso all’interno dei saggi presenti in Lumi sul Mediterraneo, una parola che in alcuni casi è dichiarata già nei rispettivi titoli (già a partire dall’intervento di Fathi Triki[1], motore di un dialogo a distanza), in altri appare in controluce ma senza che questa presenza in negativo le tolga consistenza generativa di senso e di proposta.
La parola è dignità.
Vorrei partire da questa parola per due ordini di ragioni: il primo è per riflettere intorno a questo libro tenendo accanto a me la sua specificità ovvero tenendolo presente come interlocutore; il secondo per potere usare il termine dignità come un filo che mi consenta di allontanarmi da questo libro, dalle sue ragioni, per farne riverberare il senso anche in territori di dibattito più lontani e apparentemente meno affini. In questo doppia messa a fuoco, verso il centro del libro e verso la sua periferia, mi sembra però di rispettare (non sembri solo un pretesto) lo spirito più originale di quest’opera, connotata appunto da un lavoro tra sponde (geografiche e culturali) distanti che racchiudono uno spazio di interazione comune.
Vorrei provare, preliminarmente, a dare una definizione di dignità. Ora, l’epoca moderna ha trovato una serie di parole dalla grande capacità di mobilitazione: libertà e uguaglianza (tralascio per ragioni che esporrò la fratellanza), giustizia sociale, diritti, rivoluzione, cambiamento… etc etc. Chiamo “mobilitanti” le parole con un significativo potere di suggestione pubblica e capaci di situare un gran numero di persone all’interno di un orizzonte di aspettativa tale da riuscire a muoverle collettivamente verso la realizzazione dei programmi sottesi alle parole stesse. Posta sotto questo segno la dignità, pur avendone alcune caratteristiche (ad esempio un certo qual grado di astrattezza) non mi sembra appartenere integralmente alla categoria sopra descritta. Per cercare in territori etimologici limitrofi, indignazione è una parola, di più recente fortuna, con un forte potere mobilitante, anche se rispetto a quelle “storiche” possiede un’accentuazione da un lato più ricattatoria (“chi non si indigna allora è complice”) dall’altro più soggetta a usura (ci si indigna un po’ per tutto). Ma la dignità sembra godere dello stesso statuto della fratellanza che, come osserva giustamente nel suo saggio Mario Reale[2], è la parola più trascurata del triplice motto coniato durante la Rivoluzione francese. Potremmo dire che entrambe le parole sono le meno ideologiche, perché la loro condizione di gratuità le rende meno adatte all’inserimento in un discorso. Ma si può anche ipotizzare che lo statuto semantico della nostra parola di partenza possa aver contribuito a attribuirle una condizione diversa, più sfumata o ambigua: la dignitas infatti indicava e indica anche il rango (e l’accezione è conservata anche nei principali vocabolari della lingua italiana), il grado, la posizione all’interno di una gerarchia. Questo slittamento da uno status a una condizione morale è interessante, come vedremo, perché in realtà i due significati tendono a stare l’uno dentro all’altro, se è vero che il senso di dignità presuppone un sentimento percepito di nobiltà negli atti e nelle parole di un individuo.
Se le parole mobilitanti, in quanto orizzonte di aspettativa e scopo di una lotta, possono essere paragonate a un grande schermo cinematografico, la dignità mi sembra piuttosto il fascio di luce che, generato da un proiettore, va a illuminare lo schermo stesso: ciò che è interessante di questo fascio di luce è il fenomeno che all’interno di esso ci fa scorgere del pulviscolo fluttuante e ci fa percepire la luce stessa. Quel pulviscolo è il riferimento alla concretezza (per usare un’espressione contenuta nella chiusa del saggio di Bruno Montanari[3]) delle individualità e dei rapporti umani rivelati da quella luce che, nel frattempo, trasporta i messaggi e le parole d’ordine sullo schermo. Il pulviscolo vaga, non ha sede, entra e esce dal cono di luce. Come rivelarlo, come dare conto della sua esistenza, della sua incostanza, della sua natura: questo è il tema della dignità. La sfida della dignità è la sfida del molteplice che, come il pulviscolo, è soggetto al riflesso della luce e anche a una certa refrattarietà: il molteplice, l’umano, è irriducibile agli schemi rappresentativi, anche ai più raffinati; il molteplice è l’altro che risponde in maniera imprevista alle mie aspettative, specialmente se le mie aspettative corrispondo al mio desiderio di fornire l’altro degli strumenti giuridici e morali per provvedere alla sua autodeterminazione e alla sua libertà. È il paradosso, citato nel saggio di Quintili[4], dell’emancipazione delle comunità ebraiche all’epoca della Rivoluzione Francese: come spiegare la resistenza alle riforme e all’abolizione dei “privilegi” (che erano in realtà termini di una segregazione secolare) da parte di comunità sottoposte per secoli alla discriminazione? Solo come a una testardaggine identitaria? un ritardo culturale rispetto ai necessari obiettivi posti dalla Modernità? Un mancato adeguamento al ruolino di marcia della Storia? In genere considerazioni di questo tipo descrivono, meglio di molte altre, lo sguardo di noi “moderni”: potremmo dire che questo sguardo, che è quello della civiltà occidentale, si sia andato a configurare a partire dalla storica “scoperta” del grande Altro, ovvero dall’arrivo dei conquistatori europei nelle Americhe (scoperta che convenzionalmente sui manuali di storiografia inaugura l’Età Moderna). Tzvetan Todorov ne La conquista dell’America (il cui sottotitolo emblematicamente recita: “Il problema dell’altro”) ricorda che è proprio questo evento epocale a porre sul tappeto la maggior parte delle questioni attualmente all’ordine del giorno: universalismo/relativismo, (presunta) arretratezza/progresso, superstizione/vera fede, distruggere/assimilare, propagare e imporre i propri stili di vita/tutelare le culture locali…
La rotazione dell’asse della storia avvenuta a partire dal 1492, ovvero dal Nord-Sud del sistema mediterraneo a quello Est-Ovest del sistema atlantico, è stato anche il principio fautore del consolidamento dell’identità europea (fino alle tappe della sua Costituzione come organismo politico e giuridico, come indicato nelle pagine di Macrì[5]), del suo cammino verso l’affermazione planetaria (violenta) e nello stesso tempo di quello sviluppo intellettuale che ha individuato e analizzato le questioni sempre aperte della laicità, dei diritti imprescindibili e universali di popoli e individui, dell’emancipazione di minoranze. È in questa consapevolezza che sta parte del paradosso segnalato fin dal titolo del saggio di Petrucciani[6]: nel fatto che mentre i paradigmi culturali europei (o occidentali) venivano esportati nel mondo attraverso “armi acciaio e malattie”(per ricordare un celebre saggio di Jared Diamond), attraverso il colonialismo o il consumismo, all’interno di quegli stessi paradigmi, grazie all’incontro/scontro con le altre culture, venivano elaborati dei processi di riflessione che mettevano in gioco e in scacco lo sguardo (e il ruolo) dell’Occidente.
La parola dignità è ciò che può tenere fermo questo sguardo, purché la dignità si faccia fissare, dato che la sua natura è sfuggente: Il grasso la cerca in una lama d’acciaio, il magro la cerca nel suo ultimo pasto, l’uomo vuoto la cerca in un campo di cotone, la dignità. Cosa stiamo ascoltando? Sono le parole di una canzone ma anche un piccolo saggio di filosofia morale. Le ha scritte il discendente americano di ebrei ucraini e lituani che all’inizio del Novecento hanno attraversato l’Oceano (da Est verso Ovest) per sfuggire alla povertà e ai pogrom. La canzone si intitola Dignity e, come eloquentemente spiega Alessandro Carrera, è una canzone “sulla società che ha criteri per tutto, tranne che per riconoscere il valore dell’essere umano”. L’autore si chiama Bob Dylan che qui sembra impegnato nella parte di un investigatore a cui stanno per ritirare la licenza, con un dito di barba di troppo e vestiti sempre stazzonati. Un vento freddo taglia come la lama di un rasoio / Edifici in fiamme, debiti non pagati / Mi affaccio alla finestra e chiedo alla cameriera / Hai visto la dignità? Bisogna essere sobri, non tanto per capire dove sta la dignità, ma per saper attraversare stanze sontuose e vicoli miserabili con la stessa determinazione a cogliere echi e visioni; bisogna farsi strada tra mazzi di chiavi smarrite e pacchetti di sigarette vuoti per imparare a fare le domande giuste, per smascherare gli impostori. Bisogna non fidarsi di chi ti mostra una fotografia della dignità: Dignity, infatti, never been photographed.
Se tu sei mio amico, entra in casa mia senza bussare alla porta. Se tu ignori chi sono, devi sapere che contavo i giorni che mancavano al tuo arrivo. Tu, fratello mio d’elezione, vulnerabile straniero. Che cosa stiamo ascoltando? domando ancora. Sono le parole di un esule e di un poeta, Edmond Jabès (da Sud a Nord, questa volta), racchiuse in un volume intitolato Il libro dell’ospitalità. Le riporto perché nell’ultima frase possiamo ravvisare un altro attributo della dignità (che non mobilita, che sfugge, che non è fotografabile) ovvero il fatto di essere vulnerabile. Nel riconoscere la vulnerabilità altrui mi faccio carico della mia: detto in altri termini, senza ferita nulla sarebbe sano, senza l’esule nulla sarebbe saldo. Elaborare un pensiero della dignità significa rinunciare a un principio maggioritario della realtà, della storia, delle relazioni tra individui; significa elaborare un pensiero della ferita che salva. Questa salvezza è soglia in attesa: esiste nella mano che invita a entrarvi e nel piede che la varca, nei due gesti presi in un unico evento (se è vero che ospite è parola che include tanto chi accoglie quanto chi è accolto). A stento può essere detta: si entrerà in silenzio senza bussare. Al massimo può essere evocata: ma nel computo dei giorni d’assenza.
Vorrei proporre un ultimo esempio. La storia è nota. Un uomo arriva naufrago presso un’isola. È solo, è nudo. La figlia del re di quell’isola lo scopre e lo invita al palazzo. Il re accoglie lo straniero chiedendogli prima se sia un dio o un uomo. “Sono uno sventurato” risponde l’uomo. Durante la cena l’uomo ascolta il canto di un aedo, vi si narrano le gesta di guerra di molti suoi compagni. L’uomo piange e il re lo invita a raccontare la sua storia. È l’antefatto del canto nono dell’Odissea, che è il canto dominato dall’episodio di Polifemo. Il ciclope negherà agli stranieri i diritti derivanti dalle leggi divine dell’ospitalità: per questo a lui Odisseo si presenterà come Outis, Nessuno. Ma cosa è accaduto all’inizio del canto? Odisseo si è svelato al re Alcinoo, ha dichiarato il proprio nome, la propria provenienza e ha rivelato la propria dignità regale, in una specularità opposta, nelle premesse come negli esiti, all’avventura col ciclope. Cosa è stato evocato dalle parole di Odisseo, prima di questo svelamento? Il consesso ospitale della reggia, il pane e la carne distribuiti sulle tavole, la condivisione e l’ascolto: la felice formula della degna relazionalità suggerita nella chiusura del saggio di Bilotti[7].
Ed è la stessa complicità dotta e amicale che ha riunito molte voci intorno alle proposte e alle riflessioni del filosofo tunisino Fathi Triki, sul vivre-ensemble dans la dignité. Ogni parola di questa formula dovrebbe essere custodita, apprezzata e poi affidata al vento, come si affida una storia. Dovremmo raccontare la nostra storia ornandola di parole preziose e vitali come se fossimo alla presenza di un re; dovremmo accogliere l’ospite, misero e cencioso, supponendo sempre in lui la dignità di un re in esilio. Dovremmo approfondire le sfumature semantiche che dalla parola dignità ci guidano ai suoi due principali attributi, all’essere dignitoso e all’essere degno di: il primo indica una condizione, il secondo un impegno.
E dovremmo imparare a vivere, contemplando e ascoltando il Mediterraneo,
poema polimorfico di correnti, onde, suoni, voci.
[1] F. Triki, “Dignità e umanità: una possibile convivenza mediterranea”,. in A. Coratti, A. Cecere (a cura di), “Lumi sul Mediterraneo”, Jouvence, Milano, 2019, pp. 21-42.
[2] M. Reale, “‘Vivere insieme con dignità’ è un altro nome di ‘democrazia’?” in ivi, pp. 43-65.
[3] B. Montanari, “Per vivere insieme con dignità: riflessioni sul ‘pensiero moderno’” in ivi, pp. 67-96.
[4] P. Quintili, “Politica e diritti tra Europa e Maghreb. Alle origini della nozione di ‘laicità’” in ivi, pp. 97-117.
[5] G. Macrì, “Costituzione europea interculturale (Multilevel) e nuovo umanesimo giuridico” in ivi, pp. 129-147.
[6] S. Petrucciani, “I diritti umani e i paradossi dell’universalismo” in ivi, pp. 119-128.
[7] D. Bilotti, “Un principio di relazionalità nello spazio giuridico mediterraneo” in ivi, pp. 149-163.
Recensione a Lumi sul Mediterraneo
di Miriam Borgia
È ancora utile e corretto utilizzare in filosofia politica le categorie della “modernità”? Quali sono le insidie della parola “laicità” nel dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo? Quali sono i paradossi dell’universalità dei diritti umani? E, infine, è ancora giusto difendere i diritti umani intervenendo in caso vengano violati?
Bruno Montanari alla prima domanda risponde che i concetti di “cittadinanza”, “sovranità”, “individuo” e lo stesso concetto di “uguaglianza” sono ormai insufficienti per affrontare le sfide attuali e, in continuità con il saggio di Fathi Triki, ritiene che la sfida sia incentrata sulla categoria “vivere insieme con dignità”: «per un’effettiva tutela dell’umanità dalla violenza, dal disastro ecologico e dalla miseria”, e d’altra parte, “delle diversità culturali su grande e piccola scala […] il termine uguaglianza è divenuto teoreticamente insufficiente». All’ “uguaglianza” va sostituita la “parità”, all’ “individuo” l’ “uomo”: la sfida allora si gioca sul terreno dell’esistenziale, con una collocazione planetaria, universale, ontologica. La politica, essendo ormai internazionale e mondiale, ha mostrato come siano insufficienti anche le categorie di “Stato” e “Nazione”; la spinta verso l’universalismo richiede categorie trans-epocali come “uomo”, traducibile in qualunque lingua, al contrario di “individuo” che è un’invenzione della modernità occidentale. La caratteristica imprescindibile di ogni uomo è quella di essere posto nel mondo, originato, ed è un dato puramente ontologico perché comune a tutti; da tale dato “ontico” deriva la parità ontologica, poiché tutti cadiamo sotto la categoria “uomo” inevitabilmente e simultaneamente e in ciò siamo pari. Facendo ciò si trascende – non si annulla – ogni differenza, mentre nella nozione di “cittadinanza” sono contenute anche le formule inclusione-in/esclusione-da. Terra, non Stato/Nazione, uomo, non cittadino. Ho accennato al carattere trans-epocale di questi concetti: J. J. Rousseau, spiega Montanari, si differenzia da Hobbes, Locke e Montesquieu perché recupera la dimensione ontologica dell’uomo (sul noto commento di Rousseau a Hobbes “parlavano dell’uomo selvaggio e dipingevano l’uomo civile” la questione è complessa: secondo l’analisi di N. Bobbio, anche Hobbes avrebbe pensato lo stato di natura senza una determinata collocazione storico-geografica, ma soltanto come un’ipotesi argomentativa su cui basare la sua riflessione sul contratto e sullo stato civile). Allo stato di natura si può solo alludere, poiché la condizione di essere-gettato dell’uomo, la sua prospettiva finita e limitata determina, appunto, un limes (Montanari ne sottolinea l’analogia con il noumeno kantiano), ma proprio ponendo lo stato di natura dalla prospettiva fenomenica dell’uomo si afferma tale prospettiva, scoprendola come l’essenza dell’uomo. Per Rousseau il problema è esistenziale: all’être essenziale dell’uomo si sovrappone il paraître della società civile, e l’uomo diventa individuo. Posto che il punto di partenza sia la parità ontologica e l’obiettivo il “vivere insieme con dignità”, il rapporto con l’altro deve basarsi sul rispetto: considerando che l’ipotesi di un Io assoluto sia controfattuale (se l’Io è assoluto ed è anche universale, ne deriva che ogni singolo Io sia assoluto, ma la pluralità di Io assoluti elimina il carattere assoluto di ciascuno), il riconoscimento dell’Altro non è un dovere etico – se fosse un dovere sarebbe possibile violarlo – ma è un dato auto-evidente, perché “negando il Tu, cioè l’Io dell’altro, si negherebbe al tempo stesso la possibilità del mio Io di essere un Tu per l’Io dell’altro”. La costruzione dell’intersoggettività a partire dalla soggettività è rappresentata proprio dalla filosofia kantiana: attraverso la ragione, la grande ratio dei Lumi, comune ad ogni uomo, ci si scopre in-relazione-a e si trascendono i limiti dell’esperienza sensibile entrando nel mondo della libertà. La libertà non può derivare da nient’altro che dal reciproco riconoscimento della parità ontologica ed è evidente, dunque, come rileggere Kant sia oggi, una forma di resistenza contro certi “sovranismi” che, al contrario di quanto propone Montanari, riaffermano le categorie di Nazione, Stato, identità nazionale e culturale, dimenticando che, per dirla con François Jullien, “l’identità culturale non esiste” e che prima del cittadino viene l’uomo.
Tuttavia, pur riconoscendo una parità ontologica, quindi fondamentale, universale, imprescindibile e che trascende ogni differenza tra popoli e tra individui, calandosi nelle singole realtà culturali emergono importanti incomprensioni che derivano da alcune ambiguità linguistiche. Ne tratta Paolo Quintilia proposito del termine “laicità”, il quale è il motivo della difficoltà del dialogo tra la cultura europea figlia dei Lumi e quella islamica. Occorre sottolineare, tuttavia, come ogni dialogo contenga strutturalmente delle difficoltà poiché l’Altro, fortunatamente, ci è sempre “altro” in qualcosa; il fatto che non si possa dare dialogo senza diversità, e che parimenti ogni di-versità di-verge sempre da qualcosa, ci dimostra come il dialogo non sia uno sforzo inutile e la difficoltà, che gli è appunto intrinseca, non deve spaventare. Occorre inoltre ricordare come le tre religioni del Libro si siano definite proprio grazie al dialogo reciproco a partire dall’età medievale, poiché difendere il proprio credo significava studiarlo, approfondirlo, cercarne giustificazioni, rafforzarlo. Dialogare con lo straniero non costituisce uno smarrimento della propria identità – nazionale, culturale, religiosa – ma, ed a qualcuno può apparire paradossale, un’occasione di rafforzamento della stessa. Nella riflessione di Quintili, il problema del termine “laicità” si incrocia con la storia dei diritti umani: la sostanziale differenza tra il significato che il termine assume nell’attuale Europa e nel Maghreb è il riferimento alla terza sfera di cui parla Michel Foucault, ovvero quella “priveé et personelle”, dove l’individuo deve essere libero. È nel 1791 che emerge l’importanza di questa sfera, quando i cittadini francesi di confessione ebraica vennero dichiarati liberi ed uguali, con la conseguente perdita di tutto ciò che li aveva resi finora una minoranza organizzata; nel 1794 viene anche abolita la schiavitù nelle colonie francesi; nel 1790 si era già costituita una Chiesa nazionale che s’impegnava ad essere fedele alla Costituzione e nel decreto del 92 lo Stato era stato laicizzato. Nel1795 vi è il Decreto sulla libertà di culto, ed ecco consolidarsi la sfera privata, dove si gioca tutta la posta politica del “vivre ensemble”. Le difficoltà, i paradossi, nascono quando alle istanze di uguaglianza e libertà si preferisce l’appartenenza comunitaria consolidata da una lunga tradizione religiosa e ne è prova il disaccordo sorto tra alcuni cittadini francesi ebrei proprio nel 1791. Non tutti erano d’accordo nel riconoscersi uguali agli altri, liberi come gli altri. La questione è evidente: come è possibile dialogare sulla “laicità”, la quale ha come premessa la considerazione della sfera privata e personale, con una cultura che non riconosce tale sfera? Gli stati islamici, tornando al Maghreb, semplicemente non capiscono il riferimento all’intimità: se noi europei oggi riconosciamo uno spazio al sacro fuori dal politico e fuori dall’ecclesiastico, che è appunto quello privato, e così definiamo i nostri Paesi “laici”, in lingua araba “eilmania”, cioè laicità, è pressocché sinonimo di ateismo, miscredenza, irreligiosità dunque lontananza dallo Stato. Secondo Quintili si tratta di spiegare la semantica del termine, ma allora sorge un’altra domanda: è legittimo pretendere un senso comune laico pressocché universalmente?
Stefano Petrucciani si concentra proprio sui rischi, le difficoltà e i paradossi di tale universalismo, collegandosi alla riflessione di Quintili. In nome della democrazia, contro la dittatura ed in difesa dei diritti umani si sono perpetrate “guerre giuste” e “interventi umani” – come analizza approfonditamente anche F. Triki -. Per Kant, condizione della pace perpetua tra popoli è adottare una costituzione repubblicana (laddove repubblicana, per Kant, può essere anche una monarchia, purché le leggi vengano fatte dal monarca come se derivassero dalla volontà generale); per Rawls, esponente del liberalismo progressista, è sufficiente che si rispettino degli standard di “decenza”, tra cui non aggredire altri popoli, possedere un sistema giuridico accettabile e rispettare i cosiddetti diritti umani. Le violazioni di quest’ultimi, per Rawls, legittimano l’ingerenza a farle cessare, provvedimenti punitivi (commerciali e finanziari), in una parola l’”ingerenza umanitaria”. Ma allora si auspica un ritorno a pratiche neocoloniali -oltre che imperialistiche-? Già Hobbes individuava tra i rapporti internazionali un ennesimo stato di natura, un campo di bellum omnium contra omnes, perché manca un giudice super partes e imparziale. Ma «di fronte all’umanità calpestata non si può voltare la testa dall’altra parte, aspettando che ci siano le giuste istituzioni internazionali», commenta Petrucciani, e «questo pessimo uso dei principi universalisti non è una buona ragione per rinunciare ad essi». Per dirla con Churchill, «la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le forme che si sono sperimentate finora».
Recensione a M. Reale, “Vivere insieme nella dignità” è un altro nome di democrazia?
in A. Cecere – A. Coratti, Lumi sul Mediterraneo, Jouvence, Milano, 2009
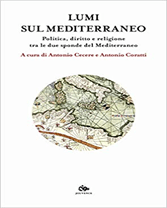
Nel saggio scritto in risposta a Triki, Mario Reale si chiede se il vivere-insieme teorizzato dal filosofo tunisino non sia, in fin dei conti, un altro nome di “democrazia”. Ovvero, se la democrazia non sia in fondo definibile come un vivere-insieme “istituzionalizzato” che nel corso della storia moderna (europea) si è dispiegato nell’ambito degli Stati-nazione, chiudendosi in confini spesso “inospitali”. Da una parte, Reale riconosce alla nazione il ruolo da protagonista giocato nei processi moderni di «democratizzazione primaria e fondamentale», dall’altra ne denuncia l’attuale inadeguatezza nel rappresentare il «traino della storia», ovvero nel costituire «il terreno decisivo di riferimento ideale e politico» in una dimensione globalizzata[1]. Cercare di lavorare su operazioni di mediazione continue tra dimensione nazionale e globalizzata, «senza combatterci tra lungimiranti globalisti e retrogradi sostenitori dello Stato nazione»[2], è la proposta per far fronte ai complessi rapporti economici, politici e culturali che da decenni determinano la tensione fra dimensione nazionale e globale e per costruire una via percorribile che renda il vivere-insieme un progetto politico concreto e non una nozione «abusata e quasi priva di senso, impiegata per difendere l’ideologia di una società pacificata e armonica»[3]. Ma il processo di istituzionalizzazione del vivere insieme passa necessariamente, secondo Triki, per la costituzione di una “vie sociale égalitaire” che attenui le differenze tra “nord” e “sud” del mondo e del Mediterraneo. In effetti, a dominare nel dibattito filosofico-politico degli ultimi decenni è stato lo scontro (spesso ideologico) tra “più libertà” da una parte e “più uguaglianza” dall’altra, mentre, come nota Reale, la domanda sulla fraternité, «la terza parola d’ordine della Rivoluzione francese»[4], è stata per lo più trascurata, assumendo un ruolo del tutto marginale nella tradizione politica dell’occidente. Nel Contratto sociale stesso – opera considerata da molti manifesto programmatico della più radicale forma di “collettivismo” della modernità – Rousseau antepone chiaramente, in nome della costituzione della «grande Repubblica democratica», il «dominio della legge» alla esigenza di socialità, per lo più «messa sullo sfondo, solo implicita, se non proprio espunta»[5]. Il collettivismo in Rousseau sarebbe così fagocitato dal programma politico di porre “la loi au-dessus de l’homme”, avendo la legge come obiettivo primario quello di superare «la temibile dipendenza dell’uomo dall’altro uomo con il darsi a tutti non dandosi a nessuno», rendendo «gli uomini indipendenti e in un certo senso “solitari”»[6]. D’altra parte, è proprio in virtù dell’impersonalità, generalità e universalità, nonché della «reciprocità tra parti autonome» che la legge può farsi garante della «conservazione intatta delle individualità»[7], anche in nome della dignité che è nel titolo stesso del progetto filosofico trikiano, vivre-ensemble dans la dignité. In questo senso, vivere-insieme e dignità, comunità e individualità, rappresentano i due momenti da conciliare politicamente, allorché la tradizione democratica moderna pare privilegiare la tutela della sfera delle autonomie dei singoli. Per lo meno nella fase avanzata. Mentre la socialità emerge prorompente «nei momenti, sempre in qualche modo rivoluzionari […] che preparano l’avvento della democrazia e quindi nel vigore del suo stato nascente»[8], momenti in cui «è necessario mobilitare tutte le risorse “corali” del popolo, perché il vecchio scompaia e il nuovo sorga»[9]. Anche in questo caso, Reale propone uno scambio sinergico a partire dalla diversa storia dei popoli mediterranei e dalle diverse esperienze in corso sulle due sponde, l’una segnata dal fermento delle primavere arabe, ancora in movimento, l’altra alle prese con una storia democratica matura e ormai secolare, ma non priva, come sappiamo, di criticità.
[1] M. Reale, “Vivere insieme con dignità” è un altro nome di democrazia, in A. Cecere, A. Coratti (a cura di) Lumi sul Mediterraneo, Jouvence, Milano, 2019, p. 54
[2] Ivi, p. 58
[3] F. Triki, Vouloir vivre dans la dignité, tr.ita. A. Coratti, www.filosofiainmovimento.it/voler -vivere-nella-dignita/
[4] Ivi, p. 59
[5] Ibidem
[6] Anche per quanto riguarda la questione della “volontà generale”, Reale evidenzia il fatto che, «contro ogni forzatura collettivistica», essa va interpretata in quanto «frutto del “silenzio” tra i cittadini (che non devono avere “alcuna comunicazione tra loro”), ognuno dei quali nella sua intimità s’interroga, con un atto intellettivo e insieme morale, se la legge, comunque proposta dal governo, sia o no conforme alla volontà generale che è in lui» Ivi, p. 60
[7] Ivi, p. 60
[8] Ivi, p. 61
[9] Ibidem
IL CORANO NELL’EPICA LAICA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Esiste, soprattutto in Francia, una letteratura quanto mai eterogenea che associa al diritto e, in particolar modo, al diritto interno alle diverse esperienze religiose, due componenti fondamentali. Da un lato, il diritto invoca una propria solennità, spesso direttamente mutuandola dalla sfera del sacro, per favorire il riconoscimento della propria necessità e la garanzia della propria legittimazione. D’altra parte, il contenuto concreto dei comandi giuridici rischia di dipendere sin troppo spesso dalle intenzioni del singolo detentore della potestà decisionale e dal contesto sociale e culturale entro cui quei comandi devono essere attuati. A conclusioni simili sono giunti, tra gli altri, l’orientalista Herbert Fingarette, che ha studiato le istituzioni del pensiero politico cinese, e ancor prima lo storico del diritto canonico Pierre Legendre.
Risulta, semmai, difficile stabilire se la transitorietà debba essere riferita alle forme o al contenuto materiale degli obblighi. Le une e gli altri possono mutare in ragione delle esigenze fattuali o, all’opposto, pretendere una propria irrevocabilità, desumendola, secondo i casi, da argomentazioni religiose, politiche, ideologiche, persino militari. Simili riflessioni sulla natura del comando coinvolgono ormai ampiamente le scienze sociali secolari e finiscono per inscrivere anche le fonti di natura religiosa in una rappresentazione tipicamente laica, umana, immanentista, del potere e del diritto. Parafrasando Schmitt, il problema non è più soltanto quello di capire chi decide sullo stato d’eccezione, ma anche come si definisce lo stato d’eccezione, chi lo definisce e perché la sua definizione dovrebbe risultare più convincente delle altre.
Tutte le volte in cui ci si rifiuta di prendere in considerazione questo aspetto del problema (come si definiscono le istituzioni che governano l’ambito normativo dell’agire umano) si cade nel fondamentalismo. Il fondamentalismo, in altre parole, dipende molto spesso dal ritenersi gli esclusivi portatori di grandezze incommensurabili, sottratte a qualunque riflessione comparatistica, di approfondimento evolutivo o di ricostruzione storico-giuridica.
I pastori battisti americani che diedero vita all’inizio del XX secolo ai movimenti cristiani fondamentalisti e neocongregazionalisti ritenevano la Bibbia incomparabile a qualunque testo religioso, incomprensibile con i normali strumenti cognitivi dell’interpretazione. E non fornivano alcuna spiegazione sulla presunta fondatezza della scelta compiuta, sottraendola in radice alla riflessione dei fedeli.
Come si attua, però, l’interpretazione letterale di un testo religioso se la massima parte dei fedeli di quella religione non conosce l’alfabeto in cui il testo sacro è stato scritto? Può il favore per l’interpretazione letterale generare ex se una traduzione univoca, perfetta persino più dalle sacre scritture da cui si è partiti? Questo travaglio riguarda tutte le esperienze religiose, in particolar modo quelle in cui si è data stretta corrispondenza tra l’appartenenza religiosa e il diritto alla partecipazione nella sfera politica.
Il proselitismo che poggia sul primato dell’interpretazione letterale non si premura di chiarire le due questioni fondamentali: perché l’interpretazione letterale dovrebbe essere la più fedele? E chi ha deciso che l’unica interpretazione letterale possibile sia quella oggetto della propaganda fondamentalista? Come può, poi, l’interpretazione più rigorosa divenire contemporaneamente quella più massificata e più ampia, senza deformarsi o con la coazione sulle menti o con la manipolazione delle fonti?
Dilemmi del genere hanno crescente rilievo nella riflessione dell’Islamismo politico, dove istanze di liberazione rispetto alla tirannia politica si uniscono al fondamento religioso delle istituzioni normative di riferimento.
Non è, ad esempio, estranea all’esegesi coranica l’esigenza di raggiungere il più vasto numero di fedeli possibile. E anche un’istanza del genere si è declinata in modo spesso policromo, dal punto di vista storico-giuridico. Restando a traduzioni celebri del testo coranico, ad esempio, lo stile del grande letterato anglosassone convertito, Marmaduke Pickthall, ha il gusto dell’arcaismo, del tono declamatorio. Ciò non ha impedito a Pickthall di realizzare una delle più diffuse traduzioni del Corano nell’Inghilterra del XX secolo: oltre a rendere manifesta la conversione personale, Pickthall dimostrava di avere scelto un linguaggio congruo allo scopo.
Un convertito di pari fervore era lo scrittore austriaco Muhammad Asad, eppure la sua traduzione del Corano, omologa nell’impianto, è in più punti diversa da quella di Pickthall: qui si preferisce sottolineare l’aneddotica pragmatica, da cui al fedele sia sempre possibile ricavare con immediatezza e decisione il precetto giusto. Non stupisce perciò che la traduzione del Corano sia spesso stata, fuori dai Paesi di lingua araba e anche all’interno delle stesse comunità islamiche, una questione eminentemente politico-religiosa. Non si trattava più di fermarsi a rispettare i vincoli di fedeltà al testo rivelato; la problematica diventava (e di molto) più complessa: dare alla traduzione uno scopo – se divulgativo, propagandistico, letterario, accademico – e trovare il linguaggio secolare più opportuno per quello scopo. Le testate cartacee e telematiche che predicano l’odio dei movimenti terroristi utilizzano un linguaggio di massa e per le masse convincente? Conta più il numero di persone che le segue o la cieca determinazione a seguirle, anche da parte di gruppi estremamente minoritari? E il linguaggio di questa propaganda non perde ogni valenza religiosa proprio quando si esaurisce nel pretendere cruda e diretta efficacia?
Anche alla luce di questi interrogativi, non sembrano da prendere in considerazione le letture, spesso di provenienza occidentale, che ascrivono al Corano limitata efficacia giuridica formale, enfatizzandone la componente narrativa o quella etica, pratica e prudenziale. Questo approccio al Corano è in fondo inesatto per qualunque testo lo si adotti. Non ci si può estraniare consapevolmente dalle implicazioni globali di un testo, a meno che non sia proprio il testo in esame a dichiarare espressamente una specifica destinazione (anche se, dalla retorica classica in poi, sappiamo che questa “dichiarazione” può essere spesso mimetica, artificiosa, inattendibile).
Con intenti apparentemente inclusivi, si tende a privare il Corano di effetti giuridici vincolanti per i fedeli musulmani. Argomentazioni del genere sono note: quel testo non merita alcun interdetto laico, in nulla è in contrasto con i valori liberali occidentali, perché non si tratta di un testo giuridico. Questa visione, però, è solo in apparenza pluralista: nei fatti derubrica il riferimento religioso e normativo di milioni di persone ad appendice del folklore etnico e geografico. Il Corano ha, invece, un’intrinseca valenza normativa, non è l’atto di negarla la via migliore per evitare i conflitti al riguardo.
Il diritto non si riduce per forza all’idea positivistica della norma (breve, puntuale, immediatamente dispositiva), che noi stessi a Ovest attuiamo sovente così male, finendo per produrre arbitrii e burocrazie tutto fuorché agevoli e razionali. è ben possibile, al contrario, che in culture diverse da quella euro-occidentale il diritto sia il prodotto di narrazioni antropologiche che non conducono affatto a esiti univoci e già scritti. Chi potrebbe mai scambiare per codici civili l’etica confuciana, la cosmologia induista o i commentari biblici in slavo ecclesiastico? E, al tempo stesso, chi potrebbe mai negare all’etica confuciana, alla cosmologia induista e ai commentari biblici dell’Europa ortodossa l’ambizione a individuare alcune condotte che le donne e gli uomini sono tenuti fedelmente ad osservare?
Studiare l’attitudine giuridica del Corano, perciò, è una sfida necessaria. In forza di una giurisprudenza religiosa basata sull’interpretazione esclusiva dei precetti coranici, nelle comunità islamiche in Occidente va aumentando il peso delle giurisdizioni confessionali, che dirimono contrasti che gli altri cittadini (i non fedeli) affidano all’autorità civile, secondo logiche, principi e soluzioni concrete anche profondamente diverse. L’applicazione del diritto islamico, sia in una prospettiva giuridica e formalista sia in un’ottica sociologica e sostanzialista, tende, poi, a dipendere dalla comunità entro la quale le norme coraniche sono applicate. Il preteso universalismo del Corano è piegato, spesso dall’inettitudine umana, a scopi e situazioni che aborriva. Lo stesso comportamento (si pensi alla poligamia) può essere ammesso o vietato, e chi sostiene l’una o l’altra posizione lo fa usando come scudo lo stesso parametro religioso.
Proprio questo, in fondo, è indice tipico dell’epica laica delle fonti giuridiche. Esse, pur così altamente fondate (nella rilevanza che molti attribuiscono al sentire religioso, per gli studiosi laici; nella diretta rivelazione di Dio, per i giuristi teocratici; nel patto costituzionale, per i teorici del diritto pubblico), non sfuggono mai alla mutevolezza umana. Ecco perché suggerire l’evoluzione non significa snaturare il testo, semmai implica orientarne l’applicazione in direzioni più rispondenti alle esigenze della comunità cui quel testo si riferisce. E questo forse è l’unico lascito universalmente difendibile nella tradizionale elaborazione liberale sulla libertà d’opinione: il contrasto interpretativo esiste soprattutto quando viene negato. A garantire la parte soccombente non può essere ad incertam diem la sola provvidenza divina. Qui e ora, esige la responsabilità umana.