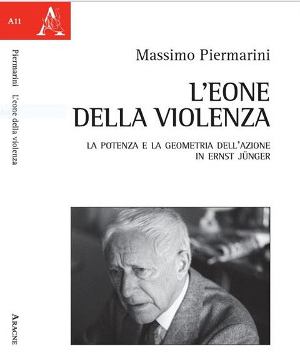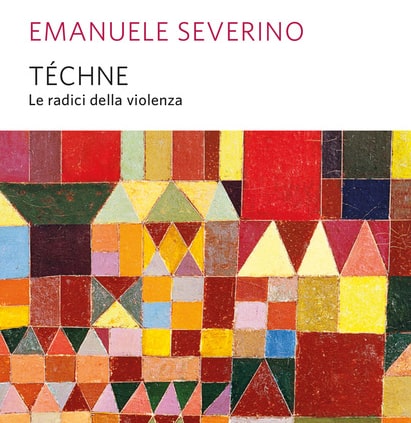Tag Archivio per: tecnica
All’ombra del Coronavirus
di Francesco Correggia
Siamo in una specie di regime tecno burocratico della comunicazione dove si continua a far finta di niente sulla povertà, la disperazione, l’accentramento della ricchezza, il mondo dominato dall’ingiustizia. Con il Coronavirus i vecchi mali non sono spariti anzi sono resi ancora più tragici e irrisolvibili da una specie di controllo delle nostre esistenze imposto dalla situazione attuale, dalla confusione istituzionale, dalla mancanza di una solidarietà europea. Il pericolo della sparizione di diritti individuali e costituzionali si fa consistente.
Emanuele Severino, “Téchne. Le radici della violenza” (BUR, 2010)
Ciò che Severino vuole comunicarci è questo: anche il marxismo, così come il cristianesimo, così come tutte le dottrine che si presentano come antitesi o come proposte di superamento del nichilismo, in realtà non sono altro che diverse manifestazioni di quella estrema follia che ha ridotto gli enti a nulla, consegnandoli così all’illimitata e incontrollabile dominazione e manipolazione, per l’esercizio della quale la Tecnica mette a disposizioni strumenti sempre più efficaci. “Ancora nel libro primo del Capitale – prosegue Severino – Marx scrive che il lavoro evoca le cose dal regno dei morti, cioè dal regno del niente”, esprimendo con parole leggermente diverse ciò che già Platone affermava nel Simposio: “Ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa dal niente all’essere è produzione (poiesis), cosicché sono produzioni anche i lavori che vengono compiuti nell’ambito di ogni tecnica, e quindi anche tutti i lavoratori (demiourgoi) sono produttori.
Contro la frammentazione
In un tempo in cui gli uomini, in quanto singoli e in quanto specie, appaiono adagiati su un terreno che di stabile non ha più nulla, in un periodo storico che vede ciascuno di noi come un piccolo quanto insignificante ingranaggio d’un apparato tecnico sempre meno controllabile dal suo costruttore, in questo tempo, occorre ricordarsi che l’uomo è strutturato su un’identità che ha un centro psico-fisico unitario e che la comunità degli uomini non può essere frammentata senza produrle danni irreversibili.
L’uomo è un intero e l’umanità stessa non può essere concepita se non nella sua interezza. In un tempo segnato dalle grandi conquiste della tecnica, peraltro, l’uomo è ancor di più parte costitutiva ed essenziale dell’intera umanità: in un periodo storico segnato dalla globalizzazione culturale, sociale, economica, tutto ciò è del tutto (e a tutti) evidente. Ancor più evidente e decisiva, però, è l’interrelazione ambientale quando si assuma con chiarezza che viviamo in una fase temporale nella quale un qualsiasi “incidente” di tipo tecnico, qualsiasi evento che si registri in un determinato continente, prima o poi è in grado di diffondersi su larga scala, producendo danni catastrofici e spesso irreversibili. Per quanto riguarda poi il fenomeno dell’immigrazione transcontinentale, vero e proprio fenomeno esodale del contemporaneo, è sotto gli occhi di tutti che la mancanza d’una geopolitica globale e di istituzioni internazionali in grado di andare al di là di logiche spazio-temporali miopi e spesso ottuse e meschine, e dunque incapaci della sia pur minima lungimiranza, hanno prodotto e produrranno inesorabilmente fenomeni che minacciano di azzerare l’intero campionario dei diritti umani nella cui elaborazione si è affaticato l’Occidente da secoli.
Sulla base di considerazioni di questo tipo – forse troppo semplici per poter essere intese nella loro importanza epocale – occorre allora ripensare radicalmente l’essere dell’uomo, riconnettendolo strettamente con le sorti del suo mondo. Non c’è uomo senza mondo, mentre al contrario il mondo senza l’uomo è pensabile sia logicamente sia storicamente. In questa luce, dobbiamo aver chiaro che, se è senz’altro vero che è l’essere umano a produrre il mondo, è ancora più vero che il mondo possiede delle leggi che non possono essere alterate senza che l’umanità nel suo complesso ne debba risentire.
Entrando dunque in una logica di questo tipo (nulla è più necessario in sede politica di tali consapevolezze), una delle prime conclusioni a cui è necessario giungere è che le discipline settorializzate – così come gli interessi regionalistici – costituiscono un’espressione disastrosa del nichilismo imperante. Dividere le scienze e gli ambiti della produzione umana (simbolica o reale che siano), impedire la loro comunicazione essenziale, cioè, risulta del tutto irresponsabile ed è totalmente sbagliato. Così come è sbagliato e politicamente criminale costruire aree geopolitiche caratterizzate da crisi (economiche e politiche) permanenti, se non da vere e proprie guerre locali. In altri termini, tutto ciò va a costituire l’antefatto teorico di un tempo che, non occupandosi più del mondo, non è più in grado di curare neppure gli interessi fondamentali dell’uomo.
In modo particolare per le discipline filosofiche, inoltre, da sempre considerate a giusta ragione il collante di tutte le scienze, oltre che l’attività principale dell’uomo in quanto essere pensante, bisognerebbe entrare nell’ottica secondo la quale la conoscenza o è “integrale” o non è affatto. Nessuna particella dell’umano, in questo senso, può rendersi autonoma in maniera anarchica, nella convinzione che l’intero non reagisca.
L’impero della tecno-finanza estesa a livello planetario, tuttavia, va in direzione diametralmente opposta. È del tutto ovvio che rientra negli interessi precipui del capitale dividere uomini, Stati, aree geopolitiche e saperi. Assistiamo così al sempre più incalzante processo di disgregazione individualistica a cui fa seguito da presso una costruzione artatamente costruita di conflitti fittizi messi in scena ad uso e consumo del capitale e delle classi dominanti. Donne contro uomini, bianchi contro neri, guerre fra poveri, sovranità assoluta di visioni del mondo antisociali e grette come il neo-liberismo prima e l’ordo-liberismo a seguire. Evidentemente, tutto ciò nel mentre asserisce di incorporare una verità storica, alle sensibilità più acute si manifesta per quello che è, ossia un tentativo di distruggere le masse orizzontali e compatte della modernità nella direzione di un’atomizzazione sociale sempre più estesa. Nulla sembra più evidente, infatti, di quanto i processi di soggettivazione contemporanei stiano costruendo un uomo senza alcuna appartenenza: fuori da tessuti comunitari e da radici ambientali. Sta emergendo e sempre più consolidandosi un modello (post)umano passivizzato, senza passato e senza futuro, interamente appoggiato sulla tecnica e con addosso una crescente sensazione di superfluità. Inutile far notare come individui di tale sorta (atomizzati ed irrelati) non possano in alcun modo sfuggire alla presa irresistibile del potere tecno-finanziario. Inutile sottolineare, altresì, quanto un dispositivo di “verità” di questo tipo sia del tutto funzionale all’edificazione e al consolidamento progressivo di una massa di “diseguali” che ha tutti i vantaggi dalle divisioni interne che vengono operate nelle masse di “uguali”.
In questo quadro, credo che debba essere la filosofia, anzitutto, a segnalare la necessità di un cambio radicale d’orizzonte. Ovviamente, non parlo della filosofia da “torre d’avorio”. Meno ancora di quella autoreferenziale che gioca i propri narcisismi nelle conferenze per élite sempre meno significative sul piano pubblico o che imperversa all’interno delle ritualità annose ed inveterate del potere accademico. Mi riferisco, molto diversamente, alla filosofia che ha per oggetto il pensiero e l’unità dello spirito umano che al pensiero corrisponde. Credo, infatti, che, da questo punto di vista, la filosofia sia anzitutto una politica. Una politica degna di questo nome, infatti, sa bene che il suo compito è quello di guardare alla comunità (lato sensu) nel suo complesso e al rapporto originario fra gli uomini, nel quadro di un bisogno ineludibile di costruzione del “luogo” del loro stesso abitare. Non c’è politica adeguata a se stessa che non sappia coinvolgere nella sua prassi quotidiana la filosofia, ossia l’unica disciplina capace di disporre di una visione complessiva dell’uomo in quanto singolo e in quanto specie. L’uomo che deve essere preso in considerazione, inoltre, non può più essere “il soggetto razionale” della tradizione illuministica, o il “cittadino” della tradizione statualistica moderna, né tantomeno l'”agente economico” tipico delle posizioni liberali, bensì un essere peculiare che si caratterizza essenzialmente per un’esposizione radicale all’evento della sua stessa esistenza.
Per giungere ad un approdo di questo tipo è chiaro che tutte le scienze sono utili e necessarie: anche quelle che non avevano mai raggiunto la dignità di “scienza accademica”. A patto, però, che tutte loro possano essere riconnesse al senso filosofico più generale ed originario possibile. Ad esempio, costituirebbe una buona filosofia quella che ritornasse a porre domande ingenue, come quelle dei bambini o dei poeti, o comunque di coloro che sanno proporre “uno sguardo straniero” sul mondo. Una buona filosofia è tale quando si mostra capace di porre in un colpo solo davanti ai tanti paradossi e alle innumerevoli contraddizioni che caratterizzano l’esistere.
In conclusione, dunque, credo che sarebbe necessario che la filosofia diventasse una visione dell’uomo esprimibile attraverso una politica internazionalistica. Per converso, occorrerebbe una politica capace di stringere una nuova, sacra alleanza con la filosofia.
Sarebbe urgente che la filosofia mutasse il suo senso e la sua ispirazione settorializzata e divenisse “antropologia politica”.
Antonio Martone
Sulla sinistra “senza compagni e senza storia”: da Ezio Mauro a quel che sta accadendo a sinistra del PD
In un bell’articolo, che in realtà è un piccolo saggio, Ezio Mauro ha tracciato il quadro di questa sinistra “senza compagni e senza storia”. Ha ricordato che “l’inconcludenza politica e la tragedia tribale” esibite in Italia sono di tutta la sinistra di questo occidente, ormai, pressoché ovunque, sull’orlo dell’estinzione. Ne ha additato l’origine nella “frattura tra il mondo compatto del Novecento e l’universo frammentato della globalizzazione, che cancella le classi ma trasforma le diseguaglianze in esclusioni”, che sposta il “ceto medio tra gli sconfitti”, che fa del precariato la “moderna interpretazione del proletariato” e che, infine, produce una “nuova solitudine repubblicana, uno spaesamento democratico dove crescono i “risentimenti individuali incapaci di trovare traduzione collettiva … una Causa”. E ne ha evinto che l’ultima chance di quella che fu la sinistra sta “in un popolo disperso e dimenticato da riconquistare”, in uno “spazio sociale da riorganizzare”, e dunque in una “scommessa culturale da giocare per ridefinire la propria presenza nel secolo”.
C’è tutto, e detto nel modo migliore. Ma fa chiedere: chi può farlo e come si può fare, magari cominciando dall’Italia.
Tutto questo è avvenuto in forza di processi oggettivi e potenti che hanno cambiato il mondo, ma hanno cambiato con esso le sinistre che in un modo o nell’altro lo avevano governato nella seconda metà del “secolo breve”.
Piaccia o no, l’attuale PD è una formazione politica di centro, e lo è non dal tempo di Renzi. Non è certo un’ingiuria, ma solo una constatazione: non perché non è più anticapitalistica, ma perché ha finito per far proprio il pensiero unico, l’idea che ai fallimenti del mercato si ovvia solo con più mercato, e dunque, in primis, riconducendo il lavoro, tutto il lavoro, alla logica della merce. Ha provato, e prova, a salvare l’assistenza, ma dall’esterno, senza “disturbare il manovratore”. Renzi ha solo accelerato questo processo, abbandonando antiche prudenze con l’idea di sfondare a destra, una destra che all’epoca della sua ascesa appariva in disarmo.
Questo mutamento del PD potrebbe sembrare reversibile, se non fosse che è mutato con esso lo statuto antropologico del suo personale politico e dei ceti che questo personale coinvolge (il popolo delle primarie): il professionismo rampante in luogo della vocazione politica e la contiguità subordinata alle èlite in luogo del “popolo disperso e dimenticato”.
Questo fa sembrare improbabile che la costituzione di una nuova sinistra possa consistere in una ri˗collocazione del PD o, comunque, in una ri˗conversione che muova dal suo interno: piaccia o no, non è facile immaginare che un tal personale politico sia folgorato sulla via di Damasco o che possa essere scalzato, protetto com’è dalla sua estesa rete di piccoli patrocini. E fa pensare che le chance di una sinistra, che ripensi la propria “presenza nel secolo”, rimangano affidate, piuttosto, all’incerta e problematica costruzione di una nuova formazione politica che provi a ri˗coniugare il grande retaggio della solidarietà e della dignità con un mondo ormai dominato dalla tecno˗scienza. Il suo problema è: con quali parole si parla oggi di una nuova Causa (come la chiama Ezio Mauro) e come si recluta ad essa un personale che vi creda e che sia disposto a mettersi in gioco.
Per costruirla questa nuova sinistra ci vogliono idee nuove e programmi inediti, ma ci vuole anche una soggettività politica iniziale che si proponga di accudirvi con una attitudine che guardi oltre la contingenza.
Ed è qui che appaiono i limiti di chi dichiara di volersi far carico di questo compito.
Il campo progressista di Pisapia non riesce ad andare oltre l’obbiettivo, un po’ patetico e alla fine velleitario, di ricondurre le pecore smarrite all’ovile: ma l’ovile non cambia di certo perché c’è dentro anche Pisapia, magari con un manifesto comune che parla di diseguaglianze e povertà (se non dice quanto si dà e da chi si toglie). Senza il PD oggi non si governa? Ma se non si immagina un discontinuità non si capisce a che serva costruirgli accanto un nuovo movimento. Soprattutto, se si pensa che si governa anche dall’opposizione e che l’opposizione non vuol dire affatto perdere il filo della responsabilità (si ricordi il PCI).
In questo hanno, di sicuro, ragione MDP e Bersani e D’Alema: prima si capisce e definisce cos’è questa nuova formazione e poi si discute da dove e come parla col PD. Ma inciampano anch’essi in due limiti. Il primo è che questo PD, la sua incorporazione del pensiero unico ed il suo reclutamento opportunistico sono figli loro. Sicché non basta a definire una nuova identità limitarsi alla critica di quel che ha fatto Renzi. La seconda è che lo svuotamento del PD e dei partiti che in esso sono confluiti si è prodotto a partire dalla loro riduzione a mero anti˗berlusconismo. Sicché l’anti˗renzismo promette solo lo stesso finale.
Mentre SI di Fratoianni e Vendola dovrebbe, infine, convincersi che dal crescere o diminuire di un punto ne va solo della sopravvivenza di una “nicchia”, che può conservare vecchie parole d’ordine e il personale che ad esse è legato, ma che, di certo, non giova alla sinistra e, soprattutto, al “popolo disperso e dimenticato” di cui dovrebbe curarsi. Sicché ha ragione Macaluso a dire che, dopo Livorno, non c’è stata scissione che sia andata oltre la rivendicazione di una “purezza” che lasciava soli gli ultimi e i deboli.
Occorrerebbe, piuttosto, che tutti si convincessero di tre cose.
La prima è che una nuova sinistra non si può presentare, ed autorappresentarsi, come supporto esterno del PD: una nuova formazione deve innanzitutto costruire la sua identità e definire la sua autonomia, e dunque concepirsi e proporsi in competizione (che non vuol dire guerra).
La seconda è che, tuttavia, un rapporto con il PD non sembra allo stato (specie dopo gli ammiccamenti “a destra” del M5S) abbia reali alternative e che la segreteria di questo partito è una questione solo sua: non conta chi lo guida, ma dove si rende realmente disponibile ad andare.
La terza è che deve farsi carico dei problemi di quel pezzo di società che è trascinata nella precarietà e deve farsene carico mostrando che il superamento di questa cifra della contemporaneità salvaguarda il futuro di tutti: dunque, pensando una politica, che muova dal disagio della società e dalle sue ragioni strutturali, che indichi come rispondervi già oggi seppur con il necessario gradualismo e che si interroghi sull’Europa sapendo che fuori non c’è il ripristino delle sovranità nazionali ma solo il dominio delle potenze globali.
Antropologia politica (una considerazione preliminare)
La nostra vita quotidiana ce lo testimonia incessantemente: viviamo impulsi talmente imperiosi – quasi sempre legati alla sfera materiale – da farne apparire indispensabile la soddisfazione. Non se ne può fare a meno ma i desideri che ci possiedono appaiono spesso in contraddizione l’uno con l’altro: bisognerebbe necessariamente rinunciare a qualcuno di loro. Come fare, però, se essi appaiono tutti – davvero – indispensabili? Indispensabili ma impossibili da cogliere contemporaneamente – incompossibili. Si vede, tuttavia, che si tratta d’una condizione al limite della follia. Come immaginare dunque una scala gerarchica, un ordine di importanza? Quali criteri utilizzare?
Sarebbe necessario de-cidere. Fendere. Tagliare una parte di noi. Farlo però non è possibile, poiché ciò significherebbe un sacrificio che, in un tempo antisacrificale quale il nostro, l’uomo non può permettersi.
Alla fine della cultura cristiana – cultura monoteistica – riemerge dunque la tragedia del politeismo. Ma di quale politeismo sto parlando? A guardar bene, non vi è, né può esservi oggi alcun politeismo. Non esiste, infatti, alcun tempo ciclico su cui appoggiarsi – cosi com’era, ad esempio, per i greci. Il tempo ciclico è indispensabile per aprire una dimensione religiosa di tipo politeistico. Ora il tempo (ancora cristiano) rimane lineare, e orientato verso un fine – verso “la fine” dei tempi. Epperò, mentre la forma è rimasta la stessa, è andata via la sostanza: viviamo in un mondo che ha rinunciato al telos ma è ancora convinto che bisogna andare avanti nella dominazione del mondo perché il nostro Regno appartiene ad un altro mondo. Il dramma morale della società contemporanea nasce appunto da questo…
Oggi, tuttavia, diversamente da quanto accadeva nel politeismo antico, nessuna “misura” ci può aiutare: la bella armonia classica ha lasciato il posto al desiderio irrefrenabile del Kaos. Come il politeismo, lo stesso monoteismo si è svuotato e le nostre vite appaiono appoggiate oggi, inesorabilmente, sul vuoto dell’assenza.
E’ necessario ammetterlo: gli antichi Dei hanno ripreso, nel nostro petto, nella nostra emotività più riposta, la loro eterna contesa ma Nemesi è morta e Giove non domina più sulle cime dell’Olimpo.
Il limite è stato oltrepassato…
L’oltrepassamento del limite ha due grandi protagonisti, la tecnica e il denaro: il denaro in quanto tecnica e la tecnica in quanto denaro. Davanti a queste divinità, immani volontà di potenza del nostro tempo, l’uomo appare in una funzione estremamente gregaria. Anche ad una analisi sommaria, i nostri contemporanei si mostrano come piccoli quanto insignificanti ingranaggi d’un apparato tecnico sempre meno controllabile dal suo costruttore. Gli uomini oggi sono poggiati, in quanto singoli e in quanto specie, su un terreno che di stabile non ha più nulla.
Proprio in questo tempo, tuttavia, e proprio perché esso sembra procedere in direzione specularmente opposta, occorre ricordarsi dell’interezza dell’uomo e del destino comune a tutti noi.
Ogni comunità storica implica un peculiare modo di essere al mondo. Ciascuna di esse non potrebbe (non avrebbe potuto, non potrà) sopravvivere se non costruendo un “cerchio magico” intorno a cui sia possibile de-finire la propria visione del mondo. Il cerchio magico significa valori di riferimento, realtà introiettate e ritenute auto-evidenti tanto da costituire dispositivi di verità strutturati in quanto edificio di vita e di senso. Non si può in alcun modo rinunciare ad un ethos condiviso; meno ancora si può supporre che la frammentazione globale possa fare a meno d’una visione dell’intero, ossia un patrimonio di “beni comuni” e risorse pubbliche.
L’uomo è – appunto – un intero. Non solo. In un periodo storico segnato dalle grandi conquiste della tecnica, va ricordato che esso non può che essere e rimanere parte costitutiva dell’intera umanità: in un tempo segnato dalla globalizzazione culturale, sociale, economica, ciò è del tutto evidente sul piano socio-politico. Ancor più evidente e decisiva dovrebbe apparire, però, l’interrelazione ambientale in una fase storica nella quale un qualsiasi “incidente” di tipo tecnico è in grado di diffondersi su larga scala, producendo danni catastrofici quanto irreversibili.
Occorre pertanto ripensare insieme l’uomo e il suo mondo. E’ necessario farlo, però, con la consapevolezza che è senz’altro l’uomo a produrre il proprio mondo ma che il mondo stesso possiede delle leggi che non possono essere alterate senza che gli individui ne debbano risentire.
A tal fine, pertanto, non bastano più le discipline settorializzate. In modo particolare per le scienze filosofiche, bisogna entrare nell’ottica secondo la quale la conoscenza serve all’uomo “integralmente” e che nessuna particella di essa può rendersi autonoma in maniera anarchica, nella convinzione che l’intero non reagisca.
Per pensare adeguatamente il proprio tempo non è sufficiente concentrarsi sulle istituzioni politiche e sulle forme della sovranità, sulla configurazione del diritto e sulla gestione dell’economia. Non vi è dubbio: un’analisi specifica e interstrutturale di questi settori è imprescindibile. Si tratta, però, di una condizione necessaria ma non sufficiente.
L’analisi degli ambiti suddetti, infatti, per quanto tecnicamente raffinata possa essere, non serve a niente se non si osserva, comprende e descrive, nella maniera più accurata possibile, il modello umano – di donna e di uomo – che un determinato tempo è in condizione di esprimere. È necessario, pertanto, compiere un lavoro ulteriore: al fine di risalire ad una prospettiva fedele e mettere capo ad uno sguardo lucido sul reale, diventa indispensabile retrocedere fino alle passioni più intime dell’uomo contemporaneo. Occorre, cioè, entrare nelle dinamiche emozionali, comprendere nello stesso modo le forme dell’amore e quelle dell’odio, concentrarsi sulle modalità della cura. Tutto ciò costituisce presupposto indispensabile per un’indagine scientifica affidabile. A saper guardare, dice molto di più, della qualità e del tipo di comunità, una visita in una corsia di ospedale che uno studio pluriennale di ingegneria costituzionale.
Credo dunque che, da questo punto di vista, la filosofia sia anzitutto una politica. Per converso, ritengo anche che quest’ultima non abbia e non debba avere alcun valore riconosciuto se non coinvolge nel suo senso la filosofia, ossia una visione complessiva sull’uomo in quanto singolo e in quanto specie. L’uomo che deve essere preso in considerazione non può più essere il soggetto razionale della tradizione illuministica, o il cittadino della tradizione statualistica moderna, e neppure l’agente economico tipico delle posizioni liberali, bensì un essere peculiare che si caratterizza essenzialmente per un’esposizione radicale all’evento della sua stessa esistenza.
In questo senso, pertanto, vanno valorizzati studi ed esperienze le più diverse: anche quelle che non avevano mai raggiunto la dignità di “scienza accademica”. A patto, però, che tutto questo reticolo scientifico possa essere riconnesso al senso filosofico più generale e originario possibile.
Costituirebbe una buona filosofia quella che ritornasse a porre domande ingenue, come quelle dei bambini o dei poeti, tali cioè da porre in un colpo solo davanti ai tanti paradossi e alle innumerevoli contraddizioni dell’esistere. Sarebbe altresì necessario che la filosofia diventasse una visione dell’uomo esprimibile attraverso una politica. Sarebbe urgente che la filosofia si mutasse in antropologia politica.