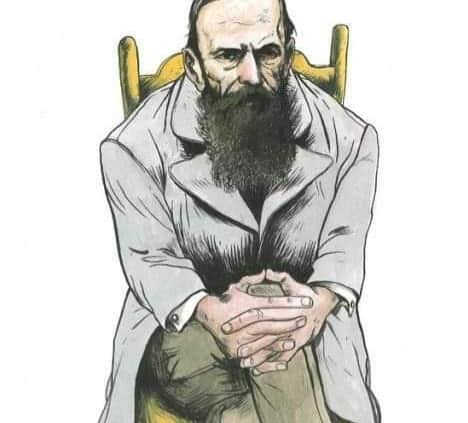Partendo dalla costatazione che la laicità implica una totale libertà di coscienza e la protezione del cittadino contro una qualsivoglia autorità religiosa o potere politico che avrebbe il diritto di controllo sulla sua credenza o sulle sue scelte spirituali, si può affermare che, in base al diritto, la costituzione tunisina garantisce una vita laica.
Ovviamente, nella pratica quotidiana, per una parte dell’opinione pubblica, è ancora difficile accettare che la religione rientri nella sfera privata.
È per questo che spetta alla società civile, oggi più che un tempo, la responsabilità di intervenire e di lottare a diversi livelli, sia contro le mancanze, sia sulla separazione tra politica e religione, al fine di far evolvere le mentalità verso la civiltà e verso le libertà fondamentali che le sono inerenti.
In questo, la lotta delle cittadine tunisine è esemplare all’interno del cosiddetto mondo arabo-musulmano.
È, in effetti, attraverso una lotta sostenuta, cautamente o in modo più diretto, che da alcuni decenni la donna tunisina aumenta l’efficacia della legge con modi di essere e di fare che la rendono cittadina a tutti gli effetti, diminuendo poco a poco le abitudini relative alla rigorosa rappresentazione islamica della donna.
Anche se, dal 1957, per volontà di Bourguiba, la donna ha beneficiato di diritti senza eguali all’interno del mondo arabo- musulmano, con l’abolizione del ripudio e della poligamia, con il diritto al divorzio giudiziario, con il diritto di voto e, più tardi, nel 1973, con la liberalizzazione totale dell’aborto, le donne hanno dovuto difendere e preservare costantemente questi diritti.
Ancora oggi, in linea con la nuova costituzione del Gennaio 2014, l’uguaglianza uomo/donna è in via di evoluzione con l’annullamento della circolare (del 1973) che impediva il matrimonio con un non-musulmano e con un dibattito, ancora in corso, sull’uguaglianza dei diritti concernenti le questioni ereditarie.
Tutte queste conquiste giuridiche vanno di pari passo con le lotte delle associazioni di donne democratiche, determinate ad essere riconosciute come cittadine a tutti gli effetti.
Ma uno dei fattori determinanti per l’emancipazione giuridica e sociale della donna è sicuramente la democratizzazione dell’insegnamento, avvenuta molto presto, subito dopo l’indipendenza. Il diritto al sapere e alla formazione professionale ha promosso forme di autonomia nel destino di generazioni di donne (2). L’accesso della cittadinanza nella scuola pubblica ha dotato la donna tunisina di una forza di partecipazione alla causa pubblica e, ancora di più, di una capacità di creazione nel campo delle arti. Il fatto di produrre delle opere che rendono sensibili delle realtà ma anche un possibile futuro apre un campo d’azione a carattere estetico che può far cambiare fortemente le mentalità per ciò che riguarda le solite rappresentazioni uomo/donna. Oggi, in Tunisia, le creazioni nell’arte plastica e nel cinema sono in gran parte opera di donne.
Soprattutto a partire dagli anni ’80, la frequentazione dell’Accademia delle Belle Arti di Tunisi ha conosciuto un numero considerevole di studentesse, in un momento di espansione delle gallerie nella capitale e di dibattito sul problema della “creazione artistica”. Alcune di queste studentesse hanno potuto continuare i loro studi in Francia e in Italia, arricchendo la loro esperienza artistica ed esponendo in gruppo o individualmente.
Il loro carattere forte e la loro passione creatrice ha permesso loro di trasgredire agli ostacoli socio-culturali che possono sempre rappresentare, per una donna, occasione di scoraggiamento.
Loro si sono imposte sulla scena pubblica lentamente ma in maniera particolarmente brillante in particolare per l’innovazione del loro metodo.
Le loro opere sono modi di fare e di pensare aperti alla diversità del sensibile, agli eventi, all’ambiente, nonché a ogni fenomeno socioculturale, specialmente riguardante le rappresentazioni della donna. Loro apprendono, attraverso un lavoro che evoca l’immaginario, il futuro della loro identità, per non parlare della loro “unicità”.
L’unicità è da intendere sia fenomenologicamente, sia socialmente. La relazione con il mondo è quella che permette di mettere in risalto mutazioni, violenze, contraddizioni o, semplicemente, situazioni singolari che le artiste trasformano in arte al fine di rendere la ricezione più intensa.
Creare ricorda “resistere”, per citare l’espressione di Gilles Deleuze e Felix Guattari. Si tratta di “osare un futuro che è sempre un’avventura”; in questo l’artista “è colui che tenta una lotta incerta” perché aperto a tutte le possibilità, con la capacità di passare da una tecnica all’altra, secondo il processo di questa o quella opera.
Questo accordo con se stesso, con i suoi desideri, con il suo bisogno di produrre o, più semplicemente, di esprimersi, attraverso un metodo adeguato, è una caratteristica che accomuna, oggi, molti artisti tunisini, specialmente quelli della nuova generazione.
I giovani artisti hanno trovato nei mezzi e nei modi di fare contemporanei un mezzo di creazione che risponde meglio ai loro desideri e che permette più libertà per poter rendere sensibile il loro vissuto.
Oggi, l’avvento della pratica delle installazioni e dei video d’arte è favorito da questa generazione di artiste che ha adottato un approccio plastico al quale il pubblico colto inizia ad aderire, malgrado la marginalità dei luoghi di esposizione.
Numerose giovani artiste contemporanee, avviate alle nuove tecnologie e alle nuove modalità di comunicazione, così come alla circolazione e al mix di immagini con la loro diversa rappresentazione, ampliano il loro campo di creazione. Esse rivendicano, allo stesso tempo, la loro singolarità artistica e una certa posizione “cittadina”; si confrontano con un ambiente più ampio, internazionale, che supera la ristrettezza delle identità culturali. In questo, l’immaginario costituisce un motore di emancipazione.
Le opere di queste artiste mostrano fino a che punto la loro creazione si allontani da quella dei loro predecessori, i quali avevano come “scrupolo” un certo estetismo pittorico tenendo ferma una dimensione, più o meno dichiarata, di appartenenza al patrimonio, in senso lato. Al contrario, oggi, è la dimensione, si potrebbe dire, esistenziale che ha la precedenza. È anche la relazione sensoriale in campo socio-politico che viene messa in discussione.
Le artiste cercano i dettagli impercettibili o sconvolgenti che sono al centro delle trasformazioni odierne del nostro mondo. È per loro un modo per affrontare il problema degli individui nella loro singolarità, di fronte alle tradizioni ma anche alla comparsa di diverse minacce contro le libertà, che provengono dall’interno o dall’esterno.
Le pratiche di arte contemporanea delle donne tunisine comportano una forza di dis-identificazione e soggettivazione, che sprigiona rappresentazioni alienanti. Lo spazio creativo riguarda tutti i fenomeni che influenzano il futuro degli individui in una società in cui la vigilanza è da porre prima di possibili ritorni all’egemonia religiosa.
La realtà storica è, naturalmente, nei momenti critici, ostacolata da fronti ideologici a carattere retrogrado per fare piazza pulita dei vantaggi della democrazia, al fine di sostituirvi questa o quella utopia legata al passato. L’arte rimane, in questo senso, un ricettacolo di contraddizioni vissute dalle cittadine che affrontano, nel loro desiderio di emancipazione, le ostinate rappresentazioni della condizione di disuguaglianza tra uomini e donne. È per questo motivo che si può dire che le creazioni artistiche sono anche un focolare sovversivo.
La pratica delle arti visive è una forma di resistenza contro l’uniformazione delle rappresentazioni della donna musulmana. Attraverso le virtù dell’immagine, l’arte diventa un mezzo per sottrarsi alle assuefazioni percettive.
Funziona come un processo di liberazione, per la sua dimensione che è al tempo stesso imprevedibile e instauratrice di un nuovo significato. La creazione che introduce non è solo dell’ordine dell’immaginario, ma un’iscrizione della diversità nell’esperienza dello “stesso”. Disfare una certa immagine tradizionale è cercare di liberarsi dai codici e dalle fossilizzazioni che incombono su ogni designazione e ogni identificazione.
Allo stesso modo, il cinema femminile tunisino è in forte espansione ed è uno specchio della società con le sue contraddizioni, evoluzioni e chiusure(4). Contro l’immagine televisiva della donna, trasmessa da molti canali satellitari nel mondo arabo, la sfida per i registi tunisini consiste nel liberare lo sguardo dalle rappresentazioni che sono diventate convenzionali e si sostituiscono in modo quasi formale alla realtà locale. Ciò rende possibile affrontare la dimensione esistenziale delle situazioni socio-culturali nella loro particolarità. È in questo senso che le artiste giocano la strategia della finzione della realtà. I loro dispositivi immaginari rendono l’immagine del reale diversa dalle rappresentazioni sensate portatrici di verità perché sono mimetiche o indicizzate; così forgiano le nostre rappresentazioni di eventi in prossimità fenomenologica.
Diversi film sollecitano il nostro sguardo e la nostra sensibilità in modo differente,
mostrando le immagini di donne che confrontano i divieti dettati dall’abitudine di una cultura in cui il religioso ritma il sociale. Essi offrono l’immagine di un nuovo tipo di vita possibile, nel rispetto delle libertà altrui.
È un cinema che osa, con molta libertà di tono, portando sullo schermo i temi-tabù che hanno fatto notizia, come lo stupro di una studentessa da parte di agenti di polizia nel recente film (2017) di Kaouther Ben Hania: “La bella e il branco”. Si tratta di produrre, diversamente, con un’attenzione concentrata sulle singolarità delle situazioni, immagini del presente che rispettino lo spazio / tempo di coloro che subiscono, nella loro vita quotidiana, gli effetti di violenze degradanti.
Questo film solleva la questione dell’impunità di fronte alla violenza sulle donne.
Si riferisce, in forma di fiction, ad un vero evento che ha avuto luogo nel 2016 e che ha provocato le proteste delle ONG al punto di smuovere la giustizia per condannare gli autori dello stupro. All’uscita del film, le organizzazioni femministe tunisine “Chouf” ed “Echi” ne hanno organizzato un tour di 100 proiezioni per un pubblico femminile in aree marginali o nelle case delle studentesse per rompere il silenzio e sensibilizzare l’opinione pubblica di Stato. Le discussioni si sono svolte dopo le proiezioni e una guida informativa sull’uso della giustizia è stata distribuita ad ogni riunione (3).
Dal gennaio 2011, ci sono stati diversi documentari e cortometraggi riguardanti la situazione delle donne tunisine e dei loro diritti. È soprattutto il caso di giovani registe come Chiraz Bouzidi il cui documentario “Ennajeh”, dal nome di un villaggio al centro della Tunisia (2013, 23 min), testimonia la fatica quotidiana di donne che raccolgono nelle discariche ciò che si può riciclare e vendere, al fine di provvedere ai bisogni delle loro famiglie. Allo stesso modo, il documentario di Sonia Chamkhi (2012, 64 min) porta sullo schermo la mobilitazione cittadina delle donne nelle prime elezioni libere dopo la rivoluzione del 2011.
Più incisivo e diretto è il film di Nadia El Fani “Laicité Inch’Allah” iniziato nell’agosto del 2010 prima della rivoluzione e che mostra le pratiche apertamente irreligiose delle donne libere che sfidano i tabù nel mese del Ramadan, che trasgrediscono i tabù riguardanti il comportamento detto “immorale”. Le riprese sono continuate dopo il gennaio 2011 per sollevare chiaramente la questione di una Costituzione laica che non avrebbe lasciato alcun dubbio sulla libertà di coscienza e sull’uguaglianza di genere. Questo film è stato censurato.
Anche i lungometraggi, opera di giovani registi non mancano di difendere le libertà tracciando il quotidiano delle giovani donne anche nel loro ambiente familiare, come nel caso del primo film di Leila Bouzid (2016). “A peine j’ouvre les yeux” che mostra la ribellione di una giovane ragazza contro tradizioni tenaci anche nel caso di un ambiente di piccola borghesia.
Questo film è in linea con i film che affrontano il problema del rapporto con il corpo come quello della regista Raja Amari, la storia di “Satin rouge” che ha messo in scena una vedova alla scoperta del suo corpo desideroso, attraverso l’uso della danza. Allo stesso modo, lo fa un film più vecchio di Moufida Tlatli “Le silence des palais” (1990), in cui si parla della segregazione della massaia secondo le consuetudini e le frustrazioni del corpo, nell’epoca Beycale. Il numero di donne registe che prendono iniziative per la produzione dei loro film non cessa di crescere e allo stesso tempo attira un vasto pubblico. Questo cinema femminile contribuisce certamente a rendere visibile una realtà celata da immagini e discorsi che portano un’ideologia conservatrice che non ha più legami con la realtà. Partecipa a una forma di democratizzazione delle mentalità.
Queste produzioni artistiche delle donne tunisine valorizzano la funzione vitale delle differenze e delle trasgressioni in campo culturale. Trasgredendo l’esperienza ordinaria, rendono possibile il liberarsi dalle prove e l’aprirsi a una visione critica delle rappresentazioni e delle modalità di identificazione concordate culturalmente. Questo dinamismo del campo artistico è quindi un processo di invenzione di una cittadinanza sociale che si basa sulla diversità inerente al fenomeno stesso della creazione e alla sua ricezione. Infatti, lo spazio di produzione culturale è, allo stesso tempo, uno spazio di convivenza che presuppone a priori la condivisione e il riconoscimento dell’autonomia di ciascuno; è proprio per questo che in Tunisia, attualmente, gli attori culturali e gli artisti sono consapevoli di partecipare al processo di democratizzazione della vita sociale come potere che si oppone all’autoritarismo che allarma ogni stato. Di fronte all’astrazione dei valori istituzionali di libertà e giustizia, rivendicano un’effettiva emancipazione in cui venga riconosciuta l’autenticità di ogni creatore nella sua capacità di inventiva, comunicazione e creazione di nuovi valori. In questo senso, la postura critica propria dell’arte diventa una sorta di auto-fondamento dell’atto creativo. La censura che è stata esercitata nel vecchio regime e che ancora minaccia, al momento attuale, opere giudicate sovversive dalle forze reattive, diventa così più insostenibile; questo dà luogo a un dibattito in cui la società civile è coinvolta nelle questioni della libertà di espressione e della libertà di coscienza e prende atto dell’importanza della cultura nel processo democratico. La natura esemplare dell’arte funziona da cavallo di battaglia per le rivendicazioni all’autonomia del singolo individuo cittadino.
Note:
(1) Le cifre parlano da sole: ci sono 75 deputati (donne) su un totale di 217, con il 60% delle donne in ambito medico, il 41% magistrati, il 43% avvocati e il 60% laureate.
(2) Già, la seconda metà del ventesimo secolo è stata quella dei cambiamenti sociali dovuti all’avvento del pensiero riformista, specialmente riguardo la didattica, in generale (e quelli dal 1938) in cui abbiamo introdotto un programma moderno aperto su scienze e lingue (francese, italiano, turco) con, inizialmente, la creazione del Politecnico di Bardo, poi nel 1875 con l’istituzione del Liceo Sadiki promulgato da Sadok Bey nel 1875 (questo insegnamento arriva a distaccarsi dall’educazione religiosa tradizionale). Nel 1883 scuole francesi e italiane, maltesi e israelite, per ragazze, sono venute alla luce, ma il numero di ragazze musulmane era inferiore allo 0,2%.
La sensibilizzazione di un’educazione moderna per le ragazze avvenne principalmente attraverso gli scritti di riformisti pubblicati nella rivista El Manar nel 1898: Mohamed Abdou (1849/1905), Rachid Ridha (1865/1935), e in particolare l’egiziano Rifat Rafée At Tahtaoui (1801/1873) che difese l’idea di adattare la religione musulmana al progresso che l’Europa conobbe in materia di educazione delle donne (come nel suo libro takhlis al ibriz fi talkhis baris; l’apercu abrege de Paris); in seguito Kheiereddine Bacha influenzata da Tahtaoui reclamò ufficialmente in Akwam al Massalek l’educazione moderna per le ragazze.
Già prima dell’indipendenza, sono stati fatti tentativi per aprire spazi di istruzione e formazione per le ragazze, a cui all’educazione delle responsabilità domestiche doveva aggiungersi un insegnamento più vasto. Il 1 ° maggio 1900, fu inaugurata la prima scuola per ragazze musulmane nella medina di Tunisi che fu nominata Dar el Pasha.
(3) Il progetto “Images au-dessus de l’impunité” è stato avviato dalle associazioni Echos e Chouf, in collaborazione con FIDH, CNCI e IFT, con il contributo di Euromed, distribuzione HAKKA e Ciné téléfilms, con la partecipazione di l’associazione Beity, ATFD, AFTURD e CREDIF e il supporto di OOUN.
(4) Abdelkrim Gabous, Silence, elles tournent! Les femmes et le cinéma en Tunisie, edizioni Ceres, 1998.
Sonia Chamkhi, “Du discours social au discours de l’intime ou de la démystification de la violence “, in Patricia Caillé, Florence Martin (regista), Les Cinémas du Maghreb et leurs publics , Africultures n ° 89, Paris, L’Harmattan , 2012.
Rachida Triki
traduzione a cura di Alexia Banica