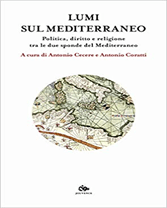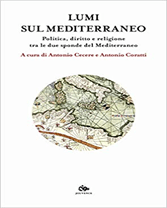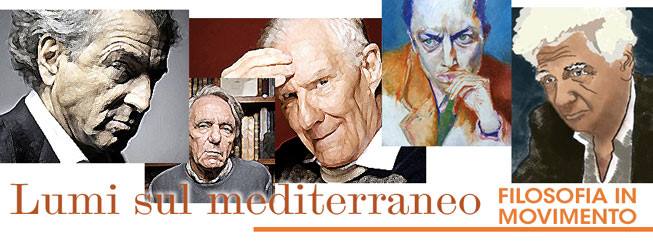di Francesco Coniglione
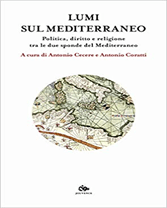
Per capire il senso del discorso che vorrei qui non tanto svolgere, ma almeno abbozzare, è utile partire da quanto sostenuto da Fathi Triki nel suo contributo incluso nello stimolante volume Lumi sul Mediterraneo (a cura di A. Cecere e A. Coratti, Jouvence, Milano 2019). Qui viene fatta la distinzione tra Ensemblisme identitario e “vivere-insieme nella dignità”. Il primo non ammette la differenza, lo scarto e quindi finisce per governare gli uomini attraverso la dittatura, la violenza e la guerra; esso esclude il non familiare e quindi genera l’estremismo e l’identitarismo totalitario: «Detto in altri termini, la prossimità partecipa, in un modo o nell’altro, all’annientamento dell’individuo e rafforza il peso della comunità. È il motivo per cui uno scarto, una distanza sono necessari perché l’individuo recuperi la propria dignità, la propria ragion d’essere e la propria rispettabilità» (ivi, p. 26). Ad esso si contrappone la teoria del “vivere-insieme nella dignità”, la quale esige la liberazione dell’individuo dall’imperium della comunità e si fonda sul concetto islamico di mahabba cioè la socialità e la filìa, l’amore, che conduce a una forma di ospitalità, tratto comune delle culture del Mediterraneo. Questo “vivere insieme” rifugge all’uniformizzazione ed evita di cancellare le differenze, ma piuttosto è una «forma d’essere al mondo aperta ai cambiamenti di civiltà che abitano la sua [del Mediterraneo] storia: atteggiamento volontario di lottare contro ogni chiusura e ogni tentativo di distruggere i valori che hanno forgiato la sua fisionomia» (ivi, p. 27).
A prima vista si potrebbe pensare che tale concetto di “vivere-insieme nella dignità” sia una sorta di indicazione meramente postulatoria dallo scorso contenuto propositivo ed operativamente poco efficace, una sorta di appello ai buoni sentimenti che evita di affrontare le questioni cruciali che stanno al centro di quello che si è indicato – con efficacia propagandistica, ma con scarsa presa reale – come “scontro di civiltà”, che vede coinvolte in prima istanza le due sponde del Mediterraneo. Ma questa è una impressione che può permanere solo in un lettore superficiale; ed è la lettura dei saggi che accompagnano quello di Fathi Triki a dare delle importanti indicazioni per intendere in modo adeguato tale nozione, sviluppandone il contenuto in essa non sempre pienamente esplicitato.
Infatti, già il fatto che nel “vivere insieme” si rivendichi la «liberazione dell’individuo dall’imperium della comunità» pone in essere una significativa sintonia con quella “terza sfera” della laicità e della libertà di coscienza indicata da Foucault, cioè quella che si riferisce alla dimensione privata e personale (e che si aggiunge a quella temporale legata alla storia e a quella spirituale legata all’appartenenza comunitaria). È in sostanza l’esigenza che Paolo Quintili presenta nel suo contributo (“Politica e diritti tra Europa e Maghreb. Alle origini della nozione di ‘laicità’”, pp. 97-117): «Il problema della costituzione della laicità e del suo spazio inviolabile si esprime, a mio avviso, in questi termini. Come lasciare libertà di costituzione, nei diversi ambiti e contesti geo-storici determinati, a questa terza sfera, in ogni individuo, anzi, di più: come favorire, a livello culturale e istituzionale, la sua costituzione? Ciascuno di noi – uomini e intellettuali del XXI secolo, emancipati grazie all’operazione storico-culturale dell’Illuminismo – ha una propria “religione personale”, anche inconsapevole, taciuta, che s’esprime nell’intimità del dialogo con sé e prende poi corpo nell’agire quotidiano» (Quintili, p. 115). È una importante indicazione su come sia possibile “rileggere” e ritradurre nella nostra lingua dei concetti che per un islamico si pongono in modo diverso, appunto nella misura in cui è difficile, a sua volta, tradurre nella sua concetti che sono correnti nel nostro mondo intellettuale, come quello di “laicità”, del resto non sempre presente in tutti gli ambiti storico culturali in cui di fatto esso viene praticato. Ed infatti, come ci avverte sempre Quintili, nel contesto geo-storico arabo-islamico parlare di “laicità” avendo appunto come riferimento questa “terza sfera”, che pure abbiamo visto è implicita nel “vivere-insieme nella dignità”, fa correre il rischio dell’incomprensione, in quanto il suo equivalente arabo – eilmania – si confonde con l’ateismo e quindi con l’irreligiosità, la miscredenza e di conseguenza anche con l’immoralità, analogamente a come veniva intesa la parola “ateo” nel periodo di dominanza religiosa cristiana, cioè tra Sei e Settecento.
Il “vivere-insieme” riconquista tuttavia il contenuto del concetto di laicità (e quindi, vedremo, di democrazia) attraverso una manovra ad aggiramento: già l’esigenza posta della liberazione dell’individuo dall’imperium della comunità funziona da esigenza critica affinché si eviti che tale vivere insieme si trasformi nel criticato “ensemblisme identitario”. Ma, ancor più, Fathi Triki si approssima al contenuto concettuale della laicità nel momento in cui fa scendere in campo la nozione – ripresa esplicitamente da Derrida – di “ospitalità”, quale antidoto alla possibile violenza del “vivere-insieme”; infatti, «ogni umanismo è fondato sull’ospitalità» (Triki, p. 36), giacché (come ha intuito Terenzio) «appartenere all’umano implica rivendicare la sua pluralità» (p. 37) nel fare il bene e nel fare il male. Per Derrida l’ospitalità è l’essenza dell’umano e Triki afferma che essa è «una condizione necessaria per ogni filosofia del vivere-insieme, perché essa permette alla dignità di compiersi e all’umanità di diffondersi» (p. 39). L’ospitalità è quindi il fondamento di ogni “vivere-insieme nella dignità” e può realizzarsi solo mediante la regola d’al-karam, ovvero la generosità (dell’accoglienza – karam al dhiafa) fondatrice della dignità, che si apre alla condivisione assoluta e senza condizioni della vita. Insomma «la dignità come karamah designa uno statuto onorevole, che l’altro deve riconoscere e che impone certi atteggiamenti coerenti con il senso dell’umano» (p. 41), offrendo una nuova dimensione dell’umanità, un «vivere insieme armonioso, ragionevole e confortevole».
In fondo – come avverte Mario Reale nel suo intervento (“’Vivere-insieme con dignità è un altro nome di ‘democrazia’”, pp. 67-96) – si potrebbe sostenere che tale nozione proposta da Fathi Triki non sia altro che un equivalente della democrazia, una forma istituzionale che farebbe uscire il “vivere-insieme” dalla sua “levità culturale e poetica”, dandole corpo organizzativo concreto, operatività politica. E ciò perché la democrazia sarebbe la soluzione della domanda fondamentale su come può l’individuo conservare la propria autonomia impegnandosi al tempo stesso a costruire “uno spazio di convivenza”, promuovendo diritti e unità, individualizzazione e socializzazione. Ma giustamente non può non nascere la domanda che Reale non evita di porre: è la democrazia in grado di soddisfare l’esigenza del vivere-insieme, cioè quella «socialità intensa, tramata di philia o di “disposizione affettuosa”»? (ivi, p. 59). È in sostanza questa la dimensione della ‘fraternité’, la cui esigenza si è espressa anche come “religione civile”. Una domanda a cui non si può che rispondere negativamente, giacché la democrazia da noi praticata «non consente […] un’irruzione di “socialità” nel suo ambito proprio di espressione» (ib.), anche se questa socialità si trova nei momenti in qualche modo rivoluzionari che preparano l’avvento della democrazia, «nel vigore del suo stato nascente» (p. 61), dove è implicito il riferimento alle riflessioni Francesco Alberoni (specie nel suo Movimento e istituzioni, Il Mulino, Bologna 1981).
Tale richiamo alla esigenza della socialità e di conseguenza alla ‘fraternité’ è importante in quanto è proprio in tale sentimento o forma di legame sociale che s’è visto, in molti teorici ma anche in diversi movimenti istituzionali, il modo per compensare e riequilibrare il tipico universalismo illuministico. Al senso di anomia che ne potrebbe derivare viene contrapposto un momento, un ambito, un ‘tempo’ nel quale possa vigere un nuovo senso di comunità, in cui sia possibile ricreare un sentimento di appartenenza, ritessendo quel legame sociale che in una società sempre più frammentata, universalistica e atomizzata tende ad attenuarsi. È questa appunto l’esigenza posta dal terzo termine del motto della Grande Rivoluzione: appunto la ‘fraternité’ mette in luce l’insufficienza di un’etica laica, quale quella implicita nell’universalismo illuminista e nella separazione tra sfera religiosa e sfera pubblica, che si differenzia da quella religiosa per il fatto di rivolgersi e argomentare sulla base della sola ragione, a differenza delle etiche religiose in cui è essenziale il riferimento ai testi sacri o alla rivelazione. Tale etica laica si esprime, ad es., in modo paradigmatico e quasi ‘puro’ nelle recenti parole di un grande scienziato, Richard Dawkins: «La mia utopia è un mondo nel quale le credenze sono basate sull’evidenza e la moralità è basata su una intelligente progettazione – una progettazione effettuata da umani intelligenti (o robot!). Né le credenze né la morale dovrebbero essere basate sui sentimenti della pancia, o su antichi libri, rivelazioni private o tradizioni clericali» (“Richard Dawkins Offers Advice for Donald Trump, and Other Wisdom”, in Scientific American Daily Digest, August 10, 2017).
Col far appello solo all’intelletto, questa etica dimentica però quelle che Blaise Pascal ha chiamato “le ragioni del cuore”, quelle medesime ‘ragioni’ che nell’epoca del trionfo dei lumi, Chateaubriand lamentava fossero assenti dai nuovi templi eretti dalla Rivoluzione francese, dedicati solo a un astratto concetto di Vero: «questi stessi templi, dove in altri tempi si contemplava un Dio conosciuto in tutto l’universo o le immagini di una vergine che consolavano tanti infelici, questi templi dico, erano dedicati a quella Verità che nessuno conosce e alla Ragione che non ha mai asciugato una sola lacrima» (Le génie du christianisme, 1802, Alfred Mame et Fils, Tours 1848, p. 21). Di converso, l’etica religiosa infiamma innanzi tutto il cuore e solo successivamente si trasforma in analisi razionale, la quale getta però un velo di freddezza sulla fede, come aveva ben capito un giovane Hegel. Ecco perché l’etica laica è così difficile non solo da rendere universalmente condivisa, ma anche di diventare forza motivante e propulsiva dell’agire per le grandi masse; essa è inevitabilmente aristocratica, condivisa e perseguita da pochi spiriti eletti che fanno del culto della ragione il faro della propria vita, così come è stato rimproverato alla proposta morale di Kant. Tuttavia, anche nelle religioni edificate sulla base di una forte adesione emotiva a principi di fede, l’amore predicato universalmente perde di forza, si illanguidisce e finisce per scolorare in un generico imperativo etico che lascia spesso freddo l’agire quotidiano del singolo. Sicché, a fronte del declino delle grandi strutture istituzionali – politiche come religiose – è sempre nata nella storia l’esigenza di rivalorizzare le comunità di base, di attaccarsi al campanile, alla “piccola società”, in cui il legame interpersonale viene ri-creato in un senso assai prossimo al re-ligare religioso, grazie alla prossimità fisica, alla stretta coesistenza. È quella esigenza propria alla “culture comunitarie” che si esprime in una sorta di ‘tribalismo mirante a una sorta di “reincantamento del mondo”, come ha messo in luce Michel Maffesoli (“Le culture comunitarie”, in G. Finis, R. Scartezzini, a cura di, Universalità & differenza. Cosmopolitismo e relativismo nelle relazioni tra identità sociali e culture, FrancoAngeli, Milano 1996, pp. 257-65).
In ciò si esprime il bisogno di rinsaldare, di ritessere, i rapporti che si sfilacciano, tanto più in società nelle quali vengono a cessare gli antichi legami comunitari. E se in passato erano stati gli ordini monastici a fungere da punto di accumulazione della solidarietà cristiana, successivamente sono state le varie associazioni confessionali tra laici ad adempiere questa funzione, come accade oggi con gruppi quali Comunione e Liberazione, i focolarini, l’Opus Dei e sul piano non religioso club quali i Lions, Rotary e tante altre forme di aggregazione in cui si cerca di mettere in atto e di vivere nel concreto, all’interno di un forte legame comunitario, la ‘fraternité’, in modo da riattualizzarla e continuamente confermarla.
Questa esigenza motiva la richiesta della ‘fraternité’, ad integrazione e completamento di liberté ed égalité. Con una importante differenza da queste ultime: se è facile dare un significato e un contenuto alla libertà, come anche alla eguaglianza, che sono concetti per molti aspetti anche normativamente definiti o definibili attraverso leggi e principi costituzionali, invece la ‘fraternité’ sembra essere, ad un superficiale sguardo, più un generico appello a un sentimento di reciproco ben volere, che un termine cui sia assegnabile un preciso contenuto concettuale. Esso tuttavia riceve una sua prima ragion d’essere dalla circostanza di fatto che libertà ed eguaglianza possono entrare tra loro in tensione: la rivendicazione della prima spesso è contraria all’esigenza della seconda, così come insistere eccessivamente sulla seconda può voler dire una limitazione della prima. Ecco allora che la ‘fraternité’ assume quasi una funzione mediatrice tra quei due opposti, mitigandone l’applicazione unilaterale e mortificante: grazie ad essa la libertà non può trasformarsi in assoluta licenza a danno degli altri e l’eguaglianza non può disconoscere l’autonomia e la personalità altrui, in quanto accomunati da un legame condiviso.
La ‘fraternité’ così intesa, pertanto, non si esercita in generale, non concerne tutti gli uomini, non è un principio universalistico che bisogna solo riconoscere e a cui è necessario semplicemente aderire con la forza dell’intelletto. Ciò fa sì che essa sia qualcosa di più della semplice adesione ad un’etica laica, in quanto fornisce quelle motivazioni interiori che altrove sono tipiche della fede religiosa. Essa scaturisce dalla necessità di “riunire ciò che è disperso”, che, in antitesi alle società complesse ed atomizzate, si preoccupa di riconnettere le persone, di farle sentire nuovamente solidali, di dare loro il senso della comunità, di farle uscire dall’anomia tipica di individui eterodiretti formanti la cosiddetta “folla solitaria” (come ha detto David Riesman, La folla solitaria, il Mulino, Bologna 1999). Tale esigenza è stata condensata nel concetto di ‘reliance’ – di ricollegamento, ritessitura, riconnessione – che è stato forgiato dal sociologo belga Marcel Bolle de Bal (cfr. “Reliance, déliance, liance: émergence de trois notions sociologiques”, Sociétés 2013/2, 2003, pp. 99-131) ed è stato quindi messo alla base del suo modo di concepire la ‘fraternité’, in contrasto a quella ‘deliance’ – la dissociazione, la frattura, la disaggregazione atomistica – che invece caratterizza le società contemporanee. Come ha scritto Edgar Morin (La méthode, t. VI, “Ethique”, Seuil, Paris 2004, p. 114), la ‘reliance’ è alla base degli altri imperativi etici, come tolleranza, libertà, fedeltà, amicizia, amore, rispetto, cortesia, e quindi tende naturalmente a rivolgersi agli altri, alla comunità, alla società, ed infine all’umanità. Ecco perché l’etica che deriva dal senso della fratellanza non contraddice quella laica, non contrasta con quella che può essere motivata religiosamente, ma si aggiunge ad esse, le tonifica, le rende vigorose e salde, le sostanzia con una forza emotiva che viene rinnovata continuamente.
Quanto detto da Morin mette in campo un concetto che ci sembra fondamentale, anzi il perno attorno a cui l’esigenza del “vivere-insieme con dignità” di Fathi Triki assume la sua piena pregnanza significativa: il “rispetto”. Lo introduciamo attraverso le parole che vi dedica – quasi per inciso – Bruno Montanari (“Per vivere insieme con dignità: riflessioni sul pensiero moderno”, pp. 67-96), ma che a nostro avviso costituiscono anche uno degli assi fondamentali intorno ai quali si svolge il suo argomentare: «Il rispetto è la concretizzazione pratica, nell’agire, della reciprocità: rispettare non vuol dire “tollerare” o “omologare”; non vuol dire agire come se le differenze non fossero significative. Al contrario, il rispetto implica il riconoscimento della differenza dell’“altro”, poiché essa è reciproca differenza. Nell’atteggiamento del “rispetto” non vi è un soggetto sociologicamente, culturalmente o politicamente dominante, come nella tolleranza: un soggetto tollerante ed uno tollerato. Nel rispetto c’è la presa d’atto di un come me originario e dunque strutturalmente reciproco. In sintesi, il rispetto è la traduzione pratica dello svolgersi individuale della strutturale e reciproca relazionalità dell’io di ciascuno» (p. 92).
È questo un punto nevralgico: il richiamo al rispetto è importante in quanto pone il proprio fuoco sulla circostanza che nel trattare con gli altri – verso i quali si deve avere del ‘rispetto’ – le azioni o comportamenti che possono essere intrapresi verso di essi non debbono essere suscettibili a venir commisurati con un metro oggettivo, che possa essere normato in maniera positiva. Quando si ha rispetto si deve innanzi tutto prendere in considerazione quello che è il riflesso soggettivo, interiore che un dato atto può avere in un altro soggetto, sicché la medesima azione può suscitare una lesione o una gratificazione maggiori o minori a seconda dell’individuo che viene da esse attinto. È la rilevanza di questa lesione o gratificazione che deve essere la ‘misura’ del ‘rispetto’: non si è rispettosi perché ci si comporta in un certo modo verso un individuo, che potrebbe anche essere indifferente alla ritualità di quel comportamento, ma solo nel caso in cui si è consapevoli del riverbero interiore che quel comportamento potrebbe avere in un soggetto; e ci si astiene o meno dal metterlo in atto, per quanto lo si ritenga secondo il metro dell’agente di lieve o trascurabile importanza. Solo in questo caso si ha ‘rispetto’. Ne deriva da ciò che il ‘rispetto’ è sempre contestuale e non può prescindere dalla storia dell’individuo, dal modo in cui la sua persona si è formata, onde non può essere dettato da una norma astratta di comportamento. La famosa regola aurea viene a ricevere una sua particolare accentuazione che la piega a una più profonda comprensione: non solo “non fare agli altri ciò che vorresti non fosse fatto a te stesso”, bensì “fai agli altri ciò che essi si aspetterebbero venga loro fatto, in modo da rispettare la loro interiorità”. Si ha una re-inversione della rivoluzione soggettocentrica di Kant: l’etica del rispetto non ha come perno la volontà legislatrice dell’Io, bensì l’oggetto verso cui è diretto, ovvero l’altro.
Solo in tale quadro l’ospitalità riceve una sua piena motivazione, in quanto questa è una delle forme in cui si manifesta più propriamente il rispetto. Nei confronti dell’ospite si assume un atteggiamento di ‘cura’ verso i suoi sentimenti, ci si industria per farlo sentire a proprio agio, capendone le esigenze e persino le idiosincrasie: gli si offrono pietanze che corrispondono ai suoi gusti, stanze che si conformano ai suoi modi di vivere, non si esibiscono forme di comportamento o manifestazioni di cultura che gli possano essere sgradevoli (ci si astiene, ad es. dal fare la croce e di ringraziare il signore prima dei pasti se l’ospite è di religione o sensibilità diversa). Come ha affermato recentemente Nunzio Galantino, «il rispetto è, in fondo, un prendersi cura in maniera viva e consapevole dell’altro, sia esso una persona, una legge o la natura nella quale viviamo e dalla quale siamo circondati» (“Accorgersi degli altri”, in Il Sole 24 Ore 13-10-19, p. 29). E questo avviene perché è la dignità il valore che si riconosce all’altro, in quanto solo verso chi è dotato di dignità, così come noi pensiamo di esserne, si può avere ‘rispetto’ e lo si può trattare con ospitalità. È questa quella dimensione ‘orizzontale’ che – da una prospettiva cristiana quale quella di Mons. Galantino – unisce alla dimensione verticale la dimensione orizzontale «che si fonda sull’uguale dignità delle persone, al di là della funzione e del ruolo» (ib.). Da questo triplice nesso – rispetto, ospitalità dignità – trova a nostro avviso tutto il suo pieno valore il “vivere-insieme nella dignità”.
Il ‘rispetto’ impedisce anche quell’atteggiamento che è tipico in ciò che Fathi Triki chiama “nuova colonialità”, caratterizzata dall’uso di ‘nobili’ nozioni tipiche della cultura occidentale – diritti umani, democrazia, guerra ai dittatori, intervento umanitario, diritto di ingerenza, missioni di pace ecc. – per poter intervenire in situazioni di crisi: la creazione artificiale di guerre perpetue (il Medio Oriente ne è un esempio quasi esemplare) è finalizzata a «distruggere l’edificio delle istituzioni statali, in nome, evidentemente, dell’ideale “democratico” e contro la dittatura, facilitando così lo sfruttamento a oltranza di tutte le ricchezze di questi paesi» (Triki, p. 31). Al cosmopolitismo e all’utopia di libertà illuminista viene sostituita la globalizzazione imperialista: l’ospitalità degli stranieri che vanno coi flussi migratori nei paesi occidentali avviene all’insegna del razzismo e della colonialità, con islamofobia, paura, accuse di terrorismo ecc., dimostrando quanto sia difficile il “vivere-insieme” in Occidente. Di tale colonialità fa parte integrante una strategia culturale fondamentale: la inferiorizzazione: «L’intellettuale del Sud è sempre inferiorizzato, raramente ascoltato e citato dai suoi pari del Nord […] questo rapporto di inferiorizzazione non tocca soltanto l’intellighènzia: esso è presente in tutti i tipi di rapporto fra le due sponde del Mediterraneo. È il motivo per cui, d’altronde, il vivere-insieme, in queste condizioni, non può che essere violento» (ivi, pp. 35-6). Il “vivere-insieme” non è nella dignità, in quanto tra coloro che partecipano di questo rapporto non v’è rispetto, ma si richiede solo l’ossequio formale a delle norme che di solito sono quelle del paese ricevente, ‘accogliente’.
Questo dimostra perché il laicismo possa essere visto con diffidenza dagli intellettuali che non si sono formati nella cultura occidentale, assorbendone sin dall’infanzia i valori, come anche, tra le righe, da Fathi Triki. Infatti esso, in ambito politico è un atteggiamento solo negativo: ci si astiene dal fare o esibire atteggiamenti di carattere religioso negli spazi comuni, e quindi si separa autorità civile e religiosa, in nome di una comune appartenenza a una entità sopraindividuale che – ecco l’accusa che viene fatta – spossessa delle identità le singole comunità. Donde uno dei paradossi o aporie della laicità: «nelle società chiuse o di lunga e grande tradizione religiosa, l’appartenenza comunitaria – con tutti i suoi segni, simboli e pratiche – è sentita, in molti casi, come avente un valore superiore alla stessa uguaglianza e libertà. In questi casi, perché si affermino i “diritti dell’uomo” (uguaglianza e libertà), occorre cambiare anzitutto il senso comune, operare cioè per quel cambiamento in un modo pacifico, attraverso i mezzi di formazione e di educazione delle coscienze, prima di affermare o rivendicare ogni possibile primato della laicità» (Quintili, pp. 108-9). Tuttavia questa aporia può essere aggirata solo se eguaglianza e libertà sono esercitate nell’ambito del rispetto, cioè quando si intende e si ha cura del riverbero interiore del nostro comportamento nell’altro; esso ha per questo aspetto uno statuto diverso dalla mera affermazione dei cosiddetti diritti umani, che sono l’estrinsecazione pratica dell’universalismo illuministico: il diritto all’esistenza, alla libertà e alla proprietà, diritti oggettivamente e positivamente configurabili. Il rispetto, invece non lo è: esso richiede, per così dire, una capacità ermeneutica di interpretare il sentimento altrui, una sensibilità che si può alimentare solo con cultura e formazione. Esso richiede una maturazione interiore che deve essere il frutto di un processo educativo lungo e arduo, implica «il bisogno di doversi prendere del tempo per accorgersi degli altri, per conoscere chi o cosa si ha di fronte, cosa pensa e cosa di conseguenza ci domanda» (N. Galantino, cit.). Ecco perché il rispetto è difficile da mettere in atto. Ne consegue la necessità dell’educazione, che non è solo quella esplicita, ma soprattutto la implicita, che si acquisisce nella pratica comunitaria, nelle comunità in cui il rispetto viene già esercitato. È, come avviene nella scienza, una conoscenza tacita: come l’uomo morale non è fatto dall’apprendere i precetti di un qualche catechismo o trattato delle virtù (lo sapeva bene Wittgenstein, che per questo disprezzava i preti moralisti), analogamente il bravo scienziato non è quello che apprende i principi della scienza nei manuali e nei trattati di metodologia, ma solo a contatto dei grandi scienziati, nei laboratori dove si fa scienza, nel concreto del suo esercizio. Per utilizzare due belle espressioni il rispetto è inscritto in una “forma di vita”, come direbbe Wittgenstein, o è come l’essere ‘iniziati’ a uno stile di pensiero, per dirla con Ludwik Fleck: ad esso «non v’è la possibilità di accedere […] per mezzo di una qualche strada genericamente umana, ovvero grazie a una cosiddetta strada “logica” o “razionale”. Tutti gli educatori sanno che l’introduzione a un qualsiasi ambito di pensiero deve sempre passare per un periodo di “apprendistato” nel quale opera solo l’autorità e la suggestione, e non una qualche generale e “razionale” spiegazione. Queste introduzioni hanno in tutti i campi il valore del sacramento iniziatico noto dall’etnologia. Ad ogni disciplina non è possibile accostarsi attraverso lo studio del suo compiuto sistema concettuale, bisogna che sempre vi sia una “introduzione” in parte storica, in parte aneddotica e dommatica. È questo un esercizio di sottomissione allo specifico stato d’animo del collettivo» (Stili di pensiero. La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di F. Coniglione, Mimesis, Milano-Udine 2019, p. 196). Solo grazie a questa educazione, a questo peculiare ‘apprendistato’ (del resto segnalato pure da Thomas Kuhn), che ha il vero e proprio carattere di un percorso esoterico, è possibile ‘vedere’ ciò che prima era invisibile; in particolare è possibile sentire e rendersi conto dei possibili riflessi delle nostre azioni nell’altro, sviluppare quell’esprit de finesse da Pascal ritenuto non meno importante dell’esprit de géométrie.
L’approccio qui delineato permetterebbe anche di vedere in una diversa luce quello che è stato indicato da Stefano Petrucciani come il paradosso dell’universalismo, insito nel proclamare il principio dell’eguale rispetto per tutti gli uomini e le loro culture, basato sulla loro dignità. Infatti, «il paradosso dell’universalismo sta nel fatto che esso per un verso riconosce la pari dignità di tutte le persone, le idee e le culture, mentre per altro verso implica in qualche modo l’idea che le culture che non si riconoscono nei principi dell’universalismo hanno un valore inferiore rispetto a quelle che invece lo fanno» (“I diritti umani e il paradosso dell’universalismo”, p. 119). Tale paradosso viene meno se l’universalismo è filtrato secondo l’etica del rispetto ed è sovraordinato a quei “diritti umani” che sono il tipico portato della cultura occidentale, in quanto solo questi ultimi di fatto comportano una “inferiorizzazione” dell’altro e quindi delle altre culture. Il rispetto invece richiede solo la reciprocità, è sempre bilaterale, scambiato, così come l’ospitalità, ponendo in campo quell’esigenza di socialità e ‘fraternité’ senza la quale l’universalismo, come anche i diritti umani restano morte impalcature che possono facilmente assumere un carattere vessatorio e un atteggiamento inferiorizzante.
Il che non vuol dire che si possano mettere da parte l’esigenza insita nell’idea di democrazia e i valori incarnati nei cosiddetti “diritti umani”, ma solo che queste non possono essere il modo esclusivo con cui si possono rapportare le culture, con cui si può interagire con l’altro, portatore di una storia e di una cultura autonoma e spesso assai lontana da quella occidentale. In fondo la proposta del “vivere-insieme con dignità” non solo non si contrappone ad essi, ma si propone come una necessaria integrazione che risponde a un bisogno fondamentale, ad un’esigenza che ha percorso tutta la storia delle società umane e che si è espressa storicamente in forme diverse (solidarietà, ‘fraternité’, stato nascente, legame fusionale, comunitarismo, “spirito tribale”, ecc.), pur essendo del tutto dimenticata nelle società secolarizzate, rette da una ragione strumentale se non addirittura mercantile, come quelle occidentali nella loro declinazione neo-liberale degli ultimi decenni. In fondo la proposta di Fathi Triki suggerisce di sostituire – con il concetto di “vivere-insieme nella dignità” – alla globalizzazione economica-finanziaria e al dominio neoliberista dei mercati, un’altra e più importante globalizzazione, quella culturale e politico-civile, attenta all’ecologia planetaria e ‘rispettosa’ della sensibilità degli altri. È la transizione dalla società tollerante alla “società rispettosa”.