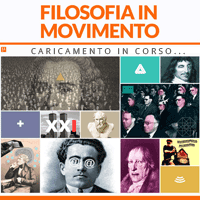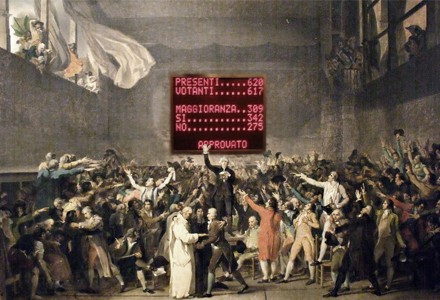di
Rosario Gianino
Il testo che segue è il risultato di una lettura della Scienza della Logica di Hegel, ed in particolare delle analisi dedicate alla categoria del “divenire”, che si trovano nel libro, sezione e capitolo, primi dell’opera[ref]Scienza della logica, G.W.F.Hegel, trad. Moni, rev. Cesa, Laterza, Bari 1988, tomo primo, pp. 71-102.[/ref].
1.
Per cominciare richiamiamo l’attenzione del lettore di queste pagine sul doppio statuto che la negatività insita nella categoria del divenire viene ad assumere nella teoresi del nostro autore. Questa lettura individua due negazioni attive nel divenire. Nel divenire abbiamo il nulla. Questa è la prima negazione. Ma abbiamo anche l’annullamento del nulla. Questa è la seconda negazione. La lettura cerca di mostrare come questa doppia scansione all’interno del testo del filosofo di Stoccarda permette di ordinare la direzione ed il senso del processo dimostrativo messo in opera nella trattazione del divenire.
2.
Nel divenire hegeliano abbiamo una negazione immediata: l’essere che insorge nega il nulla; l’essere che sparisce si nega. Così inteso, il divenire, in cui l’essere insorge “dal” nulla e sparisce “nel” nulla, si costituisce in forza di una negazione immediata dell’essere: il nulla da cui l’essere insorge e lo stesso nulla in cui l’essere sparisce. L’analisi del divenire hegeliano però non finisce qui. La negazione immediata dell’essere è contraddittoria. Essa implica l’unità contraddittoria di essere e nulla: implica che essere e nulla siano lo stesso. Implica quindi che questo rapporto tra essere e nulla, non sia un rapporto possibile e che ad iniziare e a finire siano l’essere ed il nulla insieme. Nel divenire, come insorgenza dell’essere dal nulla e sparizione dell’essere nel nulla, è lo stesso essere che è nulla che insorge per sparire. Dunque la negazione immediata dell’essere, si determina essa stessa come nulla che nega se stesso contraddittoriamente. Il divenire costituendosi attraverso la negazione immediata, allo stesso modo attraverso questa negazione immediata si determina come nulla, in forza della sua contraddizione annichilente. Se il divenire che insorge e sparisce si autosopprime, la sua determinazione, la sua destinazione, è quella di lasciar dischiudere l’esserci, il qualcosa che non è altro. Nel divenire c’è qualcosa che diviene. Ed il qualcosa che diviene, insorgendo e sparendo, non si annichila ma si altera. Provenienza e destinazione del divenire non sono più il nulla del moto insorgente e dissolvente, ma il qualcosa ed il qualcos’altro della mutazione.
A quale condizione si può fare del nulla, dell’indeterminato, un qualcosa, un determinato ? Non immediatamente per la relazione tra essere e nulla come si costituisce nel divenire nel senso del flusso (Fluss) fluente del movimento. Tanto è visibile la fluidità del movimento, quanto la contraddizione è invisibile. Solo a condizione che la relazione immediata del divenire possa venir rapportata a se stessa, possa rapportarsi a se stessa, si rivela la contraddizione dell’immediatezza. Allora la negazione immediata si rovescia in negazione determinata. E nella sua autorelazione la fluidità del movimento diventa il mutamento di qualcosa. Il Nulla è nulla, quindi sparisce esso stesso, solo se può esser riferito a se stesso da qualcosa d’altro che non è nulla ma che tuttavia vi si include (il qualcosa che diviene) includendolo (il divenire di qualcosa).
2.
Si è visto come la categoria del divenire contenga un rapporto differenziale immediato e indeterminato, quello che astrattamente viene fissato dalla contraddizione tra essere e nulla.
Se tale relazione è contraddittoria, allora impedisce lo stesso rapporto e la stessa differenza, la stessa relazione tra i due termini. Così la relazione differenziale tra essere e nulla, assume il carattere negativo della contraddizione (Widerspruch). Tuttavia per Hegel la stessa impossibilità contraddittoria di una relazione tra essere e niente, se pensata in rapporto a se stessa, cancella l’astratta fissazione dell’essere e del nulla come opposti e diversi. Quindi la contraddizione tra essere e nulla, nel suo risultato nullificante, come appare solo ad un divenire capace di autorelazione, in Hegel, non ostacola e rende impossibile il divenire, quanto piuttosto consente che accada qualcosa come un “transito/passaggio/oltrepassamento” (Übergang), un “movimento”(Bewegung).
Nel divenire, insorgenza e sparizione rendono possibile come un “attraversamento” del nulla, l’apertura di un “valico” verso il qualcosa e l’altro. La differenza, ad un tempo astratta, immediata e indeterminata, di essere e nulla, che risulta contraddittoria e quindi irresolubile e incomprensibile[ref]dieser Widerspruch, den man selbst setzt und dessen Auflösung unmöglich macht, heißt das Unbegreifliche. Per il testo tedesco: Wissenschaft der Logik, Erster Teil, G.W.F. Hegel (EBook #6729), The Project Gutenberg, Posting Date: November 9, 2012, Release Date: October, 2004 First Posted: January 20, 2003; Epub con immagini scaricabile qui: http://www.gutenberg.org/ebooks/6834 , p.156-167.[/ref], è da Hegel pensata, proprio nel rispetto delle regole logiche (logische Regeln), nell’unità antinomica del risolversi reciproco dei termini contraddittori, unità in cui i diversi precipitano nello “stesso” (selbst) e vanno pensati in quel punto della loro coincidenza in cui la loro differenza indifferenziandosi, si annulla e sparisce[ref]ein Punkt enthalten, worin Seyn und Nichts zusammentreffen, und ihre Unterschiedenheit verschwindet. Ibidem p. 117-118.[/ref]. La contraddizione distrugge i termini contraddittori, e distruggendo i termini annulla l’impossibilità stessa del loro rapportarsi reciproco. In forza della stessa contraddizione astratta l’immediato si determina come indeterminato e indifferenziato. Così l’immediatezza trova nell’astrazione il modo di rapportarsi alla propria indeterminatezza.
3.
In rapporto a tale duplicità del negativo contraddittorio, da una parte indifferenziante e indeterminante, dall’altro determinato e determinante, il divenire mostra il suo doppio volto, da un lato mutamento metamorfico e dall’altro moto insurrezionale. Nella consapevolezza della natura del divenire, lo stare in relazione al cambiamento, al volto progressivo del divenire, non può prescindere dallo stare in rapporto al lavoro catastrofico della distruzione. Questo sarebbe il doppio statuto che la negatività insita nella categoria del divenire viene ad assumere nella teoresi hegeliana. Hegel sempre sottolinea il momento essenziale, per la logica e il sapere, della contraddizione come negazione determinata, e quindi relativa ai termini che nullifica. Eppure la contraddizione è e rimane, basicamente, negazione immediata e astratta.
4.
Prima di svolgere ulteriormente la macchina della negazione nel suo doppio statuto di annientamento e autodeterminazione, all’interno della categoria del divenire, si vuole indicare il campo concettuale vasto e trasversale che una lettura delle nozioni di “immediatezza” e “astrazione” può far emergere in relazione ad una complessiva interpretazione della filosofia hegeliana.
5.
“Astratto”. Come dire il separato, l’isolato, l’estratto da un contesto e posto nella sua unilateralità in qualche modo prodotta e tenuta ferma, fissata nel risultato di un processo. Dunque “astratto” è termine di una elaborazione che è stata resa possibile da un movimento di separazione, di astrazione. L’astratto collocato nel suo contesto di astrazione, non sarebbe più tale, mentre laddove quel contesto sia stato dimenticato, sia precipitato nell’oblio, allora l’astratto manterrebbe di diritto questa sua denominazione che lo significa come separato dal processo stesso di separazione, che pure ha agito da forza propulsiva e insorgente per produrlo. L’astratto, l’intero mondo delle categorie intellettuali che nella logica egheliana vengono esaminate, si presenta come tale a motivo di una sorta di assenza di memoria, di un’incapacità di ricordare, che affetta la consapevolezza intellettuale, riducendone la dimensione cognitiva, che non saprebbe ricondurre le categorie al processo della loro insorgenza nel divenire.
5.
Aver coscienza dell’astrazione, (Abstraktion), si può solo dove sia altrettanto forte la memoria (Erinnerung). Che rapporto intrattengono la Scienza e la Logica con l’astrazione? Astrarre è una risorsa del soggetto, come lo sono sia la Scienza sia la Logica. Il soggetto, al di là di una sua decodifica meramente antropologica o psicologica, costituisce la sfera del proprio sulla base del potere che irradiando da un centro mantiene attiva la sfera di appropriazione, in equilibrio vantaggiosamente asimmetrico o unilaterale con l’esteriorità, con l’ alterità, e più radicalmente con la propria distruzione. Ora l’astrazione è un potere che esercita una vera attività, secondo il dettato hegeliano: il potere (Können) dell’astrazione sarebbe inteso come “attività del niente”[ref]das Thun des Nichts. Ibidem p. 149.[/ref], come “l’unilaterale attività del negativo”[ref]das einseitige Thun des Negativen. Ibidem p. 149.[/ref]. Tale potere viene specificato da Hegel come capacità di ridurre all’indifferente (gleichgültig), che qualcosa sia o non sia, che l’essere o il nulla stessi sparisca (verschwindet) o sorga, (entsteht). Abbiamo dunque, in questa asserzione hegeliana, l’attestazione di quell’impostazione secondo cui astrarre e cioè rimaner indifferenti all’essere o al non essere, e quindi potere e sapere agire in modo da annullare l’essere e dare un essere al niente, sarebbero prerogative del costituirsi di un centro di potenza, o ancora prerogative e tratti dell’attiva soggettiva autocostituente. Agire per negare l’essere e per negate lo stesso nulla dell’essere, sarebbero condizione di possibilità di una capacità (Vermögen) autopoietica. Il soggetto, cioè ogni centro di potere e di attività assoggettanti, dominanti e unilaterali, si affermerebbe in base a processi di astrazione progressiva dal contesto dinamico del suo divenire, in cui sconterebbe il nulla immediato del proprio essere insorgente e finito. Proprio agendo negativamente non solo sull’essere ma anche e soprattutto sul nulla dell’essere, il soggetto si edificherebbe come centro di riferimento di ulteriori relazioni e dinamiche possibili. Le categorie logiche astratte, in quanto risultato del processo di elaborazione esperienziale autocentrata e autoriferita, sarebbero le forme del agire soggettivante, insieme documento e strumento di autoaffermazione, quindi di lavoro. Ogni ordinamento formale logico astratto, sia esso finito, empirico o speculativamente assoluto, avrebbe a che fare con l’esercizio di un agire negativo autoreferenziale, di un agire negante che nega l’immediata nullità del proprio essere. Dunque questo lavoro di soggettivizzazione si caratterizzerebbe nel suo fondamento come capacità riflessiva di rapportarsi negativamente alla negazione immediata che si è, in modo che grazie a questo agire riflessivo ci si possa insediare in quel punto d’indifferenza in cui il nulla si rovescia in positiva affermazione di qualcos’altro. Questa impostazione hegeliana è stata sottolineata ripetutamente dagli interpreti. Ciò che qui si vorrebbe intravedere e si cercherebbe di ribadire è che in tale autorapporto soggettivante, la negazione determinata e relazionale si rapporta sempre ad una negazione più basica e immediata, ad una cancellazione. Essere soggetti è poter astrarre, ossia agire il negativo, rapportarsi alla propria cancellazione, negandola. Esser soggetto di sé stessi: negare il proprio nulla.
6.
L’ “immediato”, come l’astratto, è l’isolato. Esso è l’irrelato, ciò che ancora non è preso in un rapporto determinante e unilaterale, e quindi non è collegato, connesso, dipendente o condizionato, complementare ad altro. L’immediato è ciò che ancora non funge da medio, che quindi non media, ed in cui non si media, che non elabora e non lavora, ed in cui non si elabora e non si lavora, che non documenta in alcun modo una capacità ed un potere soggettivanti. L’Immediato, lasciato in tale abbandono o anche pensato e oltrepassato in tale bando, è la pura indifferenza dell’essere dal nulla, il radicale annichilimento dell’essere nel nulla, l’equivalenza dell’insorgere e dello sparire nell’essere senza provenienza e senza destino.
7.
L’astratto domina l’immediato determinandolo. Si eccepisce in esso, vi si include escludendolo, si appropria, facendosi espropriare da esso. Lo pensa come contraddizione nuda e viva ma già risolta ed oltrepassata, lo presuppone come negazione che deve essere negata, negazione da destinare al suo nulla proprio e determinato. L’astrazione deve presupporre l’immediato come quel negativo in cui il suo agire negante è incluso e circoscritto, pur eccependosi ed escludendosene. L’immediato è catturato dall’astratto e quindi usato, messo al lavoro, rivolto a proprio unilaterale vantaggio. L’astratto è appunto il risultato di un processo e di una dinamica autoaffermativa e autorelazionale, di un lavoro, che presuppone il nulla radicale del proprio essere come qualcosa da negare proprio riconoscendovisi. Così la potenza dell’astrazione è potenza del ricordo che mentre vince l’oblio consegna all’oblio. L’immediatezza di ciò che fu, permutata in astratto ricordo, nega quel nulla a cui consegna l’esser stato di ciò che è trascorso, e che altera in qualcosa d’altro, di positivo in quanto attivamente posto e elaborato. Il ricordo è il mettersi in rapporto ad una cancellazione mediante qualcosa d’altro che il nulla immemorabile.
8.
Nell’analisi della categoria del divenire Hegel presuppone nell’astratto (l’essere ed il non essere) in forza della stessa potenza negativa di cui è espressione (l’essere non è il non essere e il non essere non è l’essere) che conduce sino alla contraddizione (l’essere è il non essere sono lo stesso), un certo fondo basico primordinale, anzi primordiale (il nulla di essere e non essere nel divenire).
Nella categoria astratta e contraddittoria del divenire, Hegel allora cattura quell’immediatezza violenta dell’accadere, senza cui non vi sarebbe alcuna possibilità di agire poi in modo negativo. L’astrazione che permette di afferrare la struttura contraddittoria dell’immediatezza (giacché è solo per gli astratti essere e nulla che si dà nel divenire la loro unità contraddittoria), presuppone l’immediatezza di un divenire, senza provenienza e senza destinazione, che nega radicalmente l’essere, (giacché è solo perché il nulla è, irreparabilmente, nulla, nulla dell’essere e del niente, che qualcosa d’altro può costituirsi).
Tentando di ricapitolare quanto esplorato sino ad ora, si vorrebbe ribadire come nell’analisi del divenire Hegel decida di rinvenire, tramite l’astratto ricordo della struttura originariamente contraddittoria dell’immediatezza, il presupposto dell’esercizio di ogni appropriazione e dominio temporale, storico o logico.
9.
Astratto e immediato non sono solo lemmi coordinati. Sono l’uno condizione dell’altro.
Se il potere dell’astrazione si misura nella capacità di insediarsi nel punto indifferente, (gleichgültig) tra essere e nulla, allora l’immediato è quel “transito” (Übergang) reciproco del nulla nell’essere (insorgenza) e dell’essere nel nulla (sparizione), in cui si presuppone accadere quella potenza dell’indifferenza. E’ l’indifferenza di tale “transito” ad essere condizione del potere dell’astrazione, e quindi persino apertura di un processo di avanzamento, e progresso. Il poter lasciare il nulla al suo nulla per qualcos’altro. Ora il transito nella sua dimensione strutturale originaria d’insorgenza e sparizione, è da Hegel inteso come violenza d’eruzione e d’irruzione. Il transito è tale in quanto in esso accade qualcosa che erompe (bricht hervor)[ref]Ibidem p.147[/ref] l’immediato ovvero l’immediato è tale in quanto sbarramento sempre rotto, spezzato, frantumato, spaccato, per una “fuoriuscita”[ref]L’ Ausgang kantiano di Che cosa è l’Illuminismo, ma anche la ripartenza dall’Esserci, del capitolo secondo della Logica di Hegel.[/ref]. E’ perché si da un’eruzione che spezza un velo sbarrato, che l’immediato si fa mezzo, strumento di mediazione. Per pensare l’ irr/eru-zione dobbiamo ritornare ancora ai due possibili sensi della negazione cui abbiamo già più volte fatto riferimento sopra. Da una parte c’è la negazione determinata, la negazione sempre relativa e specifica di un certo qualcosa, che prende la forma della contrapposizione e quindi del riferimento o della relazione[ref]Form der Entgegensetzung, zugleich der Beziehung. Ibidem p. 116.[/ref]. Essa separa e distingue, tiene insieme i differenti relati, tenendoli a distanza di sicurezza e garantendoli l’uno dall’altro. E come Hegel non si stanca di ripetere la Scienza e la Logica devono costantemente affinare lo sguardo rammemorante per saper cucire e connettere i pezzi dell’essente, ritrovandovi il filo del logos mediatore che li tiene insieme determinandoli reciprocamente nella loro distinzione, a preservarli dall’annullamento. Ma ciò presuppone proprio il più radicale e tragico confliggere annichilente ! Il mezzo della mediazione è proprio il nulla che si annienta ! E’ nel nulla che l’essere di questo e quello e il loro stesso niente, già da sempre e inizialmente, precipitano e spariscono, ed è sempre nello stesso nulla che insorge ed erompe, irrompe, un methodos , il varco di un passaggio. Nella via del nulla, senza provenienza e senza destinazione, sono disposti quel qualcosa che c’era, quel qualcosa da cui si proviene insieme a quell’altro qualcosa che è appena arrivato ed a cui si è destinati come al risultato del processo. Ecco che appunto quel non essere relativo che consente il lavoro del discernimento sapiente dell’essente non sarebbe esso stesso aperto e manifesto se non fosse riconosciuto quel niente irrelativo della sparizione nella più radicale latenza, quel niente dell’insorgenza dall’occultamento radicale, quel nulla della dissoluzione, dell’annientamento o del più duro svuotamento. Per questo Hegel sottolinea che proprio a proposito della negazione non si deve dimenticare (non deve di essa darsi oblio, e quindi deve di essa proprio darsi rammemorazione) che vi è la negazione astratta e immediata[ref]die abstrakte, unmittelbare Negation. Ibidem p. 116.[/ref] : l’irrelativa “denegazione” (die beziehungslose Verneinung), espressa dal mero “non” isolato[ref]durch das bloße: Nicht ausdrücken. Ibidem p. 116.[/ref], il puro nulla in cui l’essere sparisce e da cui l’essere insorge, in cui irrompe e da cui erompe. Il nulla che sta tra un essente e l’altro e che sta dentro l’essere stesso, a romperne la compatta chiusura; quel nulla che segna la struttura aperta dell’essere stesso, la sua esposizione all’annientamento, la sua esposizione all’insorgenza e alla più radicale latenza. Questo “non” è posto e determinato come esito nullificante della contraddizione dall’astrazione ed insieme catturato come immediatezza iniziale del divenire: la contraddizione che dissolve l’astratto irrelato intellettualistico è infatti cifra di quel nulla in cui si spaziano i pezzi dell’immediato esposto al movimento del divenire.
10.
Hegel ha sempre e ripetutamente considerato la negazione determinata superiore alla negazione immediata. Hegel dice che fuori dal divenire del qualcosa in qualcos’altro, essere e nulla sono significati astratti[ref]abstrakt Bedeutung. Ibidem p.164.[/ref]. Il nulla (das Nichts), come è contenuto nel concetto del divenire, dovrebbe essere inteso piuttosto come il non-essente, (das Nichtseyn). Ossia sarebbe il non-essere altro contrapposto (Entgegengesetzt) e relativo dell’essere-qualcosa (Etwas), nella cui alterità è ancora contenuto e conservato il riferimento all’essere[ref]Beziehung auf das Seyn. Ibidem p.116[/ref]. Nella categoria del divenire il senso dell’essere dell’essente non precipiterebbe e sparirebbe nel nulla ma si trasformerebbe in qualche altro essente. Proprio per la sua capacità di contenere nell’astrazione l’immediatezza ricontestualizzandola e rielaborandola nel suo senso d’essere relativo all’essente, il divenire eracliteo è considerato da Hegel un concetto superiore[ref]den höheren totalen Begriff. Ibidem p.116.[/ref] rispetto all’astrazione indeterminata dell’essere parmenideo e del nulla orientale. E tuttavia quella stessa capacità superiore di mediazione concettuale che la categoria del divenire secondo Hegel esibisce non sarebbe possibile se non fosse stata fissata astrattamente quella nullificazione del senso dell’essere differente dal niente che costituisce la determinazione dell’immediatezza. Il divenire stesso nel seguito delle deduzioni categoriali viene come messo al lavoro nel processo che assoggetta l’immediatezza al dominio evolutivo o progressivo dell’essente. Ecco così che nel divenire viene pensata la produzione stessa dell’altro[ref]Hervorbringen eines Anderen. Ibidem p.119.[/ref], la generazione[ref]die Erzeugung. Ibidem p.140.[/ref], la nascita[ref]Geburt. Ibidem p.117.[/ref]. Questa concettualizzazione del divenire come produzione-generazione prelude alla possibile istituzione di un rapporto di fondazione, di causazione, comunque di ragione. Con tale interpretazione si istituisce la continuità graduale e determinata del filo logico di un metodo, come percorso, e di un discorso, come narrazione e dimostrazione tra gli essenti e da un essente all’altro. Risulta così pensabile un rapporto determinabile tra essenti reciprocamente negativi e determinati, come sono Padre e Figlio, Causa ed effetto, Condizione e Condizionato. Se questo è l’impianto logico che deve mettere al lavoro il divenire, non bisogna dimenticare (anche se è proprio questo ciò che il ricordo non può rammemorare !) che esso cattura un basico <<passare oltre>> immediato, insorgente e dirompente: il divenire è lo stesso <<passare>>, Übergehen ist dasselbe als Werden[ref]Ibidem p. 135.[/ref].
11.
In Hegel il pensiero astratto del divenire cattura un’immediatezza primordiale. Così l’astrazione della contraddizione fa segno all’evento dello sparire[ref]Verschwinden. Ibidem p.114.[/ref], del dileguare, o del distruggersi[ref]zerstören sich. Ibidem p.160.[/ref]; l’evento della fine[ref]Vergehens. Ibidem p. 117[/ref] , della morte[ref]Tod. Ibidem p. 117[/ref]. Il nulla che rende possibile il divenire lascia che nella determinazione negativa si produca differenza come relazione e fondazione. Questo è il lato logicamente costruttivo e mediatore della negazione insita nel divenire. Si tratta qui di quel divenire che è metamorfosi, che rimanda dal qualcosa al qualcos’altro, che segnala sempre una provenienza ed una destinazione. Ma questo divenire come progresso ed avanzamento, processo e discorso, è reso possibile solo perché presuppone un divenire che è passaggio immemorabile, sparizione e distruzione, dissoluzione della differenza, indifferenziazione contraddittoria tra essere e non essere. Il mutamento, (Veränderung ) presuppone il moto (Bewegung). Il divenire stesso è presupposto come evento appropriabile, nell’agire unilaterale del nulla, che negandolo lascia spazio a qualcos’altro. Lo stesso qualcosa apre all’altro, solo sparendo nel nulla, passando via e lasciandosi passare oltre, lasciando aperto un transito. Così in Hegel il divenuto, o il risultato ha il carattere del non-essente (Nichtseyende) come altro essente, o altrimenti essente, essente determinato, ideale (Ideelle), sul presupposto, sul fondamento, di un esser soppresso, rimosso, rilevato (Aufgehobenes), che occorre pensare nella sua radicalità nichilistica di essere sparito (das Verschwundenseyn). Così il divenire egheliano non potrebbe produrre il divenuto senza l’azione unilaterale del nulla che fa sparire l’essere dell’essente sparito. Se l’immediato non precipitasse costantemente nel nulla, se l’essere non sparisse cancellato negli essenti diversi, non vi sarebbe apertura all’insorgenza.
Il fondamento basico (Grundlage), il campo fondamentale, del potere di astrazione, quindi ciò a cui ci si deve rapportare nell’astrazione e ciò che l’astrazione stessa è e produce nel suo rapportarsi, è quel moto in cui accade il far spazio per l’essente, come agire unilaterale del nulla.
12.
Il risultato che qui come tesi si vorrebbe enunciare sarebbe dunque formulabile nella seguente asserzione: la macchina della negazione della negazione, dell’autoderminazione del negativo, è la potenza di un autorapporto che metta in relazione il cancellabile con la propria cancellazione definitiva e radicale.
Senza presupporre l’annientamento, la distruzione, cioè senza che si pensi dell’essere nulla, radicalmente niente di ciò che diviene, non si pensa l’esserci. Il passaggio nullificante, l’annientamento immediato, sta poi alla “base” del lavoro logico di relazione e riferimento mediatore che produce tutte le altre categorie intellettuali successive a quella dell’esserci. Questo annientamento autocontraddittorio di essere e nulla nel divenire è indicato da Hegel come “la prima verità fondamentale”[ref]erste Wahrheit ein für allemal zu Grunde liegt. Ibidem p.119[/ref] . Solo in rapporto all’autonegazione contraddittoria nel divenire dell’essere e del nulla si guadagna “l’Elemento in cui sono pensabili tutte le conseguenti determinazioni della logica”[ref]das Element von allem Folgenden…alle ferneren logischen Bestimmungen. Ibidem p.119[/ref]. Questo autoannullarsi della contraddizione è la verità immediata che si trova sempre innanzi a noi[ref]die allenthalben vor uns ist. Ibidem p. 120[/ref], e che ha persino una dimensione di manifestazione ed evidenza empiriche, quella del <<passare>> empirico che s’intende di per sé[ref]das empirische Übergehen versteht sich ohnehin von selbst. Ibidem p.145[/ref]. Nel “movimento” si vede, appare, si rivela come la contraddizione si risolva. Il risolversi della contraddizione è lo stesso venire a manifestazione del qualcos’altro.
La categoria del divenire è la prima delle forme categoriali e intellettuali in cui questo annientamento viene pensato, e nell’essere pensato viene catturato e afferrato come risorsa per il cambiamento possibile. Quindi il divenire non è il terzo tra essere e nulla, la medesimezza di essere e nulla, come se fosse la loro sintesi coordinante. E il terzo come la loro contraddizione distruttiva.
13.
La rammemorazione della negazione radicale dell’essere sparito, annientato, è per Hegel aprente. Anzi è l’aperto; caratteristica del nichilismo logico di Hegel sarebbe proprio questa intepretazione dell’annichilimento, della kenosis teologica e della catarsis tragica, come apertura dell’essere all’essente e per l’essente. Nell’annullarsi del nulla, l’essere si apre all’avvento dell’essente, alla sua irruzione e insorgenza “nuova”, alla sua rivelazione piena, alla sua manifestazione compiuta. La rammemorazione dell’annientamento sarebbe aprente e aperta perché nulla più ostacolerebbe o chiuderebbe, sbarrerebbe. l’insorgenza dell’essente, neppure il nulla del suo stesso esser sparito come essere, il nulla della radicale latenza dell’essere. L’essere ora determinato tragicamente è per qualcosa d’altro.
Nell’esser sparito della sua sparizione è l’impotenza suprema del nulla, la sua ineffettualità, perché la sparizione sparisce essa stessa, la liquidazione si liquida[ref]das Verschwinden des Werdens, oder Verschwinden des Verschwindens selbst. Ibidem p. 160[/ref]. La sfrenata inquietudine negativa del divenire che si affatica nella propria mobilità a liquidare l’immediato, la sua forza immediatamente annientante, finisce mentre lavora, risolve mentre si muove, sparisce essa stessa, sprofondando nella pace, consumandosi nella quiete, nel silenzio, in un oblio[ref]Das Werden ist eine haltungslose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensinkt. Ibidem p.160[/ref], immemorabile.
Che sia accaduto il divenire, che sia stato il nulla dell’essere e l’essere del nulla, ciò è l’immemorabile, che ancora è solo per il ricordo di qualcosa d’altro e di qualcun altro.
Il lavoro umano, il dominio e il potere di qualsiasi soggetto che ci sia come Esserci, Dasein (questo è termine hegeliano prima di essere heideggeriano), che faccia i conti col proprio mutamento possibile, con la mutabilità del proprio esistere, sta in rapporto memoriale e immemoriale, e quindi storico, ontologico ed esistenziale, con la struttura duplice del proprio divenire, così come la definisce Hegel. Ossia con il duplice volto del divenire come annientamento del senso dell’essere, fluidificazione impotente a cancellare quell’essente qui e ora che ricorda ma anche incapace nella trasformazione del ricordo a restituire al senso dell’essere immediato ciò che degli essenti è morto e finito, definitivamente sparito.
L’analisi hegeliana sonda la difficile e avvitata determinazione di tale rapporto memoriale e immemoriale col divenire, pensando insieme con l’annientamento dell’essere la sua insorgenza. Così nella macchina metafisica di Hegel l’annichilimento radicale del senso dell’essere, la cesura iniziale dal suo evento, l’irrevocabilità della cancellazione dell’essere, rimane complementare, logicamente vincolata e presupponente, rispetto ad una altrettanto radicale e decisa insorgenza storico-esistenziale. Il “nuovo” è tale proprio perché non potendo riscattare dalla radicale latenza ciò che è sparito, e dovendo confermare quel destino di fine e di morte che spetta ad ogni immediatezza, si appropria di una provenienza e di una destinazione storiche.
_________________________
Pubblicato in collaborazione con Critica Impura
https://criticaimpura.wordpress.com/