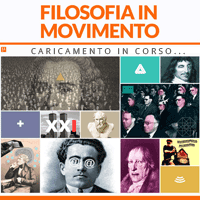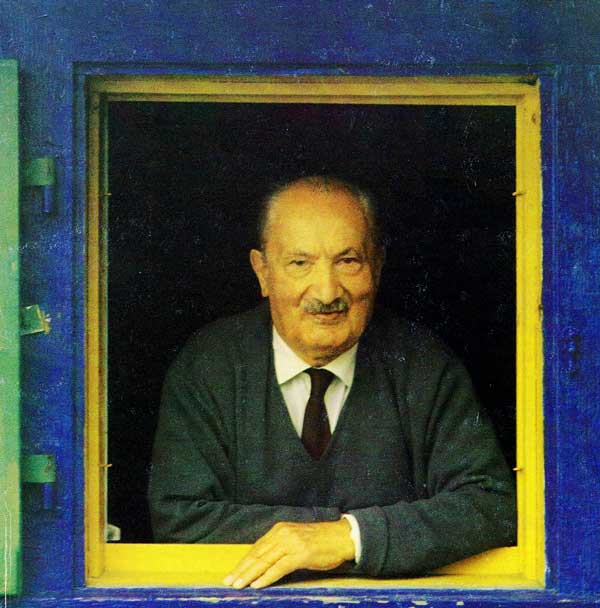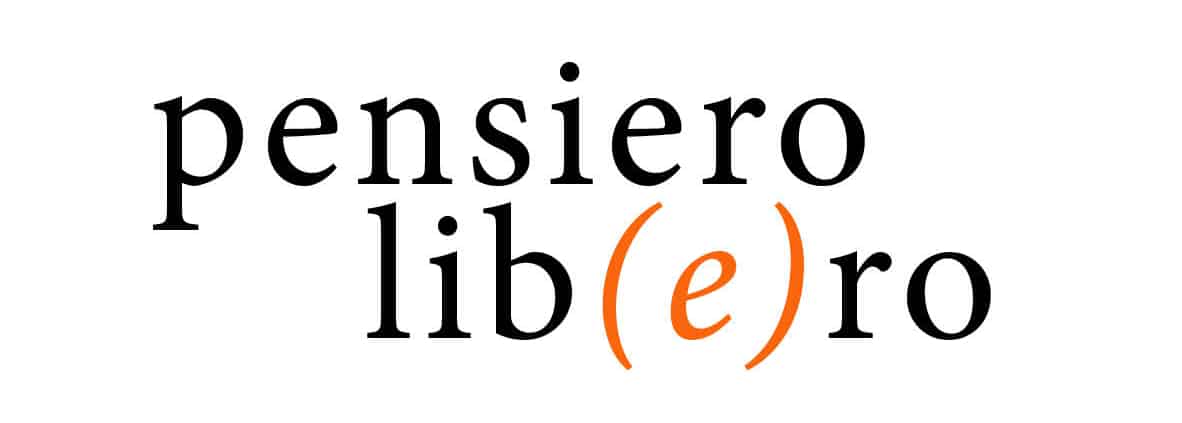Politica e Ontologia. Heidegger e il corso del semestre estivo del’34
La V uscita di Pagine Heideggeriane ospita un paper di Mattia Tritarelli, dottorando dell’Università degli Studi di Perugia. Lo scopo dello scritto qui pubblicato è quello di portare alla luce i nessi tematici che legano la questione politica all’ontologia di Heidegger nel contesto del corso del semestre estivo del 1934, cioè verificare se effettivamente Heidegger sia arrivato a mutuare la propria nozione di “politico” direttamente dall’ideologia del partito nazionalsocialista. Per poter raggiungere lo scopo indicato, l’autore si confronta con quanti hanno sostenuto una simile posizione, in particolar modo Emmanuel Faye, cercando di individuare la coerenza di un siffatto procedere teoretico con l’impostazione heideggeriana, e quelle forzature che sono estranee al pensiero del filosofo tedesco, nel tentativo di riportare la categoria del “politico” alla sua corretta relazione con l’ontologia.
Francesca Brencio
Politica ed ontologia.
Heidegger e il corso del semestre estivo del’34
di
Mattia Tritarelli
I. Introduzione
La questione della compromissione di Martin Heidegger con il regime nazista non si è mai estinta sin dalla sua sollevazione: dall’allontanamento dall’insegnamento del dopoguerra, passando per la pubblicazione dell’intervista postuma, fino agli studi di Victor Farias e Hugo Ott con le relative repliche, per arrivare alla pubblicazione odierna dei cosiddetti “quaderni neri”[ref] La recente pubblicazione dei quattro volumi che compongono i “quaderni neri”, annotazioni e appunti lasciati da Heidegger ad una pubblicazione postuma, ha coagulato il recente dibattito internazionale su Heidegger, rinvigorendo la questione del suo presunto antisemitismo. Tra i numerosi studi che stanno fiorendo a riguardo segnaliamo: P. TRAWNY, Heidegger und der Mythos des jüdischen Weltverschwörung, Klostermann, Frankfurt a. M. 2014; D. DI CESARE, Heidegger e gli ebrei. I Quaderni neri, Bollati-Boringhieri, Torino 2014; A. FABRIS (a cura di), Metafisica e antisemitismo. I «Quaderni neri» di Heidegger tra filosofia e politica, ETS, Pisa 2014; F. BRENCIO (a cura di), La pietà del pensiero. Heidegger e i Quaderni Neri, Aguaplano – Officina del Libro, Passignano s. T. 2015[/ref]. In estrema sintesi si è avuto modo di vedere lo schierarsi di due fazioni opposte: inquisitori ed apologeti. I primi hanno creduto d’individuare un’inammissibile concussione nazionalsocialista del filosofo tedesco, adducendone il carattere ‘mistico’ e ‘totalitario’; mentre i secondi hanno tentato in tutti i modi di rivalutare la sua responsabilità politica. Il presente articolo intende rimanere fuori da questo schema bipartito, che troppo spesso finisce per riempire pagine di giornali e scema nella cronaca. Non verrà affrontata neppure la questione dei “quaderni neri”, dato che nostra convinzione è che una valutazione dei contenuti di quelle annotazioni non possa esimersi da un serio confronto preliminare con la filosofia che ne è a fondamento, nonché con la sua conseguente opzione politica.
Ciò che ci proponiamo nel presente articolo è di verificare se le categorie politiche messe in campo da Heidegger scaturiscano da un’adesione all’ideologia di partito, o in alternativa, se la loro genesi sia da rintracciare nel centro pulsante della sua stessa filosofia.
La separazione dell’opera dalla biografia del filosofo di Meßkirch ha prodotto conseguenze deleterie – paragonabili alla vulgata storiografica dell’esistenzialismo del cosiddetto primo Heidegger –, che sono andate ad unirsi all’idea di svolta [Kehre] come cesura epocale della sua biografia. Con il graduale emergere delle fonti relative all’impegno del ’33, si è avuto buon gioco nell’accostarle al fantomatico esistenzialismo di Essere e tempo, denunciando l’instabilità morale e politica del filosofo, il suo pensiero inconsistente ed inefficace, fino all’ipotesi di una sua conversione ideologica [ref] Le posizioni sono state rispettivamente sostenute da Karl Löwith e Jürgen Habermas. Se per l’allievo di Heidegger «egli è nazionalsocialista già per quel radicalismo col quale fonda la libertà dell’esistenza propria di ciascuno, ovvero esistenza tedesca, sullo stato di rivelazione del nulla» (K.LÖWITH, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, tr. it. di E.Grillo, il Saggiatore, Milano 1995, p.66); per Habermas «a partire dal 1929, comincia una trasformazione della teoria in ideologia» (J.HABERMAS, Il filosofo e il nazista, tr. it. di P.Amari, in Micromega 1988 n.3, p. 103). [/ref]. A queste posizioni si sono aggiunti gli studi, il primo fazioso ed acritico di Victor Farias, il secondo ponderato e filologicamente rigoroso di Hugo Ott, che hanno arricchito la mole di fatti e aneddoti intorno Heidegger[ref]Mentre Farias afferma drasticamente che «Martin Heidegger optò per la linea rappresentata da Ernst Röhm e dalle sue SA, cercando di dare con il proprio pensiero una struttura filosofica a tale variante del nazionalsocialismo» (V.FARIAS, Heidegger e il nazismo, tr. P.Amari, Bollati Boringhieri, Torino 1988, p.5); Ott lascia aperto uno spiraglio per una autonomia del filosofo tedesco, affermando che «Heidegger sovrappone a quello reale il proprio concetto di nazionalsocialismo, che non aveva nulla a che vedere con l’effettiva prospettiva del nazionalsocialismo» (H. OTT, Martin Heidegger: sentieri biografici, tr. it. di F. Cassinari, Sugarco Edizioni, Milano 1988, p.187) [/ref]. A sollevarlo da questi imbarazzi sono state invocate dapprima la sua inettitudine politica, infine la necessaria separazione tra filosofia e scelta politica[ref]Paradigmatica a questo riguardo la biografia di Rüdiger Safranski, secondo cui per il pensatore tedesco si consumerebbe una tragica rottura con la realtà: «Vediamo dunque uno Heidegger tutto preso nel suo sogno di una storia dell’essere; le sue mosse sul palcoscenico della politica sono quelle di un filosofo sognatore» (R.SAFRANSKI, Heidegger e il suo tempo, tri. it. di N.Curcio, Tea, Milano 2001, p.286) [/ref].
Tra gli studi recenti sulla vexata quaestio sul rapporto tra Heidegger e il nazismo merita una menzione il discusso libro di Emmanuel Faye “Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia”[ref]E. FAYE, Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia, a cura di L. Profeti, L’asino d’oro, Roma 2012[/ref]. Esso sembrerebbe rintracciare un nuovo capo d’accusa. La tesi principale del volume appare risolutoria quanto estrema:
l’unico “contributo” heideggeriano alla filosofia consiste nell’aver dedicato tutte le sue forze, in molte maniere, a introdurvi i principi stessi del nazismo celandosi dietro termini come “verità” ed “essere”, che in lui sono filosofici solo in apparenza[ref]Ivi, p.394[/ref]
La posizione è chiara e monolitica: lo studio di Faye dei seminari e dei corsi heideggeriani tenuti tra il ’33 ed il ’35 – a cui rimanda il titolo originale dell’opera francese – non farebbe che confermare, se non radicalizzare, il credo nazista del filosofo di Meßkirch. Le analisi condotte nel testo hanno un intento ben più radicale di una mera ricognizione biografica:
È per questo che, attraverso i testi portati alla luce e le dimostrazioni proposte, abbiamo voluto mostrare la realtà dell’impresa alla quale egli si è dedicato, cioè l’introduzione, nella filosofia, del contenuto stesso del nazismo e dell’hitlerismo. [ref]Ivi, p.1[/ref]
L’intento del presente articolo è di verificare se effettivamente Heidegger sia arrivato a mutuare la propria nozione di politico direttamente dall’ideologia del partito, oppure, se in alternativa, possano finalmente essere delegittimate posizioni radicali come quella assunta dall’autore francese. Ciò che è necessario far notare sin da subito, infatti, è come nel testo di Faye non sia neanche prospettata una possibile autonomia politica del filosofo tedesco. Complotto, revisionismo e negazionismo, teoria razziale, se non distruzione ed inebetimento filosofico sarebbero le istanze inoculate nel pensiero occidentale da Martin Heidegger.
Qual è il metodo d’indagine adottato dal testo di Faye per argomentare queste accuse così gravi? Attraverso una massiccia raccolta di autori nazisti, le cui citazioni costituiscono una parte cospicua del testo, l’autore passa, per via di più sostituzioni, a leggere i testi heideggeriani per lasciarne emergere affinità, coincidenze e sovrapposizioni terminologiche e contenutistiche. La lettura del contesto socio-politico finisce così per imporsi ad ogni autonomia intratestuale dei documenti d’archivio[ref]Un recentissimo contributo di Thomas Sheehan ha posto l’accento sulle molteplici forzature ed argomentazioni tendenziose su cui sarebbe basato il testo di Faye, cfr. M.SHEEHAN, Emmanuel Faye: the introduction of fraud into philosophy?, in http://enowning.blogspot.de/2015/04/thomas-sheehan-on-faye-and-fraud.html. L’articolo, che è stato occasionato da un diverbio tra i due studiosi, passa in rassegna i ragionamenti forzati e le imprecisioni usati nel lavoro di Faye per argomentare la sua tesi di fondo. Giudicando il testo dell’autore francese ricco di approssimazioni, Sheehan, attraverso una lettura ampiamente documentata, denuncia: in primo luogo, l’inconsistenza del preteso antisemitismo di Essere e tempo, che sarebbe basato su di un’argomentazione costruita su dei passaggi sconnessi; in secondo luogo, le traduzioni rimaneggiate e una riscrittura delle citazioni heideggeriane. Accuse gravissime a cui Faye ha tentato di difendersi inutilmente con una lettera aperta indirizzata contro il professore di Stanford. Per un quadro della discussione tra i due autori, attualmente ancora in corso, si veda M.SHEEHAN, Emmanuel Faye: the introduction of fraud into philosophy?, cit., ∫1-2.[/ref].Raccogliamo brevemente il lessico heideggeriano di base. Secondo Faye Heidegger effettuerebbe un recupero della nozione di comunità razziale da Ludwig Ferdinand Clauß: «Della comunità di popolo come di una comunità di razza»[ref]E. FAYE, Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia, cit., p.33. A questo proposito Sheehan mostra come Faye faccia coincidere il significato della parola Umwelt – usata da Heidegger in Essere e tempo e da Clauß nell’Anima nordica -, esclusivamente accostando i testi ed attuando delle deduzioni assolutamente improprie, cf. M.SHEEHAN, Emmanuel Faye: the introduction of fraud into philosophy?, p.11-13.[/ref]; così come mutuerebbe da Erik Rothacker il “pensiero razziale” espresso dalla radice germanica[ref]E. FAYE, Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia,, cit., p.40[/ref]. Secondo la stessa direttrice passerebbe a rielaborare il concetto di lavoro grazie al confronto con Ernst Jünger: il lavoro esprimerebbe così il conio del nuovo popolo di lavoratori del ’33, per cui «Heidegger precisa nettamente il significato nazista che ormai è del concetto di lavoro»[ref]Ivi, p.116[/ref]. La nozione di popolo, indisgiungibile da quella di razza, sarebbe assunta direttamente dallo stesso Hitler: «D’ora in poi non si potrà più negare che l’uso razzista della parola Volk viene accettato da Heidegger senza l’ombra di una riserva e in mezzo ai diversi significati ammissibili»[ref]Ivi, p.152[/ref]. In maniera analoga, parlando dello stato come essere fondamentale del popolo, Heidegger finirebbe per recuperare l’istanza genuina dell’hitlerismo: «La concezione della nazione espressa nel seminario di Heidegger è appunto la stessa che troviamo nel Mein Kampf»[ref]Ivi, p.182[/ref]. Cercando di formulare un giudizio riassuntivo: «Il punto fondamentale è che “l’essere politico dell’uomo”, per Heidegger come per tutti i nazionalsocialisti, ha consistenza solo come popolo, mai come individuo»[ref]Ivi, p.184[/ref]. La politica totale finisce per sovrastare ogni campo, compresa l’ontologia.
Questo meccanismo interpretativo, che lascia imporre il contesto in cui Heidegger venne a trovarsi sull’autore stesso, finendo per neutralizzarne le categorie politiche, non lascia possibilità di riserve; se non per il fatto che tende ad incepparsi, fino ad imbattersi in delle vere e proprie contraddizioni (attribuite all’autore, se non ad errori o sue oscurità). Una volta tolte dal contesto di formulazione originaria, dalla coerenza interna del corso o del seminario in cui sono formulate, le sentenze heideggeriane non presentano più resistenze all’ermeneutica inquisitoria. Lo scopo di una contro-lettura dei testi presi in considerazione da Faye è quello di lasciar riemergere la coerenza interna del pensiero heideggeriano, che sembrerebbe avere come termini di paragone il pensiero fenomenologico piuttosto che il Mein Kampf, la politica aristotelica anziché una politica di potenza.
Il tentativo di Faye nei fatti si rivela fondato su un’argomentazione fallace, che solo una volta smascherata lascia aperta la domanda sulla coerenza del pensiero e del linguaggio politico heideggeriano. Piuttosto che assumere la prospettiva secondo cui politica ed ontologia non possano venir scisse né sovrapposte, così da discolpare o condannare allo stesso tempo il filosofo tedesco, dovremmo incominciare a chiarirne l’effettivo rapporto.
Una lettura contrastiva di tutti i corsi ed i seminari presi in considerazione da Faye sarebbe più che istruttiva; tuttavia, per tentare un passo in questa direzione, scegliamo di presentare nelle sue linee fondamentali il corso del semestre estivo 1934 Logica e linguaggio[ref]M.HEIDEGGER, Logica e linguaggio, tr. it. di U. Ugazio, Marinotti, Milano 2008[/ref]. Il corso rimane sicuramente il più istruttivo tra quelli presi in considerazione per almeno due ordini di motivi: in primo luogo Heidegger, durante il suo svolgimento, presenta le proprie definizioni politiche in maniera pressoché sistematica; mentre in secondo luogo, esso è il primo corso tenuto dopo le dimissioni dal rettorato friburghese. Le lezioni assumeranno così un ruolo paradigmatico, passando a ridefinire termini fondamentali come “popolo”, “uomo” e “storia”, sulla scorta della speculazione presentata in Essere e tempo.
II. L’introduzione al corso del ’34: temporalità e storicità nell’esperienza inautentica
Quando Heidegger si accinge a tenere il corso del semestre estivo del 1934 aveva già presentato le proprie dimissioni dalla carica di rettore dell’Università di Friburgo. In seguito i suoi dissensi con i professori più intransigenti – tra cui Ernst Krieck -, andarono inasprendosi a causa dell’accelerazione del processo di allineamento dell’ateneo friburghese alla politica di partito.
Mentre da programma accademico era stato annunciato il corso “Lo stato e la scienza”, nella prima ora di lezione Heidegger ne comunicò il cambiamento di argomento. L’esordio stesso del corso ne fissa il compito principale: determinare la struttura e la provenienza della logica odierna, con lo scopo di scuoterla e metterne in discussione il rapporto con il linguaggio. La domanda guida, che mira all’essenza del linguaggio, viene condotta attraverso lo smascheramento dell’imposizione della logica sull’asserzione per mezzo della grammatica. La questione preliminare è stabilire come la lingua sia connessa al tema dell’essere, e se essa non possa essere disgiunta dall’impostazione logicista a cui sembra definitivamente essere assegnata.
L’interrogazione intraprende da subito un moto vorticoso sino a trasformarsi in una vera e propria argomentazione circolare. Cerchiamo di seguirne il percorso principale.
Una prima analisi condotta sullo statuto del linguaggio ci induce a considerare la lingua, non come semplice raccolta di lemmi contenuti stabilmente nel vocabolario, bensì come colloquio che accade in maniera necessaria tra gli uomini. Per questo, secondo Heidegger, per mirare all’essenza del linguaggio dovremmo preliminarmente passare ad indagare la questione dell’essere dell’uomo in quanto colui che parla. Il corso subisce così il suo primo apparente slittamento.
Che cos’è l’uomo? Da subito viene notato come il modo di porre la questione possa risultare a questo punto determinante. Allo scopo di evitare di scadere in un’oggettivazione che definisca in anticipo che cosa sia l’uomo, il filosofo porta a chiederci più genuinamente chi esso sia. Heidegger presenta il motivo che sta a fondamento di questo slittamento rivolgendosi all’interrogante:
«La domanda preliminare poggia sull’uomo come se-stesso. La risposta rimanda l’interrogante al suo se-stesso. Gli interrogati siamo noi stessi. Quando l’interrogante chiede chi sia l’uomo come se-stesso diviene egli stesso il cercato»[ref]Ivi, p.54. Ogni autentica interrogazione non può non prendere in considerazione il protagonista stesso del domandare. Il se-stesso [Selbst] è una figura centrale che compariva già in Essere e tempo e che sta ad indicare il “soggetto fenomenologico” nella sua medesimezza, non esclusivamente a partire dalla sua presenza: «La domanda sul Chi deve trovare risposta nella esibizione fenomenica di un determinato modo di essere dell’Esserci. Se l’Esserci è se-stesso soltanto esistendo, la stabilità e la possibile “instabilità” del se-stesso richiedono una posizione ontologico-esistenziale della domanda quale unica via d’accesso adeguata alla corrispondente problematica» (M.HEIDEGGER, Essere e tempo, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi & C., Milano 2005, pp.147-148). [/ref]Per Faye l’intento di questo spostamento dell’indagine non mira che alla distruzione di ogni nozione di umanità, alla falsificazione della domanda intorno l’umano, che comporterebbe un’assoluta deresponsabilizzazione[ref]A questo proposito l’articolo di Sheehan mostra come la tesi sia sostenuta alla luce di una lettura viziata del ∫74 di Essere e tempo, il cui argomento è il richiamo all’autenticità dell’Esserci nella sua storicità, in rapporto alla comunità. «Ma Faye maltratta questa distinzione piuttosto ovvia ed importante. Egli afferma che il ∫74 ingloberebbe gli individui in una comunità fascista organica, un’affermazione che egli può fare esclusivamente perché non legge questa sezione attentamente o per intero» «But Faye rides roughshod over this quite obvious and important distinction. He says that SZ §74 swallows up individuals in a fascistoid organic community, a claim that Faye can make only because he has not read this section carefully or as a whole» (M.SHEEHAN, Emmanuel Faye: the introduction of fraud into philosophy?, cit., p.16).[/ref]. Heidegger, al contrario, avverte gli ascoltatori che di questa ipseità [Selbstheit][ref]L’ipseità del se-stesso è la medesimezza grazie alla quale l’ente che interroga il proprio essere, riconosce l’interrogazione come propria, rispondente al se-stesso. Da qui il suo rapporto necessario con la cura del proprio essere autentico: «L’ipseità deve esser esistenzialmente rintracciata soltanto nel poter-essere-se-stesso autentico, cioè nell’autenticità dell’essere dell’Esserci in quanto cura. In base a essa si spiega la stabilità del se-stesso, cioè la presunta permanenza del soggetto» (M.HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p.383)[/ref] non si può avere un concetto già dato – vertendo essa piuttosto sul preconcettuale –, in quanto anticiperemmo fatalmente l’interrogazione. Siamo alla prima acquisizione del corso: come ente che domanda e su cui verte la domanda del suo proprio essere, l’Esserci questiona se-stesso.
Lo scopo di questo nuovo orientamento della domanda sull’uomo è il rinvenire di una posizione fenomenologica fondamentale. Cercando di anticipare tanto una considerazione psicologica, quanto una sociologica – entrambe determinate da una definizione preconcetta di uomo -, Heidegger sta mirando all’essere dell’ente che interroga se stesso, cioè il Dasein. A partire da ciò l’interrogazione investe i tedeschi in quanto popolo che si sta interrogando, in quanto noi. Ma da dove scaturisce il noi come collettività, se non più da una serie numerica, da una semplice somma algebrica di io isolati? L’interrogazione è stata così formulata affinché fosse possibile domandarsi di volta in volta intorno l’essere del noi-stessi, senza vincolarlo ad una risposta comunitaria predeterminata, evitando con ciò ogni ricorso alla nozione di massa[ref]La massificazione sarà uno dei frutti dell’età contemporanea dominata dalla macchinazione. Heidegger presenterà il suo tempo come l’era della mobilitazione totale, come oblio del problema dell’essere a favore dell’ente. Secondo quanto scriverà qualche anno più tardi nei Contributi alla filosofia, l’occultamento e l’abbandono dell’essere si manifesterebbero nel calcolo, nell’accellerazione e nella centralità della massa. «Ciò che è comune a molti e a tutti è appunto per i “molti”: è ciò che essi conoscono come eccellente; ne deriva un’esigenza di calcolo e la celerità a disporre a loro volta i binari e la cornice per ciò che ha il carattere della massa» (M.HEIDEGGER, Contributi alla filosofia (Dall’evento), tri. it. di A.Iadicicco, Adelphi, Milano 2007, p.140). Per quanto riguarda la massa si vedano nella stessa opera anche ∫14 e ∫25.[/ref].
Né la prima persona singolare, né quella plurale, possono ricevere per Heidegger una preminenza nell’interrogazione[ref]Proprio a questo punto del corso Heidegger ci avverte che abbiamo guadagnato una posizione dirimente nei confronti della soggettività. Leggiamo infatti che il Selbst detiene il primato tanto sull’io quanto sul noi, essendone a fondamento. Tanto l’egoità quanto il noi comunitario si basano sull’ipseità; che si possa sostenere il contrario è dovuto secondo Heidegger alla valutazione del ‘34 come il tempo del noi, succeduto al dominio liberale dell’io moderno.[/ref]. Giunti a questo punto del ragionamento, il filosofo può portare a rispondere i propri studenti alla domanda sul noi:
«”Chi siamo noi-stessi?”: noi stiamo nell’essere del popolo, il nostro essere se-stesso è il popolo»[ref]Ivi, p.84[/ref].
La domanda sull’uomo ci trascina inavvertitamente alla questione del popolo. Il noi-stessi si colloca nella risposta che ognuno per proprio conto, in quanto interrogante, dovrebbe assumere e far propria. Il corso fornisce un’indicazione specifica: «Una decisione intorno a chi siamo noi stessi è stata già presa, siamo cioè il popolo»[ref]Ivi, p.87[/ref]. Ciò sta a significare che il popolo [das Volk] è tale in forza della decisione [Entscheidung]: esso non riceve la propria determinazione dall’alto, e non ha neanche un valore in potenza che si tratterebbe di attuare mediante la volontà. Come bisogna leggere quest’ultima affermazione, se, come viene fatto notare, quello tedesco è un popolo che si sta interrogando e non il popolo?
Siamo arrivati ad un primo svincolo decisivo del corso, che ci ha portato ad affrontare gradualmente una serie di questioni concatenate. Sulla base della riposta fornita sul popolo in quanto decisione, dobbiamo ora a trattare due questioni intermedie: esse vertono rispettivamente su cosa sia un popolo e che cosa stia qui a significare decisione.
Che cos’è un popolo secondo Heidegger? Faye non ne ha dubbi:
D’ora in poi non si potrà più negare che l’uso razzista della parola Volk viene accettato da Heidegger senza l’ombra di una riserva e in mezzo ai significati ammissibili[ref]E. FAYE, Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia, p.152. Secondo Faye sarebbe proprio sarebbe proprio Hitler ad ispirare la teoria statuale heideggeriana: «Heidegger fa dunque sua senza riserve l’espressione centrale del Mein Kampf, quella del völkischer Staat» (Ivi, p.215)[/ref]
Heidegger sembra intendere la parola in tutt’altro modo. Possiamo dimostrarlo illustrando le definizioni comuni – e perciò inautentiche – con le quali può essere determinato un popolo. Proseguendo la lettura del corso apprendiamo che il popolo può venir definito secondo tre criteri.
In primo luogo può essere inteso meramente come l’insieme degli abitanti di un territorio: «la popolazione costituisce il corpo [Körper] del popolo, l’insieme degli abitanti di uno stato»[ref]M.HEIDEGGER, Logica e linguaggio, cit., p.75[/ref]. Secondo questa prospettiva il popolo è considerato alla stregua di una massa censita, costituente una risorsa vivente in base alle sue membra. Proprio su questa base «spesso usiamo il termine “popolo” anche nel senso di “razza” [Rasse]»[ref]Ivi, p.95[/ref], riducendo il popolo alla sua materialità. Questa è la definizione biologica del popolo secondo la razza, secondo il sangue.
In secondo luogo, il popolo può essere preso semplicemente sotto un punto di vista sentimentale, in quanto anima [Seele]. «Popolo è inteso qui nel suo comportamento psichico – come anima»[ref]Ivi, p.97[/ref]. In questo modo una popolazione si definisce anche in virtù della propria identità romantica ricavata dalla tradizione, determinazione secondo cui sarebbe il diritto del territorio a radicare l’anima popolare nell’insediamento ed a stabilirne i caratteri. Questa è per Heidegger l’intesa antropologico-culturale del popolo.
In terzo luogo, il popolo arriva a coincidere con lo spirito [Geist]. «Ovunque sia questione di suddividere, di stabilire un ordine con leggi proprie, di decidere, il popolo è qualcosa di storico, di commisurato alla volontà, di spirituale: il popolo è spirito»[ref]Ivi, p.98 [/ref]. Secondo tale prospettiva esso è qualcosa di storicamente determinato, direttamente commisurato alla sua potenza spirituale. Questo è il popolo da un punto di vista di una filosofia della storia.
Giungiamo così ad un’altra tappa fondamentale della nostra ridefinizione linguistica. Proprio in riferimento alle definizioni appena proposte, secondo Faye comincerebbe «una lunga indagine sulla nozione di popolo, senza che nessuna di queste tre determinazioni sia rifiutata»[ref]Ivi, p.151[/ref]. Esattamente all’opposto, ciò è proprio quanto Heidegger sta cercando di dimostrare, ricusando le tre definizioni precedentemente abbozzate. Se non venisse meno la loro verità non avrebbe senso la distinzione approntata da Heidegger tra autenticità e inautenticità, l’argomentazione si ribalterebbe finendo per assumere ciò che si sta presentando appositamente in maniera negativa. Veniamo infatti nuovamente redarguiti, poiché nel corso delle analisi appena compiute abbiamo di nuovo mancato la domanda. Stiamo nuovamente questionando su cosa sia un popolo e non su chi esso sia.
Per questo motivo precedente, avevamo trasformato la domanda sul che-cosa in una domanda sul chi. Volevamo volgere le spalle alle rappresentazioni nelle quali l’uomo è fatto consistere nella connessione di corpo, anima e spirito.[ref]Ivi, p.99 [/ref]
I tre modi di determinazione di un popolo precedentemente abbozzati provengono tutti da una medesima origine, e cioè dalla considerazione dell’uomo come costrutto di corpo-anima-spirito [Leib-Seele-Geist]; ne consegue che solo una volta reimpostata la domanda sull’uomo sarà possibile formulare quella sul popolo in maniera autentica.
Per continuare a sondare la risposta sul popolo siamo subito rimandati alla seconda domanda intermedia, su che cosa s’intenda per “decidere”. La nostra comprensione quotidiana vuole che la decisione risponda ad un aut-aut, consista cioè in una possibilità esistenziale, in una scelta che ci si prospetterebbe tra due alternative. Al contrario, ed in maniera autentica, Heidegger presenta la scelta a partire dal suo sostenimento. Essa arriva a definire uno status: la decisione si dà solo ed esclusivamente nella continuità del suo accadere, nel mantenimento della scelta che corrisponde alla necessità della sua continuità. A questo proposito essa è appannaggio esclusivo dell’uomo in quanto egli rimane da sempre e inevitabilmente aperto alla decisione, sia che esso scelga o meno. Solo ed esclusivamente l’essere ferrati nell’apertura-decidente permette perciò il dischiudersi di un accadere[ref]«Questa apertura eminente, autentica, attestata nell’Esserci stesso dalla sua coscienza, cioè il tacito e pronto all’angoscia autoprogettarsi nel più proprio esser-colpevole, è ciò che chiamiamo decisione», e perciò «il decidersi, è in primo luogo, l’aprente progettare e determinare le possibilità di volta in volta effettive» (M.HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., pp. 354-355)[/ref]. L’apertura decidente [Erschlossenheit] dell’Esserci è il nuovo sguardo sull’agire: dal momento che ci decidiamo per qualcosa rimaniamo aperti alla decisione stessa determinandoci. «Siamo aperti-decidenti a qualcosa – questo indica che ciò al quale siamo aperti-decidenti ci sta stabilmente davanti determinando tutto il nostro essere»[ref]M.HEIDEGGER, Logica e linguaggio, cit., p.111 [/ref].
Non avremmo raggiunto granché se l’esito di questo domandare ci avesse portato a quello che sembra un cieco volontarismo. A tal proposito leggiamo che questo decidere perde ogni carattere d’immediatezza, esso non rimane legato al volere presente, quanto piuttosto si inserisce all’interno di una discussione temporale. Esclusivamente in virtù della decisione ci inseriamo nella temporalità venendo così ad aprirsi la dimensione della storicità:
Nell’apertura-decidente, l’uomo è anzi rinviato all’accadere futuro. L’apertura-decidente è essa stessa un accadere che, afferrando preliminarmente quell’accadere, contribuisce stabilmente a determinare ogni accadere. [ref]Ivi., p.112 [/ref]
È proprio a questo punto che l’indagine investe lo statuto della storia. Riguardo l’essenza della storicità è necessario fornire sin da subito dei distinguo in base al tempo, poiché non assegniamo un carattere propriamente storico ad ogni trascorrere. Per comprendere come non ogni decorso temporale ottenga il diritto di essere storia, in quanto non tutto ciò che trapassa milita nella storia, dobbiamo necessariamente far riferimento all’accadere della decisione dell’uomo. La storia non è una mera successione di avvenimenti ordinata in manuali scolastici, incasellata secondo nessi di causa-effetto; piuttosto, e in maniera autentica, essa è determinabile esclusivamente a partire dall’essere dell’uomo. Si apre una dimensione storica esclusivamente in presenza dell’accadere: in quanto l’accadere resta nel sapere legato ad una volontà, ne conserva una notizia che è possibile render nota. Un effetto fisico, un animale, una cosa presi nella loro autonomia possono avere un processo, un movimento ma non accedono nell’ambito dell’accadere storico in maniera indipendente. Al contrario, sono la consapevolezza, l’intenzionalità e la volontarietà che permettono alla notizia dell’accadere di essere conservata e resa nota. Ciò è cruciale dato che «con questo sbarramento, determiniamo la storia come essere dell’uomo»[ref]Ivi., p.122. Secondo le scelte del traduttore: Geschichte è tradotto qui con “storia”, e sta ad indicare la storicità autentica del dar notizia della “storiografia” [Geschichtskunde]; mentre Historie, che indica la notizia riferita all’accadere della storia, è lasciato non tradotto. Invece la “scienza storica” inautentica traduce la Geschichtswissenschaft, che in quanto scienza, ordina razionalmente la notizia come oggetto. Per quanto riguarda la distinzione tra le due maniere di trattare la storia che stiamo per andare ad affrontare cfr. M.HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., §74-§76. [/ref].
Siamo giunti all’ennesimo punto di svolta. Esattamente in questa parte del corso Heidegger indica infatti che siamo pronti ad effettuare una rotazione delle questioni fin qui poste, a rivolgerci nuovamente ad esse per passare ad un’indagine autentica. Il punto di torsione che permette di rivolgerci al percorso compiuto, rivelandone il carattere circolare-interpretativo, viene individuato nella ricomprensione della temporalità.
Durante il percorso dell’interrogazione siamo giunti al cospetto della storia e ne abbiamo fatto il carattere esclusivo dell’Esserci. La domanda sulla storia è abitualmente la domanda sul passato. Possiamo ora considerare i fatti in relazione a due modelli temporali: secondo lo scorrere degli attimi, oppure in base alla decisione dell’Esserci. Se il tempo individuato è quello di matrice aristotelica, dell’incedere dei momenti – il susseguirsi del movimento nel tempo dell’orologio -, allora il passato è qualcosa che non-è-più; esso è un trapassato, un qualcosa di compiuto in quanto trascorso. In alternativa, se il tempo è quello misurato sulla decisione dell’Esserci, esso si rivela un già-stato che perdura nel suo continuo farsi essenza, un provenire-verso della progettualità[ref]Heidegger distingue la considerazione canonica del tempo, risalente alla fisica aristotelica, dalla temporalità [Zeitlichkeit] della costituzione ontologica dell’Esserci. Temporalità che rivela la maniera autentica della cura, il rapportarsi dell’Esserci al proprio essere. A questi due modi di comprensione del tempo, il primo deiettivo ed il secondo autentico, nel disegno di Essere e tempo avrebbe dovuto aggiungersi la trattazione del tempo in relazione all’Essere [Temporalität]. Per la distinzione tra tempo inautentico e Zeitlichkeit cfr. M.HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p.396 ss.[/ref]. Mentre la prima temporalità, secondo il filosofo tedesco, è quella vigente nella metafisica occidentale sul modello aristotelico del movimento, la seconda modalità attraverso la quale è possibile trattare il passato, calibrato sull’accadere riguardante l’Esserci nella decisione, declina un nuovo modo di stare nel tempo e nella storia.
Heidegger passa ad indicare, a seconda delle due temporalità che abbiamo appena tracciato, due maniere fondamentali di trattare la storia. La scienza storica [Geschitewissenschaft] inautentica – basata sulla temporalità aristotelica-, considera la storia come un oggetto compiuto – che non è più -; essa configura gli eventi e li ordina in un’esposizione lineare secondo una linea tematica. La seconda modalità di fare storia, in quanto storiografia [Geschichtskunde – Historie], determina al contrario e di volta in volta il modo con cui un’epoca sta nella storia autenticamente. A questa seconda maniera di trattare la storia pertiene il mantenere la notizia (historia), tenuta salda a partire dall’accadere. Dal momento che è il nostro rapportarci al tempo a determinare la conseguente scienza storica, è una rinnovata discussione sulla temporalità a determinare la modalità dell’accadere dell’Esserci nella storia, la sua maniera di essere nella storia.
L’alternativa che si profila è tra un’ipostatizzazione del passato, che porta ad una forma d’ignavia storica che ci inchioda ad un atteggiamento constatativo, ed una considerazione dell’essere dell’uomo nel suo continuo essenziale maturare storico, indissolubilmente legato al carattere della decisione. La triplice canonica scansione temporale passato-presente-futuro subisce così un nuovo orientamento. Seguendo il carattere della decisione Heidegger arriva ad affermare qualcosa che ad una prima lettura può sembrarci contraddittorio. Il nostro essere nella storia, il farsi essenza da cose antecedenti, si determina a partire dal nostro futuro che s’impone come tradizione. La contraddizione risulterà solo apparente se per tradizione non intendiamo un passato immobile, da reiterare o restaurare, bensì un continuo farsi in-carico (tradere – liefern). Se quanto ereditiamo non è un patrimonio statico, ma ciò a partire da cui muoviamo, allora solo dopo aver assunto il nostro tratto antecedente potremo stare saldi nel nostro essere proprio: ciò significa farsi-essenza dal già-stato in direzione del futuro. Alla stregua di tale considerazione ci è possibile comprendere come il nostro essere anticipatamente gettati, sia subito a partire da un esser-già-stato tendente al futuro: è il tempo originariamente unico ed autentico. Focalizziamo così nel cuore del corso l’unica questione di Essere e tempo, ovvero il modo d’essere temporale dell’Esserci in rapporto all’Essere.
«Non ci è più possibile comprendere noi stessi come qualcosa che compare nel tempo, dobbiamo esperirci come quelli che facendosi essenza da cose antecedenti, estendendo la presa oltre se stessi si determinano a partire dal futuro, ossia però come quelli che sono essi stessi il tempo», poiché «Siamo noi stessi il maturarsi del tempo [zeitigen]»[ref]Ivi, pp.168-169: «Questo fenomeno unitario dell’avvenire essente-stato e presentante lo chiamiamo Zeitigung. […] La Zeitigung si rivela come il senso della Cura autentica. […] L’unità originaria della struttura della Cura è costituita dalla Zeitigung» (ET, p.387-388). [/ref]
Tutte le domande che ci siamo posti lungo il corso delle lezioni sono inserite in questo accadere temporale che noi siamo, pertanto, le risposte di cui ci siamo forniti andranno riformulate alla luce di una temporalità autentica. Quel che ci aspetta è dunque di riaffrontare le questioni passate in rassegna durante la prima parte delle lezioni, alla luce dell’autentico accadere temporale dell’Esserci, all’interno del suo effettivo maturare. Esclusivamente dopo aver assunto la nostra temporalità originaria ci riconosciamo come noi-stessi nella decisione, in quanto interroganti: ci appropriamo dell’accadere autentico, come popolo e come uomini, e, proprio rispondendo, siamo responsabili nel nostro proprio essere. Questa è propriamente la struttura della cura.
III. L’esperienza autentica di uomo, popolo e storia
Nel proseguo del corso dovremo ripercorrere la serie questioni che si erano, ad un primo tempo, presentate come inautentiche. Intraprendendo il cammino a ritroso, senza mai perdere di vista la temporalità dell’essere dell’uomo, sarà necessario mettere in luce i caratteri della nostra costituzione fondamentale. A questo proposito «facciamo esperienza del tempo solo e soprattutto se portiamo all’esperienza noi stessi nella nostra determinazione»[ref]M.HEIDEGGER, Logica e linguaggio, cit., p.177 [/ref]. In cosa consiste il nostro essere determinati? Esso si articola secondo Heidegger in tre significati reciproci: il binomio carico-mandato, il lavoro e la tonalità emotiva.
Il primo momento recettivo della nostra determinazione risiede nel nostro trovarci necessariamente impegnati nella tradizione. L’incarico [Auftrag], come determinazione ereditata del nostro essere, ci è destinato anticipatamente alla luce del nostro mandato [Sendung]; perciò siamo inevitabilmente interpellati ad una risposta responsabile nei confronti del mandato – ciò che ci è trasmesso. Abbiamo precedentemente detto che il nostro farsi-essenza procede dall’essere già-stato, ed ora ci appare chiaro come l’accostamento incarico-mandato, stimolando il nostro domandare alla risposta necessaria, illumini la nostra essenza storica costituendola in anticipo. Siamo necessariamente gettati nell’ente sempre a partire-da.
Questo carattere non rimane una constatazione erudita ed inoperosa, dal momento che la realizzazione di una sua replica passa attraverso una decisione. Scopriamo così cosa Heidegger intenda per lavoro, il secondo carattere della nostra determinazione. Lavorare è ricevere e portare all’opera la nostra determinazione [ins Werk setzen][ref]«Ricavare la nostra determinazione, mettere e portare in opera a seconda della sfera del produrre – significa lavorare» (M.HEIDEGGER, Logica e linguaggio, cit., p.180). Coerentemente Heidegger si esprime nella stessa maniera durante il discorso d’immatricolazione tenuto nel novembre 1933: «Tuttavia l’essenziale dell’essenza del lavoro non sta nell’attuarsi di un atteggiamento, e non sta nel suo risultato, bensì in ciò che in esso propriamente accade, e cioè: l’uomo, come lavorante, si confronta con l’intero dell’ente» (M.HEIDEGGER, Discorsi e altre testimonianze del cammino di una vita, tr.it. di N.Curcio, Il Melangolo, Genova 2005, p.191). Sulla stessa riga il servizio al lavoro era stato richiamato come uno dei servizi eminenti dello studente, durante il discorso di rettorato (M.HEIDEGGER, L’autoaffermazione dell’università tedesca. Il rettorato 1933/34, cit., p.25).[/ref]. Il lavoro non è un’attività del soggetto che si ripercuote su un oggetto ad esso estraneo, bensì si rivela l’operatività stessa della nostra essenza, l’efficienza del nostro agire. Agendo in direzione di una progettualità ci situiamo in un presente tra un essere già-stato e un futuro. Il lavoro si realizza come produzione della Bestimmung.
Il terzo elemento costituente la determinazione è la Stimmung: la tonalità emotiva[ref]«La tonalità emotiva ha già sempre aperto l’essere-nel-mondo nella sua totalità, rendendo solo così possibile un dirigersi verso…L’essere in una tonalità emotiva non importa alcun riferimento primario alla psiche; non è uno stato interiore che poi in modo enigmatico si esteriorizzerebbe per colorire di sé cose e persone. […] Alla situazione emotiva è esistenzialmente connessa un’aprente remissione al mondo in cui possiamo incontrare ciò che ci procura affezioni» (M.HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p.169,171). Per quanto riguarda la Stimmung in Essere e tempo cfr. anche §29 e §68b.[/ref]. Essa, in quanto tonalità fondamentale ci pervade da capo a fondo e ci determina intonandoci all’ente. Riferendoci alla Stimmung dobbiamo escludere ogni riferimento ad un flaccido sentimentalismo che si rispecchierebbe in stati comportamentali, inchiodati al vissuto di uno stato d’animo. Dato che è da sempre attraverso una tonalità che ci apriamo all’ente, essa influenza e caratterizza necessariamente ed immediatamente tale apertura, non possiamo accantonarla per una pretesa di un’oggettività scialba e fittizia.
Abbiamo già avuto modo di vedere, come, in senso inautentico, questa triplice determinazione non venga affatto rispettata. La domanda elusiva intorno l’uomo lo riduce alla sua mera oggettualità, alla sua mera presenza, così che possa rientrare nell’ambito delle scienze umane che ne mancano completamente lo statuto temporale. Ritornando a domandarci in senso autentico chi sia l’uomo, possiamo finalmente passare a connotarlo esaustivamente secondo la sua triplice autentica determinazione.
Riuniamo i tre caratteri della determinazione. Una volta sottratta la tonalità emotiva alla sua psicologizzazione in vissuti, diverrà possibile intenderla come esperienza decisiva; in necessario riferimento ad essa ci immettiamo nell’ente, esponendoci all’essere sempre secondo un’intonazione. La nostra determinazione si rivela efficace nel lavoro: l’operare dell’uomo nell’ente che ci si è aperto. L’uomo è costantemente rinviato alle cose, da sempre aperte nel mondo. Se la Stimmung ci situa emotivamente ed il lavoro ci immette operativamente nell’ente, manca ancora una linea unitaria che connetta i momenti in un unico intreccio. La traccia guida è fornita dal plesso incarico-mandato, cosicché ogni lavoro scaturisce da un compito ed è legato a quel che sopraggiunge, sempre nel rapporto all’ente sostenuto da una tonalità[ref]Ivi, p.217[/ref]. L’uomo viene a trovarsi immesso in una tradizione, dato che egli non è mai senza presupposti: la sua situatività [Befindlichkeit] è già di per sé ricevente, in quanto l’Esserci è da sempre aperto in maniera determinata. Portando a sintesi il ragionamento:
Questo senso triplice-unico di quel che chiamiamo determinazione ci consente innanzitutto di cogliere incarico e mandato, lavoro e tonalità emotiva nella loro unità commisurata all’accadere, di cogliere egualmente anche il tempo come potenza originaria che dispone il nostro essere e lo determina in sé come accadere.[ref]Ivi, p.183[/ref]
La determinazione, considerata in maniera unitaria, rappresenta la nostra completa storicità, coincidente con la nostra propria maturazione temporale. Siamo storicamente in virtù della nostra determinazione, e viceversa, siamo noi stessi in quanto esposti all’ente temporalmente. Questo intreccio corrisponde al nostro essere nel tempo – esposti all’ente nell’apertura – nel modo in cui ne va del nostro essere proprio. La nostra maturazione temporale [zeitigen] coincide con la cura del nostro proprio essere: essa dispiega il nostro farsi-essenza. Proprio quella che è presentata come la maturazione temporale viene a dispiegarsi tra il passato come già-stato, il presente situato nella tonalità emotiva e operante nel lavoro, nel continuo rinvio al futuro in virtù della decisione. L’indagine sull’uomo viene così a ricomporsi, acquistando un carattere unitario.
IV. Tentativo di una messa in discussione del concetto di politico
Solo dopo aver chiarito la domanda intorno l’uomo Heidegger nomina per la prima volta lo stato. Egli lo fa dopo aver riannodato i capi delle analisi fin qui compiute e portando a conclusione il corso, fornendo una risposta all’interrogazione intorno al popolo.
«L’ente originariamente unitario che regge esser-esposto, rinvio, tradizione e carico può essere solo quel che chiamiamo un “popolo”»[ref]Ivi, p.219[/ref]
Dato che il popolo è da subito un determinato popolo, lo stato non potrà essere legato ad una definizione concettuale frutto di un’astrazione del diritto, bensì esso rivela la propria politicità in riferimento al proprio Esserci. Se assumiamo la cura in sé come cura della determinazione, allora possiamo arrivare a riaccorpare le analisi affermando che «Lo stato è l’essere storico del popolo»[ref]Ivi.p.230[/ref]. La definizione raggiunta è decisiva:
Lo stato sussiste solo se e finché accade l’affermazione della volontà di signoria che scaturisce da mandato e carico e che all’inverso diventa lavoro e opera. L’uomo, il popolo, il tempo, la storia, l’essere, lo Stato – non sono concetti astratti che servono come oggetti per esercizi definitori, ma il comportamento essenziale è sempre un decidersi storico, ossia un decidersi già-stato-futuro[ref]Ivi, p.230. Per quanto riguarda l’utilizzo di questo concetto di stato durante il periodo di rettorato si veda in particolare M.HEIDEGGER, Discorsi e altre testimonianze del cammino di una vita, tr.it. di N.Curcio, Il Melangolo, Genova 2005, pp. 188, 302).[/ref]
Una volta guadagnata questa prima ricomprensione destrutturante dello stato, è necessario notare come le sostituzioni terminologiche adottate nell’opera di Faye siano assolutamente fuori strada[ref]Ciò che è peggio è che Faye cerchi di confermare la sua tesi effettuando una vera e propria manomissione dei testi heideggeriani per cercare di estorcerne una confessione. Nel suo articolo Sheehan passa in rassegna i maggiori interventi arbitrari compiuti dal francese: alterazione del testo per mezzo di una traduzione faziosa, come nella Lettera sull’umanismo; forzatura del testo ad un’interpretazione insostenibile, come in occasione di un commento ad un corso dedicato al Reno di Hölderlin; riscrittura integrale di alcuni passi, come nel caso di un’affermazione contenuta nell’intervista allo Spiegel. Per quanto riguarda queste tre denunce si veda rispettivamente M.SHEEHAN, Emmanuel Faye: the introduction of fraud into philosophy?, pp.23, 25-26, 28-30.[/ref]. Secondo quest’ultimo proprio i corsi tenuti durante il rettorato
ci rivelano fino a che punto il ‘filosofico’ e il politico siano per lui un’unica cosa, e come Heidegger posizioni il politico, inteso nel senso più radicalmente nazista, nel cuore stesso del ‘filosofico’[ref]E. FAYE, Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia, cit., p.8[/ref]
Il tema è cruciale. Che la nozione di politico venga a trovarsi, assieme alla storicità, nel cuore della speculazione heideggeriana, è attestato dalla ridefinizione dell’essenza dello stato; ciò che non è vero invece è che Heidegger ricavi ed usi le proprie categorie politiche a partire da una dottrina di partito. L’intento della presentazione del corso del ’34 era proprio quello di mettere in discussione la genesi dei suoi “concetti” dall’hitlerismo, per lasciarli sgorgare direttamente dall’ontologia del ’27.
Per cercare parziali conferme di questa lettura facciamo un breve riferimento a due seminari contemporanei al corso analizzato. Con questi ragguagli tentiamo di effettuare direttamente una messa in discussione del concetto di politico, per come Heidegger l’ha creduto di determinare, e sulla base del quale ha sostenuto le sue affermazioni e scelte politiche.
Sulla scorta delle affermazioni compiute nel corso del ’34 non sarà difficile comprendere come Heidegger possa asserire in un seminario dello stesso anno che «Per determinare l’essenza del politico, bisogna prima di tutto ritornare all’essenza dello Stato»[ref]«Für die Bestimmung des Wesens des Politischen ist der Rückgang auf das Wesen des Staates des Allererste» (M.HEIDEGGER, Hegel, über den Staat, seminario invernale 1934-35, protocollo del seminario conservato al Deutsches Literaturarchiv di Marbach, reportatio di W.Hallwachs, f. 78r, tri.it. in E. FAYE, Heidegger, L’introduzione del nazismo nella filosofia, cit., p.326)[/ref]. Tuttavia, se lo stato poggia sulle nozioni di popolo e storia, che a loro volta sono fondate sulla triplice determinazione dell’esserci, sembriamo trovarci di fronte ad una giustapposizione tra politica ed ontologia.
Una seconda citazione, che può servirci da guida e sciogliere ogni ulteriore riserva, è tratta da un seminario del 1933. Essa porta a compimento ed allo stesso tempo inserisce su di una traiettoria lineare tutte le questioni affrontate nel corso del ’34. Nel seminario viene affermato che:
Il politico, come possibilità fondamentale e modo d’essere distintivo dell’uomo, è – come dicevamo – il fondamento sul quale lo Stato è. L’essere dello Stato è ancorato nell’essere politico degli uomini che, in quanto popolo, portano questo Stato, si decidono per esso.[ref]«Das Politische als Grundmöglichkeit und ausgezeichnete Seinsweise des Menschen ist – wie wir sagte -, der Grund, auf dem der Staat ist. Das Sein des Staates liegt verankert im politischen Sein der Menschen, die als Volk diesen Staat tragen, die sich für ihn entscheiden» (M.HEIDEGGER, Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat, seminario invernale 1933-34, protocollo conservato al Deutsches Literaturarchiv di Marbach, appunti di I.Schroth settima sessione §1, tri.it in E. FAYE, Heidegger, L’introduzione del nazismo nella filosofia, cit., p.183).[/ref]
L’intima responsabilità e l’estrema decisione intorno al proprio essere – in quanto cura della storicità – sono a fondamento del politico. A partire da ciò: «La forma, la costituzione dello Stato è un’espressione essenziale del senso che il popolo vuole dare al suo essere»[ref]«So ist denn auch die Form, die Verfassung des Staates wesentlicher Ausdruck dessen, was das Volk sich als Sinn setzt für sein Sein» (M.HEIDEGGER, M.HEIDEGGER, Ueber Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat, cit., settima sessione §12, tri.it in E. FAYE, Heidegger, L’introduzione del nazismo nella filosofia, cit., p.204).[/ref]. Questo accadere nella decisione rende impossibile ogni corto circuito tra essere e stato, dato che il secondo scaturisce dal primo determinandolo e non viene mai a sovrapporglisi.
Tornando brevemente alle affermazioni con le quali abbiamo esordito nel presente scritto, a questo punto siamo in grado di scansare alcune delle incomprensioni che si sono venute a creare in seguito alla separazione tra il pensiero e la politica di Martin Heidegger. Il testo di Faye ci ha mostrato a proposito, come, una volta disconosciuta ogni autonomia del concetto di politico del filosofo tedesco, sarebbe facile distorcerne e interpretarne erroneamente le affermazioni politiche. Alla luce di questa procedura interpretativa diviene possibile lasciar imporre il contesto sull’autore, assumere la scelta del ’33 come evento dirimente e lasciar fagocitare l’autore dall’ideologia. Il nostro tentativo, al contrario, è stato quello di accennare ad un terreno d’autonomia del “linguaggio politico” heideggeriano.
Posto che Heidegger usi le medesime espressioni della fraseologia ideologica, senza tuttavia condividerne i significati, né tanto meno i referenti, la questione che ci si presenta è la seguente: in che rapporto stanno le stesse parole pronunciate dal filosofo e dagli ideologi del partito? A questo livello il pensiero impatta la storia e ne rivela la sua inevitabile attualità.
Il quadro storico-culturale nel quale il pensiero di Heidegger è venuto a maturare è quello della crisi di inizio secolo, dalla prima guerra mondiale, all’agonia della Repubblica di Weimar, del contemporaneo dilagare del movimento comunista. La sua posizione risulta perfettamente inscrivibile nella schiera di coloro che mossero critiche radicali alla Weltanschauung liberale, all’appiattimento borghese, alla crescente burocratizzazione dell’università tedesca, e non da ultimo al modello comunista. Tutti questi fenomeni rappresentavano agli occhi del filosofo una via impropria assunta dalla modernità per la Germania. Mann, Spengler, Jünger, Jaspers e Schmitt sono solo alcuni degli autori con i quali Heidegger condivide il sentimento di una rottura epocale della storia, un anti-modernismo viscerale, che con ben altre tinte sarà propugnato anche da Hitler stesso[ref]In questa direzione si muove lo studio di Domenico Losurdo, secondo cui l’heideggerismo non sarebbe che una delle forme assunte dall’ideologia della guerra tedesca. Per quanto riguarda invece il rapporto tra Heidegger ed il nazismo, lo studioso italiano matura una posizione ben più critica rispetto a quella di Faye, arrivando ad affermare che «a tale proposito, possiamo tentare di concludere: la denuncia della modernità è al tempo stesso motivo d’incontro col nazismo e terreno per un confronto critico con esso» D.LOSURDO, La comunità, la morte, l’Occidente, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p.130).[/ref]. Tuttavia, appiattire ogni posizione su di un’altra – come avviene nel lavoro di Faye, significherebbe compiere una semplificazione spropositata.
Prima di abbandonarsi a sentenze inappellabili è necessario chiarire come la posizione politica di Heidegger non sia stata figlia della foga dell’attimo e come, allo stesso tempo, sia arrivato ad imboccare una strada sbagliata come quella del ‘33. Se il filosofo tedesco matura la propria nozione di politico e di socialismo-nazionale a partire dalla propria speculazione, possiamo ipotizzare che è solo perché egli credette che il partito salito al potere nel ’33 avesse potuto rappresentare l’anima del “sovvertimento dell’Esserci tedesco”. Questa scelta è da egli stesso riconosciuta come il suo errore capitale, la sua colpa[ref]«Il rettorato fu un tentativo di vedere, nel movimento che era diventato potere, al di là di tutte le insufficienze e grossolanità, qualcosa di più vivo e proteso verso un orizzonte più ampio che forse un giorno avrebbe potuto condurre ad un ripensamento dell’essenza storica dei tedeschi. Non si deve negare che io allora credetti a tali possibilità e rinuncia alla vocazione più autentica del pensiero per un compito e un dovere pubblico. Né va sminuito ciò che provocò una vera e propria mancanza nell’espletamento di tale compito. Solo che, in tali prospettive, non si colse ciò che aveva determinato l’assunzione di quell’ufficio» (M.HEIDEGGER, L’autoaffermazione dell’università tedesca. Il rettorato 1933/34, tr.it di C.Angelino, Il Melangolo, Genova 1988, p.51).[/ref]. Sebbene Heidegger non contragga alcun debito di sorta con l’ideologia e con le parole del partito – pur condividendone il retroscena storico -, è comunque fondamentale, per comprendere a fondo il suo errore politico, spiegare come i due linguaggi possano essere arrivati a sovrapporsi[ref]Una delle posizioni orientate a porre i giusti distinguo è quella sostenuta dallo storico Ernst Nolte, che riconosce il rischio di appiattire la complessa situazione politica che caratterizza gli anni della presa di potere del regime. Secondo lo storico «Nel 1933-34 ci potevano quindi essere ancora diverse concezioni di “nazionalsocialismo” e non è accettabile che tutte vengano sussunte ex eventu all’interno di quella hitleriana» (E. NOLTE, Martin Heidegger tra politica e storia, tr.it di N.Curcio, Laterza, Roma-Bari 1994, p.160-161)[/ref].
La compromissione con il partito e gli insanabili attriti che con esso emergeranno a seguito di credenze inconciliabili, sono due facce della stessa medaglia. Come ci ha mostrato il lavoro di Faye, inserire un autore nel proprio contesto d’appartenenza, forzandolo in logiche che non gli sono proprie, significa disconoscerne la peculiare posizione e piegarne arbitrariamente il pensiero. Che la riflessione di Heidegger, lungi dall’essere una teoresi rarefatta, sia bensì radicata nella realtà e frutto del proprio tempo, non può più lasciar scandalizzati, ciononostante non è lecito negare al suo pensiero ogni autonomia.
Mattia Tritarelli (1988) ha conseguito la laurea magistrale in “Filosofia ed etica delle relazioni” presso l’Università degli Studi di Perugia sotto la guida del Prof. Flavio Cuniberto, con una tesi dal titolo Heidegger e la Kehre. L’emergere del linguaggio nei corsi dei primi anni ’30. Attualmente sta svolgendo il dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di Perugia con un progetto di ricerca sul rapporto tra il pensiero di Heidegger ed Hegel.
Bibliografia delle opere citate
M.HEIDEGGER, Essere e tempo, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano 2005
Ib,, Discorsi e altre testimonianze del cammino di una vita, tr.it. di N.Curcio, Il Melangolo, Genova 2005
Ib., L’autoaffermazione dell’università tedesca. Il rettorato 1933/34, tr.it di C.Angelino, Il Melangolo, Genova 1988
Ib., Logica e linguaggio, tr. it. di U.Ugazio, Marinotti, Milano 2008
Ib., Contributi alla filosofia (Dall’evento), tri. it. di A.Iadicicco, Adelphi, Milano 2007
A. DENKER, H. ZABOROWSKI, Heidegger-Jahrbuch 4. Heidegger und der Nationalsozialismus, voll. 2, Alber Verlag, Freiburg/München 2009;
P. BOURDIEU, Führer della filosofia? L’ontologia politica di Martin Heidegger, tr. it. a cura di G. De Michele, Il Mulino, Bologna 1989;
F. BRENCIO (a cura di), La pietà del pensiero. Heidegger e i Quaderni Neri, Aguaplano – Officina del Libro, Passignano s. T. 2015;
D. DI CESARE, Heidegger e gli ebrei. I Quaderni neri, Bollati-Boringhieri, Torino 2014;
J. DERRIDA, De l’esprit: Heidegger et la question, Editions Galilée, Paris 1987;
A. FABRIS (a cura di), Metafisica e antisemitismo. I «Quaderni neri» di Heidegger tra filosofia e politica, ETS, Pisa 2014;
E. FAYE, Heidegger, L’introduzione del nazismo nella filosofia, a cura di L.Profeti, L’asino d’oro, Roma 2012;
V.FARIAS, Heidegger e il nazismo, tr. P.Amari, Bollati Boringhieri, Torino 1988;
F.FÉDIER, Venire a maggiore decenza, in M.HEIDEGGER, Scritti politici, tr.it. di M.Borghi e G.Zaccaria, Piemme, Casale Monferrato 1998;
F.FÉDIER, Heidegger e la politica. Anatomia di uno scandalo, tr.it. di M.Borghi, EGEA, Milano 1993;
J.HABERMAS, Il filosofo e il nazista, tr. it. di P.Amari, in Micromega 1988 n.3;
D.LOSURDO, La comunità, la morte, l’Occidente, Bollati Boringhieri, Torino 1991;
K.LÖWITH, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, tr. it. di E.Grillo, il Saggiatore, Milano 1995;
E. NOLTE, Martin Heidegger tra politica e storia, tr.it di N.Curcio, Laterza, Roma-Bari 1994
H. OTT, Martin Heidegger: sentieri biografici, tr. It. Di F. Cassinari, Sugarco Edizioni, Milano 1988;
O. PÖGGELER, Der Denkweg Martin Heideggers, Neske, Pfullingen 1990;
R.SAFRANSKI, Heidegger e il suo tempo, tri. It. di N.Curcio, Tea, Milano 2001;
M.SHEEHAN, Emmanuel Faye: the introduction of fraud into philosophy?, http://enowning.blogspot.de/2015/04/thomas-sheehan-on-faye-and-fraud.html
P. TRAWNY, Heidegger und der Mythos des jüdischen Weltverschwörung, Klostermann, Frankfurt a. M. 2014;