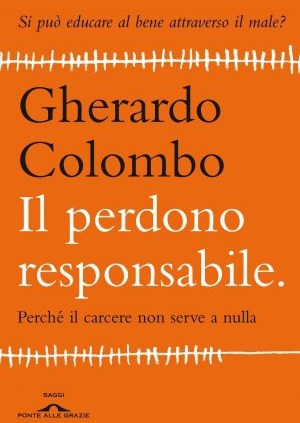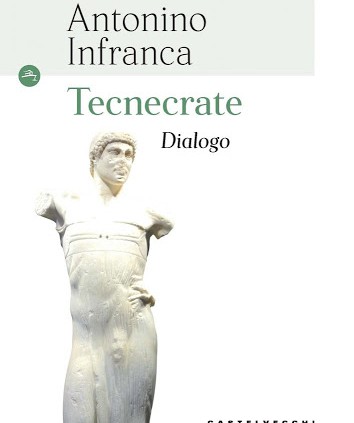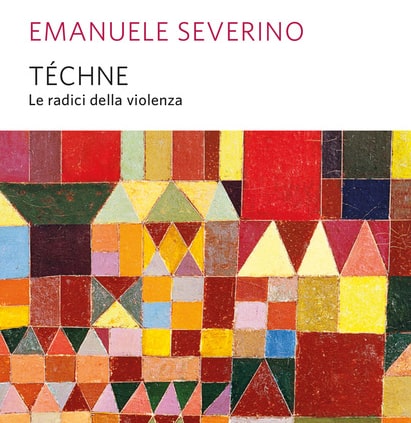CON PIGNOTTI, SEMPRE IN MOVIMENTO!
Quando nel 1979 uscì per Vallecchi editore Il Discorso confezionato– Informazione arte cultura nella società dei consumi– nessuno poteva immaginare l’epoca odierna, la nostra vita fra la grande realtà-liquida della rete delle comunicazioni di massa e il confinamento di miliardi di persone nell’isolamento delle proprie abitazioni private. Eppure il suo studio del 1979 si concentrava sull’urgenza di analizzare il «Discorso confezionato», ovvero quel discorso finalizzato alle esigenze del sistema, costruito quotidianamente dalle comunicazioni di massa, (oggi onnipresenti anche nelle nostre mani tramite device – oggetti feticcio) dell’industria culturale e del mercato dell’informazione, fatto di parole su misura (oggi: «andrà tutto bene», «state a casa», con attori e soubrette sorridenti e giornalisti compiacenti a ripetere il mantra politico-sanitario), di immagini in serie, di miti ridotti a comportamenti prescritti.
Lamberto Pignotti, già nel 1979, denunciava alcuni aspetti evidenti del Discorso confezionato dai giornali e dagli «altri media», che tendono a scrivere un copione che si impone al linguaggio comune e impedisce di fatto la vita reale, condizionando le nostre scelte.
Pignotti immaginava un’esistenza che somigliava sempre più a una recita (e non aveva ancora visto i profili di Instagram e Facebook di finte soubrette e di eterni vacanzieri persi in aperitivi rituali) di consumatori in fila al supermarket delle idee, dove tutto diventava consumo immediato. Così le notizie, la cultura, la politica, l’arte diventava solo intrattenimento e discorso adatto a formare dei sudditi addomesticati.
Ancora in questi giorni Lamberto ci sprona a riflettere sul rapporto fra l’uomo e i suoi cinque sensi, mettendo in risalto come il confinamento e lo spostamento dei rapporti umani, tramite la tecnologia, stessero facendo mancare ad ognuno di noi quell’importante dimensione dell’intersoggettività basata sul senso del tatto. A 94 anni, giustamente, è ancora Lamberto che spinge noi a lavorare incessantemente sulla riflessione circa i problemi di oggi, per costruire la comunità di domani.
Da quando Lamberto è in Filosofia in Movimento, il nostro lavoro è aumentato in termini di qualità, di quantità e, soprattutto, si è incredibilmente ingiovanito. Per questo, l’augurio sincero di tutto il collettivo di FIM è: 94 volte, ancora, Lamberto Pignotti.
Auguri!
Aldo Meccariello, “Bocca. Ouverture enigmaticamente ovvia” (Fefé editore, 2019)
di Rosaria Catanoso
Noi siamo un corpo, non lo abbiamo soltanto. Questo è un dato incontrovertibile anche per la filosofia, che da tempo ha cercato di emanciparsi da quello che è stato ritenuto quasi un assioma inconfutabile: il corpo come “prigione dell’anima”[1]. Essere un corpo significa che non abbiamo solo degli organi, ma noi siamo i nostri organi. Quindi non abbiamo due mani, ma siamo con due mani; non abbiamo due occhi; ma siamo con due occhi; non abbiamo due piedi ma siamo con due piedi. Non a caso nel Vangelo leggiamo «Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna»[2]. Seguendo il medesimo sillogismo noi siamo la nostra bocca. Dalla bocca escono parole. Con la bocca si mangia, ci si bacia, ciò significa che noi siamo quelle espressioni, quei baci e siamo anche le smorfie che la nostra bocca manifesta. Ed alla scoperta di questo organo è dedicato l’interessante saggio di Aldo Meccariello Bocca. Ouverture enigmaticamente ovvia[3]. La bocca è l’organo apparentemente più familiare, noi siamo soggetti parlanti sin dalla nascita, e prima ancora durante la gestazione la voce della madre è la prima forma melodiosa di contatto tra l’interno dell’utero e il mondo esterno. La voce è ovunque e la bocca ne è la sua dimora[4]. Ecco perché scandagliarne le sue caratteristiche è qualcosa che ci riguarda, ci incuriosisce, allo scopo di cogliere quell’unione tra dimensione intellettiva e corporea, tra razionalità e sensibilità. Infatti come ben esprime Meccariello: «corpo e mondo si intrecciano in virtù della cavità primaria che imprime una svolta performativa al nostro corpo e ne sviluppa anche una serie di percezioni relative[5]. La bocca intercetta sensazioni gustative, caloriche, dimostrando la sua complessità; del resto è proprio l’organo che rimanda alla nostra zoe, alla nostra animalità, a quanto di più istintivo e primordiale ci caratterizza. Con la bocca si parla, si bacia, si mangia, si respira. La bocca condensa in sé il mondo legato ai sapori del gusto e ai senso delle relazioni. La bocca è l’organo performativo per eccellenza. La bocca consente a ciascuno d’uscire dal suo nascondimento, sovra-esponendoci al mondo. Infatti: «l’adattabilità della bocca alle differenti disposizioni dell’animo rivela i caratteri del trasformismo umano. Ad esempio, portare la mano al volto o coprire la bocca è il tentativo di nascondere ciò che stiamo dicendo. Bugie e verità, rabbia o invidia e gioia sono leggibili o intuibili al di là di quel che si dice con le parole»[6]. La nostra bocca non sta mai ferma, involontariamente esterna i nostri stati d’animo, sorride, comunica, seduce.
Meccariello esplora la potenza creatrice della bocca, sostenuto e sorretto non solo dalla filosofia, ma dalla letteratura, dalla psicoanalisi, dalla poesia, dal cinema, dall’arte. Consapevole che il puro pensiero non possa sufficientemente colmare quella costellazione semantica rappresentata dall’organo che rappresenta l’ingresso verso la sfera erotica ed i suoi piaceri[7]. Pensiamo alle immagini pubblicitarie, alle labbra rosse carnose che invitano le donne all’acquisto di un rossetto. Pensiamo alla tipica sigaretta Malboro che negli anni Trenta ha proposto un filtro rosso al fine di coprire eventuali macchie di rossetto. Un tentativo inefficace da un punto di vista di marketing, ma simbolico quanto perché accostava il gesto del fumo alla seducente femminilità delle labbra. Pensiamo agli innumerevoli versi che non solo la poesia, o la letteratura, ma anche la canzone ha dedicato alla bocca. Dai baci di Catullo, a I ragazzi che si amano di Prevert, non è errato – in un miscuglio eterodosso – giungere a Il bacio sulla bocca di Ivano Fossati, ed a Bocca di Rosa di Fabrizio De André. Queste fonti, diverse da quelle con le quali Meccariello traccia il suo itinerario, indicano come un percorso di tal tipo sia non solo interessante, ma nostro, vicino al sentire comune, ed alla vita di ciascuno. Una via a noi familiare. La via consente un filosofare prossimo alle altre forme dello spirito, con lo scopo di rendere uno quel pensare che prende carne e corpo attraverso la bocca. Quindi, questo circolo tra forme artistiche diverse condensa in pieno il sentiero intrapreso dall’autore allo scopo di svelare come: «per uno scrittore il bacio è il territorio perfetto dell’espressività. Per un poeta è il dono più misterioso che proviene dalla bocca che solo i versi possono rendere»[8]. Da Dante a Proust, l’autore è consapevole che attraverso la bocca si apre un mondo di esplorazioni, di desiderio, quello stesso analizzato da Freud in forma psicanalitica, nella diade madre-bambino, nella fase orale. La suzione, quale istinto primordiale, è viatico di conoscenza e di scoperta per il bambino[9].
Meccariello, infatti, scrive che «nella sua miscela di espressioni e di gestualità, la bocca diventava un variegato caleidoscopio che innescava strutture semantiche e precipue organizzazioni simboliche»[10]. Ecco che immagini e scene cinematografiche sono le fonti con le quali tratteggiare un percorso nuovo ed a tratti inusitato. Quindi il sorriso beffardo di Robert De Niro sul finale struggente di C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone, fa da contraltare all’enigmatico sorriso della Gioconda di Leonardo. Il passaggio così è tra il senso velato e manifesto nelle varie sfaccettature per le quali la bocca non è solo un segno, ma diventa cogente portato di significati. Quindi Meccariello ricorre alla celebre bocca della verità, monumento romano cosparso di leggende, storie, tradizioni, miti. Eppure su tutte, vero è che «la bocca è, infatti, la maschera che sa simulare e dissimulare, ha un suo linguaggio segreto»[11]. Verità e falsità si manifestano prima ancora che nelle parole, negli organi sensibili[12]; le riproduzioni labiali della bocca sono gesti performativi simulatori e dissimulatori. La bocca manifesta, per lo più, lo stato interno dell’anima; è il tratto più espressivo del volto; manifestando fisiognomicamente molteplici significati[13].
Interessante è il tratto conclusivo del saggio che egregiamente conduce ai significati socio- politici, di cui la bocca è intrisa. Mangiare, divorare, inghiottire sono tutti gesti che hanno anche un forte senso di dominio. E qui Canetti[14], senz’altro, diventa una guida insostituibile per sondare il mondo del potere, della distruzione, quella stessa che paradossalmente ognuno compie nell’atto di disintegrare il cibo per mantenere integro se stesso. Ma riflettiamoci un attimo in più su questo passo, andiamo all’attualità, quella cogente, che ci sta anche distruggendo. Abbiamo fagocitato ogni specie vivente, non solo per quel bisogno di nutrimento, ma il gusto del potere, della potenza. Quella stessa ora, si sta rivoltando contro: «questo suo senso duplice sigilla la trama dell’umano e del suo rovescio»[15]. Afferrati, divorati. I più impensati viventi sono divenuti cibo per i potenti, e da tale fagocitazione siamo giunti alla frantumazione di un intero perfetto equilibrio, di un meraviglioso ecosistema. L’immagine del dottor Hannibal Lecter, non è molto lontana dall’uomo famelico che divora corna di elefanti, serpenti, topi, cani, pipistrelli. Tra l’umano e il bestiale il passo è stato breve, solo che a conti fatti adesso ed essere inseriti in quel ciclo distruttivo siamo noi. Ed ora dalla bocca viene prelevata la saliva da analizzare, alla scoperta di quel virus che sta appestando il pianeta. Certo, questa è un’altra storia. Una storia drammatica e tragica della quale non siamo solo vittime, ma anche fautori. Il dominio totale del mondo ha ormai i tratti della morte, della nostra. E con bocca inorridita e tremante assistiamo al lento passaggi dei feretri.
[1] Nel Cratilo Platone propone, come aveva già fatto nel Fedone, il rapporto corpo –anima riprendendo la relazione tra le due parole “sóma” corpo e”séma” tomba, da è derivata la tradizione del corpo come “prigione dell’anima”:«dicono alcuni che il corpo è séma (segno, tomba) dell’anima, quasi che ella vi sia sepolta durante la vita presente; e ancora per il fatto che con esso l’anima semaínei (significa) ciò che semaíne(intende esprimere), anche per questo è stato detto giustamente séma (segno)». Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pp. 213-214.
[2] Mc 9,38-43.45.47-48.
[3] A. Meccariello, Bocca. Ouverture enigmaticamente ovvia, Fefè Editore, Roma, 2019.
[4] Ivi p. 49:«aprire bocca, mettere freni alla bocca senza lasciarsi trasportare dalla forza delle parole, sono espressioni ormai di uso comune, quasi come se la bocca, fosse quel “certo luogo” in cui si intima il silenzio; e ciò può essere spiegato solo ammettendo che la parola, prima che enunciato concettuale o proposizione coerente si presenta come la mimica esistenziale in cui si realizza la presenza stessa del pensiero nel mondo sensibile».
[5] Ivi p. 58.
[6] Ivi p. 12.
[7] Ivi p. 10: «le labbra dischiudono come un libro aperto intenzioni e desideri, gioia e attesa di un piacere di là da venire».
[8] Ivi p. 19.
[9] Ivi p. 30: «il bambino non viene solo nutrito, ma sperimenta le prime esperienze di piacere; è solo in una fase successiva, che la bocca non viene più utilizzata solo per la gratificazione alimentare, ma diviene un organo di conoscenza della realtà, quindi il piacere non è più legato al bisogno di essere nutrito, ma viene provocato dalla suzione di oggetti diversi dal seno, in particolare, da parti del proprio corpo, come il pollice».
[10] Ivi p. 8.
[11] Ivi p. 36.
[12] G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, tr. It. di E. De Negri, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 258: «la bocca che parla, la mano che lavora e, se si vuole, mettiamoci anche le gambe, sono gli organi attuatori e fattivi che hanno in loro l’operare come operare o l’interno come tale».
[13] In età moderna pittura e scultura traggono ispirazione dai trattati di Fisiognomica, la parola e la risata mettono in azione ogni muscolo del volto. La conformazione morfologica è messa in gioco dai moti interiori che ne modificano l’espressione. J.K. Lavater, Frammenti di fisiognomica, Edizioni Theoria, Roma- Napoli, 1989.
[14] E. Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano 1981, p. 263: «tutto ciò che viene mangiato è oggetto di potere. L’affamato si sente vuoto, e riempiendosi di cibo vince il malessere cagionatogli da quel vuoto interno. Più è pieno, meglio si sente. Gode del massimo piacere che riesce a divorare in enorme misura; il gran mangiatore».
[15] A. Meccariello, Bocca, cit., p. 110.
Agnes Heller, “Orbanismo. Il caso dell’Ungheria: dalla democrazia liberale alla tirannia” (Castelvecchi, 2019)
Dall’epidemia alla dittatura
La lettura del fenomeno Orbán secondo Agnés Heller
di Antonino Infranca
Una delle conseguenze più inattese e paradossali della diffusione del coronavirus è stata l’assunzione, in Ungheria, dei pieni poteri da parte del Primo Ministro, Viktor Orbán, assunzione dei poteri che sicuramente si protrarrà più a lungo della stessa epidemia. Altri paesi, come Tunisia, Cile, Bolivia, Filippine, Tailandia, hanno visto i rispettivi Primi Ministri o Presidenti assumere i pieni poteri, ma lo hanno fatto fissando un termine temporale – quasi sempre due mesi, quindi congruo con la diffusione dell’epidemia e il suo contrasto – oppure approfittando dell’epidemia per consolidare il proprio potere non democraticamente eletto – questo è il caso della presidente della Bolivia, Añez – o molto poco democraticamente inteso – questo è il caso del presidente delle Filippine, Duterte. Nessuno di questi paesi è in Europa, l’Ungheria, invece, è membro dell’Unione Europea. Non c’è dubbio che Añez o Duterte stiano approfittando dell’epidemia per smantellare quel poco di democratico c’era nei loro regimi e altrettanto si può dire di Orbán, soprattutto per una ragione: al momento della concessione parlamentare dei pieni poteri (30 marzo scorso) in Ungheria si erano registrati 447 casi di contagio di coronavirus e c’erano stati 15 morti. Questo è il carattere paradossale della presa dei pieni poteri da parte di Orbán, se si confrontano le poche centinaia di contagi in Ungheria e le decine migliaia di morti in Italia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra o Francia. Ma questi ultimi paesi hanno una lunga tradizione di democrazia, l’Ungheria è un paese «privo di qualsiasi tradizione democratica»[1], sostiene Agnés Heller. In realtà una democrazia sostanziale c’è stata in Ungheria dal 1989 ad oggi. Tra il 1998 e il 2002 Orbán era andato al potere, ma era ancora schierato su posizioni di centro-sinistra. Dal 2010 Orbán è tornato al potere e si è spostato sempre più a destra e dal 30 marzo scorso ha completato la sua involuzione.
La base politica di Orbán è nelle campagne, nei piccoli villaggi, mentre la sua opposizione è radicata a Budapest, che nelle ultime elezioni municipali ha eletto un sindaco di sinistra. È una tradizione della storia culturale dell’Ungheria la spaccatura tra i popolari (népiek in ungherese) e gli abitanti di Budapest, gli urbani (városok), gli uni legati alle tradizioni ungheresi più originarie, gli altri attratti dall’Occidente, spesso parlanti tedesco, ai tempi della Duplice Monarchia asburgica. Oggi questa differenza si riproduce e la sua prima vittima è la cultura occidentale: Orbán è contro ogni forma di multiculturalismo. Ha chiuso l’Università Centro-Europea, fondata dal miliardario Soros, accusata di favorire l’immigrazione dall’estero, di essere praticamente una finestra verso l’esterno.
Adesso Orbán può governare senza voto parlamentare, addirittura può sospendere leggi in atto e non indire elezioni fino a tempo indeterminato. La condizione minima per ottenere questi poteri è stata controllare i 2/3 dei voti parlamentari. L’opposizione non ha alcuna funzione e l’autocrate Orbán – si può così definire perché ha praticamente dato i pieni poteri a sé stesso – non ha alcuna sensibilità democratica per aprire un dialogo con essa, misura che sarebbe auspicabile proprio in un caso di emergenza tale come l’epidemia. In realtà, però, Orbán ha preso immediate misure non contro l’epidemia, ma contro i transgender, un’infima minoranza della società civile ungherese: solo quattro giorni dopo l’assunzione dei pieni poteri (3 aprile) Orbán ha vietato il cambiamento di sesso. Che rapporto abbia il cambio di sesso con la diffusione del coronavirus non lo sanno neanche gli epidemiologi, ma per Orbán era una misura indispensabile da prendere rapidamente. Questa misura, però, fa capire che l’epidemia, seppure inattesa, ha facilitato la trasformazione del governo Orbán in un regime che perseguita e opprime le minoranze. Tutti i regimi totalitari iniziano identificando un nemico pubblico e Orbán lo ha trovato nei transgender, quindi ha voluto dare al suo regime un’identità sessista, opprimendo una minuscola minoranza, tradizionalmente invisa alla società civile, un nemico facile da mostrare all’opinione pubblica.
Secondo la Heller l’Ungheria di oggi sta pagando gli errori fatti nel periodo di transizione dal comunismo alla democrazia, che lei elenca nella mancata formazione di un governo di unità nazionale tra i partiti più grossi, nel non pubblicare subito gli elenchi degli informatori del regime comunista – misura che avrebbe allargato le divisioni nella società civile, perché la società civile ungherese non è quella del Sudafrica che con processi pubblici seppe chiudere la triste pagina dell’apartheid – e nel non coinvolgere la società civile nella formulazione della Costituzione[2].
Il regime autocratico di Orbán si instaura in una nazione dove la società civile, che ha vissuto la fine del regime comunista come una liberazione, è sempre stata particolarmente debole, se non assente, come era, per altro, caratteristico dei paesi del socialismo realizzato. Il filosofo Tibor Szábo rileva «due tratti caratteristici negativi della cultura politica ungherese (…). L’una è l’intolleranza politica verso tutte le posizioni “differenti” e l’altra la tendenza all’esclusività, a monopolizzare certi correnti d’idee. Di conseguenza la gente non ha appreso a rispettare il pensiero altrui, e respingono, anche oggi, i punti di vista differenti, e li condannano»[3]. Orbán rispecchia la società civile ungherese in questo suo tratto di minorità spirituale e l’oppressione dei transgender trova facilmente consenso presso la società civile ungherese. D’altronde il regime di Orbán era già famoso in Europa per il rifiuto di accogliere le quote di immigrati, che l’Unione Europea divideva tra i suoi membri sulla base della propria popolazione, all’Ungheria sarebbero spettate poche centinaia di immigrati, rifiutati con la motivazione che l’Ungheria voleva mantenere la propria purezza culturale, cioè cristiana, e la propria purezza etnica – parola che nasconde l’altra più torbida, “razza”.
L’Ungheria è un paese piccolo, come lo sono quasi tutti i paesi dell’Europa centrale, con una decina di milioni di abitanti. Dal 1920, cioè dalla fine della Prima Guerra Mondiale, pezzi del territorio nazionale ungherese sono stati separati dal corpo centrale del paese e così all’incirca 2 milioni di ungheresi vivono fuori dell’Ungheria. Dal 1 gennaio 2020 il regime di Orbán permette la doppia cittadinanza agli ungheresi che vivono fuori dell’Ungheria, il che ha creato non pochi problemi con gli stati confinanti, come la Slovacchia che non ammette la doppia cittadinanza. I rapporti con i paesi confinanti che fanno parte dell’Unione Europa, cioè Slovacchia, Romania, Austria, Croazia non sono più idilliaci; con gli Stati extra-Unione, cioè Serbia e Ucraina, sono decisamente peggiorati, il che crea problemi all’intera Unione Europea.
Il collante della etnia ungherese è la lingua. L’ungherese non è una lingua indo-europea, ma ugro-finnica, cioè non appartiene alla grande famiglia delle lingue parlate dagli Urali e India fino all’Atlantico – dopo la Conquista dell’America possiamo dire fino al Pacifico. Si tratta di una lingua che ha pochi parlanti (in pratica ungheresi, finlandesi e poche altre minoranze) e, per questa ragione, dà molto orgoglio a questa minoranza linguistica ed etnica. Lo storico e politologo ungherese István Bibó commenta questa particolarità linguistico-etnica: «Nella particolare situazione dell’Europa centrale ed orientale l’appartenenza linguistica diviene un fattore politico e storico, ed è innanzitutto il fattore che presiede alla definizione territoriale nei confini esistenti e, in alcuni casi, alla formazione di nuove nazioni»[4]. Quindi dove si trova un ungherese c’è l’Ungheria. Ma ciò non vale per i finlandesi, che non mostrano alcuna identità etnica rispetto alla rara lingua che parlano.
Dunque il nazionalismo di Orbán ha un fondamento etnico e linguistico che lo rende estraneo al multiculturalismo e cosmopolitismo a cui puntano i dirigenti dell’Unione Europea e una stragrande maggioranza degli abitanti dell’Unione. L’esempio di Orbán, come tutti gli esempi di nazionalismi, non è sempre imitabile. Agnés Heller ha lanciato un preoccupato allarme: «L’”Orbanismo” non è una specialità esclusiva dell’Europa orientale, ma può servire da modello per la conquista e l’uso del potere politico in molti Paesi europei, forse nella maggior parte di essi. Il nazionalismo etnico viene erroneamente etichettato come “populismo” perché fa appello al risentimento popolare, ma, a differenza che nel populismo, il risentimento è rivolto, non contro le classi abbienti dello stesso Paese, ma contro gli “altri”, come l’Ue, i migranti e le politiche liberali, razionali e pragmatiche»[5]. La Heller ha naturalmente ragione riguardo al risentimento verso Unione Europea e migranti che fa da modello ad altri paesi dell’Unione, ma sul nazionalismo etnico la sua riflessione pare carente. La Heller riconosce che «l’identità nazionale può basarsi sulla cittadinanza, ma nel caso ungherese (e in molti casi europei) è di tipo etnico, il nazionalismo è nazionalismo etnico. Anche se non è razzismo, il nazionalismo etnico può arrivare a quel punto»[6]. E abbiamo già visto che il nazionalismo etnico ungherese si basa sulla particolarità linguistica. Ma sul problema della lingua ungherese sorge il problema tipico dell’uso linguistico oggi: conviene più parlare inglese che altre lingue minori. Infatti oggi l’inglese è una lingua diffusissima in Ungheria, soprattutto tra i giovani ungheresi, cioè gli adulti di domani, l’ungherese, come il finlandese, è destinato a diventare una seconda lingua.
A questo punto è ovvio che un’Europa delle nazioni sarebbe un’Europa dei nazionalismi, cioè il ritorno all’Europa della prima metà del Novecento che era caratterizzata dall’altissimo livello di conflittualità reciproca, perché i nazionalismi non ammettono alleanze, ma subordinazioni, cioè non ci sono alleati alla pari, ma alleati dove uno comanda e l’altro esegue.
L’unico caso in Europa dove la politica etnico-nazionalista di Orbán ha qualche parallelo è la Catalogna. Laggiù la lingua è il collante della nazione catalana e l’indipendentismo catalano si radica sul senso di appartenenza alla comunità linguistica catalana. Anche lì non mancano le contraddizioni: si parla catalano anche nella Provincia Valenciana e nelle Baleari, ma non si rivendica una separazione dal resto della Spagna. In fondo fa comodo parlare una lingua, il castigliano, parlato da circa 600 milioni di esseri umani contro una lingua, il catalano, parlato da 11 milioni di esseri umani. Il catalano è, in realtà, una seconda lingua.
Pensiamo a Orbán come modello per i nostri nazionalisti. Se tutto quanto scritto sopra sulle contraddizioni del nazionalismo etnico-linguistico è vero, allora noi italiani stiamo tranquilli: l’italiano è lingua usata dagli italiani soltanto da 65 anni, cioè dal 1954, da quando iniziarono le trasmissioni televisive; nonostante la scuola pubblica, gli italiani non usavano l’italiano nella vita quotidiana, ma oggi anche i nostri giovani – gli adulti di domani – parlano diffusamente inglese. In effetti i nazionalisti italiani non hanno mai insistito sulla lingua come collante della nazione italiana, probabilmente consci di quanto scritto sopra. I nostri nazionalisti non hanno usato l’altra arma nazionalistica di Orbán: gli italiani all’estero. Di cittadini italiani all’estero ce ne sono 5 milioni, ma di aventi diritto a chiedere la cittadinanza ce ne sono 50 milioni, cioè quasi quanti ce ne sono in Italia. Nei paesi dell’Unione Europea solo Germania e Belgio hanno una numerosa presenza di italiani, poi gli altri stanno al di là dell’oceano: in ordine Brasile, Argentina, Stati Uniti, Australia, e altri. L’Italia a differenza dell’Ungheria esporta ancora forza-lavoro: circa 130.000 italiani sono emigrati all’estero (dati del 2017, gli ultimi disponibili) in cerca di lavoro e si tratta nella stragrande maggioranza di “cervelli in fuga”. Emigrano più italiani di quanti immigrati entrano nel nostro paese. È una tradizione dell’Italia, da quando si è unita, l’espulsione della forza-lavoro e i nostri nazionalisti, difensori delle tradizioni, non se ne interessano affatto. La “fuga dei cervelli” non è un argomento dei loro programmi politici. Gli emigrati ungheresi, fuori dai confini della “Grande Ungheria”, sono emigrati per motivi politici. Tuttora l’emigrazione ungherese in cerca di lavoro è irrilevante, il regime di Orbán è in grado di offrire lavoro, altrettanto non si può dire dei nostri governi.
Dopo avere analizzato i limiti del modello di nazionalismo etnico, ritorniamo alla riflessione della Heller sul regime di Orbán. La preoccupazione maggiore della filosofa ungherese era la politica di Orbán verso l’Unione Europea. La Heller sostiene che Orbán conduce una politica di “rifeudalizzazione”: «La relazione dare/ricevere/ricambiare è infatti più vicina al feudalesimo che alla tipica corruzione capitalistica. Il governo Orbán crea la sua stessa oligarchia. La ricchezza di questa oligarchia dipende interamente dal Partito [di Orbán]»[7]; e questa ricchezza proviene in buona parte dall’Unione Europea: «È probabilmente vero che qualcosa come il 20-30% del denaro che l’Ungheria riceva dall’Ue finisca nelle tasche dei più stretti sostenitori di Orbán»[8]. Non c’è, ovviamente, riconoscenza verso l’Unione Europea, come abbiamo visto prima, anzi secondo la Heller: «Fino a che i sostenitori del nazionalismo etnico non ne avranno preso il controllo un’Ue liberale, conservatrice, socialista, rimane il nemico. Quando il nazionalismo etnico avrà preso il sopravvento nell’Ue, chi sarà il nemico degli Stati etnici? […] Il nemico di uno Stato nazionale è sempre un altro Stato nazionale. Le piccole schermaglie diplomatiche di oggi diventeranno guerre domani»[9]. Spero, ovviamente, che la previsione della Heller non si avveri e che non si arrivi alla paventata – da lei – dissoluzione dell’Unione. Ho paura di sbagliare e non faccio previsioni, ma posso constatare che finora la politica di Orbán è stata sostanzialmente anti-Unione Europea, allora perché continuare a tenerlo dentro l’Unione e non indicargli, invece, dove si trova la porta?
[1] A. Heller, Orbanismo. Il caso dell’Ungheria: dalla democrazia liberale alla tirannia, tr. it. M. De Pascale e F. Lopiparo, Roma, Castelvecchi, 2019, p. 5.
[2] Cfr. Ivi, pp. 17-18.
[3] T. Szábo, Le sujet et sa morale. Essais de philosophie morale et politique, Algyõ (Hongrie), Innovariant, 2016, p. 170.
[4] I. Bibó, Miseria dei piccoli Stati dell’Europa orientale, tr. it. A. Nuzzo, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 30-31.
[5] A. Heller, Orbanismo, cit., pp. 5-6.
[6] Ivi, p. 35.
[7] Ivi, pp. 28-29.
[8] Ivi, p. 28.
[9] Ivi, p. 8.
Luis Sepùlveda, “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” (Guanda, 2001)
“…dimenticare la barbarie umana”. Un omaggio a Luis Sepùlveda
di Francesco Sirleto
Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, un omaggio di Luis Sepúlveda all’Amazzonia minacciata di estinzione da bande di assassini armati, «pagati da criminali ancora peggiori, che hanno abiti ben tagliati, unghie curate e dicono di agire in nome del progresso». Una grande epopea che vede come protagonisti un uomo che rispetta la natura e che ama i romanzi sentimentali, una belva sofferente e vendicativa, l’immensa verde e liquida foresta equatoriale.
“All’imbrunire, l’acqua trasparente offre un bellissimo spettacolo. Pesci di tutti i colori si avvicinavano alla zattera. Enormi pesci gialli e verdi, pesci a strisce azzurre e rosse, rotondi, piccolissimi, accompagnavano la zattera fino al calar della notte. A volte si vedeva un lampo metallico, un fiotto di acqua sanguinolenta cadeva dentro la zattera e i pezzi di un pesce squarciato dal pescecane galleggiavano per un secondo vicino alla zattera. Allora un’incalcolabile quantità di pesci minori si precipitavano sui resti” (G. Garcia Marquez, Racconto di un naufrago)”.
Le ultime parole del romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, scritto da Luis Sepúlveda durante l’esilio seguito al colpo di stato in Cile del 1973, racchiudono, nella loro amara essenzialità, il senso dell’esistenza di Antonio José Bolìvar, e in particolare del suo rapporto con la natura e con gli uomini: «[…] senza smettere di maledire il gringo primo artefice della tragedia, il sindaco, i cercatori d’oro, tutti coloro che corrompevano la verginità della sua Amazzonia, tagliò con un colpo di machete un ramo robusto, e appoggiandovisi si avviò verso El Idilio, verso la sua capanna, e verso i suoi romanzi, che parlavano d’amore con parole così belle che a volte gli facevano dimenticare la barbarie umana».
L’anziano solitario abitatore dell’altrettanto solitaria capanna, situata nello sperduto avamposto (ironicamente denominato “L’Idillio”) nell’impenetrabile foresta equatoriale alimentata dal grande fiume, ha appena vissuto – ci sembra di capire – una dolorosa tragedia. Dopo un’epica caccia, nella quale è impossibile distinguere il cacciatore dalla preda, Antonio José Bolìvar ha ucciso il tigrillo, il felino che per giorni si è aggirato nei pressi dei pochi e isolati villaggi che sorgono sulle rive del fiume, seminando morte e incutendo il terrore. Tra le vittime delle sue incursioni vi erano i gringos, uomini venuti da lontano a sterminare gli animali della foresta per semplice divertimento, e i rapaci cercatori d’oro che, anno dopo anno, andavano distruggendo l’ultima area incontaminata rimasta sulla faccia della terra. Il vecchio ha imparato, durante l’inseguimento, a conoscere l’animale, a prevedere i suoi spostamenti e le sue mosse, sa che il tigrillo (una femmina) è accecato dal dolore per l’inutile sterminio dei suoi cuccioli, sa anche che il maschio giace ferito da qualche parte, nascosto nel fitto fogliame. Il vecchio ha vissuto sempre nella foresta, a contatto con gli animali e con gli ultimi indigeni dell’Amazzonia, sopravvissuti a secoli di massacri perpetrati dall’uomo bianco. Sa quindi come riconoscere e distinguere le innumerevoli voci e i suoni delle creature che popolano la sterminata, intricata e verde regione che dal grande fiume riceve il suo quotidiano nutrimento. Egli non odia la bestia, e questa non odia lui. Essa, dopo essersi vendicata dell’uccisore dei suoi cuccioli e dei suoi complici, vuole soltanto attirare il vecchio verso il luogo dove giace nascosto il suo compagno ferito e morente: la bestia esige che Antonio José ponga termine alle sofferenze del maschio e, poi, che le consenta di finire i suoi giorni. Tra i due, quasi antagonisti della stessa tragedia, si svolge un dialogo, privo di parole, sul tema universale e atemporale della vita e della morte, sulla malvagità degli uomini e sulla loro tracotanza nei confronti della natura e dei loro simili, sulla loro inestinguibile sete di dominio. Dopo che il vecchio, mosso da compassione, ha posto termine alle sofferenze del maschio ferito, deve a malincuore completare la sua involontaria missione. Sono inutili i suoi tentativi di ritrarsi: la femmina del tigrillo lo tallona assumendo le innumerevoli forme della foresta: «Davanti a lui qualcosa si muoveva nell’aria, tra il fogliame, sulla superficie tranquilla dell’acqua, sul fondo stesso del fiume. Qualcosa che sembrava avere tutte le forme, e allo stesso tempo nutrirsi di tutte. Cambiava incessantemente, senza lasciare che gli occhi allucinati vi si abituassero […]».
C’è qualcosa di epico in questa lotta, qualcosa che riproduce analoghi combattimenti di altri grandi romanzi della letteratura moderna, quali ad esempio Moby Dick di Hermann Melville e Il vecchio e il mare di Ernst Hemingway. C’è anche, tuttavia, un aspetto che nelle citate fonti non poteva ancora emergere: il senso dell’inesorabile e sciagurata distruzione della natura, operata con insensatezza e protervia, frutto di quella logica di dominio manifestatasi nell’incredibile progresso scientifico e tecnologico ma che, tuttavia, sta conducendo l’uomo contemporaneo a dilapidare tutte le risorse del pianeta. Ci sono soltanto due modi – e in ciò sembra consistere il messaggio contenuto nel titolo del libro di Sepúlveda – per uscirne o, per lo meno, per tentare di ridurre il ritmo di questa folle corsa verso l’autodistruzione: la cultura e l’amore o, se preferite, la cultura dell’amore o, ancora, l’amore per la cultura e per tutte quelle cose che, per la loro bellezza, a volte riescono a far «dimenticare la barbarie umana».
Gherardo Colombo, “Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla” (Ponte alle Grazie, 2013)
di Barbara Petrone
Il buio di queste giornate ci consegna una realtà dinnanzi alla quale ciascuno di noi si trova profondamente impreparato: la compressione di alcune libertà fondamentali, seppur giustificata da motivi di sanità e sicurezza, – costituzionalmente idonei a limitare la libera circolazione dei cittadini (art.16) – pare oggi un sacrificio spropositato alla maggior parte dei suoi destinatari.
La quasi incontrollata diffusione del nuovo COVID-19 sorprende chi parlava di “semplice influenza”, paralizza i più anziani, gli immunodepressi e, infine, mobilita chi vive ogni giorno privato della libertà personale: le fiamme sul carcere di San Vittore sono il simbolo di un mondo sommerso che disperatamente si aggrappa alla rivolta, per non essere cancellato. Se le prime reazioni hanno avuto ad oggetto le misure adottate per prevenire la diffusione del contagio tra le mura circondariali (interruzione dei colloqui con l’esterno), i successivi – e in alcuni casi drammatici – sviluppi hanno riacceso la luce su un tema a lungo insabbiato. Il sovraffollamento degli istituti di pena italiani è da anni il cancro di una società civile sempre più innamorata del giustizialismo di narrazione mediatica e sempre più ansiosa di ingannare le emergenze – reali o fittizie – con nuove pene, nuovi processi, nuovi imputati. Non si tratta di slogan radicali, ma di una situazione di concreto pericolo per quell’umanità già costretta a pagare i propri sbagli con il prezzo altissimo dell’inadeguatezza del nostro sistema penitenziario. Lo stesso presidente dell’Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, avverte che: “Siamo di fronte al rischio di un’epidemia esplosiva, a un 130 per cento di sovrappopolazione carceraria di media. Significa che ci sono istituti penitenziari che hanno una sovrappopolazione del 150-160 per cento, e non ci sono strumenti sanitari adeguati interni alle carceri. E allora, rispetto ad un’epidemia occorre capire come prevenire l’esplosione di una bomba atomica sanitaria che ricadrebbe sull’intera comunità.”
E’ così che lo stato emergenziale dichiara guerra alle politiche del passato: da un lato si pagano le spese di una sanità pubblica violentata per anni, mentre dall’altro si cerca di capire perché, malgrado la sentenza Torreggiani, la sensibilità politica del nostro Paese non sia arrivata ad una rottura drastica rispetto ai “trattamenti inumani e degradanti”, di cui i nostri istituti di pena sono palcoscenico.
La lettura del libro di Colombo sembra, a questo punto, la chiave perfetta per non trascinarsi senza senso nel mondo chiuso delle nostre case e non distrarsi troppo da ciò che accade altrove. Il “Perdono responsabile” è qui assunto a simulacro di una cultura possibile, in grado di rimettere in discussione l’immaginario della retribuzione, ove la sanzione risponde alla devianza senza tuttavia proporsi di correggerla. E’ la cultura della riparazione, che, allontanandosi dal polo unico della proporzionalità tra reato e pena, si sviluppa più complessamente attorno all’idea di una “giustizia senza spada”. Quest’ultima offre al reo la possibilità di “ricucire” la frattura che le sue azioni hanno cagionato alle relazioni sociali, e lo fa attraverso un coinvolgimento attivo della persona offesa.
“Perché il carcere non serve a nulla” è un sottotitolo inequivocabile, che non lascia interrogativi tra parentesi e, al più, consegna alle pagine successive il compito – certo ostico, tanto più per un ex magistrato – di spiegare contraddizioni, storture e fallimenti veri e propri della pena detentiva. Un’indubbia provocazione, lanciata nel tentativo di ricondurre la dignità umana al centro della speculazione sulla giustizia.
Se dal punto di vista etico questa sensibilità incontra un pubblico ristretto, dal punto di vista linguistico, il pregio è quello di una fruibilità volutamente ampia: è attraverso una scrittura asciutta, spogliata di ogni infiorettatura, che queste pagine propongono una visione decisamente rivoluzionaria della pena e della responsabilità che il perdono esige, da parte di tutti i suoi interlocutori.
Passando attraverso le letture di Von Spee, Locke e Beccaria, Colombo analizza le tappe di un percorso giuridico che, per espungere dall’orizzonte metodologico torture e supplizi, ha dovuto attendere il pieno affrancamento dei concetti di “reato” e “peccato”. E neppure la sofferta affermazione dell’individuo “come dignità, e perciò come autonomo e originario portatore di diritti intangibili” (pag. 40) – epilogo delle tragedie umanitarie consumatesi nel corso delle guerre mondiali- era servita a stralciare la retribuzione, retaggio di una cultura incompatibile con la “nuova” funzione rieducativa della pena. Una funzione formalmente esistente, ma sostanzialmente tradita dall’impietosa realtà delle carceri.
L’ultima pagina lascia con sé la consapevolezza che il perdono esige non solo mezzi efficienti, ma anche recettori predisposti a compiere un gesto così laicamente rivoluzionario. Ma, in una società sorda persino al principio di civiltà giuridica insito nella prescrizione, quale speranza rimane a chi sta già scontando la propria pena? Siamo già troppo coinvolti da questo clima di disconoscimento dell’altro, o possiamo ancora tornare indietro?
“Si era alla fine percepito che tali terribili eventi erano dipesi da un generale disconoscimento dell’altro: non si può fare la guerra se ci si riconosce nello straniero; non si possono uccidere programmaticamente ebrei, zingari, disabili, omosessuali e avversari se non li si considera dissimili in radice, se non si disconosce loro di far parte dello stesso genere umano nel quale ci si identifica; non si può sganciare una bomba atomica su una popolosa città se prima non si disumanizzano i suoi abitanti.” (Pag. 40)
Abbiamo davvero bisogno di nuove tragedie, prima di essere pronti a perdonare responsabilmente? Certo, è lecito augurarsi che la sensibilità rieducativa abbracci ognuno di noi, quando riabbracciarsi sarà possibile, perché questa parentesi storica possa servire a non ripetere gli errori politici, economici ed umanitari del passato.
Pascal Chabot, “Il robot filosofo” (Castelvecchi, 2017)
La riflessione di Pascal Chabot circa il tema del rapporto uomo-macchina, al di là della semplicistica polarizzazione tecnofobia/tecnofilia, si sviluppa a partire da un breve dialogo filosofico in cui i protagonisti sono da una parte i “filosofi” e dall’altra un chatbot (una macchina in grado di conversare). La commissione esaminatrice è chiamata a stabilire se il robot è stato programmato adeguatamente per entrare nella “confraternita dei filosofi”.
Luciano Floridi, “Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale” (Raffaello Cortina, 2020)

di Carlo Crosato
(Università di Venezia)
L’interrogazione intorno a cosa sia la filosofia ricorre frequente in molti pensatori: ci si interroga su cosa significhi praticarla, sulla natura troppo accademica di alcune questioni, sull’opposto eccessivo annacquamento divulgativo, sulla funzione degli intellettuali, a volte chiacchieroni altre volte muti, spesso rinserrati nella loro Torre d’avorio. L’innovazione delle riflessioni di Luciano Floridi intorno alla “quarta rivoluzione” e all’“infosfera”, però, attribuiscono alla sua interrogazione sulla natura della filosofia grande potenziale provocatorio e rara unicità.
Il libro Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale è la traduzione di parte di un’opera più voluminosa, pubblicata in inglese nel 2019 e pensata come il terzo volume di una tetralogia sui fondamenti della filosofia dell’informazione. La sua pubblicazione in Italia segue la traduzione, sempre a cura di Raffaello Cortina, del volume La quarta rivoluzione, in cui si propone lo studio dell’impatto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul nostro mondo.
Copernico ha tolto la Terra dal centro dell’universo; Darwin ha rivelato le umili origini dell’homo sapiens privandolo della sua posizione privilegiata nel mondo dei viventi; Freud e, più di recente, le neuroscienze hanno messo in crisi la presunta sovranità del soggetto sulla propria vita interiore. Oggi le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno investito in poco tempo ogni dimensione della nostra vita, dalla quotidianità alle istituzioni, su scala microscopica o su scala macroscopica, colmando ogni possibile anfratto in maniera così efficiente che ormai ci siamo abituati a considerarle come i normali strumenti di interazione con il mondo e con gli altri; ma proprio questa abitudine e la funzionalità con mediano il nostro mondo relazionale ci rende tali tecnologie difficilmente apprezzabili nella loro essenza di vere e proprie forze ambientali, antropologiche, sociali e interpretative. Esse rappresentano un fattore di mutamento nelle prerogative dell’uomo sulle realtà naturali e artificiali che lo circondano, impossibile da slegare dagli effetti inerenti il rapporto dell’uomo con se stesso, con la comprensione che ha di sé e della propria storia. Uno snodo rivoluzionario, che conforma la relazioni umane su un registro non più – o non solo – politico o economico, ma anche e prima di tutto informazionale e comunicativo; e questo orizzonte necessita di una filosofia all’altezza per poter essere compreso e abitato, se non si vuole piombare in una inversione di ruolo fra servo e padrone in senso hegeliano.
«Non siamo enti isolati e unici, quanto piuttosto degli organismi, il cui sostrato è informazionale (inforgs), reciprocamente connessi e parte di un ambiente costituito da informazioni (infosfera), che condividiamo con agenti naturali o artificiali simili a noi sotto più profili». La quarta rivoluzione sulla cui soglia ci troviamo contribuisce a sua volta a togliere all’uomo la presunta centralità che un ingenuo umanismo gli vorrebbe spacciare; ma questa perdita di unicità e di centralità è, insieme, un impoverimento e un arricchimento, costringendoci a adottare una prospettiva consapevole, attiva, sollecita nella relazione con l’altro. Ci troviamo in un momento di fondamentale mutamento storico, afferma Floridi, e la filosofia deve sincronizzarsi con gli eventi e forgiare gli strumenti semantici adeguati per descriverli con consapevolezza. Pensare l’infosfera, prendendo molto sul serio questi elementi trasformativi, ambisce a ridestare l’attività filosofica, i suoi strumenti e i suoi obiettivi, gettando le basi per un rinnovamento intellettuale dell’etica, dell’estetica, dell’epistemologia.
La filosofia, paragonata a un computer piantato, secondo l’autore va riavviata e rimessa al lavoro su simili questioni, se si vuole che essa conservi un senso e un ruolo. E un senso e un ruolo irriducibili la filosofia ce li ha da sempre, con la sua capacità di relazionarsi con l’attuale in maniera problematica, o, come dice Floridi, ponendo domande aperte, impossibili da affrontare in chiave empirica o logico-matematica. La filosofia si è sempre proposta e dovrà continuare a proporsi come una postura problematica: anche a seguito di osservazioni o calcoli, anche dopo che ogni formulazione sarà stata ben strutturata, e dopo che ogni tema e concetto saranno stati chiariti, gli interlocutori che praticano la filosofia dovranno accettare la possibilità di ritrovarsi in una condizione di perdurante disaccordo. Non un ottuso muro contro muro, bensì un disaccordo informato, razionale e onesto, ma potenzialmente non ricucibile, se non in quel dato minimale consistente nella necessità di continuare a sostare in quell’apertura discorde. E tuttavia, perché il domandare filosofico non si riduca a un barocchismo fra filosofi, pur concentrandosi su questioni fondamentali esso non potrà pretendere di abbracciare il reale in senso assoluto: il debito che, secondo Floridi, la filosofia contemporanea e del futuro dovrà riconoscere a Alan Turing deriva soprattutto dall’aver compreso l’urgenza di attribuire legittimità al disaccordo – altrimenti derivante dall’incomprensione reciproca e fonte di confusione – attraverso l’identificazione e il chiarimento di livelli di astrazione, capaci di offrire il corretto punto di vista a partire dal quale affrontare la domanda e attendersi risposte ragionevoli e produttive.
L’idea di Floridi è che, assunti questi presupposti tutt’altro che semplicemente metodologici, la filosofia possa ripensarsi come un’impresa costruttiva, coordinata al presente in cui viene praticata grazie all’inquadramento delle proprie domande entro livelli astrattivi concordati. Non si tratta semplicemente di un appello ai filosofi a una maggiore responsabilità nei confronti della loro contemporaneità; passando attraverso lo stesso contesto informazionale e tecnologico che è chiamata a indagare, la filosofia riscopre se stessa come una pratica relazionale e come studio della relazione, in cui metodo formale e oggetto indagato coincidono in un curioso isomorfismo.
La rivoluzione dell’infosfera è un’occasione: essa contribuisce al decentramento dell’uomo e dell’ego, collocandoci costantemente in una periferia da cui poter meglio osservare la galassia relazionale che ci coinvolge; ma il digitale è, secondo Floridi, anche un’occasione per superare alcune narrazioni politiche legate a ideologie o vecchie strutture sovranitarie, per individuare strumenti economici ed ecologici adeguati; il digitale aiuta l’analogico non rimpiazzandolo, ma permettendo di ottimizzare le risorse; perfino in campo etico, l’allargamento degli strumenti dovuto al digitale permette di concentrare l’attenzione sul destinatario, adeguando a esso l’azione, la cura, la parola. D’altra parte, la rivoluzione dell’infosfera implica anche una sfida, consistente nell’abbandono di ogni velleità metafisica assolutistica, nell’assunzione delle più promettenti novità metodologiche e tecniche proposte dal digitale, e nella definizione di soluzioni efficaci nella complessità che solo l’apertura tipica della filosofia sa affrontare.
“Costruttivismo” e “design concettuale” sono le parole che Floridi usa per descrivere questo rapporto, al contempo di avvicinamento e di gestione, tra la filosofia a venire e le tecnologie informazionali e comunicative. Per agganciare questa novità, Floridi propone di tornare al punto in cui, con Platone e la sua separazione del sapere e della tecnica, il pensiero occidentale ha preso a interpretare la propria conoscenza del mondo privilegiando il punto di vista dell’utente, di chi usa l’oggetto, di chi lo scopre e ne disvela la verità intrinseca, relegando in secondo piano la conoscenza di chi quell’oggetto, quella verità, quel concetto ha forgiato. Invertendo la tendenza, Floridi pone l’accento sul valore irriducibile del sapere come costruzione, e non come mera fruizione mimetica: la conoscenza, lungi dall’essere adeguamento del soggetto all’oggetto, va ripensata come vera e propria tecnica della formulazione di domande e della ricerca di risposte efficaci. Qui sta la pretesa, secondo Floridi assente in gran parte della filosofia da Platone in poi, di vivere attivamente la filosofia, come una vera ingegneria concettuale, che monta e smonta i problemi, sempre con l’urgenza di collocarsi dentro un contesto reale.
Ciò che sembra legittimo chiedersi è se una filosofia come quella suggerita da Floridi, così presa dalla propria operatività, dall’efficacia e dall’utilità delle risposte che è chiamata a dare, sia in grado di dar conto di se stessa e del contesto in cui opera. L’isomorfismo tra l’ambiente informativo e la prassi filosofica che Floridi consiglia è senza dubbio il motivo per cui si può ben sperare che la filosofia dell’informazione saprà aderire all’impresa digitale e consigliare il migliore uso degli strumenti in vista dei fini da raggiungere; ma tale isomorfismo rischia di trasformarsi nell’incapacità di mantenere aperte domande non immediatamente rilevanti, e di trascendere in maniera davvero filosofica il “tutto pieno” che la quarta rivoluzione edifica attorno a noi. Il rischio è quello di trasformare la filosofia in consulenza tecnico-ingegneristica, in predisposizione di mezzi in vista di fini la cui elezione e i cui significati rimangono difficili da problematizzare. Insomma, se il metodo filosofico, più che trascendere, è in funzione di una saggia transizione avviata già altrove, se l’armamentario che la filosofia utilizza è mutuato dall’oggetto che essa è chiamata a pensare, se lo stesso lessico – design, capitale semantico coerente, efficienza, prestazione – è affratellato alle dinamiche contemporanee, il pericolo che la filosofia divenga conferma di un esistente appena ritoccato rimane un problema che la filosofia di Floridi dovrà dimostrare di saper affrontare.
In un passaggio del suo libro, sostenendo la sua prospettiva del costruttore, Floridi parafrasa Austin, sostenendo che “facciamo cose con le informazioni”; e proprio perché sappiamo come fare possiamo ambire a sapere che. A proposito, tornano alla mente i lavori di Michel Foucault sulla parrhesia, la prassi cinica del parlare francamente, come attività di vera critica filosofica e rottura con il presente: Foucault presenta la parrhesia come un’attitudine speculare all’atto discorsivo di matrice austiniana, essendo quest’ultimo conservazione delle funzioni che a ciascuno vengono imposte nelle varie situazioni, laddove il cinico sa tagliare il presente in maniera obliqua trascendendo le condizioni fattuali e materiali, e sa perturbare tali condizioni irrompendovi con un atto di incoerenza, mostrando così la contingenza degli armamentari semantici in uso e la fragilità delle condizioni pragmatiche in funzione. Fra le molte trattazioni su che cosa sia la filosofia di cui si è detto all’inizio, si può scegliere di rileggere quella di Deleuze e Guattari, in cui, proprio in relazione a Foucault, viene proposta la distinzione tra presente e attuale: «L’attuale non è ciò che noi siamo, ma piuttosto ciò che diventiamo, ciò che stiamo divenendo, ossia l’Altro, il nostro divenir-altro. Il presente, al contrario, è ciò che siamo e proprio per questo, ciò che già non siamo più». La filosofia di Floridi, così avvertita di quanto le avviene attorno, sa calarsi nel presente e ancorarsi nel reale, immedesimarsi con essi e, appunto in termini immanenti, riordinarne gli elementi. Saprà essa rivelarsi anche “attuale”, e perciò intempestiva non solo rispetto alla vecchia filosofia ma anche alle nuove dinamiche tecniche? La filosofia non serve perché non è serva: saprà la filosofia dell’informazione contraddire il presente e aprire spazi di possibilità e critica, o si rivelerà uno strumento troppo immanente alle dinamiche presenti per poterle riconsiderare dalla giusta distanza?
Antonino Infranca, “Tecnecrate” (Castelvecchi, 2019)
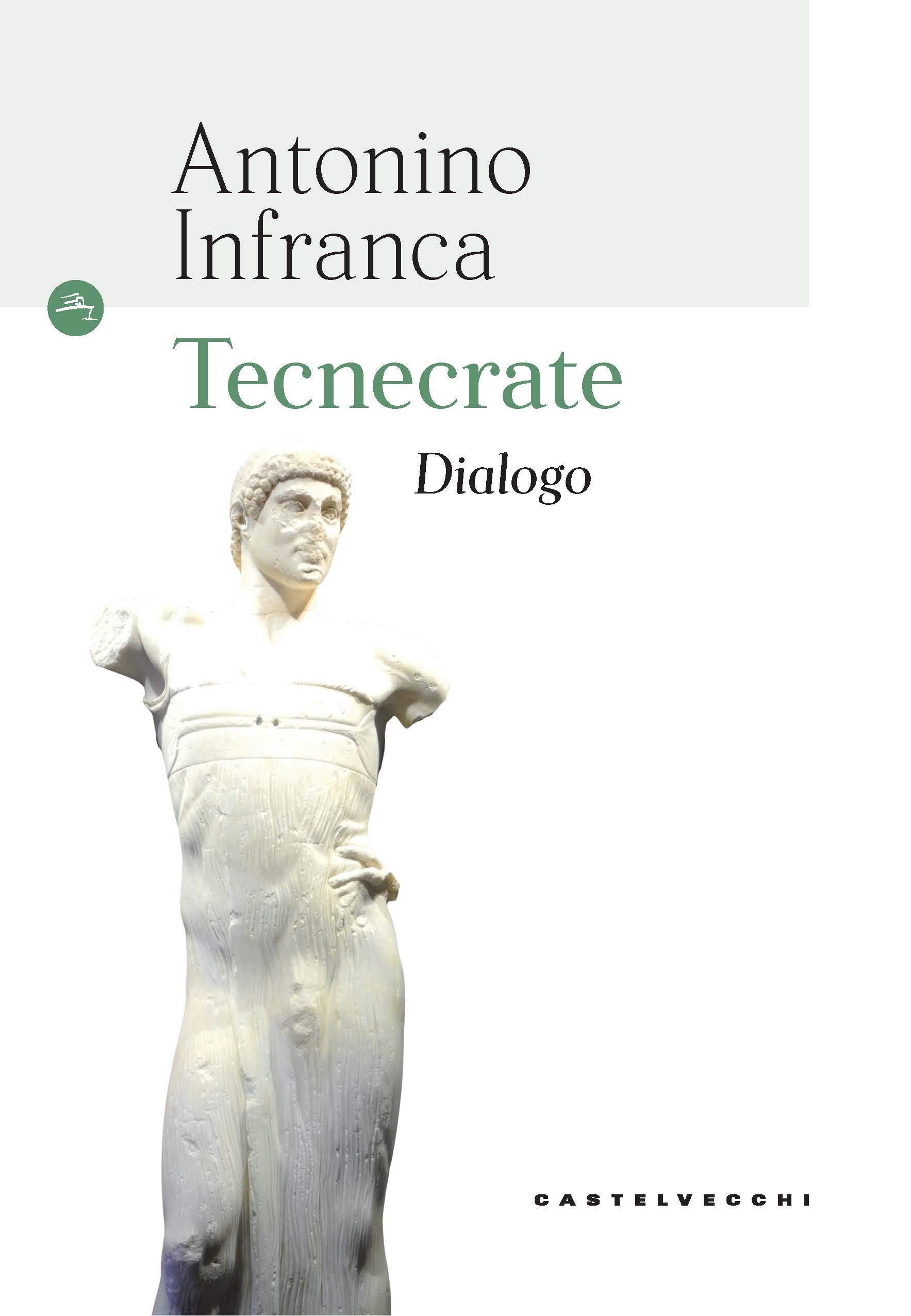
di Francesca Giammei
Siracusa, IV secolo a. C.
Ma anche qui e ora. O da qualche parte nel futuro.
Tecnecrate di Antonino Infranca (Castelvecchi, 2019) è la storia di un dialogo: Theoutimene (“ciò che rimane di Dio”), figlia del tiranno Dionigi, interroga e ascolta Tecnecrate (in greco “potere dell’arte”), vecchio mendicante cieco, desiderosa di conoscere la storia della sua vita (e però – scopriremo – della vita di entrambi): fenicio per nascita, greco per scelta, offende e si inimica gli dèi di ambedue le culture; si punisce togliendosi la vista al cospetto proprio del tiranno Dionigi, ma è così che diventa – e forse solo così che può – ciò che è e che vuole essere, ormai libero anche dal suo tragico destino, ribelle e rivoluzionario, con grazia e calma e in un’immobilità soltanto apparente.
Quanto tempo occorre per raccontare una vita tanto piena? E per quanto i due si intrattengono a parlare? Il tempo del racconto si fa via via quasi incomprensibile e si dilata avvolgendo il lettore nella dimensione e nel ritmo della storia: è un libro che si fa leggere più di una volta, prima tutto d’un fiato fino ad arrivare alla preziosa postfazione dell’autore stesso, e poi ripartire di nuovo da lì per cogliere le sfumature perse, oppure un po’ alla volta come è stato scritto e poi ancora a pagine sparse, non più per comprendere ma per sentirsi compresi.
L’opera – a metà tra la saggistica e la narrativa – consegna le chiavi di accesso ai tanti argomenti trattati come un buon saggio e però anche lascia i dubbi tipici di una riuscita narrazione: Tecnecrate è davvero anche il Tecnecrate che ci è sembrato di (ri)conoscere? Quando si incomincia o si finisce di essere Theoutimene? È possibile sentirsi entrambi? Le allegorie e le metafore sono tutte opera dall’autore o a tratti alcune sempre diverse di chi legge?
Tecnecrate è un libro che educa all’attesa, alla comprensione e – attraverso la cecità di lui – alla realizzazione e al superamento della nostra: è una climax ascendente verso l’emozione, la commozione e la sensibilità dell’autore, che maturano e si svelano insieme alla lettura e ai personaggi. Così, ad esempio, Tecnecrate non nasce omosessuale dalla penna dello scrittore né lo diventa per sua volontà, ma con naturalezza rivela la sua natura, attraversando le categorizzazioni e le tradizioni che lo costringono per la necessità di liberarsene, arrivando ad essere insieme maschile e femminile o nessuno dei due o essere e basta. Allo stesso modo Theoutimene compie la sua missione di personaggio e di persona, raggiunge la sua consapevolezza e fierezza di donna, e chiude il racconto adempiendo a sé stessa e mescolandosi con Tecnecrate come con la di lui terra natia prima di morire. In noi forse dunque insieme è, può essere o deve l’uomo e la donna, l’umano e il divino; in noi è il “potere dell’arte” e allo stesso tempo siamo però tutto “ciò che rimane di Dio”. E “custodi della bellezza”, in un’epoca storica che, pagina dopo pagina, fatichiamo a identificare come successiva o precedente a quel IV secolo a.C., e da quella piazza di Siracusa, vicini o lontani.
“- È giusto. Vado. Ma rispondi, Tecnecrate, a un’ultima domanda: perché secondo te, che sei stato spesso al centro del pensiero divino, gli dèi hanno scelto proprio me per conservare e tramandare la tua storia?
– Perché sei una donna, la lingua negata dagli dèi e dagli uomini. Tu, dunque, sei il greco e il fenicio e ogni altro idioma del mondo.”
Emanuele Severino, “Téchne. Le radici della violenza” (BUR, 2010)
Ciò che Severino vuole comunicarci è questo: anche il marxismo, così come il cristianesimo, così come tutte le dottrine che si presentano come antitesi o come proposte di superamento del nichilismo, in realtà non sono altro che diverse manifestazioni di quella estrema follia che ha ridotto gli enti a nulla, consegnandoli così all’illimitata e incontrollabile dominazione e manipolazione, per l’esercizio della quale la Tecnica mette a disposizioni strumenti sempre più efficaci. “Ancora nel libro primo del Capitale – prosegue Severino – Marx scrive che il lavoro evoca le cose dal regno dei morti, cioè dal regno del niente”, esprimendo con parole leggermente diverse ciò che già Platone affermava nel Simposio: “Ogni causa che faccia passare una qualsiasi cosa dal niente all’essere è produzione (poiesis), cosicché sono produzioni anche i lavori che vengono compiuti nell’ambito di ogni tecnica, e quindi anche tutti i lavoratori (demiourgoi) sono produttori.