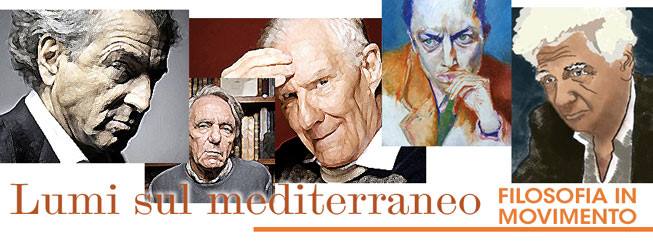Quando il governo senza pluralismo attacca la libertà religiosa
Quattro notizie apparentemente slegate tra loro hanno contraddistinto la fine del 2015. Subito prima di Natale, il Parlamento greco ha approvato la proposta Tsipras per estendere la regolamentazione della convivenza anche tra persone dello stesso sesso, nonostante la forte opposizione della Chiesa Ortodossa. Appena pochi giorni addietro, in Slovenia gli elettori hanno bocciato, con quasi i due terzi dei voti validi, la legge nazionale in materia di unioni tra persone dello stesso sesso e adozione da parte degli omosessuali. Ancora nei discorsi di auguri, tra Natale e la fine dell’anno, il Premier inglese Cameron aveva ribadito un concetto che ha spesso espresso, anche in modo più diretto, da almeno un anno e mezzo a questa parte: l’inscindibile legame tra l’identità britannica e la tradizione cristiana. Per quanto riguarda gli scenari al di fuori del Vecchio Continente, grosso risalto ha avuto, nella medesima settimana, il rinvenimento di una fatwa che autorizzerebbe il traffico d’organi (degli infedeli) a fini di finanziamento dello Stato islamico e delle sue azioni rivendicative dentro e fuori i confini medio-orientali. C’è di che rabbrividire. Per tutte e quattro le notizie che potremmo e dovremmo ascrivere all’ambito tematico “diritto e religioni”. E che, tutte e quattro, potrebbero benissimo figurare alla voce “malintesi su libertà politiche e religioni”. In Grecia, la crisi sociale è ancora molto forte. Come, con acuti meno gravi, lo è in Italia, nonostante la debole ripresa. Il risultato è persino ovvio: dopo anni di recessione, di contrazione della spesa sociale in Stati tradizionalmente assistenziali, non è un lieve sblocco dei dati macroeconomici a ridipingere tutto di rosa. Perciò, mentre suscita un qualche apprezzamento che la proposta di Tsipras sia proceduta indipendentemente dalle pressioni esterne alle aule parlamentari, non è senza significato che molto elettorato di Sinistra (anche ben al di là del vecchio ed esangue PASOK) cominci a chiedersi dell’utilità della riforma. Quando altri temi -lavoro, previdenza sociale, processo civile e penale, questione sanitaria – richiederebbero ben maggiori sforzi di quelli di un governo, obtorto collo, votatosi all’attuazione “umana” dei memorandum finanziari europei. Tsipras si è imposto come rappresentante di una nuova Sinistra, molto più evoluta della tradizionale socialdemocrazia, ma per molti profili ne rappresenta la continuazione con altri mezzi. L’elettorato giovanile di Tsipras ha certo in mente il tema dei diritti civili ben più di tanti vecchi militanti del Partito Comunista Ellenico: era perciò inevitabile che la legittimazione sociale di Tsipras passasse anche per il riformismo sui temi civili. I quali, del resto, possono ridistribuire benessere sociale, almeno dal punto di vista delle aspettative dei cittadini (meno, nell’immediato, sulle concrete condizioni di vita). Bisognerà vedere bene questa riforma in quale disegno si inserisca. Se in un piano di riassetto del diritto di famiglia, al di fuori dei tradizionali rapporti tra lo Stato greco e la Chiesa ortodossa, o se da “distrattore” rispetto a temi sui quali la convergenza parlamentare sarebbe molto più difficile. In altre parole: in Grecia in questo periodo è molto più semplice varare norme promozionali a favore delle unioni omosessuali che non piani di riorganizzazione dei livelli amministrativi decentrati. E questo in parte svilisce anche il buono che c’era nella proposta Tsipras, dandole il timbro di provvedimento (apparentemente) a costo zero, (ma) in attesa di tempi migliori. Sono ragioni intrinseche non troppo dissimili da quelle che hanno reso largamente prevedibile il voto sloveno. Anche qui le responsabilità dei “vecchi” partiti socialdemocratici, e non solo, sono purtroppo visibili. L’Europa dell’Est è sospesa tra secolarizzazione e riscoperta religiosa, tra istanze comunitarie ed innesti favorevoli a concezioni “spinte” dell’economia di mercato. Lo è da almeno due decenni. Il ruolo dei partiti socialdemocratici doveva consistere nell’apertura alla laicità (contro il modello ateistico e contro le tentazioni confessionali particolaristiche) e all’economia sociale di mercato (contro il capitalismo di Stato e il facile asservimento ai grandi interessi economici zonali). Obiettivi sin qui falliti, se si guardano le legislazioni nazionali di molti Stati della medesima area. Ci sono riforme che nessun politico può pensare di introdurre senza essersi misurato col complessivo cambiamento delle agenzie di formazione e rappresentanza politica. Nessuna coalizione politica oggi attiva in Slovenia avrebbe mai la stessa maggioranza dei contrari alla legge sull’adozione e sulle unioni omosessuali. È un dato che fa riflettere. Se si voleva riformare, si è corso troppo o si è corso “male”. In un territorio piccolo e con ancora percepibili discriminazioni sociali, la tutela dei diritti di libertà non può essere percepita come prioritaria rispetto alla difesa delle forme tradizionali dell’appartenenza. Procedendo come ha fatto il legislatore sloveno, resta invece la sensazione di una scissione innaturale: tra una società evoluta, progressiva, aperta (circa il 40% degli elettori ha votato a favore della legge), e comunque minoritaria, e le afflizioni materiali che sono trasversali alle appartenenze tradizionali, ma che in esse si sentono meglio rappresentate. Questo meccanismo è ben noto a Cameron, che sta dimostrando di saperlo applicare con machiavellico pragmatismo. Lo ricordiamo al tempo della sua prima campagna elettorale. Era il volto trash dei Tories: velatamente favorevole all’abbandono delle posizioni proibizioniste dei conservatori, sostenitore di politiche di libero mercato più aggressive di quelle di Brown (e in parte di Blair). In cinque anni la sua comunicazione ha cambiato pelle. Non doveva stravolgere, doveva stravolgere gli altri, quando ad esempio ha coinvolto i liberaldemocratici, determinandone l’esilio dall’immaginario collettivo, nella discussa riforma sulla tassazione universitaria. Cameron ha abbandonato anche l’idea della “big society”: ha sottratto pluralismo, ha aggiunto sussidiarietà. Scambio di livelli tra pubblico e privato, ma un privato sociale fortemente custode del galateo istituzionale (compresa la tradizione religiosa cristiana e le istituzioni giuridiche che essa ha portato anche in una società secolare come quella inglese). Il successo politico è evidente, meno le prospettive di durata. Come si riarticolerà, qui e ora, la presenza di immigrati di fedi e culture diverse in un Paese che ha pur sempre un tessuto normativo di tradizionali, ampie, garanzie, ma che a parole sembra sempre meno ospitale, sempre sul punto di restringere più che di allargare? Davanti ai diritti civili adoperati come scorciatoia dubbia a riforme radicali (Grecia e Slovenia) e all’identità tradizionale – anche religiosa – collettiva usata come perimetro dell’azione politica (Gran Bretagna), sta da perfetto antagonista cinematografico il cruento e truce ghigno del fondamentalismo armato. Elargendo dottrine che il Corano non sembrerebbe ammettere in alcuna misura. Trafficare le interiora degli apostati, però, non costituisce un aggiornamento delle peggiori (o migliori) dottrine belliciste. È, purtroppo, pure peggio: è mero calcolo. È certezza di avere individuato e, perciò, consentito un settore di elevata e immediata lucratività. Tutto quello che ci aiuta è autorizzato a distruggere gli altri. In tutta evidenza, perciò, il problema non è quello della (ri)conduzione della religione a mero fatto privato, ma di pluralismo (negato) del discorso politico. In questo senso, il 2015 è buon candidato al ruolo di annus horribilis.