Introduzione
Il dibattito sulla crisi della sinistra è in corso da anni, così come da anni sono sotto gli occhi di tutti le tendenze che certificano questo declino, basti analizzare a questo proposito gli andamenti elettorali della maggior parte dei partiti socialisti e socialdemocratici europei degli ultimi anni. Tuttavia, quando si entra nel vivo del confronto attorno alla diagnosi di questa crisi e alle terapie per uscirne, emergono ancora letture contrastanti e dissensi di fondo, che investono la questione stessa del senso di una sinistra oggi: quale deve essere la sua funzione nelle società contemporanee, quali le pratiche che devono caratterizzarla, quali i suoi soggetti di riferimento, i suoi programmi, le strategie per invertire la rotta di questa parabola di declino.
Sono tutte questioni molto complesse, che rinviano, in ultima istanza, alla questione della cultura politica della sinistra. È oggi tesi ampiamente condivisa quella secondo cui all’origine dell’attuale crisi della sinistra – e quindi, anche, della scarsa qualità dei suoi ceti politici e della sua perdita di radicamento tra i ceti popolari – ci sia lo smarrimento, dopo l’89, di una cultura politica critica di riferimento, capace di dare anima e identità alla sinistra, senso della sua missione storica e normativa, nonché credibilità e attrattività. Con cultura politica di riferimento intendo qui, in termini molto ampi, un orizzonte culturale e valoriale capace di orientare l’azione politica concreta, di indicarle senso e direzione, di discernere interessi e soggetti a cui riferirsi in via primaria, di leggere da un punto di vista determinato (per esempio, quello dei ceti subalterni) le trasformazioni sociali del proprio tempo, ma anche di qualificare lo stile dell’azione politica, di strutturare un campo politico e un’identificazione simbolica, di mobilitare impegno, passioni e immaginazione, di dare forma, articolazione politica e una rappresentazione capace di egemonia a bisogni, istanze, sentimenti di malessere e rabbia sociale.
Da dove ripartire, quindi, per ridefinire e rinnovare la cultura politica di una sinistra capace di futuro nel XXI secolo?
Non appena si solleva questa domanda, si affacciano dissensi di fondo, ma anche ambivalenze e opacità, che fanno comprendere come il lavoro da fare su queso tema, anche su un piano strettamente teorico, sia ancora molto grande. Se oggi sempre più voci concordano sul fatto che il primo passo di un rinnovamento delle cultura politica della sinistra deve essere quello di operare una soluzione di continuità nei confronti della cosiddetta Terza Via propagandata da Blair, Clinton e dalla maggior parte dei partiti socialdemocratici negli anni Novanta, il dibattito è oggi più che mai aperto sulle modalità concrete di questa cesura e discontinuità.
È una questione, questa, che è resa più complicata anche dal fatto che oggi il dibattito pubblico è dominato, a livello internazionale, da polarizzazioni insidiose, che sembrano mettere fuori gioco la stessa divisione tra destra e sinistra: si pensi a contrapposizioni come quelle tra élite e popolo, progressismo liberal vs populismo, cosmopolitismo vs. sovranismo, diritti civili vs. diritti sociali, politiche di accoglienza vs. politiche di sicurezza, multiculturalismo vs. nazionalismo, etc.
Si tratta per lo più, a mio avviso, di alternative ideologiche, alle quali è possibile non soccombere, tuttavia, solo se si dispone di un’attrezzatura culturale capace di spostare i termini del confronto, di individuare diversi terreni di contrapposizione e di conflitto, di formare nuovi blocchi sociali, e allo stesso tempo di integrare elementi di entrambe queste polarità in una diversa narrativa. Nel proseguio procederò nel modo seguente:
- Per dare un’idea più concreta di quello che intendo quando parlo di diverse opzioni in gioco nel dibattito teorico sul rinnovamenteo della cultura politica della sinistra, e della confusione che domina questo dibattito, proverò innanzitutto a isolare, senza nessuna pretesa di esaustività, quelle che a me sembrano quattro distinte opzioni che oggi aleggiano nel dibattito teorico – 1. una liberal, 2. una populista, 3. una costituzionalista, 4. una socialista;
- esporrò quindi come si dovrebbe procedere, a parer mio, per fare chiarezza in questo dibattito e per orientarsi criticamente nella scelta tra queste opzioni;
- svilupperò infine qualche considerazione su quella che definisco l’opzione socialista, ricostrendo alcune linee di riflessione sviluppate recentemente sul tema dal filosofo tedesco Axel Honneth.
I.
Il dibattito sul rinnovamento della cultura politica della sinistra: ambivalenze e problemi aperti
- Una prima posizione che vorrei isolare nel dibattito in corso è quella che, senza nessuna pretesa di precisione concettuale, definisco liberal. Con questa denominazione, vorrei riferirmi a quelle voci che, anche muovendo da una diagnosi critica della subalternità culturale della sinistra negli ultimi decenni nei confronti del paradigma neoliberista, considera tuttora fondamentale portare avanti il percorso di avvicinamento della sinistra europea alla cultura politica liberal e democratica americana. Una cultura politica, questa, che ha esercitato molta presa presso tanti ambienti intellettuali negli anni Novanta e negli anni Duemila, soprattutto nel segno della teoria normativa della giustizia di John Rawls. Secondo questa posizione, quindi, compito della sinistra sarebbe quello di approdare ad una cultura politica che declina il tema della giustizia sociale assumendo come proprio punto di referimento etico fondamentale l’autonomia individuale e il vocabolario universalista dei diritti, s’ispira ad un’attitudine ricostruttiva e conciliativa nei confronti dei fondamenti normativi e delle procedure deliberative degli ordinamenti liberal-democratici, e a partire da qui sviluppa poi una critica serrata nei confronti delle disuguaglianze prodotte dall’attuale fase della globalizzazione neoliberista, senza tuttavia mettere in questione il mercato capitalista in quanto tale. Senza scendere nei particolari, e rimanendo su questo piano molto generic, mi interessa qui mettere in evidenza un punto. Spesso, uno degli assunti che accompagnano questa linea teorica è che la sinistra è in crisi anche perché non ha ancora ultimato il proprio congedo da una certa tradizione “lavorista” di matrice socialdemocratica. Tradizione che avrebbe ormai perso la propria ragion d’essere, per i profondi mutamenti intervenuti in primis nel mondo del lavoro e del consumo, con i loro effetti di scomposizione di soggetti collettivi e di individualizzazione degli stili di vita e delle scelte etiche. Alla luce di queste tendenze, quindi, si tratterebbe di incentrare il discorso della sinistra sul vocabolario dei diritti individuali, puntando sul potenziale aggregativo delle lotte per i diritti – per esempio le lotte per i diritti dei consumatori contro le grandi corporations – e parallelamente di congedarsi non solo da ogni riferimento a soggetti collettivi o antagonisti, ma anche da ogni pretesa di costruzione di un discorso “contro-egemonico”, e questo sullo sfondo del riconoscimento del “fatto del pluralismo”.[1]
Un’opzione di questo tipo solleva però ovvie domande: può un’impostazione di questo tipo orientare un progetto politico capace di mobilitare passioni e immaginari, aggregare istanze e bisogni di soggetti e ceti svantaggiati, rompere l’egemonia culturale e politica del neoliberalismo, contrastare la sfida populista? E ancora: può esistere una sinistra che non sia di parte, che non faccia propria una lettura non conciliata ma conflittuale della società, che non aspiri a trascendere i confini delle società liberal-democratiche, che non eserciti una critica del capitalismo, che non ponga al proprio centro il tema del lavoro? E non è forse vero che oggi i ceti subalterni rimangono pur sempre coloro che patiscono in primo luogo l’attacco al mondo del lavoro?
- Anche a partire da queste domande, c’è chi oggi, a sinistra, ritiene che la crisi del proprio campo sia talmente grave, soprattuto per il distacco dei ceti politici della sinistra dai ceti sublaterni e popolari, che questa crisi può essere arginata solo se si abbraccia una forma di “populismo di sinistra”. La tesi è che la sinistra può riguadagnare consenso solo se riesce a intoriettare al proprio interno linguaggi e movenze populiste. Più concretamente, si tratterebbe di declinare i temi del popolo, della patria, della nazione, della leadership – i “significanti vuoti” di Laclau, capaci di costituire punti di riferimento simbolici per aggregare lotte e istanze diverse ed eterogenee – in modo sì opposto alla destra, ma altrettanto identificante e polarizzante, ossia chiarendo ogni volta un fronte di lotta nei confronti di un nemico: le élite corrotte, il mondo della finanza, la globalizzazione neoliberista, etc. È questa, come è noto, la linea di ricerca ispirata dagli scritti di Ernesto Laclau e di Chantal Mouffe, che ha assunto credibilità negli ultimi anni anche per via del successo elettorale di Podemos in Spagna, ma anche poi di France Insumnise in Francia, e per certi versi del Movimento Cinque Stelle, per alcuni ancora un soggetto politico che manifesta in potenza tutte le caratteristiche di un movimento populista di sinistra.[1] Ma anche i problemi posti da questa opzione sono evidenti. Come declinare in senso emancipativo o addirittura universalista categorie e riferimenti che sono oggi colonizzati dalla destra di tutto il mondo – come quelli appunto di identità nazionale (“America first”), di patria, di sovranità, di popolo? E un populismo di sinistra, in particolare nelle sue declinazioni “sovraniste”, non è esposto strutturalmente ad entrare in collisione con il vocabolario universalista dei diritti (si pensi alla questione dei migrant o dei diritti umani), nonchè con la vocazione internazionalista che dovrebbe costituire un requisito irrinunciabile della sinistra? E d’altra parte, concetti come quelli di popolo, interesse nazionale, Stato sovrano, non offuscano invece che illuminare le linee di divisione interne alle società nazionali, le strutture di classe che le attraversano, nonchè i terreni di lotta politici internazionali contro i poteri economici globali, come quello dell’Europa?
- Sullo sfondo di queste domande emergono i meriti di un’altra opzione che vorrei isolare e definire di proceduralismo costituzionale o anche di “patriottismo costituzionale”. Secondo questa posizione, interpretata da autori che muovono anche una critica alla teoria del populismo di Laclau e alla deformazione populista della democrazia,[1] la sinistra per (ri)trovare la propria bussola di orientamento non deve far altro che rifarsi all’insieme di indicazioni normative e programmatiche contenute negli articoli fondamentali della Costituzione italiana.[2] Articoli che, come è ben noto, muovono fra l’altro dal riconoscimento della centralità del lavoro come dimensione fondamentale di integrazione sociale, di emancipazione umana e di riconoscimento sociale. Senza minimamente ambire in questa sede ad entrare nel merito di questa posizione, vorrei semplicemente osservare che quest’ultima rappresenta indubbiamente un’indicazione del tutto condivisibile, soprattutto alla luce di quelli che, proprio a cospetto dei principi costituzionali, appaiono come dei veri e propri sbandamenti politici della sinistra recente: le politiche di Renzi sul lavoro, sulla scuola, il suo progetto di riforma istituzionale. Quello alla Costituzione è inoltre un richiamo che, dalla sua, ha anche ragioni di ordine simbolico, se si pensa al valore identificante che continua a rivestire per il campo della sinistra il richiamo alla Resistenza e alla Costituzione. Tuttavia, anche qui non mancano le domande: può bastare il richiamo alla Costituzione per riqualificare in termini innovativi la cultura politica della sinistra? A rigore, infatti, in un ordinamento liberal-democratico tutte le forze politiche dovrebbero riconoscersi nel dettato costituzionale, salvo poi declinare quel dettato in forme diverse, a partire ogni volta, appunto, dalla propria cultura politica di riferimento. In questo senso, normalmente – ma è anche vero che questa “normalità” in Italia è stata ampiamente deteriorata dagli anni di Berlusconi – è il modo in cui si interpreta quel dettato che fa la differenza. E a conferma di ciò basti richiamare il fatto che oggi, in Italia, il richiamo alla Costituzione costituisce uno dei collanti di identificazione più forti del Movimento Cinque Stelle, movimento che proprio appellandosi alla difesa della Costituzione ha vinto la battaglia contro la riforma costituzionale di Renzi e di Boschi. Si può argomentare, quindi, che c’è bisogno di riferimenti più identificanti e forse anche più divisivi affinché l’imprescindibile richiamo alla Costituzione possa davvero riqualificare il senso di una cultura politica di sinistra.
- È di fronte a questi dubbi che si staglia quella che denomino l’opzione socialista. Secondo questa opzione – che del resto non è necessariamente alternativa rispetto a quella costituzionalista – la sinistra può ritrovare oggi la propria identità soltanto rimettendo mano all’idea di socialismo, riarticolando questo riferimento però in un orizzonte democratico e liberale. Tuttavia, anche in questo caso non mancano i problem aperti e le opacità. È evidente che, senza una preliminare ridefinizione teorica e concettuale, anche il richiamo all’idea di socialismo rischia di essere troppo vago e generico, oltre che poco innovativo e mobilitante. Come è ampiamente noto, poi, la storia del socialismo è talmente varia e complessa, contraddittoria e irrisolta, che oggi come in passato molti possono richiamarsi a questa eredità intendendo con ciò cose anche molto diverse tra di loro. Per altro, proprio questa denominzionea sembra oggi, in particolare in Europa, definitivamente squalificata dalla parabola recente dei partiti socialisti e socialdemocratici. Il compito prioritario, in questo caso, sarebbe quindi quello di chiarire cosa può significare oggi l’idea di socialismo democratico e in che modo questa idea possa effettivamente guidare il lavoro di ricostruzione culturale e politica della sinistra, per rispondere alle sfide del nostro tempo.
La mia idea è che quest’ultima opzione – quella socialista – rimane quella più promettente, e cercherò di fornire ulteriori elementi per giustificare questa tesi.
Tuttavia, la tesi più generale che vorrei sostenere è che un modo per superare ambivalenze e opacità nel dibattito in corso sul rinnovamento della cultura politica della sinistra sia quello di situare storicamente questo dibattito, di parametrarlo alle sfide contemporanee.
Ciò vuol dire, in primo luogo, ricostruire attentamente le ragioni che sono state alla base del progressivo assorbimento di pezzi consistenti della sinistra nell’orizzonte del neoliberalismo, individuando in questo sbandamento culturale la matrice prima di tutti i problemi e le impasses attuali.
In secondo luogo, si tratta di prendere consapevolezza del fatto che stiamo vivendo un tempo in cui l’egemonia neoliberale sta entrando in crisi, ma il più delle volte grazie all’avanzata di un populismo autoritario di destra e della sua cultura di rivolta contro la globalizzazione, l’immigrazione e i diritti umani, e che, quindi, oggi la prima sfida della sinistra è quella di rispondere in termini emancipativi e democratici ai bisogni di sicurezza e di protezione sociale dei ceti subalterni a cui sta rispondendo, in termini regressivi, il populismo di destra.
Si tratta quindi, in terzo luogo, di comprendere come a questa sfida si può rispondere solo articolando quella che il saggista inglese Richard Mason ha definito una «nuova narrazione post-liberista», capace di convogliare rabbia e malessere sociale nel quadro di un ampio progetto di trasformazione democratica della società. Una trasformazione che può trovare il proprio punto prospettico ideale nella ridefinizione di un’idea di socialismo democratico.
A questo proposito va osservato che la riscoperta di un’opzione socialista può compiersi oggi anche alla luce della consapevolezza che il momento storico che stiamo vivendo presenta dei caratteri di maggiore dinamicità rispetto anche ad un recente passato. Se è vero che la “sfida populista” è oggi l’espressione di una crisi del consenso attorno alla globalizzazione neoliberista che aveva coagulato al centro, negli ultimi decenni, tutti i principali partiti tradizionali – di destra e di sinistra – proprio questa crisi può aprire, insieme a scenari molto foschi di regressione democratica e civile, anche uno spazio per nuove possibilità che fino a qualche anno fa non erano immaginabili.
Se oggi trionfa elettoralmente in giro per il mondo l’internazionale del populismo autoritario di destra, le porte possono apirsi anche, potenzialmente, per la vittoria di una sinistra post-liberista d’ispirazione socialista, come quella rappresentata da Corbyin in Inghilterra e Sanders negli Stati Uniti. Come è noto, Bernie Sanders non ha vinto le primarie del partito democratico per poco, ma se avesse vinto le resistenze lobbystiche e clientelari del Partito Democratico e fosse riuscito a candidarsi per le elezioni presidenziali, probabilmente avrebbe vinto contro Trump. E a quest’ora, invece di parlare del governo più a destra della storia americana, ci troveremmo di fronte al governo più a sinistra della recente storia americana.
II. Genealogia di una crisi: esaurimento delle energie utopiche e subalternità al neoliberalismo. II.1 L’89 e il ’68: gli appuntamenti mancati della sinistra
Il primo punto di un ragionamento attorno alla ricostruzione della cultura politica della sinistra deve concernere, quindi, una diagnosi dello sbandamento culturale che ha caratterizzato la parabola dei partiti socialisti e socialdemocratici per lo meno negli ultimi due decenni. È possibile affermare che questo disorientamento culturale affonda le proprie origini in due date spartiacque, cariche di valore simbolico: l’ ’89 e il ’68. In primo luogo, dall’’89 in poi, ovvero la data che ha sancito sul piano simbolico oltre che politico il fallimento dell’esperienza storica comunista, la sinistra ha colpevolmente dedotto l’impossibilità di un’altra società possibile: ha abbandonato di fatto ogni progetto di trasformazione politica radicale della società e ha smesso di alimentarsi a qualsiasi sostrato di «energie utopiche». Come scriveva qualche anno fa il compianto politologo tedesco Ekkerhardt Krippendorf, l’impeto morale da cui la sinistra trae le sue origini e che ha motivato i suoi rappresentanti e i suoi sostenitori è stata sempre la critica dell’oppressione e dell’ingiustizia, dello sfruttamento e dei privilegi, della divisione della società in poveri e ricchi, in servi e signori. «Essere di sinistra significava e significa interessarsi e prendersi cura dei deboli, degli svantaggiati, dei meno privilegiati, e denunciare pubblicamente e condannare ogni genere di pregiudizio sociale diretto o indiretto, sottile o manifesto».[5] Ma come ha messo in evienza recentemente Axel Honneth in L’idea di socialismo, tutti i movimenti di lotta della sinistra, e in primis quelli contro le condizioni sociali determinate dal capitalismo, sono sempre stati animati da utopie, ossia sostenuti dalle immagini di come la società futura un giorno sarebbe dovuta essere organizzata – «basti pensare al luddismo, alle cooperative di Robert Owen, ai consigli di fabbrica o agli ideali comunisti di una società senza classi».[6] In altre parole, le “energie utopiche” della sinistra – per riprendere la denominazione di Ernst Bloch, che ne metteva in luce la filiazione da istanze religiose – sono state sempre alimentate dalle immagini di una migliore vita comune, le quali hanno sempre stimolato e animato i soggetti di sinistra, immunizzandoli dalla rassegnazione nei confronti di massive condizioni di ingiustizia, e fornendo alla loro indignazione un orientamento normativo e un senso della direzione storica. Con la fine del comunismo è stato abbandonato, invece, il compito, vitale per la sinistra, di alimentare un’immagine credibile di una realtà al di là delle società capitalistiche, e ciò ha creato la situazione paradossale nella quale ci troviamo: ossia quella in cui l’accrescimento esponenziale delle ingiustizie e il senso di malessere sociale, generati dai processi della globalizzazione neolibersita, suscitano sì indignazione popolare, che si esprime anche in forme marcate e visibili, ma questa indignazione rimane priva di direzione, è ripiegata su se stessa oppure è dirottata verso obiettivi regressivi e reazionari dalle forze populiste di destra. Dopo l’89, quindi, è mancata alla sinistra una rielaborazione critica della propria storia, capace di mettere a fuoco le tare della propria cultura politica di provenienza ma anche i valori, le pratiche, i potenziali critici dal passato che non andavano dispersi, ma ripensati e riattualizzati.
Ma le ragioni della crisi della sinistra, mi preme sottolineare, possono essere ricondotte, in secondo luogo, anche ad un’altra data simbolica: ossia il ‘68. Molti ceti politici della sinistra, a causa di deficit radicati nella propria cultura politica di provenienza, non hanno saputo valorizzare le istanze di trasformazione democratica della società, che sono provenute, dal ’68 in poi, dai movimenti sociali. Movimenti, questi, che non hanno mai mirato soltanto ad ottenere una redistribuzione più equa di risorse e opportunità, ma anche a lottare per il riconoscimento di nuove identità, a trasformare gli immaginari culturali dominanti e a mutare le forme stesse della vita ordinaria: ad edificare modi di produrre, di consumare, di abitare, di intessere relazioni di intimità, di organizzare la vita sociale, alternativi rispetto ai modelli di vita individualistici e competitivi imposti, o anche solo indotti e incoraggiati, dalle società del consumo a capitalismo avanzato. Quelle dei movimenti sociali sono state sempre lotte per un radicale ampliamento delle forme e delle pratiche della democrazia, a partire dall’emergenza di 1. nuove soggettività politiche conflittuali (operaismo, femminismo, lotte anti-razziste e post-coloniali), 2. di nuovi orientamenti culturali (ambientalismo, pacificismo, movimenti contro le istituzioni disciplinari del manicomio, delle carceri, etc.) e 3. di nuove pratiche sociali (intreccio tra politica ed etica, pubblico e personale, globale e locale, etc.). Una certa sinistra politica – in Italia: ampi settori del PCI – si è mostrata ermeticamente chiusa rispetto alla cultura politica espressa dai nuovi movimenti sociali e questo ha avuto un doppio effetto negativo: da una parte le strutture di partito hanno perso un legame con le forze più vive e più innovative della società, nonché con i sensori delle trasformazioni sociali in corso – per esempio le trasformazioni che investivano il mondo del lavoro fordista; d’altra parte, gli stessi movimenti, non trovando sponde politiche e istituzionali, sono spesso caduti vittime di dinamiche di autoreferenzialità, di sclerotizzazione, di estremizzazione, etc., oppure sono stati integrati dallo stesso capitalismo neoliberale, e dalla sua capacità di assorbire al proprio interno, ma snaturandone il senso, le istanze di emancipazione individuale emerse negli stessi movimenti (su questo si veda l’analisi di Boltanski e Chiappello sul Nuovo spirito del capitalismo e le analisi di Nancy Fraser sul progressisimo neoliberale sulle quali tornerò subito).
Se da una parte, quindi, la sinistra politica dopo l’89 non è stata in grado di ricostituire un nesso critico con la propria storia e la propria tradizione, dall’altra non è riuscita nemmeno a integrare al proprio interno la carica utopica di trasformazione politica, sociale, culturale, esistenziale, emersa nei movimenti sociali dal ’68 in poi, fino al movimento per la giustizia globale di Seattle 1999 e di Genova 2001 e ai movimenti per una nuova cittadinanza democratica degli Indignados e di Occupy degli ultimi anni.
La furia iconoclasta nei confronti della propria storia, l’ansia di accreditamento nei confronti dei poteri stabiliti, una lettura superficialmente ottimistica dei processi della globalizzazione economica, sono stati alla base, invece, di quel vero e proprio sbandamento culturale che dagli anni Novanta in poi si è espresso in una sostanziale accettazione del paradigma neoliberale.
II.B Gli inganni della Terza Via. L’analisi di Paul Mason sul disfacimento della cultura politica delle working class inglese
L’economista inglese Paul Mason ha ricordato come al congresso laburista del 2005, Tony Blair ammoniva che discutere della globalizzazione non aveva senso: «il mondo cambia in un modo che è del tutto indifferente alla tradizione. Non perdona la fragilità. Non rispetta le antiche reputazioni. Non ha usi e costumi. È colmo di opportunità, ma solo per coloro che sono pronti ad adattarsi, lenti a lamentarsi, aperti, desiderosi e capaci di cambiare».[7]
Si trattava, come oggi appare evidente, non solo di una lettura superficialmente ottimistica della globalizzazione economica, nutrita inoltre da una chimerica volontà di governare dall’alto e in modo tecnocratico i suoi processi – laddove invece era l’economia globalizzata che stave assorbendo la politica – ma anche di un’inversione completa degli schemi categoriali della sinistra. In questa lettura non c’era più posto per un’analisi della divisione in classi della società, non si assumeva più come compito prioritario quello di farsi portavoce dei bisogni e delle istanze dei ceti subalterni e delle loro domande di giustizia. Al contrario, si adottava una narrativa di fatto interna al paradigma neoliberale, laddove il tema dell’emancipazione perdeva ogni dimensione collettiva, ugualitaria e anti-gerachica, si conferiva assoluta centralità al mercato e alla competizione, e la responsabilità dei successi e dei fallimenti, nel cogliere le opportunità dischiuse dai processi di globalizzazione, veniva spostata sull’autoresponsabilità etica degli individui. Proprio questa narrativa ha inferto un colpo durissimo ai tradizionali ceti sociali di riferimento della sinistra e alla percezione della loro identità e del loro valore morale, preparando il terreno a quel vero e proprio esodo di larghi strati popolari dalla sinistra politica, che si è consumato negli ultimi cicli elettorali. Sempre Paul Mason ha ricostruito nel suo saggio raccolto nell’antologia di scritti La grande regressione (2017), in modo particolarmente efficace, con riferimento all’Inghilterra, il modo in cui, proprio il vuoto di sinistra venutosi a determinare in seguito alla svolta neocentrista del New Labour, ha messo in moto una parabola nella quale la cultura politica solidaristica, internazionalista e di resistenza al capitale, che era propria della classe operaia inglese, alla fine si è trasformata in una cultura di rivolta contro la globalizzazione, l’immigrazione e i diritti umani. Ossia in quella cultura politica fomentata dai partiti della destra populista, che hanno vinto la battaglia della Brexit, sfondando elettoralmente nelle aree rurali e nelle province de-industrializzate dell’Inghilterra.
Mason invita a puntare l’attenzione in particolare su un punto: il neoliberalismo ha operato tutta una serie di trasformazioni strutturali, con l’obiettivo di atomizzare la classe lavoratrice, neutralizzare l’efficacia dei sindacati, bloccare il ciclo di lotte sociali e di conquiste democratiche degli anni Sessanta e Settanta, reagire all’esaurimento del ciclo di accumulazione capitalistica dei cosiddetti «trent’anni gloriosi» creando nuove opportunità di valorizzazione del capitale. Tuttavia, «è solo comprendendo gli effetti narrativi di questi cambiamenti, insieme ai loro effetti economici diretti, che possiamo spiegare il collasso ideologico del centrismo iniziato nel 2016»[8] e l’ascesa del populismo autoritario di destra tra la stessa working class inglese.
Mason ricorda come, dal punto di vista della working class inglese, le principali trasformazioni strutturali prodotte dal neoliberalismo sono state: 1. la delocalizzazione delle industrie produttive; 2. la ristrutturazione delle società per azioni in values chains di aziende più piccolo; 3. il taglio delle tasse per snellire l’apparato statale; 4. la privatizzazione dei servizi pubblici; 5. la finanziarizzazione della vita quotidiana. Tutte queste trasformazioni sono state accompagnate, però, sempre da una nuova narrazione imposta sulla vita di milione di persone, «che alla fine ha deterioriato le basi della cultura politica solidale della classe operaia, e ha obbligato a comportarsi come se la logica del mercato fosse più importante della logica del luogo o dell’identità di classe».
- La delocalizzazione, finalizzata a ridurre il costo degli stipendi, ha avuto l’effetto narrativo di annullare lo spazio: di segnalare ad un’intera classe che il luogo – la fonte principale dell’identità – non aveva valore.
- La ristrutturazione delle aziende finalizzata a subordinare ogni aspetto della vita aziendale ai dettami dei mercati finanziari, ha avuto come messaggio implicito che l’azienda non avrebbe più rispettato alcun obbligo sociale informale, come mantenere un circolo ricreativo all’interno dell’azienda.
- Il taglio della tassazione progressiva, insieme alla nascita delle bolle speculative e alla nascita dei paradisi fiscali, aumentando le diseguaglianze e sopprimendo la mobilità sociale, ha comunicato alla classe lavoratrice che il patto sociale del dopoguerra era finito.
- La privatizzazione, aumentando l’ammontare di capitali investibili e offrendo nuove possibilità ai profitti, ha comunicato l’idea della fine dell’idea di una dimensione economica pubblica, ossia che lo stato non avrebbe più aiutato e avrebbe reso i servizi pubblici più costosi.
- La finanziarizzazione dell’economia e del consumo, esaltando il predatore finanziario come nuovo eroe proletario e squalificando i manager locali che volevano conservare i rituali di cooperazione sociale, ha avuto l’effetto narrativo di trasformare la cultura popolare in un’ideologia filocapitalista che celebrava l’ignoranza e l’egoismo.
Quando poi la narrativa del neoliberalismo cominciava a fallire, a causa dell’infrangersi della promessa di mobilità sociale e dello scoppio della bolla delle Dot.com, il Labour Party ha fatto intendere che non avrebbe opposto alcuna resistenza al cambiamento e nemmeno avrebbe protetto le vecchie forme di coesione sociale. Al contrario, il partito di Blair ha continuato a far propria una politica basata sulle privatizzazioni, la finanziarizzazione dell’economia e l’aumento indiscriminate del credito privato, continuando a veicolare una narrativa fondata sull’idea di autopromozione individuale. Tutto ciò spiega perché, quando il neoliberalismo è stato messo in questione, questo non è avvenuto nella direzione della sinistra, che ormai era stata screditata ad opera dello stesso New Labour, ma in quella indicata da un populismo autoritario. Un populismo che oggi sta riuscendo a canalizzare il senso di frustrazione, di disorientamento, di abbandono dei ceti subalterni, con parole d’ordine ispirate al razzsimo, al conservatorismo sociale e alla demagogia.
III. Superare l’alternativa tra neoliberismo progressista (e populismo reazionario. L’analisi di Nancy Fraser e la speranza socialista di nome Bernie Sanders
Le analisi di Mason convergono in buona parte con quelle che la teorica femminista statunitense Nancy Fraser ha dedicato recentemente alle tendenze politiche in corso negli Stati Uniti.[9]
Per Fraser, l’elezione di Trump rappresenta uno dei tanti sconvolgimenti politici che segnalano il crollo del consenso attorno alla globalizzazione neoliberista che aveva coagulato al centro, negli ultimi decenni, tutti i principali partiti tradizionali. Tuttavia, se l’elezione di Trump va interpretata come un «no alla combinazione letale di austerità, libero mercato, debito predatorio e lavoro precario sottopagato, dell’attuale capitalismo finanziario», è anche vero che gli elettori di Trump hanno detto il loro no, più determinatamente, al «neoliberismo progressista»: ossia all’«alleanza tra le correnti mainstream dei nuovi movimenti sociali (il femminismo, l’antirazzismo, il multiculturalismo e i diritti Lgbtq) e i settori simbolici di alto livello del capitalismo cognitivo soprattutto della finanziarizzazione», che aveva costituito il cuore del ciclo del Partito Democratico, da Bill Clinton a Barack Obama. Fraser invita dunque a spostare l’attenzione sul’inglobamento delle istanze di trasformazione e di emancipazione dei movimenti sociali all’interno della narrativa, egemonica negli anni Novanta, del «neoliberismo progressista». Inconsapevolmente, le correnti meanstream dei nuovi movimenti sociali hanno prestato il loro carisma ai settori in ascesa del capitalismo cognitivo e finanziario, e «i principi della diversità e dell’autonomia hanno mascherato politiche che hanno devastato il settore finanziario e i mezzi di sussitenza della classe media».[10]
Con «neoliberismo progressista» va inteso, quindi, quell’orientamento ideologico che si è sviluppato negli Stati Uniti a partire dall’elezione di Bill Clinton nel 1992, il principale architetto dei Nuovi Democratici, il progetto gemello rispetto a quello del New Labour di Tony Blair. Al posto della alleanza del New Deal di Roosvelt tra lavoratori sindacalizzati del settore manifatturierio, gli afroamericani e la classe media cittadina, Clinton ha forgiato una nuova alleanza tra imprenditori, periferie, nuovi movimenti sociali, giovani, «tutti pronti ad abbracciare le credenziali progressiste sposando la diversità, il multiculturalismo, i diritti delle donne, mentre allo stesso tempo sul piano di politica economica questa stessa politica procedeva, in accordo con le èlite finanziare ed economiche, alla deregolamentazione del settore finanziario, alla deindustrializzazione, all’indebolimento dei sindacati, al calo dei salari reali, all’aumento della precarietà». [11] Il tratto “ideologico” del neoliberismo progressista nasce proprio da qui: i discorsi sulla diversità, sulla valorizzazione delle donne, sulla battaglia contro la discriminazione, identificando il progresso con la meritocrazia e non con l’uguaglianza, hanno alla fine associato l’emancipazione all’ascesa di donne, minoranze e gay di talento nella gerarchia aziendale basata sul modello del vincitore, invece che all’abolizione di quest’ultima. Le visioni liberal-individualistiche del progresso hanno sostituito le concezioni dell’emancipazione più espansive, antigerarchiche, ugualitarie, anticapitaliste e sensibili ai rapporti di classe, fiorite negli anni sessanta e settanta. E questo ha fatto sì che le battaglie dei nuovi movimenti sociali siano alla fine state integrate ideologicamente all’interno dello stesso neoliberalismo.
Così come Mason, anche Fraser sottolinea come tutto questo è stato reso possibile dalla mancanza di una sinistra autentica: ossia dall’assenza di una narrazione di ampia portata che articolasse le rivendicazioni legittime di chi ora sostiene Trump «con una critica radicale alla finanziarizzazione e con una visione emancipativa antigerarchica, antirazzista e antisessista».
Fraser conclude la sua analisi, tuttavia, con una nota di speranza. Per la teorica statunitense, la campagna politica di Bernie Sanders per le primarie ha mostrato come oggi è possibile riannodare i legami tra i movimenti dei lavoratori e i nuovi movimenti sociali, prefigurando un nuovo blocco sociale, capace di far saltare il senso comune neoliberista dominante, nel segno però della democratizzazione della società. Sanders ha condotto una campagna tanto «contro una economia truccata che da trent’anni ridistribuisce la ricchezza e i profitti tra le fasce più alte della popolazione, quanto contro un sistema politico truccato che ha sostenuto e protetto questo tipo di economia», e quindi contro democratici e repubblicani che hanno cospirato per bloccare qualsiasi progetto di riforma strutturale. Sventolando la bandiera del socialismo democratico –in un contesto in cui questo richiamo suona come un gesto di rottura e radicalità – Sanders è riuscito a portare questa battaglia contro le èlite, tuttavia, senza cedere al populismo, nella sua accezione più negativa. Al contrario, è riuscito a convogliare, in una grande insurrezione politica, sentimenti che erano rimasti sepolti dai tempi di Occupy Wall Street e a mostrare che «l’unico amuleto contro il fascismo è oggi un progetto di sinistra che mobiliti la rabbia e il dolore dei diseredati in favore di una profonda ristrutturazione sociale e di una rivoluzione politica democratica».[12] In altre parole, Sanders ha mostrato la strada per sottrarsi non solo all’alternativa tra neoliberismo progressista (Hilary Clinton) e populismo autoritario (Trump), ma anche alla catena di polarizzzazioni che discendono da questa prima alternativa, e che oggi stanno dominando e inquinando il dibattito pubblico: come quelle cosmopolitismo vs. sovranismo, multiculturalismo vs. nazionalismo, diritti civili vs. diritti sociali, politiche di accoglienza vs. politiche di sicurezza, etc. Per non farsi ingabbiare in queste polarizzazioni, la sinistra deve oggi dare vita ad una nuova alleanza tra l’emancipazione e la protezione sociale. «Emancipazone non significa diversificare la gerachia aziendale, ma abolirla. E prosperità non significa la crescita del valore delle azioni, ma quella dei prerequisiti materiali di una vita buona per tutti».[13]
Fraser conclude, quindi, osservando come, fino a poco tempo fa, questo progetto non poteva nemmeno essere auspicato, tanto era soffocante ed egemone il senso comune neoliberista. Ma oggi, grazie alla crisi di questo consenso, e grazie a Sanders, così come a Corbyn, Syriza e Podemos, con tutte le loro imperfezioni, è possibile riuscire di nuovo a immaginare un ventaglio più ampio di possibilità politiche, che si sottraggono all’alternativa tra un progressismo liberal, negli ultimi anni subalterno a interessi e orientamenti del capitalismo neoliberale, e il populismo di destra.
Tutto questo può avvenire oggi sullo sfondo di un ripensamento e di una riformulazione di un’idea di socialismo democratico.
Ma cosa si deve intendere per socialismo democratico nel XXI secolo?
III.
Un socialismo democratico per il XXI secolo. La linea di ricerca di Axel Honneth.
Molti spunti per impostare una riflessione sull’idea di socialismo per il future, li ha offerti recentemente il filosofo tedesco Axel Honneth nel suo libro L’idea di socialismo. Mi interessa qui richiamare soltanto alcuni passaggi di questa riflessione, che considero molto importanti nel quadro del discorso attorno alla cultura politica della sinistra che è l’oggetto di questo intervento.
La diagnosi da cui muove Honneth, nel suo tentativo di riformulare l’idea di socialismo, non è molto diversa da quella degli autori finora richiamati. Anche per lui, la crisi della sinistra va ricondotta all’abbandono di ogniorientamento etico-politico forte, di un punto prospettico di un’idea di società alternativa, verso cui far convergere le lotte e l’indignazione. Riabilitare l’idea di socialismo deve servire, dunque, in primis, a riguadagnare questo senso della direzione normativa, senza la quale ogni politica e prima ancora ogni indignazione per lo stato di cose esistenti, sono incapaci di aggregare energie critiche in grado di intaccare i processi sociali ed economici che generano ingiustizie e malessere sociale. Per recuperare questo orizzonte etico-politico è necessario riscoprire l’idea di socialismo. Ma questa riscoperta non può avvenire fino a quando non si mettono a fuoco le tare teoriche interne a questa tradizione. La linea di ragionamento di Honneth sul socialismo si scandisce quindi in due parti. In primo luogo, Honneth si sofferma «sulle ragioni interne oppure esterne che hanno condotto al punto in cui le idee del socialismo sembrano aver perso irrevocabilmente il potenziale propulsivo d’un tempo». In secondo luogo, alla luce dell’analisi di queste ragioni, pone «la questione di quali siano le modifiche concettuali da apportare alle idee socialiste perché esse possano riacquistare la forza perduta». Questo doppio lavoro è preceduto dal tentativo di isolare il cuore normativo, la scintilla ideale ed etica, presente nella storia del socialismo, che si tratta a suo parere di riscoprire e di rilanciare nel presente. Mi sembra questo un punto meritevole di considerazione: per Honneth il socialismo non può essere ridotto ad una teoria normativa della giustizia, come quella per esempio di Rawls. Il socialismo è sempre stato un programma politico di trasformazione della società, radicato in concrete prassi sociali che dovevano incarnare nel presente l’idea di società solidale verso cui orientare le lotte. Le richieste del socialismo non possono essere intese come un appello alla sfera del dovere, ma come l’espressione di un qualcosa a cui in qualche modo già si aspira.«Il socialismo mira a far divenire consapevoli delle tendenze storiche portatrici di quelle promesse che non sono state mantenute dall’ordine sociale esistente, e il cui adempimento richiederebbe una trasformazione delle istituzioni in gioco».[14] Per Honneth, la differenza rispetto al liberalismo filosofico e politico di Rawls non concerne però soltanto questa impostazione di fondo, ma anche il punto di riferimento etico: mentre per il liberalismo il punto di riferimento etico è l’autonomia individuale e la grammatica dei diritti che la rende possibile, per il socialismo il punto di riferimento etico è la libertà sociale, ovvero quello che potrebbe essere definite anche il principio di cooperazione solidale. Nella lettura di Honneth, la scintilla normativa del socialismo non è l’uguaglianza nè la giustizia sociale, ma un’idea di libertà: ossia appunto l’idea di libertà sociale. È «l’idea che bisogna pensare la libertà individuale non come un bene di cui si può disporre in modo meramente soggettivo, bensì come un bene che può essere realizzato solo intersoggettivamente».[15] È l’idea che ciascun io, nella sua singolarità, è tanto più libero quanto più, nella realizzazione dei suoi scopi e nella soddisfazione dei suoi bisogni, corrisponde agli scopi dei suoi partner e per questa via si apre al loro riconoscimento sociale. Detto ancora diversamente: è l’idea di un noi fatto di persone che si sostengono reciprocamente nella realizzazione dei loro scopi individuali, anche se rimangono le une alle altre estranee. Se si torna alle origini del socialismo, per Honneth, ci si può rendere conto che il movente ispiratore dei primi socialisti, delle loro prime esperienze cooperativiste e mutualiste, era proprio quello di mostrare come è possibile instaurare un sistema economico non come sfera dell’egoismo privato, come nel capitalismo concorrenziale, ma come un ambito di realizzazione della libertà sociale. E per Honneth, un modo per riattualizzare oggi questa intuizione di fondo – quella appunto della libertà sociale o del principio-solidarietà – è quella di rileggerla alla maniera in cui il pragmatismo americano ha interpretato il principio di associazione o di cooperazione. La libertà sociale, scrive Honneth, «è la rimozione delle barriere che si contrappongono a quella libera comunicazione tra i membri della società, il cui obiettivo è di individuare soluzioni intelligenti per i problemi in gioco». Alla luce dell’idea di socialismo «si devono considerare quali ipotesi sperimentali valide e feconde dei modelli istituzionali tutte quelle proposte che in qualche modo si impegnano a realizzare l’obiettivo normativo di emancipare dalla costrizione, dal paternalismo e dalla dipendenza tutti coloro che operano nell’ambito economico» – ma anche più complessivamente in ogni sfera sociale – «fino al punto da metterli nella condizione di interpretare il loro rispettivo ruolo nei termini di un contributo volontario al compito, da realizzare sempre con reciprocità, di soddisfare in modo equilibrato i bisogni di tutti i membri della società».[16] Si tratta dunque dell’ «utopia concreta» di una società fondata su istituzioni e pratiche che favoriscono a tutti i livelli (famiglia, vicinato, associazioni, mercato, politica) processi di associazione e di cooperazione tra i soggetti nella risoluzione di problemi comuni. Processi di cooperazione concepiti, secondo l’ideale di democrazia sociale del pragmatismo americano di Dewey, come lo strumento più adatto per includere tutte le voci della sfera pubblica, e quindi per ampliare i livelli di intelligenza sociale nelle prassi di decisione; ma intesi anche come forme di autorealizzazione individuale tramite riconoscimento intersoggettivo.
Per rendere questa utopia sempre di più un’utopia concreta, tuttavia, bisogna sganciare l’idea originaria del socialismo dalle tare teoriche che hanno contribuito a farle perdere attrattività e forza di mobilitazione. Honneth individua tre problemi di fondo nel vecchio socialismo.
1) la mancata connessione della libertà sociale con i diritti di libertà liberali, per lo più rigettati in toto nella tradizione del socialismo;
2) un legame di tipo trascendentale della teoria socialista al proletariato, in quanto soggetto collettivo ritenuto in possesso di una coscienza permanentemente rivoluzionaria;
3) infine una fede nel futuro che spingeva a ritenere che il passaggio al socialismo si sarebbe compiuto con necessità storica, in modo conforme a leggi oggettive.
1) Rispetto al primo punto, il socialismo di Honneth vuole essere un socialismo liberale, ossia capace di assimilare la lezione del liberalismo, quindi di accogliere al proprio interno il riconoscimento del pluralismo e delle libertà fondamentali di ogni essere umano, come valori irrinunciabili e criteri di giudizio critico di ogni società. D’altra parte, il socialismo deve preservare anche una sua irriducibilità rispetto all’orizzonte del liberalismo, a partire da una diversa idea di libertà, che preserva un elemento critico irriducibile nei confronti del capitalismo. Rispetto alla questione economica, il compito più importante per rilanciare la tradizione socialista, consisterebbe quindi nel revocare l’equiparazione ipotizzata da Marx tra economia di mercato e capitalismo, e ricavare in tal modo lo spazio necessario per riprogettare delle forme alternative di utilizzo del mercato. Forme cooperative, mutualistiche, associative di utilizzo del mercato, la cui sperimentazione deve andare di pari passo con una lotta a tutto campo per una legislazione volta a sottoporre i poteri economici e finanziari globali ad un controllo democratico. D’altra parte, un socialismo rinnovato deve muovere anche dall’assunto che esistono altre sfere sociali, oltre quella dell’economia di mercato, dotate di una logica propria, irriducibile a quella economica, e che anche tali sfere possano essere esaminate dal punto di vista della realizzazione della libertà sociale: oltre alla sfera del mercato, c’è una sfera dei rapporti d’intimità – amicizia e amore – e una sfera della formazione democratica della volontà. Anche in queste altre sfere avvengono lotte per il riconoscimento volte ad ampliare gli spazi di esercizio della libertà sociale. E In quest’ottica, quindi, non va vista alcuna tensione tra diritti civili e diritti sociali: entrambi devono essere pensati come condizioni affinché possano essere rimossi quegli ostacoli che limitano i processi di libera cooperazione sociale nelle diverse sfere della società.
2) Rispetto alla seconda tara teorica del vecchio socialismo, Honneth sottolinea come quest’ultimo non può più perdere la consapevolezza che non c’è nessun automatismo nella nascita di una coscienza “rivoluzionaria”. Nessuna classe possiede il monopolio della coscienza socialista, e non esiste alcun nesso diretto e oggettivo tra determinazione sociale e orientamento politico. Se certamente è innegabile che coloro che non traggono vantaggi dalla situazione esistente sono più disposti ad intraprendere azioni di trasformazione e riforme progressive, senza una mediazione politica e culturale questa insoddisfazione può prendere la strada di una rabbia sorda e priva di futuro, oppure essere manipolata demagogicamente. Da qui il compito irriducibile della politica, nel formare, mediare e articolare i bisogni. Compiti che fanno segno verso una lotta per l’egemonia culturale. Un tema questo a dire il vero non trattato direttamente da Honneth – che non cita quasi mai Gramsci – ma che tuttavia non si fa fatica ad inserire nel suo quadro teorico, sebbene nel suo quadro teorico questo tema assume un senso diverso dal modo in cui il concetto di egemonia è stato elaborato dalla linea populista di Laclau e Mouffe.
3) Infine riguardo al terzo punto, l’abbandono di qualsiasi fede in un progresso storico necessario e conforme a leggi deve andare di pari passo, per Honneth, con l’assunzione di uno sperimentalismo storico, come auspicato per esempio, di nuovo, dal pragmatista americano John Dewey. Questo richiamo obbliga a fare propria un’impostazione riformista, che si volge cioè ad interrogare ogni situazione storicamente data riguardo le opportunità, in essa contenute, di trasformazione verso il meglio, ossia di ampliamento delle libertà sociali. Ci si può avvicinare solo lentamente – attraverso passaggi che rappresentano l’esito di una ricerca di tipo sperimentale – all’abbattimento di quelle limitazioni della nostra libertà sociale che ci impediscono di pervenire alla realizzazione di un’altra società.
Giorgio Fazio
[1] Esemplificativo di questa linea di riflessione è l’intervento di A. Ferrara: Dalla lotta di classe alla class action, in: http://www.fondazionebasso.it/2015/publications/pensare-la-politica-dalla-lotta-di-classe-alla-class-action-una-sinistra-per-il-21-secolo-di-alessandro-ferrara/
[2] Per un esempio di questa linea di ragionamento cfr. C. Formenti, La variante populista. Lotta di classe nel neoliberismo, Derive e Approdi, Roma 2016.
[3] Cfr. per esempio N. Urbinati, Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità, Feltrinelli, Milano 2017.
[4] Cfr. su questo anche l’ampia produzione di Luigi Ferrajoli, per es. L. Ferrajoli, Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale, Editoriale Scientifica, Roma 2015.
[5] E. Krippendorff, Critica della politica estera, Fazi Editore, Roma 2004, p.215.
[6] A. Honneth, L’idea di socialismo, Feltrinelli, Milano 2016, p. 3.
[7] Citato in P. Mason, Superare la paura della libertà, in: La grande regressione, a cura di H. Geiselberger, Feltrinelli, Milano 2017, p. 122.
[8] Ivi, p. 119.
[9] Cfr. N. Fraser, Il neoliberismo progressista contro il populismo reazionario: una scelta di Hobson, in: La grande regressione, cit., pp. 61-71.
[10] Ivi, p. 64.
[11] Ivi, p. 63.
[12] Ivi, p. 66.
[13] Ivi, p. 69.
[14] A. Honneth, L’idea di socialismo, Feltrinelli, Milano 2016, p. 136.
[15] Cfr. anche Socialismo come libertà. Axel Honneth in conversazione con Giorgio Fazio, in MicroMega, 1, 2017.
[16] Ivi, p. 124.







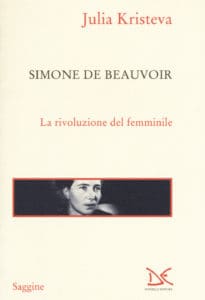


 Francesco Postorino
Francesco Postorino