Autonomia e secessioni: la Catalogna e le altre
I recenti indipendentismi (o addirittura secessionismi) invocati da più parte in Europa, a mio modo di vedere, rappresentano un errore clamoroso. Essi dipendono da una doppia inefficienza: quella dello Stato da una parte e quella delle istituzioni sovranazionali dall’altra. Gli indipendentismi sono connessi, altresì, agli egoismi irresponsabili delle comunità monoculturali. Stiamo andando nella direzione esattamente contraria a quella di una sana e quanto mai auspicabile integrazione europea.
In questo quadro, credo sia impossibile occuparsi della “questione catalana” senza porre quest’ultima in un contesto storico e politico più ampio. Sono convinto, anzi, che tale crisi sia incomprensibile se non la si considera alla luce della globalizzazione – intendendo quest’ultima come lo stadio estremo della storia occidentale moderna.
- Globalizzazione
Dal 1945 al 1989 i confini interni dei paesi europei non sono cambiati. Alla caduta del muro di Berlino, invece, annose quanto irrisolte questioni culturali e politiche sono riemerse con prepotenza. A partire dalla fine della guerra fredda, infatti, sono venute alla ribalta questioni etniche e nazionalistiche che hanno provocato spesso conflitti dolorosi. Tutto ciò, del resto, alla maggior parte degli osservatori è apparso non facile da spiegare dal momento che molte dei problemi riaffiorati – peraltro talvolta in maniera estremamente cruenta – erano parsi superati da una nuova e più pacifica fase storica. E così, la dissoluzione della ex-Iugoslavia avvenuta nel sangue, negli anni Novanta, è stata la prima grande lacerazione, esplosa peraltro nel cuore stesso dell’Europa, che ha riportato alla luce il problema della convivenza pacifica fra etnie diverse.
Questi fenomeni – come detto – sono particolarmente complessi da valutare e anche gli analisti politici fanno fatica poiché ci sono buoni motivi per ritenere che le spinte indipendentistiche costituiscano delle secessioni illegali (o addirittura dei tradimenti), ma si può ammettere anche che esse rappresentino il coronamento libertario di un sogno cullato da tempo.
Ciò che è certo, tuttavia, è che viviamo in un tempo in cui la frammentazione socio-politica – per non parlare di quella esistenziale, familiare, istituzionale – costituisce una questione di estrema rilevanza. Sul piano geopolitico il referendum catalano, così come quello svoltosi nel Kurdistan iracheno, insieme alle molteplici manifestazioni indipendentistiche in diversi Paesi del globo, mostrano in quale misura il nazionalismo a base mono-etnica o mono-culturale riguardi ormai tutti i continenti. Per rimanere nella vecchia Europa, e citando soltanto en passant le rivendicazioni nostrane relative alla Sardegna e soprattutto al Lombardo-Veneto, come non menzionare in Spagna, oltre alla questione catalana, il focolaio indipendentistico basco, quello corso in Francia, quello relativo alle Fiandre in Belgio e, anche, le richieste autonomistiche delle Isole Far Oer per quanto riguarda la Danimarca?
Se dunque alla fine del bipolarismo USA-URSS vanno riemergendo, magari con rinnovata virulenza, antichi conflitti etnici, mi sembra che si possa giungere già ad una conclusione teorica: il processo di globalizzazione, nel momento in cui si prende atto che non riesce a coniugare insieme l’universale dello Stato e delle istituzioni sovra-nazionali con le spinte identitarie delle appartenenze locali, fallisce il suo intento e anzi si risolve drammaticamente in un potente stimolo verso ulteriori frammentazioni più o meno cruente.
- Comunità europea
Il dato su cui dobbiamo lavorare, dunque, è molto chiaro: la globalizzazione ha coinciso con una nuova e ancor più rigida ripresa dei nazionalismi particolaristici. Diventa di somma importanza, allora, verificare quali elementi siano venuti meno dal lato dell’universalismo, ossia dello Stato e delle comunità sovranazionali nate nel tempo della globalizzazione.
A questo proposito, vorrei citare qualche rigo di un libro che io stesso, in quanto appassionato di letteratura e soprattutto come uomo del sud, ho sempre amato. Carlo Levi, in Cristo si è fermato ad Eboli, riferendosi al governo fascista nell’Italia degli anni ’30 del Novecento, scrive quanto segue: “Pare infatti che il governo avesse da poco scoperto che la capra è un animale dannoso all’agricoltura, poiché mangia i germogli e i rami teneri delle piante: e aveva perciò fatto un decreto valido ugualmente per tutti i comuni del Regno, senza eccezione, che imponeva una forte imposta su ogni capo, del valore all’incirca della bestia. Così, colpendo le capre, si salvavano gli alberi. Ma a Gagliano non ci sono alberi, e la capra è la sola ricchezza del contadino, perché campa di nulla, salta per le argille deserte e dirupate, bruca i cespugli di spine, e vive dove, per mancanza di prati, non si possono tenere né pecore né vitelli. La tassa sulle capre era dunque una sventura: e, poiché non c’era il denaro per pagarla, una sventura senza rimedio. Bisognava uccidere le capre, e restare senza latte e senza formaggio”[1].
Nella potente suggestione della pagina di Levi, mi pare che un punto debba essere sottolineato con forza. Il potere centrale – in particolare quello dei governi democratici – ha il dovere di conoscere e di “rappresentare” l’intero territorio entro il quale gli è stata attribuita la sovranità. Ebbene, è storia antica e sempre rinnovata che ciò non avvenga, o avvenga in maniera parziale o addirittura del tutto insufficiente. Venendo alla situazione che si è venuta determinando nei nostri giorni, la comunità europea appare maggiormente inclinata verso la promozione di fatti burocratico-finanziari i quali, in larga misura, non vengono compresi come propri da tutte le micro-regioni che fanno parte integrante dell’Unione. Le decisioni dell’Unione Europea vengono viste anzi dai territori locali, soprattutto quelli più poveri, più o meno come veniva considerato il governo fascista e la politica di Roma dai contadini del sud al tempo di Levi, e cioè come un fenomeno lontano se non addirittura ostile.
Vi è inoltre da considerare un altro elemento estremamente importante, ossia le crescenti disuguaglianze in abito europeo che vengono registrate e perfino incrementate.
Per limitarci al caso della Catalogna, vorrei elencare alcuni dati particolarmente significativi. In questa bellissima regione spagnola, quasi il 20% delle importazioni arrivano dalla Germania: un numero decisamente superiore a qualunque altro paese. Basterebbe già questo a mostrare l’importanza decisiva che assume per questa regione il rapporto con la potente economia tedesca. Ma c’è dell’altro. La Germania è il secondo più grande acquirente delle esportazioni catalane. In Catalogna, inoltre, oltre il 10 per cento degli investimenti provengono dalla Repubblica Federale. La regione, infine, è il principale punto di appoggio per le aziende in Spagna, dal momento che circa la metà delle 1600 aziende spagnole con partecipazione tedesca hanno la loro sede in Catalogna. Fra queste BASF, Bayer, Böhringer, Henkel, Merck e Siemens.
Sotto il profilo della collaborazione commerciale con la Germania, oltre all’esempio catalano, è possibile, anzi doveroso, ricordarne altri: tutti molto significativi dal punto di vista delle richieste di autonomia. Una situazione simile, infatti, vige anche nei rapporti tra la Germania da una parte e la Lombardia e le Fiandre dall’altra. Esistono canali esclusivi e privilegiati che connettono insieme “economie forti”, indifferenti, se non ostili, ad economie più deboli. Tutto ciò – è evidente – ha provocato un aumento considerevole delle disuguaglianze in ambito europeo e infra-nazionale. E ciò si comprende assai bene: mentre giocavano un ruolo decisivo nell’espansione della già forte economia tedesca, tre regioni economicamente rilevanti come Catalogna, Fiandre e Lombardia aumentavano il già consistente divario con le zone più povere di Spagna, Belgio e Italia.
Esiste, infine, un altro elemento che crea disuguaglianza. All’interno della comunità europea, vi sono accordi fra regioni più ricche, tesi a tagliare fuori le regioni meno sviluppate. Va detto, inoltre, che tali collaborazioni fra economie forti non è soltanto – come forse vorrebbero i liberali – una faccenda “naturale”; una situazione, cioè, che risponde a dinamiche spontanee del mercato. Molto diversamente, essa rientra in un preciso disegno politico. Un esempio significativo è costituito dalla comunità di lavoro denominata “Quattro motori per l’Europa”, fondata nel 1988. Di tale comunità fanno parte – manco a dirlo – il Land tedesco del Baden-Württemberg, la Catalogna, la Lombardia e il Rodano-Alpi. Tale comunità si propone il non trascurabile obiettivo di estendere la cooperazione economica delle aree consociate. Insomma, si prevede una stretta collaborazione fra ricerca, investimenti e tecnologia sul campo: l’accordo era infatti quello di intessere una relazione fra le quattro regioni suddette nei campi della scienza, della ricerca, dell’istruzione, dell’ambiente, della cultura e in altri ancora.
- Indipendentismo
In una situazione di questo tipo, e cioè in una situazione di forte e crescente disuguaglianza, è chiaro che le élite regionali hanno fatto (e faranno) di tutto per condizionare il flusso di redistribuzione nazionale dei fondi statali, chiedendo a viva voce maggiore autonomia o, in ultima analisi, perfino la secessione. E pazienza – così come è avvenuto nel referendum sull’autonomia catalana – se tutto ciò impone uno strappo profondo del dettame costituzionale e non potendo contare neppure sulla maggioranza interna che sia favorevole alla secessione.
L’età moderna – ciò che è nato con la fine delle guerre civili di religione e la fondazione degli Stati nazionali – aveva colmato il vuoto che si era aperto fra gli uomini, quando le comunità tradizionali si erano sgretolate, con i grandi apparati politico-burocratici nei quali si identificavano, in fondo, le costituzioni delle “nazioni”. Lo Stato aveva ricondotto, cioè, ad unità quelle soggettività frammentate, irrelate, atomizzare e fondamentalmente solitarie che rivendicavano uguaglianza e libertà meramente individuale se non individualistica. Nel nostro tempo, ora che lo Stato appare bypassato da sovranità sovra-nazionali da una parte, infra-nazionali dall’altra, il vuoto riemerge allora in tutta la sua forza.
In una condizione geopolitica nella quale la finanziarizzazione dell’economia elide le sovranità statuali classiche, oltre alle loro abituali prerogative, accade pertanto che piccole comunità etniche – appunto, più ricche di altre – rivendichino piena autonomia politica. Tali richieste vorrebbero andare nella direzione della libertà: in realtà rappresentano un’espressione inconsapevole e pericolosa delle disuguaglianze, degli egoismi e delle inefficienze delle istituzioni statuali – in fondo, dunque, esse non sono altro che l’espressione dello stesso vuoto che le ha generate.
La forma caratteristica della soggettività moderna fa sì che gli individui entrino soltanto in quanto unità astratte e sradicate nelle masse storiche (di consenso o di partecipazione) che di volta in volta si costituiscono. Gli individui a noi coevi, però, non dispongono di alcuna massa o, meglio, le masse contemporanee vengono formate rapidamente e repentinamente si dissolvono. E tutto questo grazie all’ausilio di una tecno-scienza che informa di sé, nel profondo, tutte le forme di vita dell’attuale. L’individualismo diventa così polverizzazione estrema del fatto sociale e lo sradicamento raggiunge livelli inauditi nella storia dell’uomo.
Slegati da qualsiasi contesto comunitario, privi di un potere centrale capace di porsi da collante, vincolati esclusivamente alle regole della finanza e a quelle del capitalismo tecnocratico, è inevitabile, allora, che forze regionalistiche provino, in ogni modo, a far prevalere i propri egoismi ai quali, del resto, non si contrappone altro che l’egoismo simmetrico dei poteri centrali – magari collocati in maniera supina e subalterna rispetto ad organizzazioni sovra e transnazionali.
Se vogliamo traghettare questo mondo fuori dal nichilismo della globalizzazione – credo sia evidente a tutti – dobbiamo cercare un’altra strada.
- Lungimiranza
La civiltà europea si è caratterizzata da sempre in virtù d’una peculiarità decisiva. Essa, cioè, si è perennemente posta come una forma culturale “particolare” che ha in sé l’”universale”. La nostra cultura ha mostrato una singolare attitudine che soltanto apparentemente sembrerebbe andare in direzione auto-contraddittoria: essa, infatti, disgrega l’unità nella differenza proprio mentre si mostra disponibile a dare delle differenze una visione unitaria. È questa la nostra storia, ed è in questo dato che risiede anche la nostra grandezza. In un quadro simile, allora, è del tutto ovvio che porre la questione di identità etnicamente stabili e monolitiche in Europa sia una impresa destinata al fallimento anche soltanto per ragioni di tipo culturale – per non parlare di quelle economiche che vi si connettono. Nel nostro continente, nel corso dei secoli, nulla è stato più massiccio ed influente della contaminazione e di un fruttuoso incontro/scontro di valori. In fondo, a rifletterci bene, non stiamo parlando soltanto della storia ma anche dell’essenza stessa della libertà e della democrazia nate all’interno di quella storia. Non c’è libertà o democrazia – appunto – senza un confronto fra differenze da ricondurre all’unità della rappresentazione/rappresentanza. Per rimanere sul piano storico, tuttavia, occorre ribadire fortemente che la cultura occidentale è diventata la forma di vita più forte del pianeta non certo per il suo integralismo, meno che mai per la difesa rigida e ottusa delle sue innumerevoli forme culturali, ma piuttosto per la sua capacità di metterle in gioco. È diventata forte, cioè, per la sua portata democratica e perfino “anarchica” – per la sua capacità di emancipare gli individui e di considerare tutti, a prescindere dalle etnie e dalle convinzioni individuali, ugualmente preziosi per la comunità. La cultura europea – in estrema sintesi – fa del pluralismo il motore propulsivo della propria azione nel mondo.
Se tutto questo è vero, mi sembra ineludibile il bisogno di contrastare il gretto provincialismo che sembra dettare legge ormai nelle egocentriche (piccole o grandi) capitali europee: è del tutto ovvio, infatti, che non si possa fare affidamento soltanto sulle solite logiche di potenza economica particolaristica che, mentre favoriscono alcune zone dell’Europa, lasciano indietro le altre, incrementando ferali disuguaglianze che, prima o poi, non potranno che produrre frutti avvelenati. Se si vuole creare o consolidare un’identità politica, io credo, è invece assolutamente necessario indicare dei valori comuni capaci di integrare i territori e le diverse identità, lasciandole essere per quello che sono, nella convinzione che soltanto chi possiede una propria identità può metterla in gioco sul piano pubblico a beneficio di tutti.
Da questo punto di vista, pertanto, un’entità geopolitica che possiede da sempre una vocazione differenzialistica e universalistica insieme – come l’Europa appunto – potrebbe offrire un contributo decisivo al mondo globale. Al di là e oltre un’Unione Europea concentrata quasi esclusivamente su questioni finanziarie, e indifferente ad elementi che dovrebbero essere fondamentali quali la ricerca dell’uguaglianza e del confronto politico fra uguali, sono convinto che la politica, nazionale e internazionale, abbia il compito ineludibile di riprendere a praticare un valore come la “democrazia lungimirante”. Senza la capacità di con-vergere su un fronte unico, infatti, e senza “guardare lontano”, non c’è alcuna speranza di affrontare i fenomeni e gli eventi di un mondo sempre più complesso che richiede tutta la nostra attenzione e i nostri sforzi.
Le politiche che, per inseguire il loro interesse particolaristico, mostrino una pervicace incapacità di guardare al domani e tengano conto soltanto della logica del consenso a breve termine, della ricchezza del “noi” isolati dagli altri, sono viziate in partenza e gli effetti negativi non tarderanno a farsi sentire.
È necessario perciò – ora più che mai – ripensare con forza ad una “grande politica” europea. All’interno di un mondo sempre più interrelato, infatti, quale potrebbe essere il destino di una regione, magari oggi più ricca delle altre, ma che, slegandosi dalla nazione nella quale è cresciuta e si è sviluppata, rischia di tagliare lo stesso ramo sul quale è seduta?
Ancora una volta, dunque, credo sia assolutamente necessario l’uso d’una virtù consustanziale ad ogni “grande politica”: ciò che rappresenta una dote imprescindibile per ogni uomo politico o classe politica degni di questo nome, ossia – come detto – la lungimiranza.
ANTONIO MARTONE
[1] C. Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, Einaudi, Torino 1990, pag. 42.




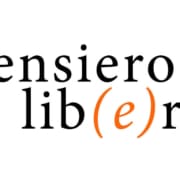

Caro Martone, tutto quello che hai scritto è condivisibile, vede il pericolo di un’espressione inconsapevole e pericolosa delle disuguaglianze, degli egoismi prodotti dal vuoto delle inefficienze delle istituzioni statuali: “Slegati da qualsiasi contesto comunitario, privi di un potere centrale capace di porsi da collante, vincolati esclusivamente alle regole della finanza e a quelle del capitalismo tecnocratico, è inevitabile allora che forze regionalistiche provino, in ogni modo a far prevalere i propri egoismi”. Tuttavia come tu stesso riconosci e riconosci come causa sono le inefficienze delle istituzioni statutali a creare il problema. Io aggiungo che non si tratta solo di inefficienza ma anche di malgoverno in sede di giustizia, una mentalità assurta a sistema che da sempre sperequa a propria discrezione tra regione e regione, un problema tutto italiano. I dati impressionati della distribuzione delle risorse e della spesa tra regione e regione sono al di là di ogni plausibile principio di solidarietà e meritano senz’altro attenzione e intervento. Mi rifaccio al principio che in analisi se il paziente non paga la terapia non riesce, per dire che il Sud non può essere solo assistito e ripagare le trasfusioni con voti.
Non si tratta di gnenetica ma di mentalità incancrenite che nessuno si azzarda a toccare. Nè regioni a statuto speciale possono continuare a godere di privilegi che altre regioni non hanno solo perchè ogni deputato passa prima delle elezioni a confermare i privilegi (Monti compreso). Ora, pare chiaro che tutta la faccenda finanziaria verta su chi e come si debba redistribuire le somme incassate dallo stato. non si può certo tollerare che Renzi dia soldi alla Campania per far eleggere De Luca. Che la redistribuzione venga fatta da governi assistenziali con residenza a Mafia Capitale costituisce un enorme problema cui nessuno, nessuno, ha mai avuto l’ardire di mettere mano. Corruzione, collusione, clientelismo, CCC, sono di fatto al potere a Roma. L’unica variante è la misura, che comunque resta sempre alta. Una risposta a questo malcostume (eufemismo) va data. E per me il referendim se considerato da questo punto di vista era una buona occasione, portando questi come temi e proponendo un federalismo di regioni sorelle pronte ad aiutarsi di contro a un centro da sempre in ogni senso sperequante. Grazie anche a giustissime osservazioni come la tua a mio vedere una sempre valida ma malriposta generosità ha imperdito alla sinistra di cavalcare con motivazioni più che valide il referendum regalando ancora una volta il successo a forze reazionarie. Così facendo Roma rimarrà sempre Roma e il Sud il Sud.