di Fathi Triki
traduzione a cura di A. Coratti
Voler vivere diventa, nello stato attuale, un obiettivo primario per l’individuo la cui fragilità aumenta con lo sviluppo straordinario della tecnologia. Egli rischia, in qualunque momento, di finire emarginato a causa della disoccupazione, a causa dei più diversi inconvenienti, dell’isolamento, di ogni tipo di malattia, dell’inquinamento, delle sostanze nocive o della violenza sociale che aumenta senza tregua e, ai giorni nostri, a causa del terrorismo che si normalizza sempre di più e tocca tutti i paesi del mondo. Effettivamente, nelle nostre società, come ha scritto il sociologo tedesco Ulrich Beck, “la produzione sociale di ricchezze è correlata sistematicamente alla produzione sociale di rischi[1]”. Tali rischi, che si aggravano sempre di più, non derivano solamente da cause esterne come le catastrofi naturali, ma soprattutto dalla società stessa e dalle inattese conseguenze, spesso negative, dello sviluppo delle scienze e delle tecnologie, generando angoscia, paura e mettendo in pericolo non soltanto l’individuo nella sua libertà e nella sua esistenza singola, ma la società stessa. E’, senza dubbio, possibile parlare di disuguaglianza del rischio, poiché il sistema economico e politico nelle società iper-capitaliste protegge maggiormente le classi agiate e le classi dirigenti. Attualmente, nella logica di ciò che chiamiamo “risorsa umana”, si può anche parlare dell’uomo “usa e getta”, al quale proporre, per esempio, un contratto di lavoro a tempo determinato, per poi abbandonarlo, in un secondo momento, alla propria miseria.
Dunque, in questa nuova configurazione della società, non resta nient’altro che la vita, al punto che il “sistema dell’assicurazione”, a tutti i livelli della vita individuale e sociale, cresce continuamente e diventa, talvolta, padrone nel sistema finanziario stesso.
Voler vivere è, quindi, un’espressione rivoluzionaria poiché richiama alla lotta quotidiana per un ambiente sano, una vita sociale piena di uguaglianza, una società senza paura e senza rischi. Abou el Kacem Chebbi, poeta tunisino della libertà e dell’amore ha espresso, in tutt’altro contesto, questa volontà di vivere: “Lorsqu’un jour le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre,
force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser[2]”.
Dalla rivoluzione tunisina del 17 dicembre 2010, questo celebre verso è diventato la parola d’ordine di protesta in parecchi paesi nel mondo. «Il popolo vuole» non esprime soltanto un atteggiamento per imporsi e un modo di dimostrare la propria capacità di resistere o la propria forza di partecipare al governo del paese e della società. Esso esprime anche una forma di restance, per utilizzare un termine caro a Derrida, in una vita minacciata da una politica mondiale fondata essenzialmente sulla morte. Effettivamente, restare in vita, restare coscienti, restare svegli e mobilitati è un mezzo per il popolo, come per l’individuo, di lottare contro lo sfinimento, le minacce e la morte. Voler vivere è, alla fine, un mezzo per lottare contro l’isolamento dell’individuo contemporaneo che, pur essendo presente all’interno delle formazioni sociali che costituiscono il suo mondo, si trova di fronte a un solipsismo inquietante. Facendo zapping davanti alla propria televisione, parlando davanti al proprio smartphone o, persino, leggendo il proprio giornale, l’uomo delle nuove tecnologie della comunicazione si sottrae alla presenza della parte umana e si chiude sempre di più dentro una sorta di cyber solipsismo dominante. Se si aggiunge a ciò, la straordinaria macchina mediatica che, attraverso le informazioni, i film, i giochi mirati ecc., aumenta quotidianamente i sentimenti d’isolamento, di paura e di angoscia, questo esilio diventerà, ineludibilmente, una prigione “sur le chemin sans gloire de la peur et de l’angoisse”. Non sto sostenendo, qui, la tesi retrograda di un voler vivere senza tecnologia e senza le acquisizioni di culture scientifiche e tecniche. Io penso semplicemente che bisogna rimettere in discussione il modo di usare questo patrimonio e sviluppare una visione umana della ragione e della tecnica. Ciò si farà attraverso l’esigenza del “ragionevole”, che sposa armoniosamente la ragione e l’affetto, l’argomentazione e l’immaginazione, la scienza e la creazione artistica e attraverso la necessità del vivere-insieme nella dignità, come via di accesso all’umano e all’universale.
La nozione del vivere-insieme è, ai nostri giorni, svalutata. È stata recuperata da ideologi e politici per difendere una certa armonia che essi vedono necessaria nella loro società. Essa può anche essere una trappola, poiché potrebbe veicolare un’immagine irreale e paradisiaca della società cancellando i conflitti, le lotte, le esclusioni e le violenze che accompagnano generalmente ogni raggruppamento sociale. Quando ho formulato una possibile filosofia del vivere-insieme nel febbraio 1998[3], durante il discorso inaugurale della Cattedra Unesco di Filosofia per il mondo arabo, mi sono ispirato a Hannah Arendt, alle sue riflessioni sul “pubblico” e “l’agire umano”. Il pubblico, per lei, designa “il mondo stesso in quanto comune a tutti e si distingue radicalmente dal posto che occupiamo in quanto individui»[4]. Questo mondo comune è legato all’agire umano, “agli oggetti fabbricati dalle mani degli uomini, alle relazioni che esistono fra gli abitanti di questo mondo”. Poi aggiunge, “vivere insieme nel mondo: vuol dire essenzialmente che un mondo di oggetti regge solamente tra coloro che li hanno in comune, come un tavolo è situato tra coloro che si siedono intorno ad esso; il mondo unisce e separa gli uomini nelle stesso momento[5]”. Il vivere-insieme, questo mondo comune, quindi, ci riunisce e ci divide contemporaneamente. “Una strana situazione che evoca una seduta spiritica nel corso della quale gli adepti, vittime di un trucco di magia, vedranno il loro tavolo sparire improvvisamente, le persone sedute una davanti all’altra non sono più separate, ma neanche legate, perché si tratta di qualcosa di concreto[6]”. Ciò significa, effettivamente, che l’uomo è sempre più solo nella società. Il vivere-insieme ha pertanto bisogno di essere pensato e spiegato affinché acquisisca un senso nella nostra attualità. Aristotele ha ben dimostrato che il vivere-insieme è una necessità biologica. Questo vuol dire che ogni animale, solo che sia, è obbligato nella vita e dalla vita a costruire una relazione con il mondo.
Ecco perché, la filosofia, a partire da Aristotele, cerca di spiegare il fine e l’obiettivo di ogni vivere insieme. Hannah Arendt, per esempio, lo vede nell’ “agire in comune”; Etienne Tassin[7] segue le tracce di Arendt e dimostra che la filosofia ha fallito nella sua elaborazione del vivere-insieme poiché non ha saputo superare il rapporto dominante-dominato nella società umana. È dunque necessario un ideale che dia un senso al vivere-insieme. Etienne Tassin lo trova nella figura della promessa che “è un atto di raccolta dal quale emerge una potenza, finalizzata non a dominare ma ad agire insieme[8]”.
In un libro pubblicato nel 1998 dall’Unesco[9] ho difeso il principio di dignità che deve regolare tutto il vivere-insieme e inscriverlo nell’ordine dell’ospitalità. La filosofia del vivere insieme nella dignità[10] ha aperto un interessante campo teorico che riprende alcuni concetti operativi come quelli di “umanità”, “giustizia”, “violenza”, “diritti”, per poi studiarli alla luce di questa nuova filosofia. La sfida, per noi, è difendere nella nostra cultura l’emergere dell’individuo libero contro l’unilateralità della comunità, senza che questo individuo sprofondi nella solitudine e nella dissociazione[11]. Difendere la libertà, il diritto alla differenza, l’alterità, significa, in fin dei conti, lottare affinché la dignità della persona sia il principio fondamentale per ogni vivere-insieme.
Quando il presidente della Repubblica tunisina, la domenica del 13 agosto 2017, ha aperto un fondamentale dibattito, proponendo di introdurre l’uguaglianza nelle successioni tra uomini e donne e l’annullamento della circolare del 1973 che proibisce alle donne tunisine di sposare non-Musulmani, egli non ha fatto altro che mettere in pratica lo spirito stesso della costituzione tunisina redatta dopo la rivoluzione, nel 2011, che sancisce che “i cittadini e le cittadine sono uguali nei diritti e nei doveri”. Faccio rapidamente un esempio della circolare del 1973 che proibisce alle donne tunisine di sposare non-Musulmani. Ecco il versetto coranico a cui fanno riferimento gli Ulema[12] per confermare questo divieto: “Non sposate le donne idolatre finché non avranno acquisito fede. Una schiava credente è preferibile ad un’idolatra libera, anche se ha il vantaggio di piacerti. Non fate sposare le vostre figlie con gli idolatri finché non avranno acquisito la fede. Una schiava credente è preferibile a una idolatra libera, anche se questa dovesse piacerti. Non date in spose le vostre figlie agli idolatri fino a che essi non abbiano acquisito la fede. Uno schiavo credente è meglio di un ateo libero, anche se quest’ultimo ha il vantaggio di piacervi perché gli atei vi indirizzano all’Inferno, mentre Dio, attraverso la sua grazia, vi invita al Paradiso e all’assoluzione dei vostri peccati. Dio spiega chiaramente i suoi versetti agli uomini, per portarli a riflettere (Al Baqara, 221). L’ipocrisia e la fallocrazia di questi Ulema hanno fatto in modo che l’interdizione si applichi solamente alle donne, nonostante il fatto che questo versetto riguardi chiaramente sia gli uomini che le donne. In più “le donne idolatre” e gli uomini idolatri non sono né gli ebrei, né i cristiani. Dunque, bisogna avere il coraggio di iniziare un dibattito ed anche una lotta per istituire definitivamente, in ogni caso, in Tunisia, la libertà e l’uguaglianza tra uomo e donna. L’identità è sempre stata evocata come argomento contro ogni mutazione sociale. Noi siamo musulmani e dunque tutto deve farsi nell’ordine dogmatico di questa religione. In questo senso, questa può essere pericolosa e mortale. Sappiamo, per esempio, che attualmente c’è una deterritorializzazione dell’islam politico. Essa ha avuto, come conseguenza, una nuova configurazione dell’identità dell’individuo. La base sulla quale si edifica questa identità è semplicemente l’Islam, proprio come viene vissuto ed applicato. Poco importa il luogo di nascita o di residenza, poco importa il paese dove i genitori e gli antenati hanno vissuto, noi siamo definiti dall’islamità e da tutta la simbologia che veicola questa appartenenza. Il principio dello Stato-Nazione è stato introdotto dalla colonizzazione e impiantato dai razionalisti progressisti in alcuni paesi islamici ma, una volta ottenuta l’indipendenza, l’appartenenza nazionale ha avuto problemi ad imporsi come criterio d’identità. Il Panarabismo, peraltro introdotto all’inizio da intellettuali arabi di religione cristiana, non ha potuto superare l’appartenenza all’Islam per ricostruire una nuova identità fondata sulle radici arabe. La facilità con la quale avviene il coordinamento nelle azioni dei gruppi islamici politici terroristici ovunque nel mondo, dalle Filippine agli Stati Uniti, passando per la Cecenia e la Nigeria, si spiega in parte con questa identificazione islamica senza confini, che si diffonde per tutta la territorializzazione politica.
La filosofia del vivere-insieme è in fin dei conti un’incursione nella strategia delle nostre abitudini, un incitamento a riflettere liberamente sui problemi della nostra cultura, della nostra società, sui problemi della donna, della libertà, della civiltà, della sessualità, delle minoranze, dei diritti, problemi che costituiscono “il nostro presente, che siamo noi stessi”, per adoperare una formula cara a Michel Foucault.
Che cosa ne è stato di questo vivere-insieme nella rivoluzione tunisina? Ci sono, nello svolgimento della storia, degli avvenimenti che gli storici chiamano “eventi fondatori”. I filosofi sottomettono questi eventi fondatori alla riflessione per decidere ciò che deve essere considerato come punto di partenza di una possibile profonda trasformazione dei modi di essere, seguendo l’esempio di Poulain, Badiou o Rancière. Si può, per esempio, considerare l’abbattimento del muro di Berlino come l’evento che ha permesso la fioritura della libertà, un po’ in tutto il mondo. Il trattato dell’Eliseo firmato nel 1963 tra la Germania e la Francia è, allo stesso modo, un evento fondamentale che ha reso possibile l’unità europea, garantendo una vicinanza sostenibile e duratura. La rivoluzione tunisina[13] può essere considerata, in larga misura, come un “evento fondatore” di cui un’attenta e minuziosa ricostruzione filosofica può mostrare che, attualmente, essa sta per sconvolgere la geopolitica del mondo. Le varie guerre che imperversano nelle regioni del mondo arabo e le diverse manifestazioni di violenza sociale e politica, ivi compreso il terrorismo[14], sono più o meno il risultato diretto o indiretto di questo evento fondatore. Yadh Ben Achour scrive nel suo eccellente libro Tunisie, une révolution en pays d’islam: “questa rivoluzione nel futuro sarà oggetto di profonde e numerose analisi e ricercatori verranno a scavare i solchi della storia per chiarire ancora meglio i dettagli della Rivoluzione tunisina[15]”. Innumerevoli ricerche e numerose pubblicazioni in arabo, in francese ed in inglese hanno già provato a riflettere sulla natura di questa rivoluzione, sul suo andamento e sugli impatti sulla situazione geopolitica del mondo arabo e islamico. Non sono d’accordo con quegli analisti che si sforzano di dimostrare che la rivoluzione tunisina, alla fine, non è che un “colpo di Stato”, una sorta di “complotto” voluto ed eseguito dagli imperialisti e dai loro alleati per destrutturare il mondo arabo. Senza disprezzare questa tesi, penso che alcuni servizi stranieri[16], e media occidentali ed arabi come Al Jazeera abbiano provato a deviare questa rivoluzione dal suo obiettivo ed abbiano preparato le condizioni per il suo insuccesso. Ciò non nega per niente i fatti storici accertati che danno alle differenti rivolte popolari che ha conosciuto la Tunisia dal 2008 un carattere rivoluzionario. Effettivamente, la rivoluzione tunisina è cominciata nel 2008 con lo sciopero dei minatori della regione di Gafsa[17]. Questo movimento è continuato malgrado l’atroce repressione da parte delle autorità, mettendo in atto, per mesi, diverse forme di resistenza. Esso ha contribuito a mobilitare una larga fetta della popolazione locale, provocando morti, centinaia di arresti, atti di tortura e imprigionamento che ha toccato il mondo associativo o sindacale così come quello dei giornalisti. Nata come rivoluzione operaia, ha ben presto coinvolto i laureati disoccupati della regione, poi tutti i disoccupati ed i giovani, quindi tutto il sud e le regioni occidentali che insorsero in seguito al suicidio di Bouazizi il 17 dicembre 2010. Quando la borghesia nazionale si è unita al movimento (presso Sfax e Tunisi) per denunciare l’ingerenza sull’economia e la politica del paese da parte della borghesia acquirente, affarista e mafiosa legata alla famiglia del presidente Ben Ali, la rivoluzione è diventata totale perché ha potuto inglobare tutte le classi sociali in Tunisia ed in tutte le regioni. La manifestazione del 14 Gennaio 2011 lungo il viale Bourguiba ha simboleggiato questa totalità in movimento. Ciò che è successo tra il 2008 e il 2011 è una rivoluzione popolare che doveva scuotere il regime in nome di una vita più giusta per tutte le categorie della popolazione. Questo, secondo me, è il significato più forte della parola Karama, dignità dichiarata e pretesa dai rivoluzionari. La rivoluzione tunisina è e deve essere considerata come un evento fondatore. Oggi, questa rivoluzione non sta solamente sconvolgendo la geopolitica mondiale, ma genera anche un nuovo modo di pensare l’essere-al-mondo.
Il movimento degli indignati, nato a Madrid nel maggio 2011, ovvero 4 mesi dopo lo scoppio della rivoluzione tunisina la cui parola d’ordine è dignità, è un esempio edificante dell’effetto della rivoluzione tunisina in Europa, del rinnovamento dell’azione politica cittadina e del modo di pensare filosofico e sociale.
La letteratura emersa a partire da questo movimento mostra il suo effettivo legame con la rivoluzione tunisina e con la “primavera araba” in quanto preconizza una rivoluzione culturale e intellettuale della sinistra, soprattutto europea. Un altro esempio viene dalla Francia; è il movimento Nuit debout[18]. È stato spesso affermato, durante le manifestazioni del movimento Nuit debout, che questa forma di azione politica di riunione e occupazione di luoghi pubblici non ha precedenti. È diventata, col tempo, una forma riconosciuta, ora usata come lo sciopero, la manifestazione, il sit-in, la rivolta. È anche una forma attuale e contemporanea di azione politica, esclusi i partiti, esclusi i sindacati, senza un leader, senza un programma. In realtà, è la rivoluzione tunisina che ha inaugurato questo nuovo modo di combattere al di fuori di qualsiasi forma di istituzione, senza una guida, senza un leader e senza partito politico.
Il movimento Nuit debout non si è potuto trasformare in rivoluzione, ma ha scosso l’ambiente politico in Francia e nel mondo. Ha provocato soprattutto un nuovo stile del vivere-insieme, all’insegna dell’amicizia nella lotta per la dignità.
Infine un terzo esempio: la campagna elettorale presidenziale del 2017 in Francia ha dato luogo ad un movimento politico intorno al candidato Jean-Luc Mélonchon che fu chiamato con un neologismo, “dégagisme”, facendo riferimento alla parola «dégage» adoperato dai manifestanti all’epoca della rivoluzione tunisina, il 14 gennaio del 2011. William Audureau scrive su Le Monde del 30 gennaio 2017 che il leader della sinistra francese, Jean-Luc Mélenchon, “rivendica apertamente” la filiazione con il movimento d’insurrezione popolare tunisino del 2011. I tunisini avevano, infatti, designato con il termine “dégagisme” la loro rivoluzione democratica nei confronti di Ben Ali e con “dégage” l’esortazione per tutti ad unirsi alla rivolta. La “rivoluzione del gelsomino”, popolare e non violenta, conclusasi il 14 gennaio 2011 con la fuga del presidente della repubblica Zine el-Abidine Ben Ali, ha suscitato ammirazione da parte di molti osservatori. In Belgio, in particolare, il collettivo di estrema sinistra teorizza espressamente il “dégagisme” e nel 2011 ne descrive l’originalità in un manifesto del “dégagisme”: “Per la prima volta, … non si tratta di prendere il potere, ma di rimuovere colui che lo detiene, liberando il posto che occupa».
Alcuni colleghi mi hanno contattato per dirmi che non potrebbero mai accettare di vivere insieme agli integralisti musulmani che hanno solamente un obiettivo: obbligare tutti a vivere secondo quello che loro hanno deciso come regole di vita o come Chariaa. Naturalmente, il “vivere insieme nella dignità” non ha l’ingenuità del pacifismo a qualunque costo. Il vivere insieme può svolgersi secondo l’ordine dell’ostilità o secondo l’ordine dell’ospitalità. Nello stato attuale, è l’ordine dell’ostilità che regna. “Lo stato normale, scrive Nietzsche, è la guerra, noi sigliamo la pace solo in epoche determinate”. È, dunque, impossibile coabitare con coloro che rifiutano ogni tipo di “vivere-insieme” e considerano l’esistenza solamente sotto forma di dominio e di ubbidienza, di esclusione e di interdizione, di violenza e di guerra. La vita è lotta, sofferenza, ma anche rischio ed invenzione. Il ruolo originario della filosofia, a mio avviso, è di persuadere l’altro che la vita vale la pena di essere vissuta e che il miglior modo sia quello di essere insieme nella dignità e ciò si farà attraverso la ragione e le leggi volute ed accettate da tutti. Spinoza lo afferma evidenziando che “la ragione insegna in maniera generale a cercare la pace, ma è impossibile giungervi se le leggi comuni della città non restano inviolate”.
[1] Arlette Bouzon, « Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, trad. de l’allemand par L. Bernardi », Questions de communication, Aubier 2001, p.36
[2] Traduction de Abderrazak Cheraït, Abou el Kacem Chebbi, éd. Appolonia, Tunis, 2002
[3] Discorso pubblicato in un piccolo testo, Philosopher le vivre-ensemble, Tunis, L’Or du temps, 1998.
[4] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Agora, Pocket, p. 92, (traduction de Georges Fradier)
[5] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p.93
[6] Ibidem
[7] Etienne Tassin, Un monde commun. Pour une cosmopolitique des conflits, Paris, Seuil, 2003
[8] Etienne Tassin, Un monde commun. Pour une cosmopolitique des conflits, Paris, Seuil, 2003, p. 104
[9] Taking action for human rights in the 21st century, Paris, Unesco 1998.
[10] L’idea del “vivere-insieme nella dignità” che ho difeso per la prima volta nel 1998 presso la sede dell’Unesco, mi ha permesso di ottenere il Diploma di Merito Scientifico dell’Istituto di Promozione della Filosofia Francofona di Kinshasa . L’idea è stata in seguito ripresa da diverse università, molte ONG e molti filosofi. A titolo d’esempio, cito la celebre casa editrice svizzera Peter Lang con la collaborazione dell’Università di Brema (Germania), che ha istituito una collana filosofica intitolata “filosofare il vivere-insieme”. Il filosofo francese Vincent Cespedes ha pubblicato on line un dialogo intitolato “Il vivere-insieme nella dignità. Le università del Cairo e di Zagaziz hanno introdotto questa idea nel loro programma. Molte tesi di laurea e di dottorato nelle università algerine e tedesche trattano questa questione. Lo spazio culturale Aykar a Tunisi ha organizzato un programma internazionale negli ultimi tre anni su tale tema. Recentemente il teatro Antoine-Vitez-Ivry ha pubblicato un libro «Vivere-insieme nella dignità» che raccoglie gli atti di una conferenza del 2015
[11] Giorgio Agamben, nel suo libro La comunità che viene, parla di “singolarità qualunque” che “non possono formare una società perché non dispongono di alcuna identità che possano far valere, di alcun legame di appartenenza da far riconoscere» (p.88). Per me, l’individuo che deve emergere nella nostra società non deve essere senza identità. Questa idea nichilista di Agamben è, per me, improduttiva. Certo, ogni Stato ha bisogno di identificare l’individuo, ma ciò non è una ragione sufficiente per militare in favore delle singolarità senza appartenenza o, allo stesso modo, di questa “singolarità qualunque che vuole appropriarsi della sua appartenenza stessa, del suo proprio essere-nel-linguaggio e che rigetta ogni identità e ogni condizione di appartenenza”. L’individuo à venir non deve sprofondare definitivamente nell’ “essere-nel-linguaggio” che è, fondamentalmente, un non-essere (Platone).
[12] Teologi, generalmente sunniti, della legge coranica e garanti del rispetto e della corretta applicazione dei principi dell’Islam
[13]Per avere un’idea degli avvenimenti della rivoluzione tunisina, cf. l’eccellente di Jean-Marc Salmon, 29 jours de révolution. Histoire du soulèvement tunisien, 17 décembre 2010 – 14 janvier 2011, Paris, Les Petits matins, 2016, 350 p.,
[14] Generalmente, si definisce il terrorismo come violenza causata da individui o da gruppi non-di-Stato in lotta contro un regime politico, ma causata ugualmente da un modo di governare (terrorismo di Stato). Bisogna evidenziare che questa definizione di terrorismo solleva, giustamente, dei dibattiti poiché pone la questione della violenza legittima e del diritto alla resistenza. Bisgona sapere che certi Stati utilizzano questo termine di terrorismo per designare l’opposizione legittima e spesso clandestina quando questi regimi sono autoritari o dittatoriali
[15] Yadh Ben Achour, Tunisie, Une révolution en pays d’islam, Tunis, Cérès Editions, 2016, p.30
[16] Cf. Mezri Haddad, La face cachée de la révolution tunisienne, Islamisme et occident, une alliance à haut risque, Tunis, Ed. Arabesques 2011
[17] La rivolta del bacino minerario di Gafsa è un importante movimento operaista e sociale che ha scosso l’intera regione mineraria del sud-ovest tunisino per più di sei mesi nel 2018
[18] Nuit debout è un insieme di manifestazioni svolte nelle piazze pubbliche, soprattutto in Francia, cominciate il 31 marzo 2016 a seguito di una manifestazione contro la “legge-lavoro” in Place de la République a Parigi.



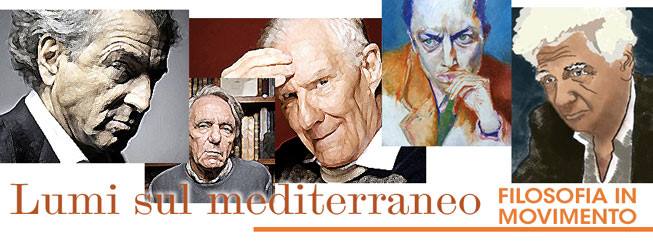


 Francesco Postorino
Francesco Postorino