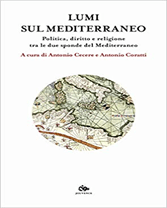Il populismo in Italia, oggi: Nazione, legalità, rappresentanza
di Domenico Bilotti
Il populismo pretende di vincere a maggioranza proprio perché si fa propaganda ergendosi a proclama di minoranze impotenti. Il suo unico scopo regolativo reale è il conseguimento di quella maggioranza, dalla quale pretende di ricavare un salvacondotto universale. Non è sostanzialismo, è strumentalismo. Le istituzioni che critica sono spesso le medesime di cui si serve per ascendere.
1-Il (non)governo populista: uno sguardo alle dinamiche storico-politiche in Italia
Il cancelliere Otto Von Bismarck, federatore degli Stati germanici e tessitore di reti diplomatiche europee, soleva dire che fosse meglio non far conoscere al popolo come venivano preparate le salsicce e scritte le leggi. Bismarck era l’alfiere di una legislazione unitaria tedesca fortemente attenta ai presupposti materiali – il consolidamento del potere – e ai suoi addentellati applicativi – la necessità di garantire l’ottemperanza. Eppure, questa massima ci restituisce l’idea di un processo decisionale pubblico che da attività di redazione, assemblaggio e selezione si fa compromesso di scarto, pastiche privo di ideali di giustizia.
Un altro fautore delle unificazioni ottocentesche, romantico più che politico, Alessandro Manzoni, mette in bocca a un mercante, nel XVI capitolo dei suoi Promessi Sposi, una spiegazione tipicamente dietrologica e complottistica dell’assalto ai forni: un vandalismo programmato come strumento di pressione politica.
Ecco probabilmente in luce due caratteristiche tipiche del fenomeno giuspolitico e storico-politologico che chiamiamo “populismo”: l’individuazione artata di un problema percepito, di cui ci si avoca l’esclusività, facendo leva sia sulla distanza tra i governanti e i governati sia sull’esistenza di una dinamica auto-conservativa di tutte le autorità. Non si tratta di strategie così inedite nella teoresi del ragionamento giuridico e dell’argomentazione. Basti ricordare che Franco Cordero, penalista di grande spessore, in una ragionata biografia dedicata a Savonarola, feroce stigmatizzatore dei mali della Chiesa e del suo tempo, faceva delle pubbliche lamentazioni un ritratto impietoso. Esse ottengono successo soprattutto quando non offrono alternative, non sono conseguenza di un dibattito interno alla minoranza sediziosa insorta, falsificando in definitiva un “nemico” che viene creato retoricamente come il massimo indice della pubblica repellenza.
Il populismo non si cura, però, di migliorarsi o di migliorare le condizioni di vita: denuncia i problemi che crea e se ne propone come unico e più immediato solutore. Non è soltanto un problema di mezzi culturali o di carente know how tecnico-legale. Giuseppe Di Vittorio, emblematico segretario generale della CGIL dal 1944 al 1957, aveva un’oratoria spiccia, talvolta poco raffinata e non sempre salva da imperfezioni grammaticali. Non veniva dalle specializzazioni di fabbrica, difendeva aulicamente il bracciantato da cui proveniva. Esprimeva, nonostante la ruvidezza del tono e la modestia dell’argomento, l’idea di un mondo che voleva elevare la propria cultura, le proprie condizioni di vita, la tutela dei propri diritti. Non era figlio di viscerale plebiscitarismo che si riteneva autosufficiente, nulla a che vedere aveva coi partiti della nazione o con la propaganda de “l’uno vale uno”.
L’argomentazione populista nella storia recente italiana, e in particolar modo nel periodo di transizione dell’età precostituzionale, dal fascismo alla forma repubblicana, cerca di darsi toni contropotere, ma è perfettamente funzionale al potere. Le forme della propaganda mutano d’impatto, ma sempre a politiche concentrazionarie mirano. Mussolini si fece fautore di una legislazione elettorale che assegnasse un allora inedito premio di maggioranza ai partiti che avessero ottenuto almeno il 25% dei suffragi validi e lo fece anticipando alcuni punti (garanzia del funzionamento parlamentare, speditezza dell’azione dell’esecutivo) che sono stati nei decenni adottati a ogni mutamento di regolamentazione elettorale, quasi che si trattasse di innovazioni attuali, moderne e contemporanee. Gli scopi di una contrazione del potere di scelta insito nella preferenza di lista sono, invero, sempre i medesimi e puntano convergentemente a dare maggior forza ai poteri egemoni. Mussolini adottò la stessa strategia nel campo dell’editoria, espropriando dietro pingui indennizzi i mecenati liberali come Frassati e Albertini, “freddi” rispetto al progetto del Partito Nazionale Fascista, e favorendo gli Agnelli e i Crespi, che non si fecero all’opposto scrupolo a riverirne l’ascesa.
2-Il “populismo legalista”: l’invenzione del decisionismo
Il populismo quale stiamo descrivendolo ha una concezione meramente strumentale dell’ordine pubblico ed è proprio su questo campo che si misura oggi la sua maggior carica venefica. Significa in altre parole negare la virtù dei pesi e dei contrappesi, dell’incontro fecondo tra istituzioni del controllo procedurale e istanze sociali materiali: si annullano, anzi, le prime, perché si ritiene così di soddisfar meglio le seconde (quando lo scopo è proprio quello di abbatterle).
C’è qualche remora ad ammetterlo oggi, ma il programma sviluppato in Costituente dal giurista Piero Calamandrei perorava un modello largamente anglosassone, temperato da un orientamento culturale formato sulle categorie del diritto civile continentale. Calamandrei, proprio in funzione antidemagogica, esaltava le virtù di un modello federale forte, coeso nell’unità nazionale e altamente proclive al raccordo delle autonomie locali, e addirittura immaginava un ruolo presidenziale bilanciato da un aumento complessivo della qualità della partecipazione politica. L’argomentazione di Calamandrei, memorabile per autorevolezza e da saper comunque sottoporre al vaglio critico dei rischi concreti del suo impianto, era marcatamente democratica, ostile alle semplificazioni becere. Dietro qualunque modulo organizzativo della Costituzione formale di uno Stato, c’è la sovranità popolare nel prisma descritto dalla Costituzione medesima. Il populismo pretende di vincere a maggioranza proprio perché si fa propaganda ergendosi a proclama di minoranze impotenti. Il suo unico scopo regolativo reale è il conseguimento di quella maggioranza, dalla quale pretende di ricavare un salvacondotto universale. Non è sostanzialismo, è strumentalismo. Le istituzioni che critica sono spesso le medesime di cui si serve per ascendere.
Il ruolo dei corpi intermedi nell’implementazione dei diritti (civili, politici e sociali) era generalmente riconosciuto dai giuristi della stessa generazione di Calamandrei, a prescindere dalla loro appartenenza ideologica. La critica della Destra liberale ottocentesca ai partiti (cara al Minghetti) aveva ancora profili d’attualità, ma pesavano la sospensione e la soppressione delle libertà associative del Ventennio nel riprenderne i dati e le conclusioni. Il plastico tradimento dei valori repubblicani fu perfezionato dalla “repubblica dei partiti”, dal complesso quadro di spartizione di cariche e nomine che i partiti dell’arco costituzionale fomentarono: il consociativismo italiano, che poteva avere la virtù di spalmare la governance, divenne, ai suoi livelli deteriori, mera divisione di “bottini” (bottini di finanza pubblica, non solo in principio di attività illecite).
Il consenso elettorale in quanto tale non legittima la richiesta di benefici derogatori o suppletori rispetto alle norme di legge. È dalle elezioni politiche del 2006, fiaccamente vinte dal centrosinistra, che si è fatta strada l’idea per cui vincere con poco margine non legittimi l’autonoma scelta di tutte le cariche pubbliche da parte del vincitore. L’argomento ha un suo fondamento se si ritiene che debbano essere riconosciute istituzionalmente delle posizioni di “garanzia”, di “bandiera”, di “tribuna”, ai “soccombenti” della competizione elettorale. È bene ricordare, però, che all’incirca nei primi trent’anni di storia repubblicana il Partito Comunista Italiano, insospettabilmente forza di maggioranza relativa in numerose zone del Paese, non ebbe mai alcuna presidenza di camere parlamentari. E, quando finalmente questa tribuna di “pluralismo costituzionale” fu riconosciuta, il Partito Comunista non sempre seppe utilizzarla nel miglior modo possibile. Pietro Ingrao, leader di una minoranza del PCI eclettica ed eterodossa nel rapporto coi movimenti sociali ma fondamentalmente disciplinata nella burocrazia di partito, è unanimemente riconosciuto tra i migliori Presidenti della Camera nella storia del Paese. Tuttavia, fu il medesimo Presidente che negò alla Camera il dibattito durante il sequestro Moro: dietro l’ottica del “maiora premunt”, si fece strada l’idea che il bene della nazione dovesse essere preservato dall’interruzione e dalla negoziazione delle sue libertà politiche.
L’attuale inadeguatezza dei partiti a svolgere una funzione chiara nella vita associata – formazione, canalizzazione e valorizzazione di istanze – nasce in fondo dalla loro permanente pretesa auto-giustificativa. La stessa da cui sono affetti i loro attuali antagonisti. Nel 1993 il referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti ebbe un risultato plebiscitario, probabilmente montato ad arte dall’onda lunga di Tangentopoli. La legislazione successiva in materia di rimborsi elettorali, concepita sin dai lavori preparatori come strategia dilatoria ed elusiva di attuazione di quel referendum, si è rivelata persino peggiorativa.
Il populismo in Italia ha sempre fondamentalmente preservato un’esaltazione manierata della giurisdizione: il processo come sistema di garanzie era lungaggine, il verdetto l’importante. Il fatto è che utilizzare i fenomeni di corruzione come forma di delegittimazione della sfera pubblica li alimenta, e non li arresta; fomenta, anzi, una comunicazione della vita giudiziaria del Paese inesatta, legalista per modo di dire, ma non proprio irreprensibile sul piano della tecnica legislativa.
Il contrasto alla criminalità organizzata è stato tra i primi epifenomeni a segnalare il divario tra il detto e il fatto, anche perché l’urgenza e l’impatto dei fatti più sanguinosi hanno verosimilmente facilitato le prese di posizione di comodo. Due episodi, uno del recente passato e uno della cronaca attuale, vistano questo sguardo miope e ne segnalano, con la giusta prudenza e rispettosità, i pericoli e i rischi.
Luciano Liggio, il primo “capo” dei Corleonesi a guidare la “Commissione” mafiosa, detenuto dal 1974 fino alla sua morte, certo nei suoi primi anni nelle strutture penitenziarie provò ad esercitare lo stesso ruolo simbolico e decisionale che aveva in latitanza e giudiziariamente gli si addebita la capacità di aver veicolato ordini anche ormai da ristretto. Fino all’alba degli anni Novanta venne generalmente ritenuto il capo per antonomasia, la guida scaltra nel reggere i fili, nonostante le condizioni di salute peggiorate. È ora possibile dire che si era progressivamente tramutato nella dimensione fumettistica della sua appartenenza mafiosa (l’idioletto, il sigaro, gli occhiali da sole), ma sin dagli anni Ottanta, come fu chiaro nel periodo delle stragi, i vertici organizzativi di Cosa Nostra avevano assunto altre denominazioni, nuove determinazioni e cariche diverse.
Negli ultimi mesi, ancora, il mondo dell’informazione ha scoperto il radicamento di gruppi mafiosi autoctoni nella zona dell’Ostiense, sul litorale Sud romano. Sia chiaro: il riscontro dell’articolo 416 bis, agli indici normativi che lo fissano, senz’altro può e deve avvenire tutte le volte in cui lo si renda necessario. Non è però la spasmodica attenzione su gesti anche clamorosi (la testata inferta a un giornalista da un presunto affiliato all’organizzazione; i danneggiamenti spettacolari; le celebrazioni funebri, ecc.) che pare idonea a risolvere il problema della penetrazione criminale nel Basso Lazio, nel quale le influenze mafiose fanno data almeno agli anni Settanta. Perché il recepimento mediatico è stato così tardivo? Si deve dare ragione alla produttività della strategia antilegale dell’inabissamento, per produrre lucro illecito nel silenzio degli organi di informazione e nella relativa discontinuità di quelli di sicurezza? Vi sono state negli anni proposte di ri-regolamentazione del voto di scambio in senso quasi smodatamente espansivo (fino alla “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’organizzazione”). Davanti a questa indeterminatezza, il penale da obbligatorio si fa discrezionale e da discrezionale si fa arbitrario, aprendo spazi politici enormi a chi lo cavalca soltanto in senso elettoralistico.
3-Prime conclusioni: la nazione e la nazione divisa
La tronfia retorica del populismo ha un altro elemento che merita di essere sottolineato. Nel primo paragrafo, abbiamo visto che essa parte deformando le esigenze sociali percepite e lavorando all’interno di quella percezione. Nel secondo, si è notato che per porre in essere ciò si adottano visioni strumentali del solo potere dello Stato che non può darsi senza imparzialità, neutralità e garanzia: la giurisdizione. Ora possiamo, perciò, analizzare l’ultimo punto che, normalmente negletto, è all’opposto centrale nell’argomentazione populistica: l’indifferente rimozione delle proprie posizioni pregresse, secondo mere ragioni di convenienza. Quale che voglia essere il giudizio sul governo in carica, o sulla legislazione prodotta dal Parlamento che a maggioranza conferisce a quel governo la fiducia, è indiscutibile che la Lega e il Movimento 5 Stelle partissero da due istanze organizzative fondazionali che oggi sono state superate con un silente e repentino colpo di spugna. La prima parlava addirittura di secessione e indipendenza delle regioni settentrionali (fino a una non troppo determinabile regione storica padana); i secondi rifiutavano l’accordo con le forze politiche diverse e si intestavano la programmatica avversione a tutti i partiti che erano stati espressi negli esecutivi precedenti. La realtà attuale è radicalmente diversa. La Lega ha deciso di proporsi come un partito di destra sociale nazionale, protezionista in campo economico, fautore della sovranità nazionale nelle organizzazioni tra Stati, largamente proibizionista nei diritti civili. Possiamo ritenere che questo programma politico sia stato ciò che la maggioranza degli Italiani votanti ha richiesto ai partiti in campo.
Il Movimento 5 Stelle è entrato in coalizione con uno dei più longevi partiti italiani e alla invocata orizzontalità delle sue decisioni ha sostituito un approccio di “aut aut”, per cui gli iscritti al sito correlato votano, si, ma sempre più spesso non concorrendo al processo decisionale, bensì schierandosi nel novero di posizioni già date e confezionate.
Non vi sarebbe nulla di male se questo processo transizionale interno venisse apertamente discusso tra gli elettori e i gruppi dirigenti di quei partiti; anzi, recupererebbe una vitalità partecipativa ampia se ciò fosse conseguenza di una delibazione collettiva e non delle stringatezze del marketing politico.
“Il bisogno di nazione”, per usare le parole del filosofo Roger Scruton, è ancora forte, lo è sempre di più, perché sempre più oscura appare al cittadino la FORMA del POTERE (e la FONTE del DIRITTO). Il diritto vivente si distacca dalla legge in quanto deliberazione e diventa prassi che nascondono rapporti egemonici, fonti informali eppure cogenti – se non minatorie – di burocrazie sovra-nazionali mal inquadrabili nei dettami classici della discussione pubblica. Il diritto soggettivo, ancora, diviene favore: se il diritto oggettivo è poroso, opinabile o strumentale, la posizione del singolo necessita dell’intermediazione parassitaria del privilegio. E il populismo in effetti gioca sulle ceneri dei diritti sociali; da Francesco Saverio Nitti e dalla sua incessante perorazione teorica ed economica sulle virtù di un intervento pubblico in economia, rettamente orientato, si torna a Cesare Lombroso, alla legislazione criminale redatta secondo il sospetto, come panacea delle insicurezze sociali. Il nuovo populismo dichiara di difendere la proprietà privata, singolare in un Paese sempre meno proprietario, e non si dispiace di citare a orecchio Adam Smith e la forza insita nella “mano invisibile del mercato”: il reddito di cittadinanza avvicina la domanda e l’offerta, la dismissione dei servizi sociali sgrava la spesa, la legittima difesa si dilata ma questo allargamento non ridurrà il contenzioso dei proprietari derubati, al contrario appare destinato ad aumentarlo.
Eppure non si cita Smith, che nelle stesse pagine si dice favorevole alle norme antitrust (leggasi, al tempo, al divieto degli accordi di cartello tra capitalisti). Non conviene fermare la mano invisibile, sol che la mano è visibilissima; è il braccio che la muove sempre più oscuro – il che, come detto, favorisce l’insorgenza dei populismi.
La nazione così appare sempre più necessaria e necessitata, nella sua carica accentratrice e comunque particolaristica, ma diventa anche contenitore di aspettative più che di identità dell’agire civile. Il frazionismo e il campanilismo dilagano, anche in Stati dove la “ragion di Stato” s’era assisa a religione civile (basti ricordare che in Francia, già nel 2002, all’inizio di una parabola politica che decretava le enormi fortune del frontismo nazionale, una partita di Coppa tra i Bretoni del Lorient e i Corsi del Bastia era stata interrotta dai fischi all’inno nazionale della Marsigliese).
Scruton, però, diceva chiaramente che la nazione da lui intesa era distinta dal nazionalismo aggressivo, quello che bandisce le migrazioni favorendone lo sfruttamento e non sempre incidendone la quantità (senza cooperazione internazionale, anche “aiutiamoli a casa loro” è un programma vuoto). Scruton parlava di fedeltà nazionale, di momento coesivo di appartenenza alla stessa, riconoscibile, comunità politica. È quel primo comma dell’articolo 54 della Costituzione repubblicana che a torto o a ragione ci invita, ancora una volta: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
Non per governare, ma per andare al governo. A proposito di democrazia rappresentativa
Globalizzazione economico-finanziaria e neo-liberismo hanno determinato nelle economie avanzate l’affermazione di potentati di puro fatto, che ha messo nel nulla il nesso politica – diritto, sia a livello planetario, sia a livello interno ai singoli Stati nazionali, orientando anche la gestione delle entità sovranazionali.
di Bruno Montanari
articolo già pubblicato sulla rivista on line www.giustiziainsieme.it
La crisi delle democrazie rappresentative è, ormai, un fatto accertato. La tendenza in atto è verso una polarizzazione delle forze politiche, con vantaggio di quei movimenti che istituiscono un rapporto diretto e immediato tra base popolare, la più ampia possibile, e una forma di leadership fortemente personalizzata. Una tale tendenza sta modificando la struttura stessa dello Stato di diritto. Sta divenendo, infatti, evanescente l’idea di un ordinamento giuridico capace di controllare la legittimità dell’azione politica, secondo regole di competenza destinate a fondare un potere “funzionale”; a tale idea va sostituendosi un pragmatismo fondato sulla negoziazione tra poteri di fatto, anche quando questi poteri coincidono con organi o con figure istituzionali; nel senso, cioè, che anche organi o figure istituzionali, dotati quindi un potere funzionale, operano, in realtà, come se incarnassero un potere di puro fatto (tornerò su questo profilo alla fine). Ciò determina una dissoluzione dell’intero sistema e il venir meno nell’ambiente sociale, sia nei cittadini sia anche nel personale politico, di quello che era, secondo Max Weber, il presupposto materiale per la legittimazione del potere di governo: la “credenza nell’ordinamento”. “Credenza”, appunto; una situazione ideale o, se si vuole, di tipo genericamente mentale, in ogni caso sociologica e pre-giuridica, consistente in uno stato d’animo diffusamente radicato in una collettività, idonea a mettere in forma una società capace di esprimere, attraverso il voto, la propria visione del governo. Globalizzazione economico-finanziaria e neo-liberismo hanno determinato nelle economie avanzate l’affermazione di potentati di puro fatto, che ha messo nel nulla il nesso politica – diritto, sia a livello planetario, sia a livello interno ai singoli Stati nazionali, orientando anche la gestione delle entità sovranazionali. Vengo ora alla questione più specifica della crisi della rappresentanza politica. Si ritiene che sia una questione di modelli elettorali, più o meno efficaci nell’individuare la funzione governante. Questa opinione è certamente corretta, a una condizione però: che esista nella mentalità comunemente diffusa quella che ho definito “credenza nell’ordinamento”. Ancora, questa opinione è assolutamente valida a partire dalla condizione che esistano “partiti” capaci di costituire una mediazione tra le esigenze della base e una visione di governo. Il nesso tra questi due profili implica l’esistenza di un tessuto sociale sufficientemente omogeneo, nella sua parte maggiore (lo zoccolo duro), che si forma attraverso la redistribuzione del reddito ed una sufficiente mediazione tra le diversità culturali. Se vengono meno questi profili, la questione della rappresentanza cambia completamente i suoi “connotati”. Vediamo. Il votare consiste in una decisione umana; quindi, prima di ogni modellistica, occorre vedere come si forma una qualsiasi decisione nella “testa” di chi va a votare (o, anche, di chi decide di non andare). La decisione si forma in base ad alcuni fattori, mescolati tra loro. Li distinguo. Il primo è il contenuto del messaggio elettorale inviato dagli attori politici; il secondo è rappresentato dagli strumenti comunicativi utilizzati; il terzo dalla capacità di ascolto, comprensione ed elaborazione del messaggio, consistente, quest’ultimo, in una osmosi tra contenuto e mezzo comunicativo. L’esempio italiano è particolarmente significativo. Consideriamo l’espressione: “sono cose – le “promesse” – che si dicono, perché siamo in campagna elettorale”. Espressione che viene ripetuta, come se fosse ovvia, da qualsiasi giornalista o commentatore politico, senza però valutarne la gravità, sul piano della funzione elettorale. E ciò è grave per due ragioni. La prima: perché si ritiene che il processo elettorale non serva “per governare”, ma solo “per andare al governo”. La seconda: perché si ritiene che la gente comune sia facilmente suggestionabile. Sotto entrambi gli aspetti è una mancanza di rispetto per quell’elettore al quale si chiede il consenso. Lo si tratta come un “utile idiota”. Ho detto della mancanza di una effettiva mediazione partitica, capace di elaborare, secondo le esigenze del governare, le istanze della base, della gente comune. Mi spiego. E’ del tutto fisiologico che l’uomo comune guardi il mondo secondo i propri bisogni e necessità quotidiane e su tale attitudine incide la diversa visione spaziale e temporale del proprio ambito vitale. Incide, cioè, quella maggiore o minore ampiezza del c.d. “orto di casa”, che esiste tra ambienti sociali di diversa consistenza economica, di diversa educazione personale e sociale, di istruzione e cultura. E’ una pluralità di condizioni di vita che determina una differente propensione a trascendere le impellenze della quotidianità. Per molti, e in certi momenti per i più, la pressione del vivere quotidiano è tale da non consentire quella presa di distanza dalla suggestione dell’immediatezza, che invece consente a chi, per consistenza economica e istruzione e cultura, può avere un’attitudine al ragionamento ed alla riflessione, sì che la sua risposta sia meno dettata dalla reattività immediata. E’ ovvio che chi abita in una periferia disagiata non abbia la “testa”, la voglia e neppure il tempo per riflettere su questioni che sono del tutto altre e lontane dal suo spazio vitale; è assai diverso, invece, per colui che abita nel centro di una città o comunque in un quartiere non periferico. Tale fenomeno trova la sua manifestazione in nuove ed inedite, fino a poco tempo fa, divisioni sociali, che non appaiono come dialettica tra idee o ideologie politiche, ma assumono le sembianze di vere e proprie contrapposizioni di ambienti umani; ad esempio, tra periferia e centro città, tra città e campagna, tra popolo ed élite, e, ancora, tra base e establishment. I referendum e i flussi elettorali ne costituiscono, talora, una esaltazione. E’ qui che la fine della “mediazione progettuale” operata dai partiti del ‘900 fa sentire tutto il suo peso. Il quadro che ho descritto mette in luce un degrado umano-culturale dell’ambiente sociale che l’attuale modo di “fare politica” insegue ed esalta, anziché cercare di fronteggiarlo. Questo fenomeno è prodotto dall’uso abituale di una tecnologia comunicativa (i cosiddetti “social”), la quale è caratterizzata da due aspetti, entrambi dagli effetti socialmente e politicamente perversi sul piano della capacità di ascolto e comprensione dei destinatari del messaggio. Il primo: il social è attraversato da affermazioni apodittiche, icastiche, dunque suggestive, impressionanti; la sua efficacia è maggiore, quanto più è capace di avere impatto sul destinatario. L’ “impatto”. Esso è ciò che destruttura la temporalità, poiché il “tempo” dell’ascolto-comprensione-riflessione è sostituito, e dunque, annullato dalla immediatezza a-temporale della reattività (su questa tematica vi sono ormai ampli studi). Il secondo aspetto consiste nel dirigersi direttamente a ciascun destinatario, nella sua assoluta ed isolata individualità, determinando quindi una frantumazione dell’ambiente umano, poiché ognuno agisce pensando esclusivamente alla propria condizione. Questa operazione disabitua le persone al confronto ed al dialogo, e le attuali formazioni partitiche fanno, come ho detto, della esaltazione delle istanze individualistiche la propria fortuna elettorale e quindi la propria affermazione sulla scena politica. Si potrebbe osservare che il puntare sulla reattività umana generata dalla immediatezza emotiva dell’ ”impatto” non sia una modalità nuova del fare politica; nella storia politica del ‘900, balconi e piazze, con le relative adunate, perseguivano il medesimo effetto. Con qualche differenza non trascurabile. I destinatari del messaggio propagandistico erano “adunati”, vale a dire stavano insieme, l’uno accanto all’altro proprio al fine di dare una risposta immediata, sì, ma unitaria. Tale condizione era possibile poiché vi era di mezzo un balcone, una piazza, un pulpito; tutti mezzi che creavano, da un lato, una distanza materiale tra il protagonista e gli spettatori e consentivano, dall’altro, di far sentire ai convenuti di essere un “insieme” socialmente unitario: un “corpo” politico. L’attuale propaganda, attuata attraverso i social, ha quell’effetto del tutto opposto che ho accennato: quello, cioè, di esaltare l’individualismo reattivo e con esso la frantumazione dell’idea stessa dello stare insieme. Il fenomeno diviene ancor più grave, quando la desuetudine alla riflessione opera nel settore del diritto che deve reggere e controllare la funzione governante genericamente intesa. Un esempio. La formula attualmente usata, “contratto di governo”, per giustificare la coalizione “giallo-verde”, rappresenta una vera e propria rottura costituzionale. Mi spiego. Il “contratto”, come è noto anche alla gente comune, è un atto diritto privato, confezionato per soddisfare interessi privati e i cui effetti valgono esclusivamente per i sottoscrittori. La sua efficacia “erga omnes“, come è per un “contratto di governo”, avrebbe avuto bisogno di una elaborazione giuridica, quale fu quella con la quale si giustificò, con il nascere del diritto del lavoro del dopoguerra, l’efficacia “erga omnes” della contrattazione collettiva sindacale (ricordo 3 giuristi con altrettante “teorie”: Francesco Santoro Passarelli, Costantino Mortati, Federico Mancini). Che le forze di governo non si siano poste il problema di una “giustificazione” giuridica (che andasse oltre la mera recezione legislativa degli accordi contrattuali di governo, così come fu, invece, per l’efficacia erga omnes giuslavoristica) non mi stupisce, ma che non se lo siano posto il Presidente del Consiglio (che è un professore ordinario di diritto privato) e neppure le cariche istituzionali di garanzia, e tanto meno la stampa, è il segno di questo tempo. Di un tempo, cioè, nel quale si assiste alla evaporazione di quella che ho definito, ricordando Weber, “credenza dell’ordinamento”. Vi è da ricordare un altro precedente in proposito, al fine di segnare la differenza con l’attualità della situazione. Oltre a quello gius-lavoristico, negli anni ’70 prese corpo in Italia il fenomeno denominato “uso alternativo del diritto”, con finalità prevalentemente di giustizia sociale ideologicamente fondata. Ricordare quel fenomeno è importante per la ragione specifica che esso mise in evidenza la sensibilità giuridica di quella generazione di giuristi, che, nelle varie vesti, vi prese parte. La denominazione è la chiave. Quei giuristi pensavano ad un uso alternativo del diritto inteso come sistema giuridico vigente, con le sue “categorie” riguardanti sia le fonti sia gli istituti. E proprio per questa dimensione “culturale”, il dibattito, ed anche lo scontro, all’interno del mondo politico, sociale e giuridico, fu assai significativo. Qui è la distanza con il tempo che viviamo. Oggi non si fa più un “uso alternativo” del diritto, ma si confeziona un diritto alternativo; un diritto, che può denominarsi tale solo perché nell’uso comune si fa coincidere la forma normativa con il termine “diritto”. Ma il diritto, anche su di un piano meramente formale, non si riduce ad una formulazione linguistica prescrittiva (talora neppure esatta, proprio perché chi la confeziona ignora il diritto); esso è razionalmente strutturato, e dunque connotato, invece, da un nesso tra procedure – finalità – ambiti di rilevanza (pubblico-privato) per quanto attiene agli effetti, che conduce all’altro nesso, superiore, competenza – responsabilità – legittimazione per quanto attiene ai soggetti. Alla origine della deriva pragmatico-negoziale sta quella linea culturale, di ben altro spessore epistemologico, denominata “funzionalistica” (à la Luhmann), che si è sviluppata nella seconda metà del ‘900, alla quale, ma in altra sede, occorrerebbe prestare attenzione proprio in relazione alla trasformazione del pensiero giuridico. Le tecnologie comunicative attuali “concretizzano” quella che nel ‘900 era solamente una linea di pensiero. Occorre aggiungere che i politici di oggi non ne sanno, certamente, nulla! Operano mossi istintivamente da una forma mentis, della quale non conoscono la provenienza. Con il riferimento alla “epistemologia funzionalistica” torno alla affermazione contenuta all’inizio di questo intervento e che, in quella sede, poteva apparire apodittica: che lo stato di diritto si sia trasformato in una negoziazione pragmatica tra poteri di puro fatto, anche quando questi coincidono con organi costituzionali. Ora credo possa avere una sua propria giustificazione. Concludo con la seguente osservazione. Poiché la realtà quotidiana è fatta dagli uomini, qualsiasi luogo sociale occupino, occorre guardare alla formazione delle generazioni. In altre parole, gli eventi, così come gli atteggiamenti mentali e materiali che li producono, in una parola la “storia” di un’epoca (di qualsiasi epoca), sono una “conseguenza anagrafica”.
Riflessioni e altre erranze intorno a “Lumi sul Mediterraneo”
di Davide Fischanger
C’è una parola che segue un tracciato preciso all’interno dei saggi presenti in Lumi sul Mediterraneo, una parola che in alcuni casi è dichiarata già nei rispettivi titoli (già a partire dall’intervento di Fathi Triki[1], motore di un dialogo a distanza), in altri appare in controluce ma senza che questa presenza in negativo le tolga consistenza generativa di senso e di proposta.
La parola è dignità.
Vorrei partire da questa parola per due ordini di ragioni: il primo è per riflettere intorno a questo libro tenendo accanto a me la sua specificità ovvero tenendolo presente come interlocutore; il secondo per potere usare il termine dignità come un filo che mi consenta di allontanarmi da questo libro, dalle sue ragioni, per farne riverberare il senso anche in territori di dibattito più lontani e apparentemente meno affini. In questo doppia messa a fuoco, verso il centro del libro e verso la sua periferia, mi sembra però di rispettare (non sembri solo un pretesto) lo spirito più originale di quest’opera, connotata appunto da un lavoro tra sponde (geografiche e culturali) distanti che racchiudono uno spazio di interazione comune.
Vorrei provare, preliminarmente, a dare una definizione di dignità. Ora, l’epoca moderna ha trovato una serie di parole dalla grande capacità di mobilitazione: libertà e uguaglianza (tralascio per ragioni che esporrò la fratellanza), giustizia sociale, diritti, rivoluzione, cambiamento… etc etc. Chiamo “mobilitanti” le parole con un significativo potere di suggestione pubblica e capaci di situare un gran numero di persone all’interno di un orizzonte di aspettativa tale da riuscire a muoverle collettivamente verso la realizzazione dei programmi sottesi alle parole stesse. Posta sotto questo segno la dignità, pur avendone alcune caratteristiche (ad esempio un certo qual grado di astrattezza) non mi sembra appartenere integralmente alla categoria sopra descritta. Per cercare in territori etimologici limitrofi, indignazione è una parola, di più recente fortuna, con un forte potere mobilitante, anche se rispetto a quelle “storiche” possiede un’accentuazione da un lato più ricattatoria (“chi non si indigna allora è complice”) dall’altro più soggetta a usura (ci si indigna un po’ per tutto). Ma la dignità sembra godere dello stesso statuto della fratellanza che, come osserva giustamente nel suo saggio Mario Reale[2], è la parola più trascurata del triplice motto coniato durante la Rivoluzione francese. Potremmo dire che entrambe le parole sono le meno ideologiche, perché la loro condizione di gratuità le rende meno adatte all’inserimento in un discorso. Ma si può anche ipotizzare che lo statuto semantico della nostra parola di partenza possa aver contribuito a attribuirle una condizione diversa, più sfumata o ambigua: la dignitas infatti indicava e indica anche il rango (e l’accezione è conservata anche nei principali vocabolari della lingua italiana), il grado, la posizione all’interno di una gerarchia. Questo slittamento da uno status a una condizione morale è interessante, come vedremo, perché in realtà i due significati tendono a stare l’uno dentro all’altro, se è vero che il senso di dignità presuppone un sentimento percepito di nobiltà negli atti e nelle parole di un individuo.
Se le parole mobilitanti, in quanto orizzonte di aspettativa e scopo di una lotta, possono essere paragonate a un grande schermo cinematografico, la dignità mi sembra piuttosto il fascio di luce che, generato da un proiettore, va a illuminare lo schermo stesso: ciò che è interessante di questo fascio di luce è il fenomeno che all’interno di esso ci fa scorgere del pulviscolo fluttuante e ci fa percepire la luce stessa. Quel pulviscolo è il riferimento alla concretezza (per usare un’espressione contenuta nella chiusa del saggio di Bruno Montanari[3]) delle individualità e dei rapporti umani rivelati da quella luce che, nel frattempo, trasporta i messaggi e le parole d’ordine sullo schermo. Il pulviscolo vaga, non ha sede, entra e esce dal cono di luce. Come rivelarlo, come dare conto della sua esistenza, della sua incostanza, della sua natura: questo è il tema della dignità. La sfida della dignità è la sfida del molteplice che, come il pulviscolo, è soggetto al riflesso della luce e anche a una certa refrattarietà: il molteplice, l’umano, è irriducibile agli schemi rappresentativi, anche ai più raffinati; il molteplice è l’altro che risponde in maniera imprevista alle mie aspettative, specialmente se le mie aspettative corrispondo al mio desiderio di fornire l’altro degli strumenti giuridici e morali per provvedere alla sua autodeterminazione e alla sua libertà. È il paradosso, citato nel saggio di Quintili[4], dell’emancipazione delle comunità ebraiche all’epoca della Rivoluzione Francese: come spiegare la resistenza alle riforme e all’abolizione dei “privilegi” (che erano in realtà termini di una segregazione secolare) da parte di comunità sottoposte per secoli alla discriminazione? Solo come a una testardaggine identitaria? un ritardo culturale rispetto ai necessari obiettivi posti dalla Modernità? Un mancato adeguamento al ruolino di marcia della Storia? In genere considerazioni di questo tipo descrivono, meglio di molte altre, lo sguardo di noi “moderni”: potremmo dire che questo sguardo, che è quello della civiltà occidentale, si sia andato a configurare a partire dalla storica “scoperta” del grande Altro, ovvero dall’arrivo dei conquistatori europei nelle Americhe (scoperta che convenzionalmente sui manuali di storiografia inaugura l’Età Moderna). Tzvetan Todorov ne La conquista dell’America (il cui sottotitolo emblematicamente recita: “Il problema dell’altro”) ricorda che è proprio questo evento epocale a porre sul tappeto la maggior parte delle questioni attualmente all’ordine del giorno: universalismo/relativismo, (presunta) arretratezza/progresso, superstizione/vera fede, distruggere/assimilare, propagare e imporre i propri stili di vita/tutelare le culture locali…
La rotazione dell’asse della storia avvenuta a partire dal 1492, ovvero dal Nord-Sud del sistema mediterraneo a quello Est-Ovest del sistema atlantico, è stato anche il principio fautore del consolidamento dell’identità europea (fino alle tappe della sua Costituzione come organismo politico e giuridico, come indicato nelle pagine di Macrì[5]), del suo cammino verso l’affermazione planetaria (violenta) e nello stesso tempo di quello sviluppo intellettuale che ha individuato e analizzato le questioni sempre aperte della laicità, dei diritti imprescindibili e universali di popoli e individui, dell’emancipazione di minoranze. È in questa consapevolezza che sta parte del paradosso segnalato fin dal titolo del saggio di Petrucciani[6]: nel fatto che mentre i paradigmi culturali europei (o occidentali) venivano esportati nel mondo attraverso “armi acciaio e malattie”(per ricordare un celebre saggio di Jared Diamond), attraverso il colonialismo o il consumismo, all’interno di quegli stessi paradigmi, grazie all’incontro/scontro con le altre culture, venivano elaborati dei processi di riflessione che mettevano in gioco e in scacco lo sguardo (e il ruolo) dell’Occidente.
La parola dignità è ciò che può tenere fermo questo sguardo, purché la dignità si faccia fissare, dato che la sua natura è sfuggente: Il grasso la cerca in una lama d’acciaio, il magro la cerca nel suo ultimo pasto, l’uomo vuoto la cerca in un campo di cotone, la dignità. Cosa stiamo ascoltando? Sono le parole di una canzone ma anche un piccolo saggio di filosofia morale. Le ha scritte il discendente americano di ebrei ucraini e lituani che all’inizio del Novecento hanno attraversato l’Oceano (da Est verso Ovest) per sfuggire alla povertà e ai pogrom. La canzone si intitola Dignity e, come eloquentemente spiega Alessandro Carrera, è una canzone “sulla società che ha criteri per tutto, tranne che per riconoscere il valore dell’essere umano”. L’autore si chiama Bob Dylan che qui sembra impegnato nella parte di un investigatore a cui stanno per ritirare la licenza, con un dito di barba di troppo e vestiti sempre stazzonati. Un vento freddo taglia come la lama di un rasoio / Edifici in fiamme, debiti non pagati / Mi affaccio alla finestra e chiedo alla cameriera / Hai visto la dignità? Bisogna essere sobri, non tanto per capire dove sta la dignità, ma per saper attraversare stanze sontuose e vicoli miserabili con la stessa determinazione a cogliere echi e visioni; bisogna farsi strada tra mazzi di chiavi smarrite e pacchetti di sigarette vuoti per imparare a fare le domande giuste, per smascherare gli impostori. Bisogna non fidarsi di chi ti mostra una fotografia della dignità: Dignity, infatti, never been photographed.
Se tu sei mio amico, entra in casa mia senza bussare alla porta. Se tu ignori chi sono, devi sapere che contavo i giorni che mancavano al tuo arrivo. Tu, fratello mio d’elezione, vulnerabile straniero. Che cosa stiamo ascoltando? domando ancora. Sono le parole di un esule e di un poeta, Edmond Jabès (da Sud a Nord, questa volta), racchiuse in un volume intitolato Il libro dell’ospitalità. Le riporto perché nell’ultima frase possiamo ravvisare un altro attributo della dignità (che non mobilita, che sfugge, che non è fotografabile) ovvero il fatto di essere vulnerabile. Nel riconoscere la vulnerabilità altrui mi faccio carico della mia: detto in altri termini, senza ferita nulla sarebbe sano, senza l’esule nulla sarebbe saldo. Elaborare un pensiero della dignità significa rinunciare a un principio maggioritario della realtà, della storia, delle relazioni tra individui; significa elaborare un pensiero della ferita che salva. Questa salvezza è soglia in attesa: esiste nella mano che invita a entrarvi e nel piede che la varca, nei due gesti presi in un unico evento (se è vero che ospite è parola che include tanto chi accoglie quanto chi è accolto). A stento può essere detta: si entrerà in silenzio senza bussare. Al massimo può essere evocata: ma nel computo dei giorni d’assenza.
Vorrei proporre un ultimo esempio. La storia è nota. Un uomo arriva naufrago presso un’isola. È solo, è nudo. La figlia del re di quell’isola lo scopre e lo invita al palazzo. Il re accoglie lo straniero chiedendogli prima se sia un dio o un uomo. “Sono uno sventurato” risponde l’uomo. Durante la cena l’uomo ascolta il canto di un aedo, vi si narrano le gesta di guerra di molti suoi compagni. L’uomo piange e il re lo invita a raccontare la sua storia. È l’antefatto del canto nono dell’Odissea, che è il canto dominato dall’episodio di Polifemo. Il ciclope negherà agli stranieri i diritti derivanti dalle leggi divine dell’ospitalità: per questo a lui Odisseo si presenterà come Outis, Nessuno. Ma cosa è accaduto all’inizio del canto? Odisseo si è svelato al re Alcinoo, ha dichiarato il proprio nome, la propria provenienza e ha rivelato la propria dignità regale, in una specularità opposta, nelle premesse come negli esiti, all’avventura col ciclope. Cosa è stato evocato dalle parole di Odisseo, prima di questo svelamento? Il consesso ospitale della reggia, il pane e la carne distribuiti sulle tavole, la condivisione e l’ascolto: la felice formula della degna relazionalità suggerita nella chiusura del saggio di Bilotti[7].
Ed è la stessa complicità dotta e amicale che ha riunito molte voci intorno alle proposte e alle riflessioni del filosofo tunisino Fathi Triki, sul vivre-ensemble dans la dignité. Ogni parola di questa formula dovrebbe essere custodita, apprezzata e poi affidata al vento, come si affida una storia. Dovremmo raccontare la nostra storia ornandola di parole preziose e vitali come se fossimo alla presenza di un re; dovremmo accogliere l’ospite, misero e cencioso, supponendo sempre in lui la dignità di un re in esilio. Dovremmo approfondire le sfumature semantiche che dalla parola dignità ci guidano ai suoi due principali attributi, all’essere dignitoso e all’essere degno di: il primo indica una condizione, il secondo un impegno.
E dovremmo imparare a vivere, contemplando e ascoltando il Mediterraneo,
poema polimorfico di correnti, onde, suoni, voci.
[1] F. Triki, “Dignità e umanità: una possibile convivenza mediterranea”,. in A. Coratti, A. Cecere (a cura di), “Lumi sul Mediterraneo”, Jouvence, Milano, 2019, pp. 21-42.
[2] M. Reale, “‘Vivere insieme con dignità’ è un altro nome di ‘democrazia’?” in ivi, pp. 43-65.
[3] B. Montanari, “Per vivere insieme con dignità: riflessioni sul ‘pensiero moderno’” in ivi, pp. 67-96.
[4] P. Quintili, “Politica e diritti tra Europa e Maghreb. Alle origini della nozione di ‘laicità’” in ivi, pp. 97-117.
[5] G. Macrì, “Costituzione europea interculturale (Multilevel) e nuovo umanesimo giuridico” in ivi, pp. 129-147.
[6] S. Petrucciani, “I diritti umani e i paradossi dell’universalismo” in ivi, pp. 119-128.
[7] D. Bilotti, “Un principio di relazionalità nello spazio giuridico mediterraneo” in ivi, pp. 149-163.
Carteggio Lukàcs – Morante
di Antonino Infranca
L’interesse di György Lukács è ben anteriore al periodo in cui i due si scambiarono le lettere che qui presentiamo. In una lettera dell’8 novembre 1957, indirizzata a Cesare Cases, Lukács chiedeva che gli fossero inviati i libri della Morante, tradotti in lingua a lui accessibile. E’ noto, infatti, che Lukács non parlasse affatto l’italiano e che lo leggesse, per altro, con grande difficoltà – come confessa in una delle lettere spedite alla Morante. Fu Cesare Cases che gli diede per la prima volta notizia delle opere di Elsa Morante; e Lukács lo invitò anche a scrivere saggi su di lei – lettera del 26 febbraio 1958. Il nome della Morante ricorre spesso nella corrispondenza tra Cases e Lukács. In un’altra lettera del 12 gennaio 1958, Cases riporta a Lukács l’emozione che la Morante provò, apprendendo dall’Unità, che Lukács, durante il periodo di deportazione in Romania nel 1956-57 avrebbe trovato persino il tempo di leggere Menzogna e sortilegio.
L’emozione, che la Morante provò nell’apprendere che Lukács si era dedicato alla lettura del suo libro anche in quelle difficili condizioni di vita, è la stessa che trapela dalla lettera che indirizzò al filosofo ungherese dieci anni dopo. Il carteggio tra i due è carico di pathos, di forte emotività, confessata da Lukács con pudore; sentimenti che testimoniano la profonda umanità dei due protagonisti. Da un lato il vecchio filosofo, che per rispondere alla sua più giovane interlocutrice abbandona temporaneamente il lavoro di stesura dell’Ontologia, e dall’altro la più giovane scrittrice che si guarda attorno per cercare nella “torre di Babele” una lingua, affinché possa manifestare al filosofo tutta la sua devozione, entrambi colgono l’occasione per confrontarsi sui problemi del loro tempo. Entrambi avvertono il bisogno di prendere posizione a favore di coloro che lottano per ideali superiori o che subiscono, come nel caso di Angela Davis, le conseguenze dell’“essere contro”. È emblematico il coinvolgimento emotivo del vecchio Lukács nella vicenda Davis tanto simile a quella da lui stesso vissuta a Vienna nel 1919-20, quando a salvarlo dall’estradizione nell’Ungheria fascista di Horthy, fu una protesta di intellettuali tra i quali era anche Thomas Mann. Forse anche per questa ragione Lukács avverte l’esigenza di prendere posizione a favore della Davis e invita Elsa Morante, una delle pochissime voci della letteratura italiana contemporanea, a partecipare alla sua iniziativa. A tre anni di distanza dalla prima corrispondenza il filosofo marxista e la scrittrice che egli ha elevato ad esempio ormai raro di realismo critico trovano il modo di dibattere e di riflettere sui problemi del tempo. L’alta considerazione in cui Lukács teneva Elsa Morante fu espressa il 27 ottobre 1967, su Rinascita, in un articolo di Lukács, “L’Ottobre e la letteratura”. Quel “grazie” di Elsa Morante, nel telegramma di adesione alla petizione in favore della Davis, esprime la soddisfazione di essere partecipe non solo a quell’azione, ma ad un dibattito molto più vasto, al centro del quale stanno i problemi essenziali dell’uomo. Due personaggi, per altri aspetti tanto diversi, comunicano attraverso i problemi di fondo, rendendo retorica la domanda della Morante: «Perché è stata costruita la torre di Babele?».
Questo carteggio non può, ovviamente, esaurire tutto ciò che accomunava Lukács ed Elsa Morante; probabilmente non sapremo mai cosa si dissero i due nelle loro conversazioni personali, tanto più ricche di valore umano che una semplice lettera. Possiamo, però, immaginare quale fosse la “lingua” nella quale si parlarono.
Antonino Infranca
Lettera di Lukács ad Elsa Morante, lingua originale: tedesco
6/2/1968
Cara signora Morante,
il suo pacchetto e soprattutto la Sua dedica mi hanno causato una profonda gioia. È per me, che da lungo tempo scrivo critiche, necessario l’imperativo di fronte all’“oggetto”: «se io Ti amo, a Te cosa importa». Ma se si è critici, si è anche uomini e si avverte una gioia sincera per ciò se 1’“oggetto critico” – anche un essere umano, perfino un essere umano altamente onorato – reagisce in modo tale che ci si sente compresi e confermati. Questa era per me un’esperienza importantissima, e non è male, se La ringrazio compiaciuto di ciò.
Per ciò che riguarda il poema [probabilmente Alibi, N. d. C.], sempre più col passare del tempo ho “dimenticato” il mio molto problematico italiano, così che mi è impossibile leggerlo nell’originale. L’ho dato per questo motivo ad un giovane amico, che si ripromette di provvedere ad una traduzione ungherese. Ha qualcosa in contrario, che nel caso la traduzione riesca poeticamente, che essa appaia in una rivista locale?
Ancora una volta grazie di cuore e nella effettivamente sincera, pura e profonda venerazione
Suo
Georg Lukács
Lettera di Elsa Morante a Lukács, lingua originale: inglese
18 aprile I968
Mio caro amico Lukács (Spero che mi permettiate di chiamarla in questo modo)
ho ricevuto la Vostra lettera, sto cercando, in questa Torre di Babele della Terra, una lingua per scrivere una lettera a Voi! Il fatto è che la sola lingua nella quale posso scrivere senza errori è l’italiano. Ma sapendo che Voi non sapete leggere l’italiano, devo scrivervi nel mio cattivo inglese, sperando che possiate leggere in queste parole, almeno, il mio affetto!
Mi chiedete se sono d’accordo a pubblicare quel poema (che Vi ho spedito) in ungherese. Sarei felice se fosse accettato nel Vostro paese. Spero sempre di trovare qualche modo di venire colà, e visitarvi una volta. Non solo perché Vi ammiro, come tutti Vi ammirano, ma anche perché, per me, Voi siete uno dei pochi amici che ho in questo mondo. E questa amicizia è la cosa di cui sono più fiera – in tutta la mia vita – soltanto la Vostra amicizia è più di 1.000.000 di amici per me!
Sto adesso pubblicando un libro di storie-poemi. Il titolo è II mondo salvato dai ragazzini. Spero che Vi piaccia se non tutto, almeno in parte. Vorrei avere il dono delle lingue [in italiano nel testo N. d. C.] per tradurre almeno il meglio di esso nella Vostra lingua. Penso di trovare qualcuno per tradurre il meglio di esso, almeno, in tedesco e di spedirvi la traduzione. Perché fu costruita la Torre di Babele?
Grazie caro György Lukács, per ogni parola che Voi dite sulle mie parole e per averle letta, alcune volte sono tentata di non scrivere più libri e non lavorare più, perché mi sento molto stanca. Ma penso: Lukács apprezza la mia opera e questo pensiero mi spinge di nuovo al lavoro.
Vorrei spiegarVi molte cose e chiederVene molte! Ma il mio inglese non è abbastanza buono per ciò. Vi chiedo di ricordarmi qualche volta e spero di incontrarvi nel Vostro paese non appena sia possibile per me di venirvi.
Vostra Elsa Morante.
Con tutti i miei auguri a Voi e alla Vostra opera.
Lettera di Lukács ad Elsa Morante: lingua originale: tedesco
23/7/1968
Cara amica,
è per me addirittura doloroso vedere che non abbia risposto per molto tempo alla Sua lettera, sebbene compaia raramente nella mia vita una lettera che mi abbia procurato una tale gioia, come la Sua; una lettera che mi onora tanto – perdoni l’espressione patetica – come fa la Sua.
Dovevo tuttavia condurre a termine, in un periodo di caldo terribilmente deprimente, un lavoro, e le mie forze non erano più sufficienti per scrivere una lettera.
Anche adesso mi è difficile rispondere adeguatamente alla Sua lettera. Ma è per me una grande gioia che Lei mi annunci una Sua eventuale visita a Budapest. Poiché un incontro personale, una conversazione personale può essere sufficiente cento volte più che la migliore lettera – e sono un cattivo scrittore di lettere. Potrei soltanto dire che molto verosimilmente sarò a Budapest nuovamente dopo il 15 settembre. Certamente per tutto l’intero autunno e l’intero inverno.
Cosa posso dirle per lettera? Mi pare che l’unica cosa è che noi – sebbene ci siamo incontrati soltanto una sola volta – possediamo un fondamento comune, molto solido, per una seria amicizia. La più grande preoccupazione della mia vita è che tutta l’attuale civilizzazione lavora alla distruzione di ciò che è effettivamente umano per l’uomo. Nella lotta contro ciò si hanno pochi alleati. Lei è una di quelli. Nei suoi libri si avverte sempre che la sostanza umana è in ultima analisi ancora qualcosa di indistruttibile. In ciò oggi non si vuole credere e soprattutto non si vogliono trarre le conseguenze di ciò in nessun campo. Quanto grande sia questo problema si si vede dal fatto che si estende dalle questioni piùgenerali, più grandi, fino alle più intime della vita privata – su di ciò ci intratterremo sperabilmente presto personalmente.
Con calorosi saluti
Suo
Georg Lukács
Lettera di Lukács ad Elsa Morante, lingua originale: tedesco
Budapest, 30/11/l970
Cara signora Morante,
A questa lettera aggiungo il testo di un appello, che ho spedito a numerosi intellettuali, in difesa di Angela Davis, minacciata di condanna a morte. Credo che sia superfluo insistere sul significato per un uomo di sinistra di una protesta che costringerebbe alla ritirata la demagogia reazionaria, nella preparazione del processo e nel giudizio che ne è previsto. Le chiedo, perciò, di unire il Suo nome e la Sua attenzione all’azione, e di invitare anche altri intellettuali di un certo rilievo del Suo paese – da Lei conosciuti – ad unirsi. Ho composto il testo così in generale che questa firma non significa un’adesione ad un programma politico determinato. Ritengo, tuttavia, che naturalmente ogni Sua proposta può essere utile per un cambiamento e, allo stesso tempo, Lei può mantenere il diritto alla protesta individuale, sebbene vorrei osservare che una comune azione ha un effetto maggiore. La prego di spedirmi un telegramma nel caso che Lei volesse partecipare all’azione e mi faccia anche sapere a quali nomi ha comunicato la sua decisione di partecipare. La prego, inoltre, di pubblicare lo scritto di protesta e agisca a questo scopo sulla stampa del Suo paese, sempreché sia possibile. Manderò poi agli organi di stampa i nomi di tutti coloro che hanno preso parte all’azione.
Con cordiali saluti.
Suo
Georg Lukács.
Lettera di Lukács ad Elsa Morante, lingua originale: tedesco
30/12/1970
Cara signora Morante,
Molte grazie per la veloce risposta e la firma. Alla fine di questa settimana spedirò il testo dell’appello e la lista dei firmatari e dei patrocinatori locali alla grande Weltblätter. Aggiungo adesso la lista, e la informerò su ulteriori sviluppi.
Con cordiali saluti.
Suo
Georg Lukács
Recensione a M. Reale, “Vivere insieme nella dignità” è un altro nome di democrazia?
in A. Cecere – A. Coratti, Lumi sul Mediterraneo, Jouvence, Milano, 2009
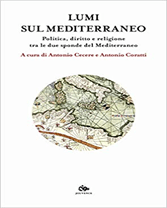
Nel saggio scritto in risposta a Triki, Mario Reale si chiede se il vivere-insieme teorizzato dal filosofo tunisino non sia, in fin dei conti, un altro nome di “democrazia”. Ovvero, se la democrazia non sia in fondo definibile come un vivere-insieme “istituzionalizzato” che nel corso della storia moderna (europea) si è dispiegato nell’ambito degli Stati-nazione, chiudendosi in confini spesso “inospitali”. Da una parte, Reale riconosce alla nazione il ruolo da protagonista giocato nei processi moderni di «democratizzazione primaria e fondamentale», dall’altra ne denuncia l’attuale inadeguatezza nel rappresentare il «traino della storia», ovvero nel costituire «il terreno decisivo di riferimento ideale e politico» in una dimensione globalizzata[1]. Cercare di lavorare su operazioni di mediazione continue tra dimensione nazionale e globalizzata, «senza combatterci tra lungimiranti globalisti e retrogradi sostenitori dello Stato nazione»[2], è la proposta per far fronte ai complessi rapporti economici, politici e culturali che da decenni determinano la tensione fra dimensione nazionale e globale e per costruire una via percorribile che renda il vivere-insieme un progetto politico concreto e non una nozione «abusata e quasi priva di senso, impiegata per difendere l’ideologia di una società pacificata e armonica»[3]. Ma il processo di istituzionalizzazione del vivere insieme passa necessariamente, secondo Triki, per la costituzione di una “vie sociale égalitaire” che attenui le differenze tra “nord” e “sud” del mondo e del Mediterraneo. In effetti, a dominare nel dibattito filosofico-politico degli ultimi decenni è stato lo scontro (spesso ideologico) tra “più libertà” da una parte e “più uguaglianza” dall’altra, mentre, come nota Reale, la domanda sulla fraternité, «la terza parola d’ordine della Rivoluzione francese»[4], è stata per lo più trascurata, assumendo un ruolo del tutto marginale nella tradizione politica dell’occidente. Nel Contratto sociale stesso – opera considerata da molti manifesto programmatico della più radicale forma di “collettivismo” della modernità – Rousseau antepone chiaramente, in nome della costituzione della «grande Repubblica democratica», il «dominio della legge» alla esigenza di socialità, per lo più «messa sullo sfondo, solo implicita, se non proprio espunta»[5]. Il collettivismo in Rousseau sarebbe così fagocitato dal programma politico di porre “la loi au-dessus de l’homme”, avendo la legge come obiettivo primario quello di superare «la temibile dipendenza dell’uomo dall’altro uomo con il darsi a tutti non dandosi a nessuno», rendendo «gli uomini indipendenti e in un certo senso “solitari”»[6]. D’altra parte, è proprio in virtù dell’impersonalità, generalità e universalità, nonché della «reciprocità tra parti autonome» che la legge può farsi garante della «conservazione intatta delle individualità»[7], anche in nome della dignité che è nel titolo stesso del progetto filosofico trikiano, vivre-ensemble dans la dignité. In questo senso, vivere-insieme e dignità, comunità e individualità, rappresentano i due momenti da conciliare politicamente, allorché la tradizione democratica moderna pare privilegiare la tutela della sfera delle autonomie dei singoli. Per lo meno nella fase avanzata. Mentre la socialità emerge prorompente «nei momenti, sempre in qualche modo rivoluzionari […] che preparano l’avvento della democrazia e quindi nel vigore del suo stato nascente»[8], momenti in cui «è necessario mobilitare tutte le risorse “corali” del popolo, perché il vecchio scompaia e il nuovo sorga»[9]. Anche in questo caso, Reale propone uno scambio sinergico a partire dalla diversa storia dei popoli mediterranei e dalle diverse esperienze in corso sulle due sponde, l’una segnata dal fermento delle primavere arabe, ancora in movimento, l’altra alle prese con una storia democratica matura e ormai secolare, ma non priva, come sappiamo, di criticità.
[1] M. Reale, “Vivere insieme con dignità” è un altro nome di democrazia, in A. Cecere, A. Coratti (a cura di) Lumi sul Mediterraneo, Jouvence, Milano, 2019, p. 54
[2] Ivi, p. 58
[3] F. Triki, Vouloir vivre dans la dignité, tr.ita. A. Coratti, www.filosofiainmovimento.it/voler -vivere-nella-dignita/
[4] Ivi, p. 59
[5] Ibidem
[6] Anche per quanto riguarda la questione della “volontà generale”, Reale evidenzia il fatto che, «contro ogni forzatura collettivistica», essa va interpretata in quanto «frutto del “silenzio” tra i cittadini (che non devono avere “alcuna comunicazione tra loro”), ognuno dei quali nella sua intimità s’interroga, con un atto intellettivo e insieme morale, se la legge, comunque proposta dal governo, sia o no conforme alla volontà generale che è in lui» Ivi, p. 60
[7] Ivi, p. 60
[8] Ivi, p. 61
[9] Ibidem
Carteggio Lukacs-Berlinguer
Quando, nel corso dell’anno accademico 1984-‘85, mi recai in Ungheria, usufruendo di una borsa di studio, per portare a termine il mio lavoro di specializzazione sul giovane Lukács, non avrei mai immaginato che, ricercando nei cataloghi presso l’Archivio Lukács di Budapest, avrei trovato uno scambio di lettere fra il filosofo e quello che era stato uno dei leader comunisti italiani più amato, cioè Enrico Berlinguer