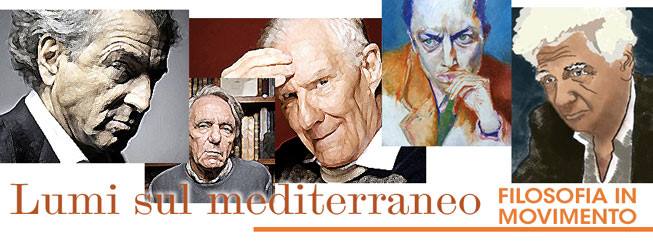- I «diritti dell’uomo e del cittadino»
Come e quando nasce il concetto di «diritti dell’uomo e del cittadino»? Le tappe del processo di definizione dei diritti umani che vengono svincolati dal riferimento normativo alla credenza nella trascendenza di un Dio e nelle sue leggi, sono numerose – anche in quei luoghi in cui vien fatta menzione retorica di un «Dio» che non appartiene tuttavia più a una religione rivelata determinata, ma è il Dio di Spinoza e dei deisti, l’«architetto del mondo» di un Voltaire. Alcune di queste tappe, in particolare, devono ritenere la nostra attenzione. Lo Spirito delle Leggi (1747) di Montesquieu, le voci «Autorità politica» e «Diritto naturale» dell’Encyclopédie (1751) di Diderot, la Storia delle due Indie (1780-1782), dell’abate Raynal, cui lo stesso Diderot diede un importante Contributo. Dietro questi elaborati testuali ci sono ovviamente altre grandi sintesi – il Trattato teologico-politico (1670) di Spinoza, ma va ricordato anche il Locke dei Due trattati sul governo (1690) e la tradizione del diritto naturale tra Sei e Settecento (Grozio, Pufendorf), il Contratto sociale di Rousseau (1762), che da quella tradizione emana; infine la Politique naturelle (1773) e l’Ethocratie (1776) di D’Holbach, le diverse forme di pensiero «utopistico», affidato all’anonimato o alla letteratura clandestina, durante tutto il periodo dell’Illuminismo[1].
Cosa accade in questi testi? Dico «accade», per sottolineare il valore performativo di queste opere, che dal linguaggio passano, spronano direttamente all’azione. Lo Spirito delle Leggi, di Montesquieu, va ricordato, venne subito condannato al rogo dal Parlamento di Parigi nel 1748 e l’autore si salvò solo grazie alla sua condizione di nobile e ai potenti appoggi di cui godeva presso certi ambienti della corte. Il primo evento è di ordine metodologico, e va sotto il nome di «determinismo geografico». Cosa s’intende con ciò? Montesquieu sostenne che il carattere, appunto lo «spirito» delle leggi è determinato, nei diversi popoli, dalla situazione geografica e geo-politica, diremmo oggi, nella quale essi si trovano a formularle. Le leggi cambiano, a seconda dei tipi di popoli: del Nord, delle Zone temperate, del Sud ecc. Il mutamento e la varietà delle leggi, e i conseguenti «diritti» (al plurale), sono dipendenti anche dalla storia, dal passato diverso di questi popoli. Inoltre, contrariamente a Hobbes, Montesquieu sposta il terreno del conflitto tra gli uomini dal cosiddetto ius naturae, dallo «stato di natura», allo ius civilis, lo stato civile, in questo vicino alle tesi del Contratto sociale di Rousseau.
Gli uomini non si fanno la guerra in un ipotetico «stato di natura», nel quale sarebbero, al contrario, essenzialmente buoni (il «buon selvaggio» di Rousseau), bensì si fanno la guerra solo nello stato civile, quando cioè si organizzano in società e in Stati. Le leggi servono, perciò, a rendere incruento il conflitto e a regolamentarlo. È un passo avanti enorme. Ogni cittadino è libero fin là dove inizia la libertà del suo simile, e le leggi stabiliscono appunto i confini di tale libertà nel diritto comune a ciascuno. Si capisce bene tuttavia – come osserverà criticamente Rousseau, nell’articolo «Economia politica» (1752) dell’Encyclopédie – che i cittadini più ricchi e potenti hanno facilmente la meglio sui più deboli, se la condizione di partenza di ciascuno è diseguale. Montesquieu, ad esempio, con Lo Spirito delle leggi, la vinse facilmente contro la censura, mentre un povero artigiano che nel 1773 venne trovato con una copia in tasca dello Spirito delle leggi e del Bon sens (1772) di D’Holbach, dovette scontare ben otto anni di prigione. In linea di principio, sul piano formale, tutti, sovrano compreso, sono sottoposti alle leggi, che al tempo di Montesquieu erano applicate in modo diverso secondo i diversi «stati» di cittadini. La rivendicazione di eguaglianza reale di fronte alla legge sarà una delle idee di punta del rousseauismo, che ispirerà molti rivoluzionari del 1789.
Una tappa ulteriore viene compiuta, in direzione dell’eguaglianza dei diritti dei cittadini, oltre che dal già menzionato Rousseau, da Diderot e D’Holbach. Rousseau stabilì che la sovranità reale, ossia il luogo reale del potere, non risiede nel monarca, ma nella «volontà generale» del popolo, che diviene una sorta di «deposito» delle leggi cui il monarca, e il suo potere esecutivo, devono attingere. Nel Contratto sociale, emerge la nozione di «consenso» senza il quale nessun sovrano è legittimato a governare. Non è la semplice appartenenza a una comunità e la condivisione di una comune credenza, ma una comune volontà politica, a sancire il deposito di legittimità delle leggi e del diritto.
Poi ci sono i «diritti naturali» dell’uomo, su cui si soffermerà Diderot, che non sono assimilabili alle regole del «diritto positivo», diverso, storicamente e culturalmente, da popolo a popolo. Tali diritti sono più alti e più universali, indipendenti in certa misura dalle variabili storiche. Sono il diritto all’esistenza, alla libertà e, infine, alla proprietà. Nessun uomo può, neanche volendolo, alienare una benché minima parte ad esempio della propria libertà, né della propria esistenza. Solo la proprietà può essere alienata, ma è un’alienazione apparente, in quanto cedendo una proprietà, nel mercato, si riceve un altro bene formalmente equivalente, dunque anche questa proprietà è un intero inalienabile nella sua sostanza.
Su tali fondamenti Diderot condannerà, senza mezzi termini, la schiavitù come un’attività criminosa, che viola il sacro diritto dell’uomo alla libertà, attività perciò da bandire dal consesso dell’umanità civile. Ci sono pagine assai eloquenti al riguardo, nel Contributo alla Storia delle due Indie (1780), in cui Diderot usa toni molto accesi che troveranno risonanza durante la Rivoluzione francese, quando la schiavitù verrà abolita ufficialmente, per decreto, nel 1794. Sono pagine poco note, soprattutto in Italia, che val la pena di leggere. È la celebre invocazione dell’avvento di un «nuovo Spartaco», che troviamo nell’edizione della Storia delle due Indie dell’abate Guillaume-Thomas Raynal, del 1774, cui Diderot diede il suo Contributo. Il «nuovo Spartaco», sotto la penna del filosofo, diventerà nell’edizione del 1780 il «grand’uomo» che l’umanità oppressa attendeva da gran tempo:
Dov’è questo grand’uomo che la natura deve forse all’onore della specie umana? [(ed. 1774): Dov’è questo nuovo Spartaco, che non troverà dinanzi a sé nessun Crasso]. Dov’è questo grand’uomo che la natura deve ai suoi figli vessati, oppressi, tormentati? Dov’è? Apparirà, non dubitiamone, si mostrerà, innalzerà il sacro stendardo della libertà. Questo venerabile segnale raccoglierà attorno a sé i compagni della sua sventura. Più impetuosi dei torrenti, lasceranno dappertutto le tracce incancellabili del loro giusto risentimento. Spagnoli, Portoghesi, Inglesi, Francesi, Olandesi, tutti il loro tiranni diverranno preda del ferro e del fuoco. I campi americani s’inebrieranno con trasporto di un sangue che attendevano da così tanto tempo e le ossa di tanti sfortunati, ammassate da tre secoli, trasaliranno di gioia. L’antico mondo unirà i suoi applausi al nuovo. Ovunque si benedirà il nome dell’eroe che avrà ristabilito i diritti della specie umana, ovunque si erigeranno dei trofei alla sua gloria. Allora il codice nero sparirà; e quanto sarà terribile il codice bianco, se il vendicatore non consulterà che il diritto di rappresaglia! In attesa di questa rivoluzione, i negri gemono sotto il giogo dei loro lavori, la cui descrizione non può che renderci più interessati al loro destino[2].
I concetti-chiave ci sono già tutti: «diritti della specie umana», «rivoluzione», «codice» ecc. Poco sopra, nello stesso capitolo, Diderot aveva fatto intervenire un’altra figura, odiosa stavolta, quella del negriero intento ai propri affari, e, soprattutto, quella della religione che, proibendo la resistenza al male ̶ cioè il Cristianesimo ̶ li legittimava. Qui, la laicità occidentale emette, in concreto, i suoi primi vagiti rivoluzionari:
Guardate quest’armatore che, curvo sul proprio scrittoio, regola, con la penna in mano, il numero di attentati che può far commettere sulle coste della Guinea; che esamina, a suo agio, di qual numero di fucili avrà bisogno per ottenere un negro, quante catene per tenerlo garrotato sul suo naviglio, quante fruste per farlo lavorare; che calcola, a sangue freddo, quanto gli varrà ogni goccia di sangue che questo schiavo verserà nella sua abitazione; che discute se la negra darà di più o di meno alle sue terre, con i lavori delle sue deboli mani, che con i pericoli del parto. Voi fremete… Eh! Se esistesse una religione che tollerasse, che autorizzasse, non foss’altro che con il suo silenzio, simili orrori; se occupata in questioni oziose o sediziose, non tuonasse senza posa contro gli autori o gli strumenti di questa tirannia; se essa facesse addirittura un crimine, per lo schiavo, spezzare le sue catene; se soffrisse di avere in seno a sé il giudice iniquo che condanna a morte il fuggitivo: se questa religione esistesse, non bisognerebbe strozzarne i ministri sotto le rovine dei loro altari?[3]
Questa «religione» esisteva. È esistita, per secoli, dopo la scoperta dell’America, e durante tutto il corso dell’età coloniale, fin nel secolo XIX, pronta a legittimare gli orrori della schiavitù in nome del «diritto canonico», quel diritto preteso superiore al «diritto naturale», che derivava dall’appartenenza confessionale alla sola e unica vera Religione Cattolica, Apostolica e Romana ̶ i nativi americani, non avendo ricevuto la rivelazione e dediti a «culti barbarici», erano considerati alla stregua di non-uomini o di animali. Ma più tardi anche la religione «pretesa Riformata» non fu da meno in tal senso, a legittimare o tollerare la schiavitù nel mondo (a parte individuali eccezioni).
Le riflessioni di Diderot sfociarono, una decina di anni più tardi, nelle prime dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino e nel già menzionato decreto di abolizione della schiavitù senza indennizzo per i proprietari, che fu sancito dalla Convenzione Nazionale a maggioranza giacobina. È il decreto 2262, del 16 Pluvioso, anno II (4 febbraio 1794) della Repubblica Francese, una e indivisibile, che abolisce la schiavitù dei negri nelle colonie:
La Convenzione Nazionale dichiara che la schiavitù dei Negri in tutte le Colonie è abolita; di conseguenza, decreta che gli uomini, senza distinzione di colore, domiciliati nelle colonie, sono cittadini Francesi e godranno di tutti i diritti garantiti dalla Costituzione. In nome della Repubblica, il Consiglio esecutivo provvisorio comunica e ordina a tutti i corpi amministrativi e tribunalizi, che la presente legge facciano consegnare nei loro registri, leggere, pubblicare ed affiggere, ed eseguire nei loro dipartimenti e competenze rispettive; in fede di ciò, noi vi abbiamo apposto la nostra firma e il sigillo della Repubblica. A Parigi, il ventiduesimo giorno di Germinale, anno II della Repubblica Francese, una e indivisibile.
Cosa bisogna intendere precisamente, a quest’epoca, con la parola «laico» e, più tardi con «laicità», termini che accompagnano questi eventi emancipativi e fondatori?
- Le insidiose ambiguità della nozione di «laicità»
La tematica della «laicità» eccede senz’altro i limiti di questo breve intervento. Tenterò dunque di abbozzare soltanto i contorni della questione, con riferimento alle prime apparizioni della “cosa”, la laicità, nell’età dell’Illuminismo e della Rivoluzione dell’Ottantanove, prima che appaia la parola “laicité”, in francese (la prima delle lingue europee). Il termine laicità appare infatti solo alla fine del XIX secolo, in occasione del caso Dreyfus, affermandosi poi nella lingua corrente sulla scia della Loi Émile Combes, del 1905, ancora oggi in vigore in Francia (con alcuni ritocchi in senso reazionario, voluti da N. Sarkozy), che sancì la radicale separazione dello Stato dalle Chiese, in particolare la Cattolica, soprattutto sul terreno dell’educazione.
L’aggettivo laïque (o laïc) esisteva già da gran tempo, come attestano i dizionari dei secoli XVII e XVIII. Il significato era sinonimo di «secolare», ossia di non appartenente al clero o all’apparato ecclesiastico, con valenza neutra, avente anche funzione di sostantivo: «un laico», come dirà il Littré nel Dizionario della lingua francese del 1873, è «colui che non è né ecclesiastico, né religioso»[4]. Ma nell’etimologia il termine ha due fonti: 1/ dal greco laos, che designa il popolo, distinto da ethnos e demos che esprimono il senso sociologico o politico. Laikòs significa dunque «del popolo» o «popolare». 2/ Più tardi, in età tardo medievale, interverrà il senso di laicus, in latino, come di ciò che non è appartenente alla chiesa.
I due significati, in età moderna vengono a sovrapporsi e a condensarsi. Quindi, «laico» è termine che si situa alla giuntura di due significazioni assai diverse: «laico» è insieme colui che appartiene al popolo e colui che non esercita alcuna funzione sacerdotale in seno alla chiesa. Tale ambiguità o ambivalenza spiega una serie di malintesi che continuano a interessare il concetto tardivo, contemporaneo, di laicità, inteso oggi più come antitesi alle credenze e alle religioni che come equivalente dell’appartenenza al popolo (laos). Tra senso neutro e senso «militante», la laicità è perciò spesso malintesa e può servire a giustificare delle prese di posizione talora opposte. È un’opposizione che viene a risorgere, oggi, in un periodo che si potrebbe definire critico per la laicità. Le profonde trasformazioni che nel mondo contemporaneo interessano lo statuto del «credere» e della credenza, in seno alle società globalizzate, accanto al risorgere di movimenti più o meno radicali e integralisti in campo religioso ̶ come anche il nesso tra le diverse «credenze» in situazioni socio-politiche difficili per certe popolazioni del pianeta ̶ , favoriscono confusioni e amalgami che sfociano sempre più in conflitti violenti e in soluzioni criminali, contrari alla pace civile e, in ultima analisi, all’equilibrio della civilizzazione mondiale.
Qui la laicità diventa una posta politica importante, che gioca a vantaggio di situazioni o di progetti contraddittori – come, ad esempio, i propositi di «laicizzare» contesti sociopolitici (Medio Oriente, bacino mediterraneo) in cui le religioni rivelate giocano tuttora un ruolo culturale egemone: quale «credere» o «credenza» offre la laicità in alternativa alle religioni rivelate?. La laicità ridiventa così un problema al quale occorre trovare una soluzione che giochi positivamente al fine di assicurare un «vivre ensemble dans la dignité» ̶ come sostiene a ragione Fathi Triki[5] ̶ per ottenere il quale occorre riportarci, in certo modo, da storici, alle sue fonti. Dobbiamo riportarci cioè all’epoca in cui le società europee dell’Occidente erano anch’esse profondamente marcate dal peso del fatto religioso, nella sua massima potenza d’espressione. Il periodo cruciale è quello che gli storici definiscono «l’età dei Lumi», tra Seicento e Settecento, cioè l’età della diffusione, su ampia scala, di un senso comune razionalista nuovo, che affrancò gli uomini dal vincolo pubblico sacrale, portando le società umane a ricostruire, su nuove basi, il nesso tra potere politico e credenza.
Per dirla in breve, la filosofia tra Sei e Settecento, dallo Spinoza del Trattato teologico-politico (1670) al Diderot dell’Encyclopédie (1751-1772), ha spostato il centro della battaglia per le istituzioni del vivere comune, dal legame sociale tra politica e credenza (legge divina, ispirata alle Sacre Scritture e alle diverse Chiese), al legame sociale che s’istituisce tra politica e diritti dell’uomo, più precisamente «i diritti del genere umano» di cui parla Diderot nel Contributo alla Storia delle due Indie, letto sopra, che diventarono un nuovo «credo» universale. I diritti del genere umano come nuovo «credo» universale, è ci che fa oggi problema. Questo concetto superò e integrò la funzione storica e sociale svolta per secoli dalle credenze religiose e assunse un ruolo nuovo, non ovunque e universalmente egemone. Fu uno spostamento di portata universale e cruciale nella storia dell’umanità.
- La nascita vera e propria della laicità
Con l’abolizione della schiavitù sancita dall’Assemblea nazionale dell’Ottantanove ̶ il «vero» Ottantanove ̶ assistiamo dunque propriamente alla nascita della laicità. È una data capitale nella storia della politica e dei diritti dell’uomo, il 4 febbraio 1794, che fa il paio solo con quella, parallela, di un’altra legge precedente, che dichiarò, nel 1791, eguali e liberi nei diritti tutti i cittadini francesi di confessione ebraica. Anche questa fu una legge fortemente voluta, dopo la fuga del re a Varennes, stavolta da una minoranza di girondini e dai giacobini insieme, che realizzava in concreto gli assunti contenuti negli articoli 10 e 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino dell’agosto dell’Ottantanove: «Art. 10. Nessuno può essere perseguito per le sue opinioni, anche religiose, purché le loro manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge. Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: ogni Cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge». La notte del 27 settembre 1791, dopo un lungo e drammatico dibattito, l’Assemblea nazionale votò la seguente legge:
L’Assemblea Nazionale, considerando che le condizioni richieste per acquisire il titolo di cittadino francese, di godere dei diritti di cittadini attivi, sono definiti dalla Costituzione; dato che ogni uomo che soddisfa tali condizioni, presta il giuramento civile e promette di adempiere a tutti i doveri imposti dalla Costituzione, ha diritto con ciò stesso a tutte le prerogative da essa accordate, abroga tutti gli aggiornamenti, tutte le riserve e le eccezioni che contengono gli antichi decreti relativi agli ebrei che prestavano il giuramento civile, in quanto tale giuramento deve essere considerato come una rinuncia a tutti i privilegi e alle leggi eccezionali che sono state precedentemente stabilite in loro favore.
Era la formula legale alquanto contorta per esprimere l’eguaglianza di diritti degli ebrei nei confronti degli altri cittadini della Nazione francese. Non esisteva più una «Nazione ebraica». Si abrogavano pretesi «privilegi», di razza, di stirpe, di religione, per restituire agli ebrei dignità e parità di uomini e cittadini. Dal quattordicesimo secolo gli ebrei non avevano il diritto di risiedere, né di soggiornare nelle terre del «Re Cristianissimo». Fatti salvi appunto i «privilegi particolari», come quelli di cui godevano gli ebrei di Bordeaux e di Bayonne o ancora quelli di Metz e d’Alsazia e, infine, di Parigi. E il loro commercio, anch’esso godeva di «privilegi» in tutto il regno. Come insegnò l’abate Sieyès, il privilegio è esenzione, dispensa per colui che l’ottiene, e scoraggiamento per tutti gli altri. Ma solo per gli ebrei quei «privilegi» significavano l’esatto contrario.
Il decreto tuttavia sortì un effetto singolare: non tutti i «cittadini francesi di religione ebraica» erano d’accordo. Perché? Il decreto esigeva infatti che, contemporaneamente e di conseguenza, gli ebrei rinunciassero a tutto ciò che aveva fatto di loro, fino a quel momento, una minoranza comunitaria solidamente organizzata. Il termine di «Nazione ebraica» portoghese o d’Alsazia è dunque definitivamente estirpato dalla lingua; ma anche le strutture comunitarie esistenti, i poteri dei rappresentanti e dei preposti, le giurisdizioni rabbiniche, le tassazioni per le casse di carità, tutto era abolito d’un colpo. Come era stato abolito, con grande clamore, pochi anni prima, il port de la rouelle, il «passo della rotella», il marchio o segno distintivo, una stoffa rotonda di tessuto giallo che gli ebrei dovevano portare addosso, per essere riconosciuti. I tradizionalisti s’opposero alla scomparsa di quel marchio, con disperazione, perché la rotella gialla dava ancora il segno della loro «elezione». Qui tocchiamo uno dei paradossi o aporie della laicità: nelle società chiuse o di lunga e grande tradizione religiosa, l’appartenenza comunitaria – con tutti i suoi segni, simboli e pratiche – è sentita, in molti casi, come avente un valore superiore alla stessa uguaglianza e libertà. In questi casi, perché si affermino i «diritti dell’uomo» (uguaglianza e libertà), occorre cambiare anzitutto il senso comune, operare cioè per quel cambiamento in un modo pacifico, attraverso i mezzi di formazione e di educazione delle coscienze, prima di affermare o rivendicare ogni «primato della laicità».
Ad ogni modo, in queste due leggi, l’abolizione della schiavitù e l’emancipazione degli ebrei, che cambiarono l’esistenza di milioni di esseri umani – anche se per un breve lasso di tempo[6] – la laicità prende corpo concreto, in leggi e pratiche di vita sociale nuove che marcheranno la cultura e le mentalità degli uomini moderni, il loro senso comune, anzitutto. Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che i rivoluzionari dell’89 e gli stessi filosofi più progressisti, sopra menzionati, che li avevano ispirati, non avevano ancora chiara l’idea-cardine del nostro concetto di laicità, come separazione dello Stato dalla Chiesa.
Tant’è che il 12 luglio 1790, per integrare i poteri della stessa Chiesa nelle nuove finalità della rivoluzione in corso, l’Assemblea decreterà la Costituzione civile del clero ̶ quella che auspicò lo stesso Spinoza nel Trattato Teologico-politico, ̶ ossia la sottomissione della Chiesa alla Repubblica, con un duplice scopo: provvedere al mantenimento del clero, per il servizio pubblico che questo assicura e, in contropartita, la costituzione di una «chiesa nazionale» fondata sul principio dell’elezione dei curati e dei vescovi, che s’impegna ad essere fedele alla nazione e alla Costituzione. In molti casi vi fu il rifiuto degli ecclesiastici di sottomettersi al giuramento civile, e la rivolta dei cosiddetti «refrattari» aprirà le porte, insieme, alla guerra civile in Vandea e a un’attitudine sempre più offensiva e ostile dei rivoluzionari nei confronti della Chiesa cattolica, considerata oramai come un avversario da combattere, anche opponendole una nuova religione civile, come quella concepita da Rousseau nel Contratto sociale, con il culto dell’Essere Supremo.
Si aprono così le porte a due successive tappe di avanzamento della laicità.
La prima è la laicizzazione dello stato civile, con il decreto del 20 settembre 1792, che ritirò alla chiesa cattolica e affidò alle singole municipalità locali, con il ruolo dell’ufficiale di stato civile, sotto sorveglianza delle autorità amministrative e, più tardi, del giudice, il compito di tenere tre registri, per le nascite, i matrimoni (e i divorzi) e i decessi. Allo stesso tempo, con la legge del 21 settembre 1791 sul divorzio, il matrimonio non è più un sacramento o atto della chiesa, ma un contratto, per scambio di consensi tra gli sposi dinanzi all’ufficiale di stato civile e i testimoni. Conseguentemente, il divorzio è la rottura consentita di tale contratto.
La seconda tappa, decisiva, è il Decreto sulla libertà di culto e la separazione delle chiese e dello Stato, del 3 ventoso anno III della Repubblica, il 21 febbraio 1795. Sotto il regime della Convenzione nazionale e dopo la caduta di Robespierre (29 luglio 1794) vengono prese delle decisioni importanti che formulano per la prima volta in assoluto, in termini espliciti, la separazione della Chiesa cattolica e della Repubblica. È chiamato il «Decret sur la liberté des cultes»:
La Convenzione Nazionale, dopo aver ascoltato il rapporto dei suoi Comitati di salute pubblica, di sicurezza generale e di legislazione, riuniti, decreta:
Art. I. Conformemente all’articolo VII della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, e all’art. XXII della Costituzione, l’esercizio di nessun culto può essere turbato.
Art. II. La Repubblica non ne finanzia nessuno.
Art. III. Essa non fornisce alcun locale, né per l’esercizio del culto, né per l’alloggio dei suoi ministri.
Art. IV. Le cerimonie di ciascun culto sono proibite al di fuori del recinto chiuso scelto per il loro esercizio.
Art. V. La legge non riconosce alcun ministro del culto: nessuno può comparire in pubblico con gli abiti, gli ornamenti o i costumi adibiti alle cerimonie religiose.
Art. VI. Ogni assembramento di cittadini per l’esercizio di un qualsivoglia culto è sottoposto alla sorveglianza delle autorità costituite. Questa sorveglianza si riassume nelle misure di polizia e di pubblica sicurezza.
VII. In un luogo pubblico, non può essere apposto alcun segno particolare di un culto, né esteriormente, in qualunque maniera si dia. Il luogo che gli viene assegnato non può essere designato da alcuna iscrizione. Nessuna proclamazione, né convocazione pubblica può essere fatta per invitarvi i cittadini.
VIII. I comuni o le sezioni di comune, in nome collettivo, non potranno acquistare né affittare locali per l’esercizio dei culti.
- Non può essere formata alcuna dotazione perpetua o vitalizia, né essere istituita alcuna tassa per pagarne le spese.
- Chiunque turbasse con la violenza le cerimonie di un culto qualsivoglia, o ne offendesse gli oggetti, sarà punito secondo la legge del 22 luglio 1791 sulla polizia e il tribunale correzionale.
Con quest’ultimo decreto si compie il passo essenziale della vera e propria separazione Stato(Repubblica)/Chiesa, inscritto pochi mesi dopo, il 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795), nella stessa Costituzione del 1795, detta «Costituzione del Direttorio»:
Art. 334. A nessuno può essere impedito di esercitare, in conformità con le leggi, il culto che ha scelto. Nessuno può essere costretto a contribuire alle spese di alcun culto. La Repubblica non ne finanzia nessuno.
Con l’avvento di Napoleone Bonaparte e il Concordato tra la Repubblica francese e il Vaticano del 15 luglio 1801, e la svolta autoritaria della Rivoluzione, si riconoscerà di nuovo una sorta di primato alla religione cattolica, non come «religione di Stato» ma come (Art. 1) «La religione della grande maggioranza dei Francesi», tenendo fermo il principio democratico del consenso e la nozione di maggioranza, con le dovute tutele e «riconoscimenti» egualmente dei culti protestanti, calvinista e luterano, e il culto ebraico, che assumono anch’essi uno statuto pubblico. Napoleone mette all’opera quello che la Rivoluzione aveva fondato: la libertà di coscienza e la libertà di culto, nei limiti dell’ordine pubblico, cioè della sottomissione alla legge e al governo.
- La ri-clericalizzazione della società civile. Dove risiede la laicità?
Il 30 luglio 1814, a Roma, in piena Restaurazione, con la bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum, il papa Pio VII ricostituì la Compagnia di Gesù in tutto il mondo, soppressa nel 1762 in seguito allo scandalo del Père de La Vallette. La Rivoluzione era finita, la Francia sconfitta, le potenze europee si stavano ricostituendo dopo il congresso di Vienna in una «Santa Alleanza». Il nemico da battere non era più Bonaparte e i rivoluzionari, ma le opere da loro compiute in venticinque anni di sconvolgimenti, di equilibri di potere, di mentalità, di senso comune. Occorreva riconquistare le coscienze, contaminate dal virus rivoluzionario dei diritti dell’uomo.
Il primo obiettivo della ricostituita Societas Iesu, in Francia e altrove, fu dunque l’educazione. Sul terreno dell’educazione e della formazione la Rivoluzione aveva compiuto passi da gigante, istituendo l’Istruzione pubblica, le Grandi Scuole di formazione superiore, aveva tolto al clero quel compito di educazione delle coscienze che fino al 1789 era stata loro esclusiva prerogativa e privilegio. La lotta, a partire dal 1814, si sposta perciò sul terreno della scuola primaria e degli Istituti superiori. La chiesa cattolica centrerà le proprie rivendicazioni su questo piano per riconquistare l’autorità di cui disponeva nell’Ancien Régime, per formare così le nuove generazioni all’obbedienza a un ordine spirituale che era, al tempo stesso, un ordine politico e sociale.
La libertà di coscienza ̶ centrale nelle stesse leggi napoleoniche e inscritta al cuore del codice che porta il nome di Codice napoleonico ̶ , diventa e resta, ancora ai giorni nostri, l’agone nel quale si gioca la partita delle libertà civili e del potere politico.
In che cosa può dunque consistere oggi, in tempi di globalizzazione e di migrazione generalizzata di uomini e idee, la libertà di coscienza? Anzitutto il concetto deve confrontarsi con le sensibilità culturali dei popoli in cui deve esprimersi ̶ secondo la grande lezione del determinismo geografico di Montesquieu ̶ e dei diversi strati sociali cui si riferisce, in rapporto all’operazione di presa di distanza e di separazione delle leggi delle religioni da quelle dello Stato. Tzvetan Todorov (1939-2017), semiologo e filosofo di origini bulgare scomparso un anno fa, ha scritto un’opera importante intitolata, L’esprit des Lumières, «Lo spirito dell’Illuminismo», in cui affronta in modo assai efficace la questione. Per Todorov anzitutto, le Lumières «non possono ‘passare’, perché sono giunte a designare non più una dottrina storicamente situata, ma un’attitudine nei confronti del mondo»[7].
All’interno di questa attitudine, riconosciuta tale anche da Michel Foucault[8], esistono sempre tre «sfere» della libertà di coscienza dell’individuo, piuttosto che le due tradizionalmente riconosciute: 1 / la «temporale», legata alla storia, e 2/ la «spirituale», legata alle convinzioni metafisiche di appartenenza (comunitaria) di ciascuno, alle credenze. La terza sfera, la più importante, è 3/ «la sfera privata e personale che l’individuo è il solo a gestire, senza che nessuno vi trovi niente da ridire». Il problema della laicità si connette all’esercizio e all’attività di questa terza sfera. Come dunque la sfera dell’intimità personale del credere, che non si può aggirare, può costituirsi, senza venire schiacciata dalle altre due, in un ambiente geo-storico dato? E anche: quale spazio lasciare al senso del sacro ̶ come la coscienza e la sensibilità privata e individuale del divino ̶ fuori di ogni discorso o posizione ecclesiastica istituzionale? Il problema della costituzione della laicità e del suo spazio inviolabile si esprime oggi, a mio avviso, in questi termini. Come lasciare libertà di costituzione, nei diversi ambiti e contesti geo-storici determinati, a questa terza sfera, in ogni individuo? Anzi, di più: come favorire, a livello culturale e istituzionale, la sua costituzione? Ciascuno di noi ̶ uomini e intellettuali del XXI secolo, emancipati grazie all’operazione storico-culturale dell’Illuminismo[9] ̶ ha una propria «religione personale», anche inconsapevole, taciuta, che s’esprime nell’intimità del dialogo con sé e prende poi corpo nell’agire quotidiano.
Il problema dei fallimenti o delle difficoltà di diffondere un senso comune laico, di farlo divenire egemone, in contesti profondamente marcati dalla presenza, talora ingombrante, delle tradizioni religiose e delle istituzioni ecclesiastiche, consiste proprio nella difficoltà di coltivare questa terza sfera della libertà di coscienza, che in molti contesti geo-politici non giunge neanche a formarsi. Il ruolo dell’educazione è qui decisivo, strategico direi.
Quando è possibile formare le coscienze a sentire il valore dello spazio dell’intimità individuale del sacro, allora sarà anche possibile togliere potere di presa, sulle stesse coscienze, delle tradizioni religiose e degli istituti ecclesiastici. L’asserzione laica fondamentale: «la religione è un fatto privato» va intesa non come un’ingiunzione o un imperativo dogmatico, da imporre con la forza, ma come un compito aperto, un progetto delicato e difficile, che spetta alla filosofia e alle istituzioni formative pubbliche realizzare. Ed è anche questo un lascito incompiuto del «vero Ottantanove».
Paolo Quintili
APPENDICE
(Trésor de la Langue Française)
LAÏCITÉ, subst. fém.
A. Principe de séparation dans l’État de la société civile et de la société religieuse. La laïcité est un des grands principes sur lesquels repose, avec l’obligation et la gratuité, l’enseignement public français (Pédag. 1972). Le principe de la laïcité n’est pas absolu : l’Alsace et la Lorraine demeurent sous le régime du Concordat de 1801 (DEBB.-DAUDET Pol. 1978) :
- … M. Piou fonde l’Action Libérale Populaire, merveilleux régulateur de l’opinion bien pensante, parfait outil aux mains de la République anticléricale, et qui va lui permettre de poursuivre, avec le minimum d’à-coups, jusqu’au vote de la Loi de Séparation, le grand œuvre de la Laïcité.
BERNANOS, Gde peur, 1931, p. 366.
- Caractère des institutions, publiques ou privées, qui, selon ce principe, sont indépendantes du clergé et des Églises; impartialité, neutralité de l’État à l’égard des Églises et de toute confession religieuse. Laïcité de l’État, de l’école publique. Pourtant le cœur déchiré, broyé par la vision du châtiment, il s’attachait encore aux paradis menteurs de la laïcité et implorait à mi-voix l’appui de son député (AYMÉ, Vouivre, 1943, p. 244) :
- En France, on préféra instituer un système dont le principe paraissait plus conciliable avec les conceptions constitutionnelles de neutralité et de laïcité. Aussi l’État s’interdit-il d’aider matériellement, de patronner, d’appuyer ou d’encourager d’une manière quelconque l’action privée dans le domaine de l’enseignement…
Encyclop. éduc., 1960, p. 89.
Prononc. et Orth. : [laisite]. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist. 1871 (La Patrie, 11 nov. ds LITTRÉ Suppl.). Dér. sav. de laïc*; suff. -(i)té*. Fréq. abs. littér. : 25. Bbg. MAUGENEST(D.). Laïcité auj. Cah. de l’actualité relig. et soc. 1981, no 223, pp. 215-216.
[1] Di fondamentale importanza il volume di O. R. Bloch (a cura di), Le matérialisme du XVIIIe siècle et la littérature clandestine, Paris, Vrin, 1982; e la rivista semestrale «La Lettre Clandestine», Paris, 1992-2018.
[2] Histoire des deux Indes, Genève, Pellet, 1781, vol 6, Livre XI, chap. XXIV, pp. 134-135: «Origine et progrès de l’esclavage. Arguments imaginés pour le justifier. Réponse à ces arguments» (corsivi miei).
[3] Ivi, p. 127.
[4] Dictionnaire de l’Académie Française, Paris, 1694: «LAIQUE. adj. de tout genre. Seculier. Il est opposé à Clerc & Ecclesiastique. Une personne laïque. un Officier laïque. de condition laïque. la communion laïque. Chappelle en patronage laïque. Il est souvent substantif. Un laïque. les Ecclesiastiques & les laïques.» ; l’ed. 1762 aggiunge: «Qui n’est ni Ecclésiastique ni Religieux. Une personne laïque. Un Officier laïque. De condition laïque. Chapelle en patronage laïque. Patron laïque». É. Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1873 : «Qui n’est ni ecclésiastique ni religieux. ̶ «Ainsi ce qu’on gagna dans la réforme, en rejetant le pape ecclésiastique successeur de saint Pierre, fut de se donner un pape laïque, et de mettre entre les mains des magistrats l’autorité des apôtres» (BOSSUET, Var. V, 8). Fig. ̶ «Nous sommes [Diderot et moi] des missionnaires laïques qui prêchons le culte de sainte Catherine» (VOLTAIRE, Lett. Catherine II, 1er mars 1773) . Substantivement. Un laïque. Une laïque. ̶ «Ils [les Vaudois] voulaient que les laïques, gens de bien, eussent pouvoir de l’administrer [la confirmation] comme les autres sacrements» (BOSSUET, Var. XI, 107). ̶ «Les pasteurs qui ont fondé leurs Églises [des protestants] étaient presque tous de simples laïques» (FÉN. T. II, p. 5). Qui est propre aux personnes laïques. Condition laïque. ̶ «Mme de Warens imagina de me faire instruire au séminaire pendant quelque temps…. il [l’évêque] permit que je restasse en habit laïque, jusqu’à ce qu’on pût juger, par un essai, du succès qu’on devait espérer» (J.J. ROUSSEAU, Conf. III). On écrit aussi laïc au masculin. HISTORIQUE. XVIe s. ̶ «Ils n’ont point estimé que leur droit fust aucunement amoindri, s’ils estoient sujects aux juges laïcs, quant aux causes civiles» (CALV. Instit. 983). ̶ «Le pape ne peut deroger ni prejudicier par provisions beneficiales, ou autrement, aux fondations laïcales, et droit des patrons laïcs de ce royaume» (P. PITHOU 30). ÉTYMOLOGIE. Provenç. laic, layc ; anc. catal. llaych ; anc. espagn. laico ; portug. leigo ; ital. laico ; du lat. laïcus, qui vient d’un terme dérivé du mot grec signifiant peuple».
[5] Cfr. Fathi Triki, Éthique de la dignité, Révolution et vivre ensemble, Tunis, Arabesques, 2018 ; ID, La philosophie du vivre-ensemble, L’Or du temps, Tunis 1998; ID, Vivre ensemble dans la dignité, Video realizzato da Vincent Cespedes: https://www.youtube.com/watch?v=ImyRhJwhjik.
[6]Con l’avvento di Napoleone Bonaparte la schiavitù venne reintrodotta, e si diede corso alla repressione della nuova repubblica libera di Santo Domingo (Haiti), con a capo il primo leader nero della storia occidentale, Toussaint Louverture (1743-1803): cfr. Madison Smartt Bell, Toussaint Louverture. A Biography, New York, Pantheon Books, 2007; Aimé Césaire, Toussaint Louverture, la révolution française et le problème colonial, Préface de Charles-André Julien, Paris, Présence Africaine, 1961.
[7] T. Todorov, L’esprit des Lumières, Paris, Robert Laffont, 2006, p. 125 ; Lo spirito dell’Illuminismo, trad. it. di G. Lana, Milano, Garzanti, 2007.
[8] M. Foucault, Qu’est-ce que les Lumières ? (1984), in Dits et écrits, vol. 2, Paris, Gallimard, 1989.
[9] Cfr. Il mio saggio (inedito): Laïcité, citoyenneté et nouveaux processus d’universalisation. Vers des nouvelles « Lumières » méditeranéennes ?, conferenza tenuta in occasione della Journée Mondiale de la Philosophie UNESCO, Tunisi, 16-17 novembre 2015, pp. 8-10.