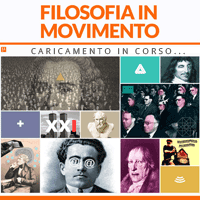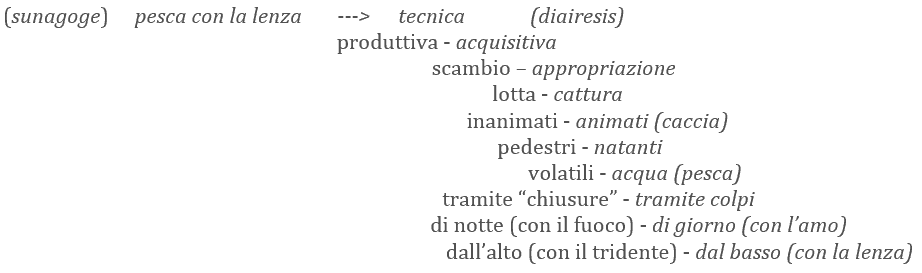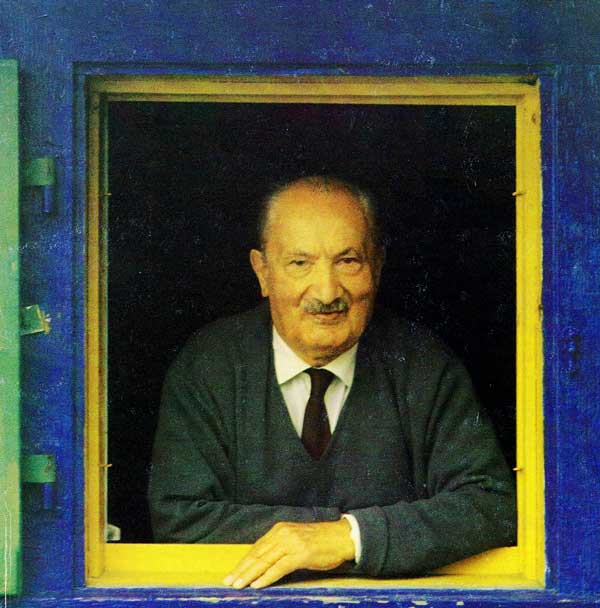Il Timeo di Platone
Il Timeo di Platone
di Francesco Fronterotta
[drop_cap style=”2″ bgcolor=”#dddddd” color=”#787882″]I[/drop_cap]l Timeo, composto fra il 355 e il 350 a.C. e appartenente perciò all’ultima fase della produzione di Platone (che morì, mentre era intento alla redazione dell’ultima sua opera, le Leggi, nel 347), è un dialogo peri phuseos, sulla natura. Ma tale precisazione non chiarisce in nessun modo l’oggetto dell’esame che vi è condotto né giustifica l’ampiezza e la varietà degli argomenti che gli interlocutori del dialogo si dedicano via via ad affrontare, con accenti, modalità e lunghezza di volta in volta assai disuguali. In linea di principio, e in via del tutto preliminare, è possibile osservare che il Timeo doveva offrire, insieme con il Crizia e forse con l’Ermocrate, che non fu mai scritto, un quadro complessivo che permettesse di fondare en te phusei, “nella natura”, quei tratti ideali, e in qualche misura utopici, della città perfetta che Socrate aveva presentato nella Repubblica e riassunto per sommi capi proprio all’inizio del Timeo (17c-19c). Si può quindi immaginare che, per legittimare un’adeguata fondazione della città perfetta nella concretezza del divenire e della storia, si debba innanzitutto procedere esaminando l’educazione, la costituzione e l’origine degli uomini che ne saranno i cittadini e, avanzando ancora a ritroso lungo questo percorso, il principio, la composizione e la struttura dell’intero universo, nel quale e a partire dal quale gli uomini trovano la loro origine. Infatti, solo a condizione di mostrare che l’universo e i viventi che lo popolano manifestano una qualche forma di equilibrio, di armonia e di perfezione, diverrà possibile pensare che la fondazione di una città perfetta, costituita cioè secondo il modello dello stesso universo e con il materiale “umano” effettivamente disponibile, sia concretamente e storicamente verosimile e credibile. Una volta individuato così il fondamento di legittimità del discorso intorno alla città perfetta, l’esposizione potrà progredire ulteriormente, giungendo a proporre un resoconto, a metà strada fra la storia e il mito, del comportamento “reale” della città perfetta e dei suoi cittadini, delle sue azioni belliche e dei suoi straordinari exploits. Timeo discuterà perciò, nel Timeo, della “natura dell’universo, (…) cominciando dall’origine del cosmo e fino alla natura dell’uomo”, mentre Crizia, nel Crizia, “come avendo ricevuto [da Timeo] gli uomini cui ha dato vita con il suo discorso (…), dopo averli condotti davanti a noi come fossimo giudici”, ne farà “i cittadini di questa città, gli ateniesi di quell’epoca, che, da oscuri che erano, la tradizione dei testi sacri ci ha riportato alla memoria”, parlandone “come di nostri concittadini e di ateniesi” (Tim. 27a-b).
Il primo e fondamentale interrogativo che si pone per ogni discorso cosmologico, o quantomeno per quello che il Timeo si propone di condurre, è certo il seguente: il mondo ha un inizio nel tempo oppure è eterno? In prima battuta, il Timeo sembra fornire una risposta esplicita al nostro interrogativo. Infatti, alla domanda se il cosmo (1) sia sempre stato (en aei); oppure (2) sia nato (gegonen), Timeo replica netto (28b-c): il mondo “è nato” (gegonen) e ciò, inoltre, “per azione di una causa”, un’affermazione che pare supporre, quale che sia l’interpretazione del dialogo nel suo insieme, un “inizio” della vicenda cosmica. È vero, naturalmente, che il verbo greco gignesthai significa sia “divenire” sia “nascere”, nel secondo caso soltanto, dunque, implicando la “nascita” dell’universo, cioè la sua generazione nel tempo, mentre nel primo caso, se l’universo “diviene”, ciò significa semplicemente che si tratta di una realtà instabile e soggetta al mutamento e che in un certo senso si genera e si corrompe continuamente (o si generano e si corrompono gli enti in esso contenuti), il che non implica però che sia “nato” in un momento determinato del tempo, cioè che se ne possa porre un “inizio”. Vi sono però ragioni per supporre che il mondo sia stato generato, e che dunque abbia avuto un inizio nel tempo, e in particolare il fatto che viene chiamato in causa un demiurgo divino che lo genera e che, di conseguenza, se ne descrive concretamente la generazione. Ma anche questo argomento, apparentemente inconfutabile, risulta tuttavia in qualche misura controverso, perché dipende dallo statuto narrativo, letterale o metaforico, che si attribuisce all’esposizione di Timeo e al ruolo che in essa viene così attribuito al demiurgo cosmico. Le due questioni, dell’origine o dell’eternità del mondo e della natura dell’artigiano supremo che lo ha prodotto e della sua azione produttiva, sono perciò indissolubilmente connesse.
Il demiurgo è infatti colui il quale riproduce nel tempo l’ordine e la disposizione delle realtà eterne, così fabbricando le cose sensibili assumendo come modello le idee intellegibili. Ora, fra le numerose questioni che una simile ipotesi, appena evocata, suscita, ne sottolineo particolarmente una, a mio avviso fondamentale per l’attuale esame: il demiurgo agisce nel tempo o al di fuori del tempo? In altri termini: con la figura del demiurgo, che rinvia all’esigenza di una mediazione fra le realtà atemporali e le realtà temporali, Platone vuole farci intendere che tale mediazione fra l’atemporale e il tempo (1) sussiste da sempre, al di fuori del tempo, sicché quella del demiurgo è di fatto una metafora, oppure (2) che essa ha avuto un inizio nel tempo, sicché il demiurgo va concepito allora come una figura personale, caratterizzata da una volontà e da una capacità di decisione che si esplica in base a un piano o a una previsione razionale? Questa è, evidentemente, la difficoltà principale posta dall’esposizione del Timeo. Ma le risposte possibili a tale domanda comportano entrambe delle temibili difficoltà. (1) Se infatti la mediazione demiurgica fosse originaria ed eterna e al di fuori dal tempo, bisognerebbe allora supporre o (A) che essa è in atto già da sempre, sicché, dunque, la funzione demiurgica non si configura come un’azione deliberata, ma come metafora di uno stato di cose o di una condizione che sussistono da sempre, e occorrerebbe in tal caso spiegare in che modo, negando di fatto che si dia un’effettiva generazione dell’universo che, anch’esso, sussisterebbe da sempre come una realtà eterna; oppure (B) che, trattandosi invece di un’azione deliberata di produzione e di modellaggio di un materiale informe, essa si estende letteralmente da un “prima” a un “poi” (perché, se la mediazione demiurgica si presenta come una vera e propria azione deliberata, vi saranno in tal caso un “prima” e un “poi” di questa azione, un momento o una condizione che la precedono e un momento o una condizione che la seguono), introducendo così nuovamente una scansione temporale e, di seguito, un principio o un’origine di tale produzione. (2) Ma se, di conseguenza, il demiurgo possiede questa funzione, se è davvero una “causa” cosciente e responsabile nella misura in cui compie un progetto che, come tale, deve avere un inizio o un punto di partenza, si cade nell’ulteriore difficoltà di dover giustificare sul piano razionale una simile funzione demiurgica associata all’intervento di una divinità personale. Mi pare si tratti di una difficoltà da non sottovalutare per un filosofo, come Platone, che fa dipendere di fatto l’ordine e la disposizione di tutte le cose da un set di modelli eterni, le idee, la cui struttura viene riprodotta su un materiale sensibile altrettanto eterno. Che spazio c’è, infatti, nell’interazione fra un modello e un materiale eterni, per un agente cui si attribuisce l’inizio o l’origine, nel tempo, di tale interazione? Da dove viene questo agente, di cui non sembra esservi traccia negli altri dialoghi? Perché e come questo agente avrebbe scelto un momento in cui dare inizio a tale interazione? A cosa servivano i modelli e il materiale eterno prima dell’intervento del demiurgo? Queste sono solo alcune delle questioni che, nella prospettiva di un’interpretazione letterale del Timeo, rimangono senza una soluzione soddisfacente.
Bisogna allora rivolgersi direttamente, per saggiare la coerenza della concorrente interpretazione metaforica, alla figura del demiurgo. “Costruttore e padre del tutto” (28c), il demiurgo è, innanzitutto, “buono” (29e e passim) il che implica che l’opera da lui compiuta sarà la migliore possibile. Egli possiede molteplici competenze, tecniche e intellettuali a un tempo: plasma la cera (74c), fonde i metalli e lavora il legno (28c; 33b), riunisce armoniosamente le diverse parti della sua opera (30b; 33d); più in generale, è l’artigiano che fa apparire l’ordine universale nel disordine cosmico (53b; 75d) e, allo stesso tempo, l’intelligenza (nous) che “riflette” (30b; 34a; 52d; 55c), “considera” (33b), “parla” (41a-e), “si rallegra” (37c) del prodotto realizzato e della sua somiglianza al modello eterno. In questo senso, il demiurgo rappresenta legittimamente la causa della generazione delle cose sensibili, cui conferisce la forma e la struttura dei paradeigmata ideali, pur rimanendo entro i limiti imposti dalla “minorità” e dall’imperfezione del mondo sensibile: il divino artefice non compie quindi in nessun modo una creatio ex nihilo, perché è costretto a operare nel contesto degli elementi già esistenti a sua disposizione, ai quali può, semplicemente, attribuire un ordine determinato. Ciò spiega l’uso in apparenza stravagante, da parte di Platone, del termine demiourgos, che indica a un tempo l’attività produttrice degli artigiani e la funzione regolatrice dei magistrati: come artigiano, il demiurgo dalle molteplici competenze tecniche e meccaniche “lavora” la materia informe; come magistrato in seno a una comunità, stabilisce l’ordine della sfera sensibile, adeguandolo, per quanto possibile, alla “legge” delle supreme realtà. Diviene così piuttosto chiara la funzione filosofica della figura del demiurgo: trait d’union ontologico fra le cose sensibili e le idee intellegibili, ma diverso da entrambe, egli contempla il mondo delle idee per riprodurne l’immagine nel mondo sensibile su cui ha il potere e la capacità “artigianale” di agire; d’altra parte, può agire sul mondo sensibile proprio in quanto ha il potere e la capacità “intellettuale” e “regolativa” di contemplare e riprodurre in esso l’immagine delle idee. Abbiamo a che fare insomma con l’indicazione di una serie di competenze tecniche o operative del demiurgo, che non contraddicono una sua rappresentazione funzionale e metaforica né pare lecito sostenere che, nell’esercizio delle sue funzioni, il demiurgo metta in atto una volontà personale e che proceda perciò ad azioni propriamente deliberate, dal momento che, nei passi del dialogo in cui si fa riferimento a una “volontà” del divino artefice (cfr. per esempio 30a6-c1; 41a7-c6; 42d2-e4), risulta abbastanza chiaro che ogni sua possibile azione è necessariamente e invariabilmente condizionata dalla perfezione della sua natura, sicché egli non può che produrre l’ottimo, nei limiti del possibile, al punto che, anzi, là dove emerge l’esigenza di popolare il mondo di viventi mortali, il demiurgo affida il compito della loro generazione agli dei suoi aiutanti, appunto perché, essendo a lui inferiori, potranno costituire creature mortali, cioè inferiori a quelle che, se egli se ne assumesse il compito, necessariamente (dunque anche contro la sua volontà) costituirebbe immortali (41a-c). Resta però la questione fondamentale: anche ammettendo la maggiore plausibilità di una comprensione metaforica, e non letterale, della figura e dell’azione produttiva del demiurgo cosmico, come conciliarla con l’indicazione di partenza di un inizio di tale azione, e della vicenda del cosmo cui essa dà avvio, che pare invece da assumere letteralmente?
Si deve tornare a tale proposito alla distinzione fondamentale, che viene stabilita in 27d-28b, fra un genere di realtà “che è sempre, senza avere generazione” e un genere di realtà “che sempre diviene, senza mai essere”; il primo genere di realtà, in quanto è eterno, immobile ed esente da generazione e corruzione, consiste delle idee intellegibili, che possono essere conosciute attraverso il pensiero e il ragionamento, dando luogo a una conoscenza e a un discorso veri perché sempre identici a se stessi, mentre il secondo genere di realtà, in quanto diviene nel tempo, si muove, si trasforma ed è soggetto a generazione e corruzione, consiste nell’insieme delle cose sensibili, che costituiscono l’oggetto di una conoscenza e di un discorso solo parziali e imperfetti. Ciò comporta che il discorso di Timeo, poiché riguarda l’universo (che è una realtà, o un insieme di realtà, sensibile, mutevole, soggetta alla generazione e alla corruzione), e non il modello eterno, immobile e sempre identico, non sarà un discorso pienamente vero, coerente con se stesso ed esatto da ogni punto di vista; si tratterà invece di un discorso soltanto “verosimile” (eikos), nella misura in cui si rivolge a una realtà, o a un insieme di realtà, l’universo, che altro non è che un’immagine (eikon) simile alla realtà vera, una copia imperfetta del modello originale perfetto (29b-d). Se dunque l’universo è una realtà sensibile e se, a questo titolo, esso non può costituire l’oggetto di un discorso pienamente vero e stabile, ma solo di un’esposizione verosimile, sarà proprio questa esposizione a esigere un punto di partenza, in modo da poter dare conto, nei termini temporali di un discorso umano soltanto verosimile, di una realtà eterna. La genesi del cosmo di cui Timeo si ripromette di parlare all’inizio del dialogo (27a-b) non costituirebbe dunque il suo inizio effettivo, la sua origine, ma indicherebbe la sua condizione eternamente mutevole e instabile, soggetta a successive generazioni e corruzioni, ma non a una generazione prima o assoluta – una condizione eternamente mutevole e instabile, nell’ambito della quale occorrerà tuttavia scegliere un punto di partenza del discorso intorno all’universo. Comporre un discorso su una realtà eternamente diveniente, che riproduca tale realtà nel suo eterno divenire, poiché il divenire eterno non può essere narrato se non da un impossibile discorso a sua volta eterno e diveniente, implica che si scelgano fittiziamente un punto di partenza e un punto di arrivo: ma tale scelta proietta sul contenuto di un simile discorso, altrettanto fittiziamente, un’origine e una fine. Ora, che non vi sia un termine dell’universo, una sua fine, è esplicitamente detto nel Timeo (32c), sicché la scelta del termine del discorso di Timeo sull’universo è evidentemente arbitraria ed è fatta coincidere con il completamento dell’universo come lo conosciamo, ossia con la descrizione delle specie viventi che lo popolano (90e-92c); credo si possa perciò ipotizzare che un’analoga condizione valga per l’inizio dell’universo, che non sussiste realmente come tale, ma dipende dall’esigenza di fissare un punto di partenza per il discorso che lo riguarda: per cominciare il discorso intorno al cosmo, si deve scegliere, nell’ambito della vicenda del suo eterno divenire, un inizio; ma questa scelta fa sì che l’inizio scelto per il discorso, l’arche tou logou, si traduca fittiziamente in un’arche tou kosmou, cioè in un inizio della vicenda, che è invece di per sé eterna, del mondo stesso in divenire. Ciò troverebbe corrispondenza nelle frequenti affermazioni di Timeo (cfr. 29c, 34c, 51c-d e passim), secondo cui il discorso che egli conduce è in parte partecipe del caso, come tutti i discorsi umani, e dunque non del tutto esatto e consequenziale, rispetto al suo ordine e alla sua disposizione; vale a dire che, plausibilmente, proprio l’ordine e la disposizione del discorso dipendono da questa strutturale deficienza.
Se dunque quella dell’origine del mondo nel tempo è una metafora costruita a fini espositivi, per illustrare la struttura e la composizione dell’universo in base all’imitazione dei modelli eterni nei limiti di un discorso umano, resta da considerare la sua concreta attuazione seguendo la rappresentazione, essa pure metaforica, dell’attività della produzione demiurgica. Il demiurgo procede infatti alla costituzione del corpo del mondo (31b-34a) servendosi dei quattro elementi fondamentali, fuoco, aria, acqua e terra: poiché l’universo è una realtà generata, e perciò corporea e sensibile, che esaurisce in sé la totalità degli enti sensibili, in esso devono trovarsi gli elementi componenti di tutte le cose. Ma quella operata dal demiurgo non è una composizione casuale, giacché egli procede mescolando i quattro elementi in base a una proporzione ben determinata e conferendo così al corpo del mondo una precisa e armonica struttura matematica. Inoltre, come Timeo spiega più avanti (53b-56c), i quattro elementi si riducono a quattro tipi di particelle elementari infinitamente piccole, dunque invisibili, indivisibili e indistruttibili, associate, rispettivamente, a quattro poliedri regolari: il tetraedro, l’esaedro, l’ottaedro e l’icosaedro; avanzando ulteriormente in questa progressiva riduzione geometrica, i primi tre dei quattro poliedri regolari hanno come base un triangolo equilatero, a sua volta composto da sei triangoli rettangoli scaleni, mentre il quarto ha come base un quadrato. Senza entrare nei dettagli tecnici di questo complesso schema geometrico-matematico, se ne possono tuttavia mettere in luce le ragioni e le finalità: la struttura corporea di tutte le cose acquista, in virtù della sua natura geometrico-matematica, una certa regolarità e un’evidente semplicità, che, a loro volta, garantiscono la bellezza e, nei limiti del possibile, l’ordine perfetto dell’universo, che, è bene ricordarlo, deve rispecchiare, secondo le intenzioni del demiurgo, l’assoluta bellezza e perfezione del modello intellegibile in base al quale esso è costituito. Per questo stesso motivo, il demiurgo attribuisce al corpo del mondo una forma sferica, completamente liscia all’esterno e priva di qualunque organo: non avendo bisogno di nulla, infatti, ed essendo pienamente autonomo, l’universo comprende in sé tutte le cose generate, nessuna di esse rimanendo al di fuori di lui, si nutre di se stesso, in virtù dei continui processi di generazione e di corruzione che coinvolgono le realtà che contiene al suo interno, e non ammette nessun vuoto, all’interno o all’esterno di sé, in quanto, per definizione, è tutte le cose. Tuttavia, per essere davvero perfetto, l’universo non può sussistere soltanto come un corpo, ma deve possedere anche un’anima che lo renda davvero un “vivente” completo. Ciò pone immediatamente, come i commentatori non hanno mancato di segnalare, il problema di capire perché l’universo debba essere concepito come un essere vivente dotato di anima e corpo, secondo uno stretto parallelismo con gli esseri umani e con i viventi individuali in genere. In prima battuta, si può pensare che, seguendo un ragionamento analogico che prende le mosse dall’esame del microcosmo che ogni essere vivente individuale dotato di anima e corpo costituisce, il Timeo sia portato a estendere un identico modello sul piano del macrocosmo che l’universo rappresenta. Su entrambi i piani, infatti, emergono una serie di caratteristiche ricorrenti (rispetto allo svolgimento di un ciclo vitale, rispetto all’insieme di mutamenti e di movimenti regolari che è possibile osservare e prevedere e così via) che sembrano presupporre l’intervento di un principio intelligente e ordinatore: se tale principio, nei viventi individuali, coincide con l’anima, sarà verosimile ammettere che, proiettando l’identico schema su ampia scala e applicandolo perciò all’intero universo, anche l’intero universo possieda un’anima e sia perciò un vivente, diverso dai viventi individuali solo rispetto alle sue dimensioni e alla sua complessità. D’altro canto, però, si può forse suggerire un’ipotesi più specifica, che dipende direttamente dalla stessa definizione delle funzioni proprie dell’anima del mondo, che, come vedremo fra breve, consistono essenzialmente nella produzione di movimento e di conoscenza. Ora, per quanto riguarda la conoscenza, è certo difficile pensare di attribuire all’universo, almeno a prima vista, una qualche capacità conoscitiva; ma che, invece, l’universo si muova, e che i suoi movimenti manifestino regolarità e ordine, appare a chiunque come un’indubitabile evidenza. E se non sussiste nessuna realtà ulteriore al di là dell’universo, che, ricordiamolo ancora, esaurisce la totalità di ciò che esiste sul piano sensibile, occorrerà credere che esso abbia in sé il principio del proprio movimento. Ma ciò che si muove di un movimento regolare e ha in sé il principio del proprio movimento deve necessariamente possedere, come principio del proprio movimento, un’anima ed essere dunque, in senso stretto, un “vivente”. Credo si possa insomma sostenere che la relazione fra movimento, vita e anima, termini che, non a caso, sono fra loro frequentemente accostati nei dialoghi platonici, appare talmente forte ed essenziale, da indurre Platone (e il pensiero greco in generale) a stabilire questa equivalenza: ciò che si muove vive, ma ciò che vive è dotato per necessità di un’anima; dunque, ciò che si muove possiede senza dubbio un’anima. E ancora, capovolgendo il ragionamento, ciò che è dotato di un’anima vive e la manifestazione prima della vita di ciò che è vivente consiste nel suo movimento. Volendo insistere su questa equivalenza, si può notare pure che alla triade “movimento-vita-anima” viene associata anche, come sua immediata implicazione, l’intelligenza, il che spiega probabilmente perché ciò che possiede un’anima, in questo caso l’universo, non solo viva e si muova, ma sia anche intelligente e dotato di una capacità conoscitiva.
Passiamo quindi a considerare la composizione, da parte del demiurgo, dell’anima del mondo. L’anima del mondo è costituita a partire da una mescolanza di essere, identico e diverso, le tre categorie fondamentali che devono necessariamente appartenere a ogni cosa esistente: ogni cosa esistente, infatti, per essere tale, deve “essere”, deve essere “identica” a se stessa e “diversa” da tutto ciò che è altro da essa. Non si tratta tuttavia delle idee dell’essere, dell’identico e del diverso, perché l’anima del mondo, pur non essendo certamente una realtà sensibile e corporea, non è neanche un’idea né si colloca interamente nell’intellegibile: essa adempie a una funzione intermedia, che è quella di mantenere nei limiti del possibile l’ordine che il demiurgo attribuisce al sensibile sulla base del modello intellegibile, e si situa perciò, costitutivamente, a metà strada fra l’intellegibile e il sensibile. Ecco perché l’essere, l’identico e il diverso di cui il demiurgo compone l’anima del mondo non sono elementi ideali né materiali, ma misti di entrambe le caratteristiche: in questo modo, solo negativamente, Timeo illustra la natura “intermedia” dell’anima del mondo e la sua collocazione “mediana” nella gerarchia del reale. Ma ancora una volta, come nel caso precedentemente esaminato del corpo del mondo, l’unione di essere, identico e diverso che il demiurgo mette in atto per dare forma all’anima del mondo non è affatto casuale, giacché segue una precisa disposizione matematica, stabilendo rigorose proporzioni numeriche per la combinazione dei tre elementi. Una volta realizzata così questa mescolanza, il demiurgo divide il materiale ottenuto in due strisce uguali, che prima sovrappone in forma di X, poi curva per far coincidere le estremità delle due strisce, ottenendo quindi due cerchi concentrici, l’uno inclinato rispetto all’altro come l’equatore rispetto all’eclittica, che si intersecano in due punti opposti: il primo, il cerchio dell’identico, ruota esternamente all’altro, il cerchio del diverso (34a-36b). Ciò introduce la questione ulteriore delle funzioni che competono all’anima del mondo così costituita: il demiurgo le attribuisce infatti, innanzitutto, una funzione motrice, da cui discende inoltre una funzione conoscitiva (36e-40d). Non è il caso di tornare nuovamente sullo statuto di essere “vivente” riconosciuto all’universo: si tenga presente, però, che è soltanto in una simile prospettiva che diviene in qualche modo comprensibile l’idea di dotare l’universo, o piuttosto la sua anima, di una capacità intellettuale e conoscitiva. Allo stesso modo, dunque, una singola ipotesi, quella dell’esistenza dell’anima del mondo, permette di spiegare due ordini di fenomeni: per un verso, in virtù dei movimenti circolari dei cerchi che la compongono, l’anima del mondo imprime e conserva il movimento regolare dei corpi celesti, ma anche il movimento dei corpi terrestri, che è un movimento irregolare che si può tuttavia, secondo il Timeo, ricondurre ai movimenti dell’anima del mondo, nella misura in cui, in gradi via via discendenti, la struttura geometrico-matematica che caratterizza l’anima del mondo corrisponde a quella che appartiene a tutte le entità, celesti e terrestri, dotate di anima e corpo; per altro verso, poiché la triade “anima-vita-movimento” finisce per implicare pure, come abbiamo visto sopra, l’intelletto e la conoscenza, alla capacità motrice dell’anima del mondo dovrà corrispondere una capacità conoscitiva: quando la sua conoscenza si realizza attraverso il movimento del cerchio dell’identico, l’anima del mondo conosce davvero gli oggetti intellegibili cui il cerchio dell’identico sempre si rivolge e con cui si trova in stretta relazione; quando, invece, si realizza attraverso il movimento del cerchio del diverso, l’anima del mondo opina soltanto, e percepisce, gli oggetti sensibili cui il cerchio del diverso sempre si rivolge e con cui si trova in stretta relazione. Controllando, in virtù di queste due sue funzioni fondamentali, l’ordine, il movimento e l’intelligenza del tutto, l’anima del mondo può realmente eseguire il suo compito fondamentale, cosmologico, etico e teleologico a un tempo, che è quello di assicurare la persistenza della bellezza e del buon funzionamento del tutto, assicurando al cosmo la perfetta condizione di un vivente eternamente felice.
Dall’esposizione del Timeo emerge infine un’immagine del cosmo concepito come un organismo vivente, perché dotato di anima e corpo, e assolutamente compiuto, in quanto esaurisce la totalità del reale comprendendo in sé tutte le specie viventi, animali e vegetali, e tutte le cose esistenti e riproducendo così, nella dimensione sensibile e vitale che gli è propria, l’assetto eterno e immutabile dei modelli intellegibili di cui è un’imitazione. Tale imitazione del modello assume inoltre i tratti di una disposizione geometrico-matematica, che conferisce all’universo un ordine, pur inferiore a quello intellegibile, almeno parzialmente stabile e comunque superiore al caos di un divenire perenne e inarrestabile. Così costruito, questo mondo, il nostro mondo unico e onnicomprensivo, appare pienamente autonomo e auto-referenziale ed è destinato a permanere per l’eternità, senza nessun intervento esterno, di carattere propriamente creativo o anche soltanto conservativo, senza chiamare in causa un disegno intelligente o provvidenziale che non sia semplicemente quello, oggettivamente ed eternamente dato, che dipende dai modelli eterni di cui esso appunto riproduce pur imperfettamente la disposizione. Si vede bene come, in relazione a ciascuna di queste pur generali conclusioni, che certo non ne restituiscono interamente la complessità, l’ampiezza e la ricchezza, il Timeo inauguri altrettante problematiche, tanto fondamentali quanto controverse, che attraversano la posteriore storia della filosofia e della scienza e fino all’età moderna.
Bibliografia essenziale
Edizioni
Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, t. IV, Oxford Univ. Press, Oxford 1902.
Traduzioni italiane
F. Fronterotta, Platone, Timeo, a cura F. Fronterotta, Milano, Rizzoli 20113.
Studi
A.E. Taylor, A commentary on Plato’s Timaeus, Clarendon Press, Oxford 1928.
M. Cornford, Plato’s cosmology. The Timaeus of Plato translated with a running commentary, Routledge & Kegan Paul, London 1937.
L. Brisson, Le même et l’autre dans la structure ontologique du Timée de Platon. Un commentaire systématique du Timée de Platon, Academia Verlag, Sankt Augustin 19942.
T. Calvo & L. Brisson (a cura di), Interpreting the Timaeus-Critias. Proceedings of the IV Symposium Platonicum, selected papers, Academia Verlag, Sankt Augustin 1997.