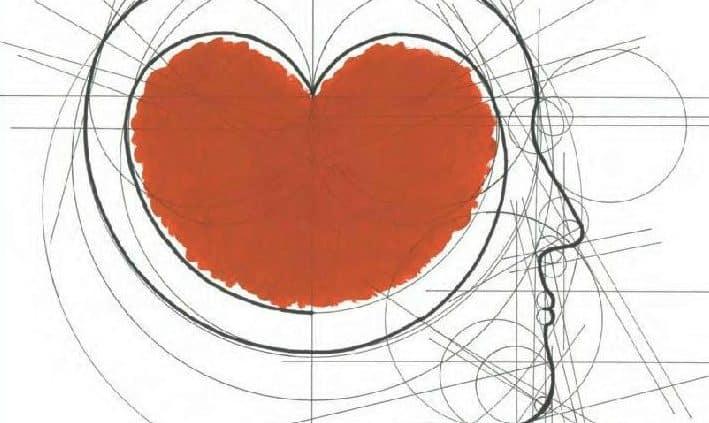Le lezioni di Giovanni Arrighi
di Giorgio Cesarale
“Introduzione” a Giovanni Arrighi, Capitalismo e (dis)ordine mondiale, a cura di Giorgio Cesarale e Mario Pianta, manifestolibri, Roma 2010, pp. 6-27
[drop_cap style=”2″ bgcolor=”#dddddd” color=”#787882″]N[/drop_cap]el dibattito sulla attuale crisi economica globale è diventato ormai quasi senso comune la critica all’incapacità della scienza economica dominante di indicare e interpretare adeguatamente le cause di questa crisi, e in particolare di uno dei suoi fenomeni più abbaglianti, e cioè il processo di finanziarizzazione. Che legami ha questo processo con ciò che, peraltro impropriamente, si chiama “economia reale”? Che nesso vi è fra questo processo e la vorticosa espansione economica di intere regioni del pianeta (il Sud-est asiatico delle quattro “tigri”, della Cina, del Vietnam ecc.)? Quale ruolo giocano in esso gli Stati, da quelli in ascesa a quelli in più evidente difficoltà? Sono domande cruciali, che obbligano a fornire una risposta alta e convincente. D’altro canto, per rispondere a queste domande è necessario collocare l’attuale crisi e la turbolenza globale che l’accompagna entro un orizzonte storico e geografico più largo. Uno “sguardo corto” sulla crisi è precisamente ciò che può impedire di comprenderla in tutta la sua complessità. E tuttavia è proprio da questo “sguardo corto” che la maggior parte degli osservatori e degli studiosi appare caratterizzata. Le eccezioni sono rare: tra queste c’è Giovanni Arrighi (1937-2009), una delle figure più rilevanti, insieme ad Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein e Terence Hopkins, dell’approccio “sistemico” allo studio della storia e della struttura del capitalismo globale, dei movimenti sociali anticapitalistici, delle disuguaglianze mondiali di reddito e dei processi di modernizzazione. Nel discorso di Arrighi l’attuale crisi e l’inarrestabile processo di finanziarizzazione che le si collega sono interpretati alla luce dell’intera traiettoria di sviluppo del capitalismo mondiale, dalle città-Stato italiane rinascimentali all’ascesa degli Stati uniti alla guida del sistema economico internazionale. In questa prospettiva, il processo di finanziarizzazione che segna la nostra epoca deve essere inteso sia come sintomo della decadenza dello Stato attualmente egemone a livello internazionale, gli Stati uniti, sia come condizione della riapertura, in un diverso contesto geografico, di un nuovo ciclo di espansione economica “materiale” (industriale e commerciale).
L’eccezionalità della figura di Arrighi, il quale, e non solo ai nostri occhi, appare come uno dei massimi studiosi dell’economia-mondo capitalistica della seconda metà del Novecento, ci fa ritenere che siano ormai giunti i tempi per avviare una riflessione a tutto tondo sulla sua opera. È un compito, questo, di cui anche altrove si è espressa l’importanza, e di cui urge preparare le condizioni di realizzazione. È anche a tale scopo che è stata concepita la presente iniziativa editoriale: essa infatti contiene materiali – dall’intervista autobiografica concessa quasi in punto di morte a David Harvey (uno dei più insigni teorici marxisti contemporanei, autore de La crisi della modernità e Breve storia del neoliberismo) ad alcuni dei più importanti, e ancora inediti in italiano, saggi di teoria sociale e di interpretazione storica scritti da Arrighi – che possono aiutare a ricostruire meglio il suo profilo intellettuale complessivo, il senso della sua operazione teorica.
Su questi scritti e sulle ragioni che ci hanno condotto a proporne la traduzione in italiano diremo qualcosa al termine dell’introduzione. In via preliminare, tuttavia, vorremmo provare a offrire al lettore il nostro punto di vista sia sull’itinerario intellettuale percorso da Arrighi sia sul significato della sua opera.
L’economia politica dell’Africa
In relazione ai “fatti” che hanno costellato la sua biografia vi è, in verità, poco o nulla da aggiungere a quanto è detto da Arrighi stesso nella intervista ad Harvey. Proveniente dai ranghi di una famiglia borghese antifascista, Arrighi compie gli studi universitari di economia alla Bocconi con l’intenzione di procurarsi le competenze necessarie a dirigere l’azienda del padre, nel frattempo deceduto. Ma, come capo d’azienda, Arrighi si accorge subito di non riuscire: decide perciò di cambiare ambiente di lavoro e di proseguire la carriera accademica, diventando assistente volontario. È un’occupazione, però, che non gli fornisce di che mantenersi: Arrighi è perciò costretto prima ad accettare un impiego come apprendista manager presso la multinazionale anglo-olandese Unilever e poi a candidarsi per un posto di docente di economia presso una sede distaccata in Rhodesia (l’odierno Zimbabwe) dell’Università di Londra. Sono gli anni in Africa della “decolonizzazione”, delle lotte di liberazione nazionale e della formazione di nuove entità statali autonome. Arrighi si fa da subito intellettualmente e anche politicamente partecipe di questa atmosfera: il suo primo e importante saggio, The Political Economy of Rhodesia (da noi tradotto poi con il titolo Struttura di classe e sovrastrutture in Rhodesia), è scritto proprio nel 1965, e cioè nell’anno in cui di solito si fa cadere la fine del processo di decolonizzazione.
Arrighi fin dal suo arrivo in Rhodesia non nutre illusioni sulla possibilità di trasformare il riscatto nazionale dei popoli africani in un riscatto economico e sociale: la struttura polarizzata del capitalismo mondiale, per la riproduzione della quale vi è la necessità da parte dei “centri” del sistema di drenare dividendi e profitti dagli investimenti compiuti nei paesi africani e di realizzarli in modo molto “selettivo” (tutti ad alta intensità di capitale e non indirizzati alla produzione di beni strumentali), è un serio ostacolo a un decollo, in particolare industriale, di questi paesi. La Rhodesia rappresenta peraltro, da questo punto di vista, una sorta di case study privilegiato: è infatti uno dei pochi paesi africani in cui sia esistita, per uno strano scherzo del destino – i sovrainvestimenti nel settore minerario, causati da un errore di valutazione, della British South Africa Company, e il tentativo, da parte di quest’ultima, di recuperarli stimolando uno sviluppo del paese e delle sue forze sociali –, una borghesia agraria nazionale in qualche modo interessata a puntare sulla crescita del paese. Non solo: è uno dei pochi paesi dell’Africa sub-sahariana ad aver ospitato un compiuto processo di proletarizzazione della propria forza-lavoro agricola, soprattutto a causa del crollo della produttività subito, tra gli anni Trenta e Sessanta, dai terreni posseduti dai produttori agricoli indipendenti. Esistendone le condizioni sociali (la presenza, da un lato, di una borghesia interessata all’allargamento della base produttiva e, dall’altro, di una riserva di forza lavoro disponibile a vendersi sul mercato), sembra offrirsi uno scenario ideale per una transizione compiuta al capitalismo; eppure tale transizione non si dà. E non si dà per ragioni che successivamente Arrighi chiamerà “sistemiche”: ciò che conta in ultima istanza è la struttura del capitalismo a livello mondiale, non la particolare configurazione produttiva e sociale all’interno di un determinato Stato-nazione. Se il sistema capitalistico mondiale poggia sulla costante riproduzione dell’asimmetria fra regioni forti e deboli del pianeta, provare a guidare un paese “arretrato” verso lo “sviluppo” è un’impresa senza possibilità di successo. A meno che, dice qui Arrighi ispirato da Samir Amin, non si lavori sulla déconnexion, sullo sganciamento, dai paesi capitalistici sviluppati, e si provveda a rompere con forza il cordone ombelicale che lega quest’ultimi ai paesi del Terzo mondo.
Si apre, con ciò, il versante più politico della riflessione di Arrighi sull’Africa tropicale; versante che trova la sua più ampia esplicitazione nei saggi scritti dopo che il governo allora in carica in Rhodesia lo espelle dal paese per attività sovversive, costringendolo a trovare riparo in Tanzania, all’università di Dar es Salaam. In questi saggi (L’offerta di lavoro in una prospettiva storica, Società multinazionali, aristocrazie del lavoro e sviluppo economico nell’Africa tropicale, Socialismo e sviluppo economico nell’Africa tropicale, Nazionalismo e rivoluzione nell’Africa sub-sahariana) e, in specie negli ultimi due, scritti con John Saul, Arrighi radicalizza la propria posizione, contestando i luoghi comuni del socialismo africano e del marxismo più volgare. Gli obiettivi critici sono, in particolare, due:
1) l’idea che occorra, per garantire lo “sviluppo”, “scendere a patti” con il grande capitale internazionale;
2) l’idea che non sia economicamente e politicamente produttivo intervenire sulla distribuzione del reddito di questi paesi, malgrado questa consegni nelle mani delle burocrazie statali e degli scaglioni medi e superiori dei lavoratori, anche formalmente proletarizzati, delle grandi imprese private una quota della ricchezza sociale nazionale assolutamente sproporzionata.
Su quest’ultimo punto, e sulla sua importanza anche negli sviluppi successivi del continente africano, Arrighi non ha peraltro mai smesso di insistere: nel suo ultimo, corposo, saggio sulle vicende africane, The African Crisis, apparso nel 2002 sulle pagine della “New Left Review”, la stessa involuzione autoritaria degli Stati africani, che li ha resi facile preda dei golpe militari, è fatta risalire alla tendenza delle burocrazie, pubbliche e private, di conservare a ogni costo i privilegi garantiti loro dalla esistente distribuzione del reddito.
Crisi ed egemonia nell’Italia degli anni Settanta
In Tanzania Arrighi rimane tre anni, dal 1966 al 1969, fino a quando non è richiamato in Italia a insegnare presso uno degli epicentri del movimento del ’68, la nuova Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. Qui il suo insegnamento riscuote un successo quasi immediato. Gli studenti del movimento, infatti, pur con qualche rilevante dissenso interno – che Arrighi nell’intervista ad Harvey rievoca in modo sapido – affluiscono copiosi alle sue lezioni, attratti dalla fama di studioso “terzomondista” e “radicale” che Arrighi si è fatto in virtù della pubblicazione, nell’estate del 1969 presso la casa editrice Einaudi, del suo primo libro, Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa, che raccoglie tutti i suoi saggi redatti nel periodo africano.
Il periodo italiano dura dal 1969 al 1979, ed è a sua volta suddiviso in due parti: nella prima, che va dal 1969 al 1973, l’azione di Arrighi si svolge sull’asse Milano-Torino, e cioè tra la sinistra extraparlamentare e, per dirla con Raniero Panzieri, le lotte operaie nello sviluppo capitalistico; nella seconda, invece, che va dal 1973 al 1979, Arrighi, trasferitosi a insegnare a Cosenza, all’Università della Calabria, abbandona di nuovo il terreno dello “sviluppo”, per reimmergersi nello studio dei processi di proletarizzazione degli immigrati, questa volta calabresi.
Nelle ricerche condotte nella fase calabrese Arrighi porta a nuova verifica il risultato cui era già giunto negli studi sul reclutamento della forza-lavoro in Rhodesia: la proletarizzazione, la creazione di grandi riserve di forza lavoro prive dell’accesso ai mezzi di produzione, non è, contro Marx e il marxismo, la conditio sine qua non dello sviluppo capitalistico. E non lo è perché, sia per i rhodesiani migrati dalla campagna alla città sia per i calabresi spostatisi in Nord Italia, la proletarizzazione coincide con la richiesta di alti salari, i quali abbassano il saggio di profitto – e quindi la convenienza a investire dei capitalisti – e procurano al proletario quelle risorse monetarie che possono aiutarlo a ritrasformarsi in soggetto economico indipendente. Come si può agevolmente constatare, Arrighi viene qui articolando una tesi che già lo colloca nei fatti dal lato della scuola sistemica di Wallerstein, Frank e Hopkins, che, come è noto, ha largamente insistito sulla non centralità del lavoro salariato per la nascita e la promozione dello sviluppo capitalistico. In forme diverse, è una tesi che emergerà anche dai suoi più recenti lavori sulla Cina, riassunti nel capitolo 5 di questo volume.
Sennonché, per quanto importante, a noi non pare che la fase calabrese aggiunga molto di più a quanto già maturato da Arrighi in Africa. Più determinante ci pare il corpo di esperienze teorico-pratiche acquisite da Arrighi a contatto con la fase ascendente del ciclo delle lotte operaie italiane degli anni Settanta, quella che va dall’autunno caldo del 1969 alla stagione contrattuale del 1973. In questa postazione, Arrighi avverte in presa diretta i primi effetti dello scatenarsi della crisi capitalistica mondiale nel quinquennio 1968-1973, dall’apparizione delle prime vampate inflazionistiche negli Stati uniti allo shock petrolifero, passando per la fine, sancita da Nixon nel 1971, della convertibilità fra dollaro e oro. E subito avverte l’importanza di questa crisi: come interpretarla? Che cosa ne sarà dell’ordine mondiale a egemonia statunitense stabilitosi dopo la fine della Seconda guerra mondiale? Che conseguenze avrà tutto ciò per i movimenti sociali anticapitalistici?
Al di là dei molteplici e apparentemente divergenti interessi tematici che Arrighi ha coltivato lungo il resto della sua vita, a noi pare che questo sia stato il fuoco principale della sua attività teorica dopo il 1973. Non a caso, uno dei testi più rilevanti di Arrighi negli anni Settanta è il saggio Verso una teoria della crisi capitalistica. In questo saggio, Arrighi comincia ad articolare una distinzione teorica cui terrà fede fino al suo ultimo libro, Adam Smith a Pechino, e cioè quella fra una crisi capitalistica causata dalla caduta del saggio di profitto e una crisi capitalistica causata dalla sovrapproduzione, dall’assenza di domanda di merci. Entrambe sono determinate dal livello di remunerazione della forza-lavoro salariata: solo che in un caso, il primo, la crisi è determinata dall’alto livello di remunerazione (e di potere in fabbrica) del lavoro salariato, che diminuisce la quota dei profitti disponibili ai capitalisti; nell’altro, il secondo, la crisi è determinata dal basso livello di remunerazione (e di potere in fabbrica) del lavoro salariato, che, poiché sul mercato ha poco da spendere, lascia invenduto un grande quantitativo di merci. Arrighi era – e lo è in parte rimasto fino alla fine – dell’idea che la crisi mondiale scatenatasi negli anni Settanta fosse del primo tipo, in virtù dell’elevato potere contrattuale e politico conquistato nella golden age dalle organizzazioni sindacali e politiche della classe operaia. Questo provvedeva, contro il parere a riguardo di buona parte della sinistra marxista e non, a differenziare la crisi degli anni Settanta da quella degli anni Trenta, che era stata, invece, una crisi del secondo tipo, una crisi da sovrapproduzione.
Pur non priva di interesse e di un certo grado di utilità euristica, questa distinzione non ci sembra tuttavia “tenere”: tutto il peso, nella eziologia delle crisi capitalistiche, è fatto ricadere sulla forza, contrattuale e politica, della classe operaia, dimenticando il nesso, altrettanto fondamentale nella genesi delle crisi capitalistiche, fra le rivoluzioni tecnologiche e la crescita delle pressioni competitive. Insomma, senza considerazione della crescita del quoziente tecnologico della produzione e della concorrenza, un adeguato schema interpretativo della crisi non è articolabile. Arrighi di questo in qualche modo si è venuto progressivamente rendendo conto, tant’è che sia in Lungo XX secolo, il suo opus magnum, sia in Adam Smith a Pechino, è venuto rettificando il suo schema iniziale di interpretazione dell’origine della crisi degli anni Settanta, facendo adeguato spazio alla questione della intensificazione, negli anni immediatamente precedenti al suo scoppio, della concorrenza intercapitalistica.
V’è da dire, peraltro, che la fedeltà all’idea che fosse stato l’elevato tasso di conflittualità operaia a determinare lo scoppio della crisi non ha sempre reso ad Arrighi un buon servizio in termini analitici: fino ad anni ’80 inoltrati, infatti, Arrighi ha ritenuto irrevocabile la forza conquistata dalla classe operaia nei paesi del centro, con la conseguenza di sottovalutare, forse più del dovuto, gli effetti sociali della rivoluzione monetarista e neoliberale di Reagan e della Thatcher.
In ogni caso, anche se per altri motivi, lo schema elaborato con Verso una teoria della crisi capitalistica comincia ad apparirgli non pienamente soddisfacente già a metà degli anni Settanta, allorché inizia la redazione di Geometria dell’imperialismo. Ciò che in quello schema non trovava posto erano essenzialmente due punti:
1) lo sviluppo ineguale del capitalismo a livello mondiale;
2) la composizione etnica e culturale della forza-lavoro a livello mondiale.
Sono due punti caratteristicamente “leniniani”, due pilastri della teoria leniniana dell’imperialismo. Ma ad Arrighi la teoria leniniana dell’imperialismo, contrariamente a gran parte della sinistra rivoluzionaria del tempo, appariva, ed è sempre più apparsa dopo, largamente inservibile. A renderla tale era stato lo sviluppo dei rapporti economici e politici dopo la Seconda guerra mondiale: la fase della acuta conflittualità interimperialistica, quella nella quale Lenin aveva forgiato la sua teoria, era terminata e al suo posto era subentrato l’impero informale statunitense, la “pacifica” ricostruzione dell’ordine del mercato mondiale sotto l’egida delle agenzie economiche e politiche internazionali a guida statunitense (Onu, Fmi, Banca mondiale ecc.). La categoria di “imperialismo” era quindi diventata senza referente oggettivo. Per dissiparne fino in fondo l’indeterminatezza, Arrighi in Geometria dell’imperialismo allestisce una raffinata analisi, basata su una matrice teorica ricavata da Imperialism di Hobson: vi sono quattro diversi tipi di relazioni interstatali in epoca moderna (colonialismo, impero formale, impero informale, imperialismo), e l’errore di Lenin è stato di pensare che l’imperialismo segnasse, all’interno del sistema capitalistico, la fase “suprema” di sviluppo delle relazioni interstatali.
Si tratta di un punto cui Arrighi non rinuncerà più, e che anzi troverà ulteriore esplicitazione nella sua più matura teoria sistemica. Certo, una critica della categoria leniniana di “imperialismo” che fa a meno di indagare quello che a noi appare come il suo nocciolo teorico (l’imperialismo come fase contrassegnata dal dominio del capitale finanziario inteso come unità di capitale bancario e industriale) non si può dire propriamente riuscita. Se si vuole, questa è la spia di un problema che, in qualche modo, Arrighi si è, fin da allora, trascinato dietro. Il problema è il seguente: Arrighi diventerà in seguito famoso come uno dei più acuti teorici della centralità, entro l’assetto capitalistico contemporaneo, del processo di finanziarizzazione. E tuttavia, come hanno notato eminenti critici (Peter Gowan, Robert Pollin, Richard Walker), non è mai chiaro in Arrighi che cosa la categoria di “finanza” celi dentro di sé. Le operazioni finanziarie saranno sempre analizzate a un grado troppo alto di generalità teorica, non saranno mai indagate nella loro concretezza. Il sospetto che questi critici hanno avanzato è che l’incapacità di Arrighi di svolgere una analisi concreta della finanza nasconda una fondamentale indeterminatezza concettuale, analoga a quella da egli rimproverata all’imperialismo leniniano.
Comunque sia, ad Arrighi va riconosciuto il merito di aver colto fin dall’inizio, e di averlo ribadito anche in seguito, che l’aprirsi della crisi capitalistica mondiale non avrebbe coinciso con il riaccendersi di rivalità di tipo “mercantilistico” e con la ripresa di politiche protezionistiche. Come è soprattutto argomentato in un saggio di grande densità teorica, Una crisi di egemonia, a impedire la resurrezione di queste rivalità e di queste politiche erano, in particolare, due caratteristiche apparse nell’ordine economico mondiale soprattutto a muovere dalla fine della Seconda guerra mondiale:
1) il prevalere dell’investimento diretto all’estero sul “semplice” commercio internazionale;
2) una competizione oligopolistica giocata non sui prezzi ma sulla innovazione di prodotto.
Entrambe queste caratteristiche hanno a che fare con il nuovo tipo di impresa insediatosi sulla scena economica mondiale nel Novecento: la multinazionale o transnazionale, integrata verticalmente e governata tramite una robusta burocrazia manageriale. Ora, dice Arrighi riferendosi alla prima caratteristica, elevare barriere all’investimento diretto all’estero di questo tipo di impresa o potrebbe risultare inutile – estendendosi queste imprese non attraverso transazioni, ma attraverso apertura di filiali nei paesi in cui si effettua l’investimento – o potrebbe essere controproducente, perché impedirebbe, suscitando reazioni omologhe nei paesi concorrenti, alle imprese transnazionali del paese “mercantilista” o “protezionista” di compiere le medesime operazioni di espansione. La competizione, invece, giocata non sui “prezzi” ma sulle innovazioni di “prodotto” impedisce, più semplicemente, che si scatenino “guerre di prezzo”, capaci di minacciare seriamente per ciascuna impresa transnazionale il livello dato di domanda delle merci.
La vera posta in gioco della crisi degli anni Settanta – e con ciò ci siamo approssimati a uno dei punti più qualificanti del discorso di Arrighi – era costituita dalla capacità degli Stati uniti di continuare a fungere da regolatore del mercato mondiale. Questa capacità, dice Arrighi a cavallo fra anni Settanta e anni Ottanta, era stata definitivamente mandata in frantumi. Gli Stati uniti, infatti, soprattutto dopo aver sancito nel 1971 la fine della convertibilità fra dollaro e oro, avevano rinunciato a rappresentare gli interessi generali della intera classe capitalistica mondiale, per badare solo alla crescita delle attività capitalistiche localizzate entro i propri confini. Gli Stati uniti avevano smesso, cioè, di essere gramscianamente “egemonici”, abbandonando il mercato mondiale all’instabilità e all’anarchia. Oggi è diventato abbastanza comune, anche presso gli studiosi di relazioni internazionali, fare ricorso, per indagare le dinamiche di potere mondiali, alla categoria gramsciana di “egemonia”. Ma non bisognerebbe dimenticare di rendere merito a coloro, e Arrighi è fra questi, che per primi hanno reso ciò possibile, esplorando le potenzialità in termini di interpretazione delle relazioni internazionali contenute nel concetto gramsciano di “egemonia”.
In un certo senso, il saggio Una crisi di egemonia si colloca teoricamente – pur essendo stato pubblicato qualche anno più tardi della sua conclusione – al margine estremo del periodo italiano. Questo perché ci pare che qui Arrighi tenda a ragionare sulla crisi degli anni Settanta in termini più strettamente marxisti di quanto farà in seguito. L’idea che soggiace al saggio è ancora, infatti, quella tipica di molte delle interpretazioni marxiste della crisi: dopo un trentennio di matrimonio felice fra Stato e capitale, quest’ultimo, per fuoriuscire dalla crisi di redditività che lo investe a partire dagli inizi degli anni Settanta, avrebbe rotto questo matrimonio, e le regole scritte e non scritte che lo avevano suggellato. Il capitale, cioè, per dare piena soddisfazione ai suoi impulsi accumulativi avrebbe riguadagnato completa libertà d’azione, soprattutto rispetto ai vincoli imposti dai compromessi sociali e politici stipulati nella fase precedente, quella del boom.
L’incontro con la scuola sistemica
Nel 1979, con il suo trasferimento a Binghamton, alla State University di New York e al Fernand Braudel Center, si apre il periodo americano di Arrighi, che è durato fino alla morte nel 2009. Questo periodo coincide con una più piena inscrizione della sua operazione concettuale sotto le insegne della teoria sistemica di Wallerstein, Frank e Hopkins e con una riformulazione dello schema di interpretazione della crisi fino ad allora adottato. In realtà, come abbiamo già anticipato, i legami di Arrighi con i sistemici sono stati profondi fin dagli inizi: Wallerstein e Frank sono citati con molto favore per le loro tesi avverse allo “sviluppo” e alla “modernizzazione” fin da Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa. Per ricapitolare, quattro ci paiono anzitutto gli elementi sistemici dell’Arrighi del periodo africano e italiano:
1) la superiorità di un approccio analitico che indaghi il capitalismo su scala mondiale e non su scala nazionale;
2) l’articolazione gerarchica del sistema capitalistico mondiale, la sua divisione in zone centrali e periferiche;
3) la disgiungibilità di proletariato e capitalismo;
4) l’importanza dei gruppi di status (le identità di razza, nazione e genere) nella composizione sociale e politica della forza-lavoro mondiale.
Sennonché, malgrado l’ispirazione sistemica abbia avvolto Arrighi fin dagli inizi, non si deve sottovalutare l’impatto avuto sul suo pensiero dal trasferimento negli Stati uniti e dal rafforzamento della sua collaborazione con i principali esponenti della scuola sistemica. A noi, in particolare, pare che i sistemici siano stati decisivi nello sviluppo intellettuale di Arrighi soprattutto per averlo indirizzato verso l’apprezzamento della centralità dell’insegnamento di Fernand Braudel per la comprensione del capitalismo moderno. Fino agli ultimi scritti del periodo italiano, Braudel è pressoché assente; la sua figura comincia appunto a stagliarsi con nettezza dopo l’apertura della collaborazione con i sistemici.
Braudel rappresenta per Arrighi un punto di svolta perché gli fornisce le basi per comprendere il nesso fra capitalismo e ciò che Polanyi ha chiamato haute finance. Dicevamo in precedenza che nell’indagine sulla categoria di ‘imperialismo” Arrighi aveva mancato il terreno del capitalismo finanziario. L’esclusione, o poco più avanti la sottovalutazione, nella considerazione analitica di questa categoria del ruolo giocato nella sua elaborazione da Hilferding ne erano state manifestazioni eloquenti. Eppure, fin dagli anni Settanta Arrighi non aveva trascurato di osservare la crescente propensione del capitale a effettuare, per sfuggire alla compressione dei profitti sul terreno produttivo, investimenti di tipo finanziario. La tendenza si era poi rafforzata decisamente a partire dal ’79, con il repentino e vertiginoso rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve a guida Volcker, con la nuova politica economica di Reagan e la crisi messicana del debito nel 1982. Come interpretare, però, questo revival della finanziarizzazione, posto che la posizione leniniana, che fa della finanziarizzazione lo stadio “supremo” del capitalismo, era per Arrighi ormai irrimediabilmente compromessa?
È qui che sopraggiunge Braudel: questi infatti aveva osservato in Civiltà materiale, economia e capitalismo, che, da un lato, la finanziarizzazione è una caratteristica ricorrente dello sviluppo capitalistico fin dal XVI secolo , e che, dall’altro lato, quando questa finanziarizzazione si dà, essa è sintomo dell’“autunno”, della decadenza, di un certo ciclo egemonico. Di colpo, ad Arrighi venivano offerti i mezzi per interpretare il nesso fra crisi e finanziarizzazione, emerso negli anni Settanta, fuori dallo schema leniniano: tale nesso poteva ora essere interpretato su uno sfondo storico più largo e complesso, quello costituito dal capitalismo nella sua intera traiettoria di sviluppo, e, soprattutto, poteva ora essere compreso come indice dell’obsolescenza di una egemonia. L’esplosione negli anni ’80 della finanziarizzazione all’interno della cittadella capitalistica statunitense era perciò sintomo dell’avanzamento del processo di decadenza di quest’ultima, anziché, come argomentato da più parti, della sua rinascita.
Con ciò, anche i legami di Arrighi con la scuola sistemica diventano più intimi. Arrighi accetta ora dei sistemici le seguenti tesi:
1) il capitalismo è un modo di accumulazione di ricchezza e non, come in Marx, un modo di produzione;
2) come tale, il capitalismo ha una storia più lunga di quella tradizionalmente assegnatagli dai marxisti. Non nasce nel XVIII secolo, con la “rivoluzione industriale”, ma alla fine del Medioevo;
3) in questa storia, il capitalismo è stato contrassegnato dal succedersi di diversi cicli egemonici, ovvero dalla nascita, dallo sviluppo e dal tramonto di diverse egemonie.
4) queste egemonie si esercitano sull’insieme, gerarchicamente articolato, dell’economia-mondo capitalistica, e cioè su quella combinazione funzionale, tipica della modernità, fra unità del mercato mondiale, divisione internazionale del lavoro e sistema interstatale.
5) i soggetti egemonici sono nell’economia-mondo capitalistica gli Stati, i quali esercitano una leadership sia sul sistema-mondo nel suo complesso, regolandolo e ordinandolo a loro immagine e somiglianza, sia sugli altri singoli Stati.
Nella versione di Arrighi, consegnata soprattutto al Lungo XX secolo, i cicli egemonici sono quattro:
1) il ciclo genovese-iberico, dal XV secolo agli inizi del XVII;
2) il ciclo olandese, dalla fine del XVI secolo alla metà del XVIII;
3) il ciclo britannico, dalla seconda metà del XVIII secolo agli inizi del XX;
4) il ciclo statunitense, dalla fine del XIX secolo fino ad oggi.
Egemonia e ciclo sistemico di accumulazione
Ma che cosa regola il ritmo vitale delle egemonie, la loro ascensione e poi il loro tramonto? È qui che Arrighi introduce la sua idea forse più originale – che gli garantisce un posto di assoluta preminenza entro la scuola sistemica contemporanea – e cioè quella di “ciclo sistemico di accumulazione”. Wallerstein aveva detto che uno Stato era da considerarsi in posizione egemonica all’interno dell’economia-mondo capitalistica quando le imprese che in esso risiedono operano in modo più efficiente delle altre in tutte e tre le “maggiori arene economiche – produzione agro-industriale, commercio, e finanza. Il margine di efficienza di cui parliamo deve essere così grande da consentire a queste imprese di mettere fuori gioco le imprese che risiedono in altre grandi potenze, non solo nel mercato mondiale in generale, ma anche in particolar modo all’interno dei mercati interni delle stesse potenze rivali”. Arrighi fa un passo innanzi: tenta di descrivere la logica interna di ogni ciclo egemonico. E questa logica è rinvenuta nella marxiana formula generale del capitale (D-M-D’), nell’accrescimento di valore (D’) del capitale originario anticipato (D) tramite l’acquisto e poi il consumo produttivo di M, dei fattori produttivi soggettivi (il lavoro) e oggettivi (le macchine). Solo che, mentre in Marx D-M-D’ descrive lo schema generale di ogni singolo investimento capitalistico, in Arrighi descrive lo schema di sviluppo di ogni blocco egemonico: questo si afferma prima attraverso una fase di espansione materiale, di crescita delle sue operazioni industriali e commerciali – fase rappresentata dal primo segmento del ciclo, da D-M – e poi, esauritesi, a causa della crescita dei salari e della concorrenza intercapitalistica, le opportunità di investimento redditizio nella sfera materiale dell’attività economica, attraverso una fase di espansione finanziaria – rappresentata dal secondo segmento del ciclo, da M-D’. La fase di espansione finanziaria è, tuttavia, in quanto chiusura dell’intero ciclo, il momento dell’“autunno” del blocco egemonico in questione. Gli succederà un nuovo blocco egemonico, che compirà il medesimo percorso.
In Arrighi è cruciale lo sguardo sui meccanismi che regolano i rapporti fra lo Stato egemonico in declino con quello in ascesa. Anche qui è Marx a fornire la giusta chiave teorica: attraverso il sistema del debito e del credito internazionale, dice Marx nel Capitale, si trasferisce capitale da un paese, in declino, che ne ha in sovrappiù a uno, in ascesa, che ne ha bisogno per avviare la sua espansione produttiva. Nella storia dell’accumulazione originaria moderna, tutti i centri capitalistici già affermati (Venezia, Olanda, Inghilterra) si sono comportati in questo modo nei confronti dei centri capitalistici emergenti (Olanda, Inghilterra, Stati uniti). Sennonché per Arrighi l’idea di Marx diventa pienamente fruibile scientificamente solo quando la si sottragga al contesto in cui è fissata, quello costituito dal discorso sull’accumulazione originaria. Questa tipologia di trasferimento di ricchezza ha infatti interessato tutte le transizioni egemoniche, e non solo quelle collocate agli albori del capitalismo. Tutte, tranne una, l’ultima, quella che, a giudizio di Arrighi, noi staremmo vivendo: la transizione dall’egemonia americana a qualcosa d’altro, di cui ancora non è possibile individuare compiutamente il profilo. In quest’ultimo caso, infatti, è l’egemonia declinante che, anziché investire all’estero, si fa prestare capitali da tutto il mondo.
Le ragioni per cui ciò sta accadendo costituiscono in particolare il tema delle ultime fatiche teoriche di Arrighi, Caos e governo del mondo (pubblicato in collaborazione con Beverly J. Silver) e Adam Smith a Pechino, e sono ben sintetizzate nel capitolo 4 di questo volume. La risposta di Arrighi si concentra sul divorzio che, nell’ultimo ciclo egemonico, si sarebbe verificato fra capacità militari e capacità finanziarie: il possesso di un ineguagliabile arsenale militare garantirebbe agli Stati uniti la possibilità di esercitare una continua pressione sulle potenze emergenti, per sottrarre loro risorse finanziarie.
Le transizioni egemoniche non sono però processi fluidi e uniformi. In genere, sono accompagnate dall’esplosione dell’anarchia nei rapporti interstatali e dell’instabilità nei rapporti economico-sociali interni e internazionali, in breve da ciò che Arrighi chiama “caos sistemico”. Le potenze emergenti si dimostrano così davvero capaci di assumere entro di sé funzioni egemoniche solo se, oltre a essere in grado di assorbire i capitali in eccesso della potenza egemonica declinante, si mostrano anche in grado di domare il caos sistemico. Per farlo, i paesi emergenti devono essere rispetto alla potenza in declino:
1) più larghi e diversificati geograficamente;
2) più efficienti economicamente e organizzativamente;
3) più capaci di governare, tramite appropriate agenzie, mercato mondiale e sistema interstatale;
4) più inclusivi socialmente all’interno;
5) più capaci di rappresentare gli interessi sociali generali presenti nel sistema-mondo, da quelli più direttamente borghesi a quelli delle forze organizzate del lavoro subalterno.
Sono punti che pur investendo tutti i processi di transizione egemonica, vengono meglio esemplificati dall’ultima delle transizioni verificatesi, quella dalla Gran Bretagna agli Stati uniti. In questo caso, gli Stati uniti hanno offerto al processo accumulativo:
1) un territorio, uno spatial fix per dirla con Harvey, più vasto e vario, senza perdere il carattere insulare di quello inglese;
2) un modello di impresa, la multinazionale, più profittevole economicamente e più efficiente organizzativamente della manifattura inglese;
3) un quadro di agenzie di regolazione del mercato e del sistema interstatale più complesso e stratificato (dall’Fmi all’Onu) di quello inglese, basato su gold standard e concerto europeo;
4) un patto sociale, il New Deal, più aperto di quello inglese alla soddisfazione degli interessi dei lavoratori;
5) un New Deal globale, non fondato sul colonialismo e sulla conservazione degli equilibri dati fra i diversi paesi capitalistici, ma capace di elevare il livello di ricchezza di tutte le classi capitalistiche e di porzioni significative del proletariato mondiale.
Al caos sistemico che accompagna le transizioni egemoniche succede quindi una riorganizzazione sistemica, che è storicamente ogni volta diversa per ciascuna transizione egemonica. Nel caso del passaggio egemonico fra Gran Bretagna e Stati uniti vi è, per esempio, una differenza storica relativa al rapporto fra egemonia e classi subalterne. Gli Stati uniti hanno pacificato le loro relazioni sociali interne prima della loro ascesa egemonica; la Gran Bretagna dopo.
La logica sistemica che soggiace alla sequenza che va dalle città-Stato italiane agli Stati uniti non è priva di una sua necessità: alla crescita delle sfide ambientali, alla crescente difficoltà di ripristinare ogni volta le migliori condizioni possibili del processo di accumulazione, si deve rispondere, da parte delle potenze egemoniche in ascesa, mobilitando più risorse (territoriali, organizzative ecc.) e maggiori capacità di governo e di regolazione. A essere modificata da questa logica è la stessa visione del capitalismo, ormai costretto a muoversi entro un fitto reticolo di determinazioni geografiche e storiche.
I movimenti antisistemici
Il capitale in cerca di accumulazione e gli Stati alla ricerca del potere non sono tuttavia gli unici protagonisti sulla scena mondiale. Lo sviluppo del capitale crea i propri antagonisti, un movimento operaio che dalla “rivoluzione mondiale” del 1848 si è dato strutture organizzative stabili – sindacati e partiti, sia nella variante socialdemocratica sia nella variante comunista. Analogamente, la gerarchia del sistema-mondo crea i propri antagonisti nei movimenti di liberazione nazionale e nelle forme di resistenza al dominio della potenza egemonica – gli imperi coloniali europei prima, la superpotenza americana poi. Entrambe queste risposte antisistemiche, come si sostiene nel libro Antisystemic movements, si sono sviluppate soprattutto entro un orizzonte nazionale con l’obiettivo di conquistare il potere dello Stato.
Questo ha portato a una istituzionalizzazione e burocratizzazione dei movimenti antisistemici – sia nel caso delle socialdemocrazie occidentali, sia nei paesi del “socialismo reale” e di quelli del Terzo mondo dopo la decolonizzazione – che li ha allontanati dalle richieste della loro base sociale, integrandole nell’ordine internazionale definito dall’egemonia degli Stati uniti.
La protesta contro quest’ordine sociale e mondiale è venuta con la “rivoluzione mondiale” del 1968, destinata ad alimentare ondate successive di mobilitazioni sociali che hanno avuto per protagonisti soggetti diversi – le categorie più deboli dei lavoratori salariati e gruppi di status individuati sulla base di identità e condizioni sociali eterogenee, dagli studenti alle donne, dalle minoranze etniche e religiose agli immigrati ecc. Il loro obiettivo non è più la presa del potere statale o la costruzione di stabili organizzazioni politiche, ma, da un lato, la soddisfazione di immediate rivendicazioni “locali” per migliorare le condizioni di vita e di lavoro e, dall’altro lato, la costruzione di campagne su temi globali che aprono la via a legami internazionali tra i movimenti. In questo modo, la sfida che i movimenti pongono al potere del capitale e degli Stati è destinata ad influenzare l’evoluzione del sistema mondiale, indirizzandone il cambiamento.
L’ultima grande crisi e l’ascesa della Cina
Allorché abbiamo parlato del passaggio di Arrighi dal periodo italiano a quello americano, dicevamo che il suo schema di interpretazione della crisi cambia. La redazione di Lungo XX secolo a questo avrebbe dovuto servire, a rendere, vale a dire, più chiara la sua nuova lettura della crisi apertasi negli anni Settanta. La sproporzione quantitativa esistente nel libro fra le parti dedicate alla descrizione dei quattro cicli egemonici del capitalismo storico e le parti più determinatamente indirizzate ad affrontare il nuovo scenario dischiusosi con la crisi dell’egemonia statunitense non deve ingannare: l’obiettivo rimane quello di offrire una analisi della crisi più credibile di quelle disponibili nel panorama intellettuale odierno (dalle letture regolazioniste a quelle basate sulla decisività del passaggio dal “capitalismo organizzato” al “capitalismo flessibile”). In parte, è già evidente, dopo quanto abbiamo detto in precedenza, dove Arrighi è intervenuto per modificare il suo schema originario di interpretazione: l’ultima crisi, con il suo inevitabile corollario costituito dal processo di finanziarizzazione, non è che la riproduzione, per limitarci alla penultima transizione egemonica, della Grande depressione del 1873-1896 che colpì l’egemonia britannica. E tuttavia, le cose sono ancora più complesse: nel precedente schema veniva adombrata l’idea, dicevamo più marxista, di una liberazione del capitale dai vincoli che gli Stati, in virtù del “patto socialdemocratico” stipulato nell’immediato secondo dopoguerra, gli avevano imposto. Era una posizione, per alcuni versi, anche più vicina a quella che si è venuta consolidando successivamente in alcune aree del dibattito sulla cosiddetta “globalizzazione”. Ma Arrighi soprattutto a partire da Lungo XX secolo respinge fermamente questa posizione: a suo giudizio parlare di “egemonia dei mercati globali” o di “neoliberismo” senza ulteriore specificazione non ha senso alcuno. Perché questo ri-orientamento teorico?
A nostro giudizio la risposta, o almeno parte di essa, sta di nuovo in Braudel (ripreso su questo punto anche dagli altri sistemici): questi differenzia nettamente fra mercato e capitalismo sulla base della presenza o meno della concorrenza. Il mercato, poiché è attraversato dalla concorrenza, è il luogo dei bassi profitti, mentre il capitalismo, poiché è popolato dai monopoli, è il luogo degli alti profitti. I capitalisti naturalmente, visto che sono marxianamente pervasi dal demone dell’accumulazione, preferiscono installarsi sul terreno capitalistico piuttosto che su quello del mercato. Ma come vi riescono? Vi riescono stabilendo una relazione simbiotica con il potere dello Stato, facendosi promuovere da esso. Ai piani alti del capitalismo, cioè, capitale e Stato sono inestricabilmente connessi. Ma ai piani alti vi è anche, e diremmo soprattutto, la haute finance. La simbiosi è quindi soprattutto fra capitale finanziario e Stato.
Per stabilire questa connessione organica fra capitale e Stato, Arrighi ricorre anche a un altro argomento, tratto da Weber: per avviare i processi di espansione materiale e poi, ancora di più, quelli di espansione finanziaria, occorre vincere la concorrenza per attrarre a sé il capitale mobile, la liquidità che fluisce a livello mondiale. Ma questa concorrenza è di solito attuata e vinta solo dagli Stati, anzi da Stati che dispongano di una sufficiente concentrazione di potenza. Anche a questo livello, quindi, pensare il capitale senza lo Stato non è per Arrighi teoricamente possibile.
Da tutto ciò scaturiscono due conseguenze, una più particolare e l’altra più generale. La più particolare è relativa alla crisi apertasi negli anni Settanta: questa non può essere collegata all’“egemonia dei mercati globali” o al neoliberismo, perché finanziarizzazione e industrializzazione di nuovi paesi (dalle quattro “tigri” asiatiche alla Cina) sono concepibili solo sulla base di una intensa e prolungata attività statale. La più generale è relativa, invece, al “ciclo sistemico di accumulazione”: poiché l’espansione, materiale e finanziaria, del capitalismo è inscindibilmente legata allo Stato, a ricoprire il ruolo di soggetto del ciclo è un blocco organico e articolato di agenzie governative e imprenditoriali. Su questo punto, sul necessario impasto di capitale e Stato che governa i cicli di accumulazione, la distanza da Marx e dal marxismo – anche da un marxismo, per altri versi, molto vicino alle sue posizioni, come quello di Harvey – ci sembra molto ampia.
Tutto ciò il lettore può trovarlo più ampiamente svolto in quello che ci sembra il libro migliore di Arrighi, il già menzionato Lungo XX secolo (“lungo”, come il XVI secolo in Braudel e Wallerstein, proprio perché cominciato con la Grande depressione del 1873-1896 e, in fondo, non ancora terminato) e anche nel capitolo 4 di questo volume. Rimane da fare, all’interno del nostro viaggio interpretativo, un’ultima fermata, quella relativa ad Adam Smith a Pechino. Qui, dentro uno scenario teorico in cui rifluiscono molti dei temi già trattati nei libri precedenti (l’interpretazione, in un dibattito serrato e appassionante con Robert Brenner, della crisi apertasi negli anni Settanta, il ciclo sistemico di accumulazione, il rapporto fra logica territoriale e statuale e logica capitalistica), appare un nuovo asse problematico: l’interpretazione di ciò che Kenneth Pomeranz ha chiamato la “grande divergenza”, la divaricazione, dopo la fine del XVIII secolo, dei sentieri di sviluppo fra Occidente e Cina. È una divaricazione, allo stesso tempo, fra Marx e Smith, fra uno sviluppo capitalistico trainato dai massicci investimenti labour-saving e dalle trasformazioni tecnologiche e uno sviluppo di mercato trainato da una rivoluzione industriosa ad alta intensità di lavoro, fra un percorso “innaturale” di crescita economica, che comincia dal commercio, passa per l’industria e finisce con l’agricoltura, e un percorso “naturale”, che comincia dall’agricoltura, passa per l’industria e termina con il commercio. Questa divaricazione ha permesso all’Occidente, prima, di recuperare il gap di ricchezza e benessere che ancora lo divideva dalla Cina nel secolo XVIII secolo, e, poi, di superarla, anche grazie alla superiorità militare garantita dallo sviluppo tecnologico accelerato. Ma l’epoca della “grande divergenza” è ormai finita: il Partito comunista cinese, quasi ispirandosi alle raccomandazioni di Adam Smith (donde il titolo del libro), ha sapientemente puntato su un efficace mix di “buona” concorrenza intercapitalistica, promozione della divisione sociale e non tecnica del lavoro, investimento nelle tecnologie capital-saving, valorizzazione di nuovi modelli di impresa (le cosiddette “imprese di municipalità e di villaggio”), governo “centralizzato” degli strumenti creditizi e monetari, che ormai quasi consente alla Cina di attestarsi sui livelli di ricchezza occidentali. Chiusa la “grande divergenza” che cosa ne seguirà? Un caos sistemico generalizzato, una nuova transizione egemonica, con la Cina a prendere il posto degli Stati uniti, o la realizzazione dell’“utopia” smithiana, un riequilibrio, cementato dal mercato, di potere e ricchezza fra tutte le aree in cui il mondo è diviso? La risposta è per Arrighi aperta, e affidata al libero corso degli avvenimenti.
Uno dei meriti più duraturi di Arrighi, e della scuola sistemica nel suo complesso, è quello di aver scompaginato le frontiere disciplinari che si sono fissate nelle scienze storico-sociali: la divisione fra scienze nomotetiche (sociologia, economia) e idiografiche (storia) non ha alcun fondamento. Peraltro, Arrighi questo lo ha affermato fin da Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa, dove si protesta energicamente contro la tendenza dell’economia neoclassica a separare rigidamente il “fatto” economico dalla storia e dalla società. Il capitalismo è un oggetto complesso, per comprendere il quale occorre guadagnare profondità storica, affinare lo sguardo sociologico e saper utilizzare il metro geografico. È anche da qui che derivano gli altri meriti della ricerca di Arrighi: l’aver indagato le dinamiche globali prima della globalizzazione, l’aver capito la centralità del processo di finanziarizzazione, l’aver intuito l’importanza del nesso fra capitale e potere statale dentro i cicli mondiali di accumulazione. E tuttavia non sono pochi neanche i punti in cui Arrighi pare non riuscire pienamente convincente: la sottovalutazione, che tocca il suo picco proprio in Adam Smith a Pechino, della “rivoluzione industriale”, l’indeterminatezza in cui è avvolto il nesso fra produzione della ricchezza e finanza, l’indebita “spazializzazione”, nel ciclo sistemico di accumulazione, del rapporto fra primo e secondo segmento del ciclo (fra D-M, produzione e commercio, e M-D’, la finanza), un nesso fra capitale e forma-Stato che lascia scoperto il piano delle forme di governo o auto-governo della società (che nesso vi è, cioè, fra cicli sistemici di accumulazione e politica democratica e non?), la scarsa attenzione per una sfida globale come quella ecologica (appena riscattata dalle pagine finali di Adam Smith a Pechino), un legame fra necessità delle riorganizzazioni sistemiche e contingenza della storia che è contingente anch’esso (è un elemento, questo, su cui non a caso anche Harvey insiste nell’intervista ad Arrighi). È anche su questi punti che la discussione deve proseguire.
I saggi del volume
Qualche parola, infine, sui saggi qui proposti. Ciascuno di essi integra tematicamente, da una diversa prospettiva, il materiale testuale di Arrighi già disponibile sul mercato editoriale. Dell’intervista ad Harvey si è detto, e non vi ritorneremo sopra. Il secondo saggio, Secolo marxista, secolo americano. La formazione del movimento operaio nel mondo, si occupa, invece, di una questione di cui Arrighi si era ripromesso di parlare in Lungo XX secolo e che invece non riuscì, da ultimo, a introdurre nel libro: la storia del movimento operaio novecentesco letta alla luce della teoria sistemica. Il saggio è, infatti, incardinato attorno alla polarità fra riformismo socialdemocratico bernsteiniano (il modello vincente di movimento operaio nei paesi del centro) e leninismo (il modello vincente di movimento operaio nei paesi della periferia). In chiusura, ci si diffonde sulle possibilità del movimento operaio nel futuro: queste sono del tutto affidate alla costruzione di quei “movimenti antisistemici” su cui ci siamo trattenuti poco sopra.
Nel terzo saggio, Le disuguaglianze mondiali, invece Arrighi riflette, sempre in modo sistemico, sulla questione delle disuguaglianze mondiali. Il risultato teorico principale del saggio è duplice: all’affermazione della chiusura, nel secondo dopoguerra, del differenziale di reddito fra i paesi europei e quelli del Nord America – quindi fra i paesi del centro – si contrappone la constatazione del mantenimento del differenziale pregresso di reddito fra i paesi del centro e quelli della periferia (ex blocco sovietico e paesi del Sud del mondo). In chiusura, la riflessione si concentra sulle potenzialità del socialismo in un tale contesto. Va detto che le conclusioni analitiche del testo, come registrato anche da Harvey nell’intervista, andrebbero aggiornate, vista la crescita del reddito nei paesi del Sud-est asiatico. Ma Arrighi è rimasto fino all’ultimo convinto della loro bontà: grazie, in particolare, alla Cina si sono ridotte le sperequazioni internazionali di reddito, ma grazie alla Cina è anche aumentato il tasso di disuguaglianza all’interno degli Stati.
Il quarto saggio, Capitalismo e (dis)ordine mondiale, è una limpida e riuscita sistematizzazione delle tesi sostenute da Arrighi in Lungo XX secolo e dallo stesso insieme a Beverly Silver in Caos e governo del mondo. Importa qui soprattutto sottolineare come in questo saggio Arrighi e Silver insistano sul carattere effimero della New Economy e della politica estera “unilateralista” inaugurata dagli Stati uniti all’alba degli anni Duemila. Nel poscritto, allegato a questo testo, Arrighi e Silver confermano, a cinque anni di distanza, la validità delle proposizioni analitiche del loro saggio.
Nel quinto e ultimo saggio, Dopo il neoliberismo. Il nuovo ruolo del Sud del mondo, qui pubblicato in contemporanea con la versione inglese, si avvalorano le possibilità, con l’inasprirsi della crisi delle politiche neoliberiste dettate dal centro e l’assestamento della crescita cinese, che sorga una nuova Bandung, un nuovo patto fra i paesi che una volta venivano chiamati “in via di sviluppo”. Una Bandung tuttavia diversa dalla prima, quella nata negli anni Cinquanta e subito dopo fallita, perché fondata non su una solidarietà di tipo puramente politico, ma sulla più solida roccia della progressiva convergenza, fra i paesi del Sud del mondo, dei rispettivi interessi economici.