Normazione, amministrazione, giurisdizione e governo
Riflessioni elementari su disegno ed esercizio della sovranità nell’ordine costituzionale vigente
Per secoli, l’Occidente (in senso geografico, dal punto di vista eurocentrico al quale si guardavano le cose) si era caratterizzato per il fatto di praticare culture politiche di “autogoverno” (erano – in ambito mediterraneo – le prevalenti: vi guardavano il mondo greco; quello italico, etrusco e romano in particolare; quello cartaginese). In tali culture l’idea generale (a prescindere dalle specifiche declinazioni che se ne facevano) era che la “sovranità” (la condizione politico-giuridica che permetteva ad una “comunità politica” di essere indipendente) fosse un attributo “della” comunità (nel suo insieme). La quale comunità gestiva dunque tale sua sovranità attraverso modalità concrete (complesse e – anche significativamente – diversificate) connotate da un elemento comune. Ciascuna (sottolineo: ciascuna) delle manifestazioni necessarie a dare forma organizzata alla propria vita collettiva ed ordinato svolgimento alle relazioni che in essa intervenivano (creazione delle “regole” di indirizzo, da un lato, ed “attuazione amministrativa e giudiziaria” di esse) prevedeva il concorso – diretto o mediato – di tutte le componenti sociali della comunità interessata.
- Non vi è dubbio che uno dei problemi più acuti venuti in evidenza negli ultimi decenni della nostra esperienza costituzionale sia il disequilibrio che è venuto nel tempo a definirsi tra i cosiddetti “poteri” (tra i quali si ripartisce il governo di una collettività politica) e, in particolare, tra quello di “indirizzo” (governativo-parlamentare), da un lato, e quello “amministrativo” e “giurisdizionale”, dall’altro, entrambi (più visibilmente il secondo), tendenzialmente sempre meno percepiti come disponibili ad operare in sintonia con le indicazioni del primo e perciò sempre più come autoreferenziali.
Non credo di tradire la realtà se osservo che la esistenza della questione sia un fatto oggi generalmente riconosciuto.
Ma credo anche che se non si guarda alle cose con la radicalità elementare che – sola – ne può lasciare comprendere le cause, non se ne comincerà mai a venir fuori. Altra cosa – molto più difficile – sarebbe immaginare anche linee di concreta soluzione. Ma ognuno comprende come ciò non solo aprirebbe immediatamente (non potrebbe non essere) un dibattito divisivo importante su obbiettivi, priorità e tempistiche, ma distoglierebbe l’attenzione dalle cause “prime” del fenomeno. Quelle la cui mancata individuazione ha reso – negli ultimi decenni (almeno due) – quel dibattito (tutt’altro che mancato) privo del suo presupposto primo: le ragioni “strutturali” che lo giustificano. Le quali vengono ben prima delle ovvie (e naturali) concrete divisioni sulle soluzioni. Sono la sola premessa possibile (di metodo insomma) verso una eventuale “condivisa” (nella necessità e non nella convenienza di parte) riconsiderazione della questione.
- Parlerò con la elementare sommarietà indispensabile.
Ogni sistema politico non può non darsi una struttura di decisione e di gestione organizzata. Il che esso fa in coerenza, ovviamente, con la propria visione di governo. Seguendo dunque una logica di coinvolgimento collettivo (visione “partecipata”) o una invece di “concentrazione” (più o meno intensa). In altre parole, secondo l’idea di sovranità da esso adottata.
I sistemi politici occidentali (tra i quali anche il nostro si situa) sono eredi, da questo punto di vista, di una duplice tradizione storica, che ne ha segnato variamente le vicende (e che li ha anche resi profondamente diversi nei loro concreti assetti).
Per secoli, l’Occidente (in senso geografico, dal punto di vista eurocentrico al quale si guardavano le cose) si era caratterizzato per il fatto di praticare culture politiche di “autogoverno” (erano – in ambito mediterraneo – le prevalenti: vi guardavano il mondo greco; quello italico, etrusco e romano in particolare; quello cartaginese). In tali culture l’idea generale (a prescindere dalle specifiche declinazioni che se ne facevano) era che la “sovranità” (la condizione politico-giuridica che permetteva ad una “comunità politica” di essere indipendente) fosse un attributo “della” comunità (nel suo insieme). La quale comunità gestiva dunque tale sua sovranità attraverso modalità concrete (complesse e – anche significativamente – diversificate) connotate da un elemento comune. Ciascuna (sottolineo: ciascuna) delle manifestazioni necessarie a dare forma organizzata alla propria vita collettiva ed ordinato svolgimento alle relazioni che in essa intervenivano (creazione delle “regole” di indirizzo, da un lato, ed “attuazione amministrativa e giudiziaria” di esse) prevedeva il concorso – diretto o mediato – di tutte le componenti sociali della comunità interessata (quasi mai ordinate secondo logiche di uguaglianza: nemmeno dove prevalevano, come ad Atene, forme di governo “democratico”). La maiestas era insomma, in quella visione, della “civitas” e non di un qualunque organo di essa. E il correlato esercizio dell’imperium che tale maiestas giustificava avveniva sempre perciò attraverso soggetti (magistrati) individuati mediante procedure (di investimento nelle funzioni) collettivamente controllate e la cui concreta attività era disciplinata da un “accompagnamento” in itinere (“pareri” necessari, collegialità/concerto dell’atto, possibilità di interventi inibitori) e da un controllo successivo (valutazione dell’operato) ispirati dalla stessa preoccupazione.
Questa visione della sovranità cedette il passo – da Augusto in avanti (in un tempo nel quale dunque l’intero Occidente era stato ormai, da circa due secoli, ricondotto di fatto ad un unico “governo”: quello di Roma) – ad una nuova visione (che si sarebbe a lungo proiettata nel tempo).
Le difficoltà (drammaticamente emerse in un secolo e mezzo di profondo travaglio, sfociato alla fine anche in una lunga stagione di guerre civili) di mantenere costante l’equilibrio conseguito nella distribuzione di funzioni e competenze, quale disegnatosi nei secoli (ed orientato a rendere possibile un ordinato concorso collettivo alla gestione politica della comunità: autogoverno) portarono ad una novità radicale. Al posto di una visione che vedeva nella sovranità un’attribuzione “della” civitas ne subentrò una che la concepiva ora come attribuzione di un organo di questa (in pratica: il princeps).
Si trattò di un cambiamento di cose che avrebbe segnato la storia occidentale per quasi due millenni. Con enormi conseguenze sulle “culture” sociali e politiche che si sarebbero nel tempo succedute (molteplici e varie sotto i più diversi aspetti, ma costanti nel vedere la sovranità come attribuzione di un organo della collettività).
- Quando alla fine del Settecento – per effetto finale delle rivoluzioni francese e americana – l’Occidente (che ormai non era più un luogo “geografico”, ma un’“area culturale”: quella legata, per i vari tramiti, all’antico luogo geografico) – tornò all’idea dell’autogoverno (come rimedio ai guasti della concentrazione della sovranità che la storia metteva sotto gli occhi di tutti), immaginò di doverne anche fissare i cardini che avrebbero reso la pratica non degenerabile in “concentrazioni fattuali” del potere, che ne determinassero una sostanziale identificazione con una parte soltanto della collettività (quella materialmente in grado di occuparne gli spazi più ampi).
Tali cardini (continuo a semplificare radicalmente) furono visti in alcuni strumenti organizzativi (variamente declinati in concreto, con conseguenti rilevanti differenze di efficienza/efficacia pratica dei vari sistemi che ne sarebbero nel tempo venuti), ma tutti ispirati ad alcune comuni idee di base.
Constatata la impossibilità – per le incommensurabili dimensioni, sia fisiche (i nuovi “stati”) che “giuridiche” (i soggetti “cittadini”) delle nuove collettività rispetto alle antiche civitates – di replicare modelli di partecipazione “diretta” all’autogoverno, si ricorse all’idea di una partecipazione attuata in forme “rappresentative”.
Per prevenire il rischio di vanificazioni fattuali (legate alle dinamiche di riposizionamento delle forze sociali) dell’ordine di governo concordato con il “patto fondativo” che dava vita alle nuove collettività (che prendevano il posto dei regimi cancellati con le rivoluzioni avviate), si ricorse all’idea di una architettura scritta (costituzione) delle strutture di governo. In essa la distribuzione delle funzioni e delle competenze doveva essere improntata all’idea di una “divisione” dei poteri/funzioni (realizzata attraverso l’attribuzione di tali poteri/funzioni a “istituzioni” (legislative, amministrative, giudiziarie) non comunicanti e il più possibile “indipendenti” ciascuna da ogni altra. Nella convinzione che gli eventuali “eccessi” (rispetto all’intervenuta ripartizione) sarebbero stati reciprocamente prevenuti/corretti dall’esercizio indipendente della funzione attribuita.
Per impedire che i fattuali conflitti (e le connesse dinamiche di potere delle forze sociali) perpetuassero il rischio di un “diritto” privo di generale controllo collettivo, si immaginò di scongiurarlo attraverso l’adozione della “legge” quale unica espressione possibile della normazione.
- Si è trattato di errori. Determinati da una visione tutta “ideologica” delle cose (della quale l’illuminismo era stato la culla finale), che ha preteso di cancellare la storia dalla realtà.
Nessuno dei tre “pilastri” ha retto all’impatto con la storia.
Nessuno degli ordinamenti ispirati a quei principi è sfuggito al disastro di inefficienza che (in misura ovviamente diversa, in ragione della varietà delle declinazioni) è sotto gli occhi di tutti. E che alimenta un vento di reazione spesso reso cieco dalla rabbia e dunque non meno pericoloso del perseverare ostinato nella conservazione dell’inconservabile.
L’ Occidente deve reagire. E il solo modo per farlo è il cominciare con il prendere coscienza di errori ed imprevidenze.
- La realtà “sociale” (come “definita” nelle articolazioni dagli interessi tendenzialmente omogenei ed aggregabili che le guidano) poteva probabilmente essere immaginata come “rappresentabile” alla fine del Settecento. E lo era anche forse ancora alla metà del secolo scorso. Di sicuro non lo è più oggi. Ed appare dunque indispensabile convincersi della necessità di rivedere (il quomodo è altra cosa) i meccanismi pubblici di “delega”/“investitura”/“controllo” dell’esercizio delle funzioni politiche (legislative e amministrative).
La società contemporanea è divenuta una società – come ama dirsi – “liquida”, nella quale gli interessi si compongono/scompongono con una grandissima rapidità e, soprattutto, si esprimono in direzioni molto difficilmente aggregabili. Il che spiega per altro perché i “movimenti” abbiano preso il posto dei “partiti” e perché gli orientamenti si formano sempre più a partire dalle “soluzioni” proposte (e sempre meno dalla più o meno presunta coincidenza di interessi di “classi”: quali oltretutto?).
Nessuno immagina, naturalmente, che nuove soluzioni “formali” (l’adozione insomma di assetti normativi più aderenti alla realtà delle cose) possano, da sole, rimettere in funzione i meccanismi inceppati. È sempre l’uomo l’insuperabile attore. Le dinamiche di potere hanno una “fattualità” non facilmente imbrigliabile. Dipendono molto dalla “cultura” dei protagonisti. Ma è certo che esse abbiano tuttavia necessità di “forme”. Ne sono condizionate. Ed è certo perciò che se quelle adottate sono inappropriate, non vi potrà essere adeguata efficienza.
Non si può più rinviare l’apertura insomma di una seria discussione.
- Ma parimenti indispensabile appare una riflessione sulla “legge”.
Non perché sia in sé erroneo pensare ad essa come strumento “moderno” di regolazione collettiva. Non ne sono negabili né la tempestività con la quale permette di provvedere, né la più elevata certezza (del diritto) che essa consente di conseguire.
Ma perché non possono trascurarsi le conseguenze (sotto gli occhi di tutti) del punto di vista adottato. Che ha fatto ritenere sufficiente preoccuparsi di assicurare procedure collettivamente (politicamente) “controllate” di creazione della legge e non parimenti importante preoccuparsi anche di individuare strumenti per mantenerne collettivamente “controllata” anche l’applicazione.
La “legge” non può essere lo strumento diretto di disciplina della organizzazione e gestione delle relazioni sociali. Ne può dare solo (ed è anche opportuno che accada) l’indirizzo. Non ne può dettare (almeno sempre) la concreta disciplina. Lo impedisce la inesorabilità delle trasformazioni (e ora anche la rapidità con la quale esse maturano).
La distanza tra “creazione formale” della “regola” e tempo di applicazione della stessa ne impone un’applicazione realizzata attraverso gli “occhiali” di coloro che leggono la realtà da disciplinare. Il significato “attuale” della regola è quello che vi vede chi la applica (non chi la crea). E gli stessi fatti che lo inducono a stabilirlo (la realtà materiale alla quale egli è chiamato a dare disciplina) sono, a loro volta, espressione di “comportamenti” (dunque di costumi operativi) che raramente corrispondono a quelli tenuti in considerazione da chi ha costruito l’enunciato formale (la legge).
Non basta l’adozione di una “legge” perché si possa dire che si sia fissato il “diritto” che ne discende. La “normazione” vivente non è quella voluta da chi vi ha dato “indirizzo” (legislatore), ma è quella di chi (amministratore) dà ad essa “attuazione”. E non possiamo perciò continuare a trascurare le conseguenze concrete di un sistema costruito senza alcuna considerazione di tale elementare verità.
Autogoverno non può che voler dire possibilità di “controllo” costante, da parte della collettività (con modalità almeno mediate), dei processi politici che la fanno vivere: adozione delle regole di riferimento e amministrazione della realtà in coerenza con esse. Una civitas (grande o piccola che si voglia) è sovrana se le decisioni che la riguardano (di indirizzo e di gestione) sono di coloro che ne sono i cives (come soggetti politico-costituzionali). Sia che le adottino direttamente, sia che lo facciano investendone organismi concordati (e da essi controllati).
- Non la faccio lunga. Mi limito ad una sola, ma spero sufficiente considerazione.
La possibilità di una “normazione” coincidente con la “legge” è impraticabile. La legge non può essere sufficiente. Necessaria (per l’indirizzo delle cose), si tradurrà in strumento di concreta valutazione normativa (permetterà insomma la disciplina di una concreta vicenda) attraverso la insuperabile mediazione di chi è chiamato ad attuarla. Riceverà “significato” da costui (dall’interpretazione che egli ne darà). La legge non “vive” insomma (non può vivere) se non attraverso la intelligenza, la sensibilità, l’attenzione, il pensiero di chi ne gestisce la sua “attuazione”. La quale dunque ha un ruolo “politico” (generale) non diverso da quello di colui che crea la legge.
Le due “funzioni” si integrano insuperabilmente.
Esse possono certo (ed è ben pensabile che sia opportuno che accada) essere affidate a “soggetti istituzionali” distinti. Ma entrambi i soggetti (istituzionali) in questione devono – all’interno almeno di un sistema che attribuisca la “sovranità” alla volontà collettiva (art. 1 della costituzione del 1947) e ne consideri possibile solo una delega di esercizio (artt. 1.2 e 101.1) – ricevere un trattamento omologo.
Non è possibile che uno dei due (nel nostro caso: il parlamento) dipenda (per l’investitura nella funzione e per il controllo di esercizio che subisce) dal “sovrano” (la collettività dei cives, che appunto lo “elegge” e ne giudica politicamente l’operato alla successiva scadenza elettorale) e l’altro (il corpo giudiziario) ne sia invece sottratto.
Se questo accade (come nel sistema adottato dal nostro costituente), il secondo non solo inevitabilmente prevale sul primo, ma (se gode anche di assoluta indipendenza nell’esercizio della funzione: artt. 104 ss.) può sovrapporsi (nei fatti) allo stesso titolare della “sovranità”. Amministrerà infatti le regole secondo il proprio insindacabile giudizio. E poiché – nell’eventuale contrasto tra “significato” della legge (quale inteso dal “legislatore”) e significato di essa (quale inteso dal “giudice”) non potrà che prevalere (nel concreto esercizio della funzione) che il secondo (è del giudice la “decisione” del caso), la “normazione” (la concreta disciplina che i fatti riceveranno) non sarà più quella immaginata dal legislatore, ma quella voluta dal giudice. E tutto questo (ragione non secondaria delle tensioni maturate) nonostante l’architettura (costituzionale) disegnata abbia proclamato di volere piuttosto, semmai, il contrario (“soggezione” del giudice alla legge: art. 101).
Nell’immaginare possibile una “normazione” affidata unicamente alla “legge” si è solo dato espressione ad un impulso emotivo.
Si è inteso cancellare dall’ordine giuridico ciò che la storia dimostra essere invece il solo contenuto compatibile con la possibilità di mantenere elevato il tasso generale di consenso nei confronti dei suoi assetti: un contenuto fattuale delle “regole” (il “dettato applicato” di esse) il più possibile prossimo ai “costumi” collettivi praticati (con generale approvazione). Quelli che orientano insomma gli indirizzi della normazione (li rendono quelli “attesi”: leggi) e quelli che ne permettono poi un’attuazione giudiziaria percepita come la “dovuta”.
In nome di un “ideologico” astratto (e immobile) “dover essere”, si è trascurata l’insuperabile (dinamica) “storicità” dell’essere.
Si sono dimenticate due cose.
Da un lato, che le scelte “normative” sono frutto (ordinariamente) di esperienza: vengono dall’osservazione, in sede “amministrativa”, dei “problemi” che hanno necessità di regolazione e dalla opportunità di introdurre regole mancanti/nuove/diverse rispetto alle esistenti.
Dall’altro, che la “regola” (massimamente se “chiusa” in un “enunciato formale”) è costruita sull’osservazione di una realtà che sarà altra (non potrà che essere altra, tanto più in tempi di rapide trasformazioni della realtà materiale) nel momento nel quale diverrà necessario “amministrarla” (adottare la decisione pratica o giudiziaria richiesta dalle circostanze). Insomma: per essere “amministrata” (applicata) una “regola” deve essere “letta” (interpretata nel suo significato normativo) e “adattata” alla realtà che ne reclama applicazione (anche qui in forza di una “lettura”). Due operazioni (interpretazione della “regola” e del “fatto”) che non possono che essere dell’interprete. Dunque di chi applica. La legge non vive del suo “dettato”, ma dell’ “interpretazione” che ne viene data. Il diritto (la normazione/disciplina che dalla legge si ricava) non è dunque ciò che ha voluto il “legislatore”, ma è ciò che (nei fatti) ne ritiene il suo “amministratore”: funzionario/giudice.
Averlo dimenticato ha dato occasione ad una gravissima incoerenza di sistema. Che ha determinato, alla lunga, le tensioni che viviamo.
Il potere “politico” (governativo-parlamentare) esaspera le sue “grida” (ne moltiplica il numero, ne estende nel massimo il dettato), nella speranza di stringere l’amministratore in binari rigorosi. L’amministratore (il giudice in particolare: aspetto di macro-evidenza della questione) guarda con i suoi occhiali alla realtà ed attribuisce alla “regola” (ormai persino quanto alla sua “esistenza” in ambiti un tempo ritenuti assolutamente e intransigentemente sottratti alla “interpretazione”: vedi il cd. “concorso esterno”) un significato che non ha altro riferimento che se stesso (ovviamente come “corpus”, non a caso “gerarchizzato”, e poi anche “organizzato” per indirizzi ideologici: vedi gestione delle carriere ad opera del consiglio superiore della magistratura).
Nella costruzione “rivoluzionario/illuministica” della “legge/veicolo unico della normazione” (illusoriamente adottata per contrastare – non va certo disconosciuto – secoli di pratiche illiberali e partigiane di interpretazione) si è consumato l’abbaglio di fondo. Che ha assunto come possibile una “vigenza” della legge in sé, indipendente dalla sua “attuazione” (amministrativa/giudiziaria). E dunque come sufficiente un’esposizione a controllo “politico” della sola funzione legislativa.
Senza dire della illusione (“complementare”) che vi potesse essere un “bilanciamento” (tra le due funzioni) determinato da spinte e controspinte (check and balance). La spinta che determina reazione è quella macroscopica (le leggi ad personam, il predicato uso alternativo del diritto di una certa stagione). Non anche quella quotidiana e strisciante, ben più stravolgente ed incisiva (come l’azione giurisdizionale che si traduce in normazione “sostitutiva”/”integrativa” di quella “legislativa”). Qualcuno ritiene reversibile a quella voluta dalle “forme” la costituzione “materiale” invalsa o cancellabile dall’ordine giuridico vigente un qualunque orientamento “suppletivo/correttivo” della legislazione adottato in sede giurisdizionale?
- Il problema non riguarda solo la relazione tra “legislazione” (attribuzione del parlamento) e “amministrazione giudiziaria” di essa (attribuzione del corpo giudiziario). Riguarda anche (e prima ancora) la libertà stessa di esercizio parlamentare della funzione legislativa.
Per effetto dei meccanismi adottati (controllo di costituzionalità delle leggi ad opera di una apposita “corte”), l’esercizio della sovranità disegnato – in materia di legislazione – ha dovuto scontare non solo la “correzione strisciante” (in sede di attuazione giudiziaria delle leggi) ad opera di un corpo giudiziario (che avrebbe dovuto esservi solo “soggetto”), ma anche i limiti (ai quali si sono sommati nel tempo quelli derivanti da vincoli internazionali di ancora più complessa decifrazione di compatibilità con la “sovranità” collettiva come affermata nella carta) derivanti da giurisdizioni sovranazionali.
Le tensioni esplose sono sotto gli occhi di tutti.
Non affronto il problema delle giurisdizioni esterne e mi limito al problema del giudizio di costituzionalità.
Ognuno comprende bene come già l’adozione stessa di una costituzione scritta “rigida” sia causa di ovvie questioni da fronteggiare. Essa non può reggere all’impatto con le trasformazioni della realtà. Lo dimostra all’evidenza, d’altra parte, il prevalere nei fatti su di essa (ormai da tutti accettato) della cd. costituzione “materiale”. Dunque della insuperabile esposizione di quella scritta ad una rivisitazione continua del significato dei suoi enunciati.
Se a ciò aggiungiamo il combinarsi di una tale visione di cose (costituzione scritta) con la esposizione della legislazione ordinaria ad un giudizio di conformità ai principi e ai valori della costituzione non possiamo sorprenderci dell’apertura di un problema ancora più grave.
Rimettere la “interpretazione” di “costituzionalità” di una “legge” ad una “corte” priva di un forte raccordo politico con la “sovranità collettiva” rischia di trasformare in legislatore “di fatto” un soggetto (la corte) che “di principio” non si vorrebbe lo fosse (essendosi appunto la legislazione immaginata piuttosto, nel disegno di “esercizio” della sovranità adottato, come prerogativa esclusiva di organismi elettivi a ciò esplicitamente delegati). Nel legiferare il parlamento ha di certo “interpretato” esso stesso la costituzione. Ma la “lettura” che ne ha fatto non è quella che – secondo un diverso, altrettanto soggettivo, punto di vista – ne doveva fare. Con una differenza: che il parlamento è la sede delegata dichiarata (art. 1.2) di esercizio della “sovranità” legislativa e la corte è un organo che, almeno dichiaratamente, non ne ha avuto alcuna (e tantomeno prevalente).
Nessuno nega che senza un qualche meccanismo di controllo del suo permanente rispetto (da parte del soggetto legiferante) sarebbe privo di senso darsi una “costituzione”.
Ma non può non osservarsi come il meccanismo di controllo adottato (avendo manifesto contenuto “politico”) avrebbe dovuto preservare almeno la possibilità che l’esercizio di tale controllo avvenisse attraverso modalità che non spostassero (senza dichiararlo e senza preoccuparsi comunque di un qualche coordinamento) la titolarità della funzione. Non si può, da un lato, dichiarare – ed enfatizzare (coro unanime della classe politica di ogni tempo e colore) – che titolarità ed esercizio della sovranità sono del popolo (come rappresentato) e, nello stesso tempo, porre le premesse perché nei fatti l’elemento fondante dell’ordine sociale (la normazione concretamente vivente) sfuggisse ad ogni controllo sociale.
La incoerenza del sistema adottato è assolutamente palese.
Da un lato, si è affidata la normazione (ritenuta coincidente con la legislazione astratta) ad un organo (il parlamento), al quale è espressamente (ed esclusivamente) delegato (attraverso procedure collettive controllate di formazione dello stesso) l’esercizio della sovranità. E del quale, inoltre, si è, altrettanto espressamente, prevista la periodica verifica collettiva della corrispondenza del suo operato alla volontà popolare. Dall’altro, si è voluto però, nello stesso tempo (nell’ambito cioè dell’architettura costituzionale adottata), prevedere che la “effettività” (la concreta “vigenza”) della legislazione votata dipendesse dal giudizio di un organo (la corte costituzionale), privo di un (almeno paritario) fattuale raccordo con la sovranità popolare.
È veramente difficile contestare l’impressione che – quanto alla funzione legislativa – l’esercizio di questa sia passato nei fatti (per la pervasiva influenza dell’orientamento della corte in ordine al “significato costituzionale” delle leggi) in capo ad un organo al quale invece – esplicitamente – esso si nega (e del quale, in coerenza con tale astratta negazione, sono state regolate perciò composizione e legittimazione). E non può perciò meravigliare se – nella considerazione comune – il “giudizio di costituzionalità” (a misura in cui si è diffuso ed intensificato nei contenuti) abbia finito (come da qualche decennio ormai si constata) con l’essere percepito come l’espressione non solo fattuale, ma anche usurpata, della sovranità politica.
Che il problema abbia assunto in Italia proporzioni più gravi che altrove è, d’altronde, sicuro.
Negli altri paesi a costituzione scritta, la situazione (anche limitando lo sguardo solo a quelli di maggiore rilievo politico) è non solo molto varia, ma sempre anche molto diversa dalla nostra.
Negli USA è vigente un giudizio “diffuso” di costituzionalità (contenuto, ai fini della uniformità delle valutazioni, dal ruolo che – in un sistema di vincolo giurisdizionale al “precedente”, secondo la gerarchia fissatane – assume il giudizio della Corte Suprema). In Francia ne vige uno invece “preventivo”. In molti se ne adotta uno “accentrato” e “successivo” come (in via quasi esclusiva) accade in Italia. Ma dove questo accade (Austria, Germania, Spagna ad esempio) la relativa disciplina non coincide con quella italiana. A parte il problema delle modalità introduttive (da noi incidentali: subordinate dunque ad un giudizio sommario di ammissibilità da parte del giudice ordinario), vi è comunque, dal punto di vista che stiamo considerando, una differenza molto significativa quanto alla ben più accentuata legittimazione “politica” dei giudici costituzionali che in tali diversi ordinamenti si osserva. Per restare ai casi evocati: in Austria – la patria del modello – i giudici sono solo di indicazione governativa e parlamentare; in Germania, è lo stesso (sono tutti di indicazione parlamentare, secondo un bilanciamento che tiene conto anche della struttura federale dell’ordinamento). Nella stessa Spagna – nella quale il modello è più vicino al nostro – i giudici sottratti alla indicazione “politica” (parlamentare/governativa) lo sono nella misura di un sesto (i 2 indicati dalla magistratura, sui 12 totali), in Italia in quella di un terzo (5 su 15), che diviene addirittura dei due terzi (se si tiene conto che anche quelli di nomina presidenziale non possono ritenersi di espressione governativo/parlamentare).
Ognuno comprende bene le profonde differenze concrete che ne conseguono.
Nei sistemi di controllo “diffuso” – si induce un percorso di mediazione continua e si attenua perciò il rischio di un’eccessiva unilateralità di orientamenti.
In quelli di controllo “concentrato” (preventivo o successivo) tutto si lega alla composizione delle corti. Se interamente “governativo/parlamentare”, si favorisce ovviamente una più immediata possibile identificazione della responsabilità “politica” degli indirizzi adottati di quella che può farsene invece quando le corti siano costituite (come in Italia) secondo logiche che ne accentuano invece l’indipendenza (e quindi una più facile sottrazione agli indirizzi assunti dagli organi ai quali spetta l’esercizio della sovranità politica).
- Una sola semplice conclusione: l’ordine politico contemporaneo non recupererà certo efficienza solo perché avrà risolto uno (per quanto centrale) dei suoi problemi. Ma di quelli le cui ragioni sono chiare esso deve cominciare con urgenza ad occuparsi. Ignorare le evidenze non aiuta, come non aiuta di certo non vedere le debolezze del sistema adottato e l’urgenza di aprire una seria approfondita riflessione sulle possibili vie di uscita. Né facili. Né prossime. Ma indispensabili.




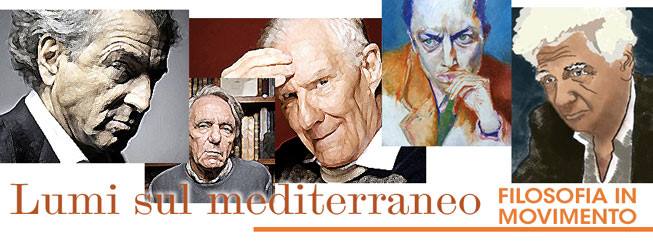


 Francesco Postorino
Francesco Postorino