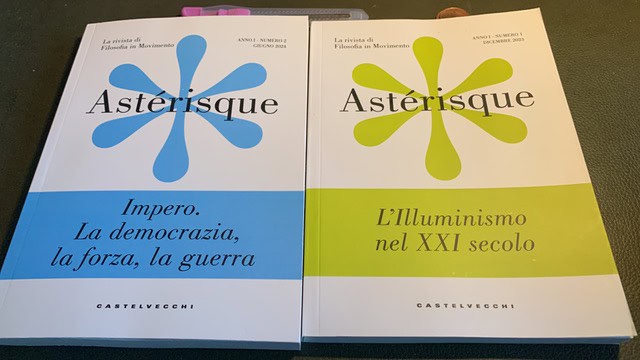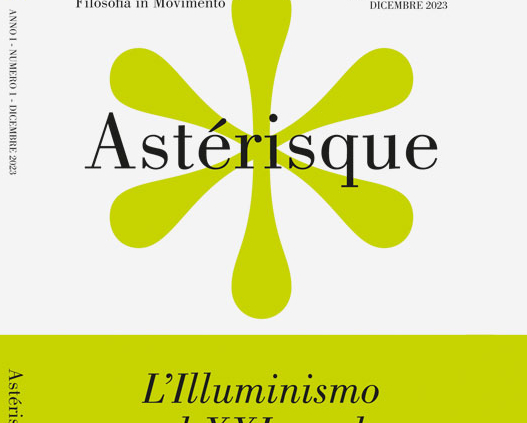Imperialismi- Illuminismo Presentazione di «Astérisque» di Mario Reale (con Francesco Fronterotta) – Venezia 17 giugno 2025.
Fratelli tutti.
Comincerei da un’esperienza personale. M’è capitato di scrivere, vicini di qualche mese, due contributi che sostenevano tesi alquanto diverse tra loro. Nel primo numero di «Astérisque», L’Illuminismo nel XXI secolo, dic. 2023, esprimevo un’esigenza di finitezza, contro ogni tentativo che (come quello, mi sembrava, di Adorno e Horkheimer) cercasse di muoversi e mantenersi nella sfera della totalità e dell’assolutezza, in quanto ineludibile premessa a ogni seria critica[1]. Ma già alcuni mesi prima di questo articolo avevo sostenuto in un altro piccolo saggio una tesi alquanto difforme[2]. Al centro era ora la diversa idea che tutti, credenti e no, potessero incontrarsi sulla base di una comune esperienza di senso in certo modo «religiosa», assolutistica cioè e totalizzante. L’Enciclica di Papa Francesco, che si commentava, mi sembrò, pur nella sua apertura «laica» rivolta a tutti, animata da una così profonda esigenza specificamente religiosa, che non si capiva come potesse, in quanto tale, appartenere a tutti, se non appunto risalendo, per «trasposizione», a una comune esperienza di totalità e di assoluto. In breve, la via che chiamerò di laicità «tradizionale», con la comune ragione e il religioso in quanto ambito riservato ai credenti, cui in generale mi richiamavo nei miei scritti[3], cominciò a sembrarmi per un verso almeno alquanto consumata e bisognosa d’altri argomenti, sebbene da questa opinione «io non mi «rimuov[essi]» (Machiavelli, DiscorsiI 37). Ne derivò una tensione tra la laicità del finito e quell’infinito o totalità e assolutezza che pur era umana e comune esperienza. Di qui un evidente cambiamento di atteggiamento, e anche di quadri di riferimento, ma non proprio un rovesciamento di prospettiva e perciò di una completa posizione. Se dapprima avevo lavorato sulla via della distinzione tra piano naturale o mondano e terreno religioso, meglio di fede, ora era la volta di vedere se, rovesciando la prospettiva, ci fosse, già in partenza, paradossalmente, un terreno comune ad atei e credenti, un ambito per essi inclusivo. La Conferenza sull’etica di Wittgenstein, infine, m’era parso che esprimesse bene e sostenesse autorevolmente ciò che intendevo dire: l’«al di là» o l’«insensato» che, espressione della finitezza, ci costituisce e ci fa pienamente uomini. Dove finiva la naturale e razionale finitezza, non c’era la separazione e il vuoto tra atei e credenti (le due rive di uno stesso fiume, come diceva Barth), quanto invece una somma di esperienze dove si nascondevano, a sentire l’autore del Tractatus, persino le cose più importanti per noi.
Nel quadro così mutato con lo scritto su «Fratelli tutti», ripercorrendo a ritroso il cammino, mi sembrava tuttavia che un passo un po’ diverso fosse stato mosso anche con Illuminismo, ché il vecchio tessuto di pensieri era già incrinato dal fatto che l’articolo del primo numero della rivista era dedicato non direttamente all’Illuminismo, ma all’Anti-illuminismo di Adorno: la positività era così in parte frenata dalla negazione, perché si lavorava al margine e sui contrari. Sostanzialmente, venivano ripresi da Adorno molti temi e, in prima battuta, persino qualcosa dell’intero quadro teorico, ma l’appunto principale di «misticismo», detrattore di determinata razionalità, che ancora mantenevo, pesava come un macigno. Senza peraltro che tenessi conto del fatto che, come contraddittoriamente riconoscevo, Adorno partiva proprio da una scissione originaria di ordo rerum e ordo idearum. Come era allora possibile parlare della forza condizionante dell’intero, della totalità e dell’assoluto, il sommamente unitario, quando si muoveva da una scissione così profonda e radicale, e dalla «paura» che ne derivava necessariamente, come da una ferita originaria e insanabile? In un mondo dove la «cervellotica» idea (Adorno) e la consistenza delle cose, dura come le rocce, non s’incontrano mai era difficile passare subito di qui a pensare la forza unitaria dell’intero. La riduzione del pensiero negativo a totalità avrebbe meritato ben altri passaggi. E semmai la vera bestia nera di Adorno era giustamente il positivismo, che pretendeva una compatta totalità di linguaggio-mondo.
Le due posizioni, della finitezza e della totalità: la forma di una possibile infinitezza.
Constatata dunque la diversità dagli asserti base che reggono le due posizioni in discussione, quella dell’infinito, dell’intero, e quella della limitazione e finitezza, mi parve da scegliere come più promettente tra esse piuttosto la prima, che riposa non sull’abbandono, ma sull’ulteriore riflessione intorno al problema dell’unità e della totalità. Ma una simile scelta, come dirò, è anche arbitraria, dato che i due momenti sono e devono essere sempre compresenti, sicché il problema è piuttosto quello di dove cominciare, o di quale sia il momento passibile di migliori sviluppi. La domanda è qui se si possa mai pensare (e agire) senza presupporre un principio di totalità, di assolutezza, assumendo quindi positivamente ciò che dapprima criticavo.
Senza giungere al modo del pensare, già la prima infanzia dell’uomo si svolge nel segno indelebile dell’intero, anzitutto con quella sorta di insieme costituito da madre-figlio, e quindi con la totale immersione del bambino nel mondo vitale della primissima crescita. Il problema è qui rovesciato, e si presenta nella forma della domanda su come si esca dall’intera, immancabile e costitutiva relazione del bambino con la madre e con i primi «altri». Più che il singolo uomo come punto di costituzione, individualisticamente «trovato» ab origine, quale accade, magari implicitamente, di incontrare in molte filosofie, l’individualità si costituisce, e con essa si dà la ricostruzione di nuove e necessarie forme di totalità, che mai potrebbe mancare in quanto innegabile presupposto di ogni atto del pensare e dell’agire. Quest’atto dovrebbe porre e conservare le forme dell’intero, senza farsene sottomettere e sopraffare, mantenendo all’interno della totalità la finitezza, la differenza e la precarietà: un assoluto non presupposto «posto», ma da porre ogni volta con lungimiranza e libertà, nutrendo contemporaneamente dentro di sé, in una con-crescita, il germe e quindi lo sviluppo dell’individualità e della differenza.
La costituzione della totalità è garantita dall’essere sempre due, anche quando l’assoluto si limita solo a preparare lo sviluppo uno e bino dell’uomo. La partenza del finito solo da se stesso è in realtà un disturbo, il permanere in una sorta di condizione di natura infantile, anche quando si è divenuti, hobbesianamente, un puer robustus. E se è vero così che l’intero e la totalità rischiano sempre di sopraffarci, è pur vero, come ora mi pare, che di questa esperienza non possiamo mai fare a meno, essendo costitutiva del nostro stesso esserci, anche se dobbiamo sempre tenerla a bada, cercando di assicurarne quei limiti (mi muovo lungo la linea che va da Cartesio, Kant e Wittgenstein) che solo la fanno produttiva, entro un progetto dell’uomo come finito-infinito. Polemizzare in questo modo solo contro la totalità e l’assoluto ha poco senso, o meglio è solo un lato della questione, che di per sé inficia anche la conquista della finitezza, se è privata di quello sfondo che ne garantisce la giusta crescita, in un’interminabile catena di finitezza-infinita o di infinita-finitezza.
L’ Impero e Pericle. Veniamo ora, dopo aver parlato in senso largo di motivi legati al primo fascicolo di «Astérisque», a temi che riguardano il secondo numero della rivista, dedicato a «Impero. La democrazia, la forza, la guerra». Se ci si riferisce all’impero ateniese, è presso che necessario occuparsi della figura di Pericle, che nella sua rilevanza, nella sua complessa ambiguità, è divenuto un luogo classico e ineludibile nel giudizio su un periodo relativamente lungo della vita dell’Impero. Anch’io, nel fascicolo della rivista di cui ora parliamo, ho presentato un contributo che si chiude con osservazioni sulla figura del Pericle di Tucidite (Umiliati e offesi. Nota sul Dialogo dei Melii e degli Ateniesi di Tucidite, V, 84.3-116); ma questi accenni erano veramente troppo brevi e veloci, sicché mi pare opportuno qui tornarci su, affrontando con un po’ più di agio una questione molto difficile.
Il Pericle tucidideo rappresenta una figura a parer mio addirittura necessaria al più profondo intendimento della Democrazia, antica e moderna, qui pur esaminata prescindendo dai numerosi problemi storico-filologici che si sono stratificati intorno al testo e assumendola come momento culturale e simbolico, un pezzo straordinario della letteratura storico-politica mondiale[4].
Se ci fosse tempo e luogo, o se fossimo in altra sede, sarebbe interessante a questo punto ragionare sulle molte forme d’Impero che la storia ci presenta, consigliando perciò di parlare piuttosto che di Impero, quasi avesse un’unica forma, di Imperi e, nella tradizione ellenistica, almeno di Impero ateniese e Impero romano (tra poco ne farò un cenno, seguendo Machiavelli).
L’Impero, con la sua straripante forza, è una complessa struttura che se da un lato è pur in grado di metter riparo ad alcuni gravi danni, per esempio dello stato-nazione, dall’altro, come si potrebbe mostrare in un’analisi agiata (qui però nemmeno accennabile per sommi capi) rischia di travolgere ogni distinzione e ogni limite, divenendo uno strumento capace perciò insieme di salvezza e di perdizione. Il fatto è, come ci mostra la storia moderna e contemporanea, che il mondo è governato da «imperi», e gli stati-nazione paiono sottomessi a più realistico e largo potere. Il tema meriterebbe di esser svolto ma qui mi limito ad assumere l’Impero in analogia con ciò che abbiamo detto l’assoluto, o meglio l’«intero», magari seguendo, per la sua delineazione positiva, la lezione dantesca del de monarchia («genus humanum totaliter acceptum»). Nella sua natura ambigua e pur sempre provvisoria e caduca, destinato come persino Roma e come tutte le cose umane al tramonto e alla fine, l’impero può farsi strumento sia di più largo sviluppo di umanità e di pace, sia estensione di prepotenza sopraffattrice e di malgoverno: l’uomo può farsi in esso sia civilmente «buono», eticamente consapevole dell’aderenza all’intero, iscritto in una prospettiva più vasta e «buona», o «cattivo», dedito cioè alla soppressione delle libertà e delle autonomie, al perseguimento di potere «astratto» (così come si cerca costantemente di accrescere nell’economia del capitalismo «ricchezza astratta»). Nulla in realtà ci garantisce della superiorità degli stati-nazione, spesso arbitrariamente tracciati per ragion politica.
Mi soffermerò ora, a illustrazione di questo tema, su un problema tratto dai Discorsimachiavelliani, dove si vede bene la forza dell’Impero che tutto riduce a sé, teso a mantenere con sagacia politica l’«acquistato» e procedendo insieme a nuovi acquisti, contro gli imperi piccoli e deboli, come contro gli antichi e ormai del tutto inattuali valori della città-stato, come accadde a Roma. Questa tensione urta con l’altro e importante precetto machiavelliano del «ricco il pubblico e povero il privato», mentre l’impero ha come condizione che tutti i cittadini ne ricavino vantaggi, sia pur con il formarsi di rilevantissime e «capitalistiche» diseguaglianze economiche e sociali: un moto che accompagna la storia romana fin dalla prima costituzione dell’impero repubblicano, e soprattutto dopo la seconda guerra punica[5]. La molteplicità degli imperi contribuisce a determinare con la loro varietà una più stringente e definibile specificità di essi.
In Discorsi II 4, circa i modi dell’«ampliare», che è quasi termine tecnico per designare l’impero, Machiavelli presenta tre forme o tre «spezie» di impero, di variabile valore a seconda dei rapporti che ciascuna forma intratteneva con i «compagni» o alleati: quella delle leghe di repubbliche, come gli antichi Toscani o i moderni Svizzeri (una forma di grande potere quella degli Etruschi, sebbene essi non «poterono uscire d’Italia con gli acquisti»); quella della grandezza, tutto sommato inarrivabile, di Roma; e quella infine, massimamente deprecata, delle repubbliche greche di Sparta e Atene, che mantennero un modo «al tutto inutile», per aver acquistato quel dominio che non le potevano tenere» (cfr., I 6). Il confronto di merito fra il grande impero dei Romani, quello medio degli Etruschi, e infine quelli piccoli dei Greci stabilisce una tipologia di valori, fosse pur basata solo su ciò che tutti riconoscevano e lamentavano: l’incredibile povertà di uomini che angustiava specialmente gli Spartiati, e insomma la mancanza della condizione prima che consentiva o no di «fare uno imperio» come a Roma, la quale ebbe invece fin dalle origini un grande numero di armati (II 3).
Nonostante tutto Machiavelli non rinuncia alla prospettiva di un Impero guidato dalla politica e dall’etico: sa che l’Impero è un bene solo se è limitato, guidato e sottomesso alla politica, così come sa bene che non v’è «buona milizia» né forza organizzata là dove non vi è «buono ordine» politico (I 4). Questa consapevolezza traspare talvolta in forma di un postumo rimpianto su come l’impero romano si era sviluppato, sui tempi della sua crescita, in vistoso controcanto a Polibio, che, con sua meraviglia e apprezzamento, riteneva essere solo poco più di cinquant’anni il tempo in cui l’impero romano conquistò l’intero mondo abitato. Questo è il caso di un noto capitolo del terzo libro dei Discorsi dove con rimpianto si dice che «se i Romani non avessono prolungati i magistrati e gli imperii, se non venivano sì tosto a tanta potenza e se fussono stati più tardi gli acquisti loro, sarebbono ancora più tardi venuti nella servitù» (III 24).
Il tema ci porta a domandarci allora quale rapporto Machiavelli aveva con l’impero? Era o no un «Imperialista»? Santo Mazzarino, il grande storico romano, poneva una simile domanda a proposito di Sallustio, rispondendo che l’illustre scrittore antico, per altro stimatissimo dallo storico moderno, condivideva, tra le molte forme possibili, una concezione molto peculiare dell’impero, «a suo modo imperialista» (Il pensiero storico-classico, II, p.374 segg., Laterza, Bari 1966). Sallustio voleva cioè che i soldati dovessero sì combattere e vincere, ma non per godersi tout court le ricchezze che procuravano – come fecero i legionari di Pompeo contro i sertoriani e i fuggitivi – ma a condizione che esse non fossero fine a se stesse, ché anzi le vittorie e l’arricchimento fossero tali da tener sempre desta l’antica virtù con cui non si temeva il nemico e si sapevano respingere tutti i pericoli.
Certo, osserva Mazzarino, noi moderni, che troppo bene sappiamo cosa sia imperialismo e cosa sia guerra, troveremo assurdo questo atteggiamento di Sallustio, che vorrebbe conciliare l’imperialismo e la morale, la guerra e l’indifferenza alle ricchezze, quando l’economico, con la sua forza selvaggia, era ed è una ragione essenziale dell’imperialismo. Le contraddizioni di Sallustio, concludeva Mazzarino, sono proprie di un’età che voleva tornare alla virtus arcaica, proprio quando Roma era ormai pervenuta a una fase di sviluppo che Mommsen giustamente chiamava «capitalista» e «schiavista», con uno di quei tentativi di ritorno all’indietro proprio quando s’era giunti alla fase matura e sviluppata di un processo storico, come Marx dice all’inizio dei Grundrisse. Ecco, credo che, se si volesse studiare il problema dell’imperialismo in Machiavelli, bisognerebbe, partire proprio di qui, dal nesso di vittorie e virtù, entro la fondamentale distinzione di pubblico e privato.
Su Rousseau e sul Pericle di Tucidite. Cominciamo da Rousseau. Il finale del capitolo II 6 del Contrat social («Della legge») assomma in sé le difficoltà cui la democrazia va incontro, in preparazione del successivo capitolo («Del legislatore»), che dovrebbe dar risposta a questi immani problemi, al centro dei quali s’incontra addirittura la necessità di «cambiare la natura umana», o, come altrove dice Rousseau, di possedere, già prima, gli effetti che dovrebbero esser prodotti dal rapporto pattizio. Questi ostacoli, tendono tutti al bisogno di avere una «guida», perché una moltitudine, pur essendo giunta alla volontà generale, è «spesso ignara di ciò che vuole», non è in grado di produrre da sé un sistema di legislazione, non ha un giudizio sempre «illuminato», e così via. Si loda Rousseau per essere uno dei (pochi) teorici classici della democrazia, ma si tien poco conto, se non per qualche formula, dei suoi meriti come critico acuto della democrazia stessa.
Anche a cercar d’interpretare la figura del Pericle tucidideo, viene in primo piano il problema della democrazia, con le sue intrinseche aporie e le necessità di porvi qualche riparo. Sono infatti in gioco sia gli effetti della democrazia, notevoli e benefici nel caso di Pericle, sia in generale le forme stesse del fenomeno democratico, che stabiliscono una qualche continuità tra l’antico e il moderno, costituendo problema ancora per noi. La democrazia è potenzialmente di tutti (purché siano cittadini, un problema che toccheremo appresso), ma aperte restano le questioni di formazione e di espressione della «volontà generale». Pericle si vanta delle sue straordinarie capacità di buon governante, dicendo, senza pudori, di essere il migliore, ma al tempo stesso sembra configurare il suo potere nella città come un’autorità duale, spartita tra lui e il popolo.
Quest’aspetto, aperto al ruolo anche dei «molti», è di solito assente o sottovalutato, perché s’insiste molto più, e a volte esclusivamente, sul potere incontrastato di uno solo nella città; ma è Pericle stesso, nei suoi discorsi, a ricordare come egli abbia agito di concerto con il popolo, tanto che i molti, non possono ormai recedere da ciò che anche essi hanno voluto («accusate me perché vi ho spinto alla guerra, ma accusate anche voi stessi che insieme a me l’avete decisa» (2, 60, 4). Si parlerà di mistificazione e di cattiva retorica, ma i discorsi di Pericle, pronunciati dinanzi al popolo e tesi a persuadere, sarebbero stati controproducenti e subito smascherati, se questa compartecipazione al potere decisionale dei molti fosse stata del tutto menzognera. Certo la politica, e specie quella democratica, è inseparabile da una certa dose di retorica e dall’uso non infrequente di espressioni enfatiche; ma chi muove con più audacia e anche competenza queste critiche, poiché il vero è misura di sé e del falso, forse da qualche parte avrà visto, come temine di paragone, una pura e incontaminata democrazia, sulla cui base sarebbe allora facile la critica agli «inganni» di Pericle.
In generale ai cittadini che vivono in democrazia chiediamo troppo. Tacitamente supponiamo che vi siano in essi sia difficili conoscenze, sia straordinarie e del tutto spontanee risorse di energia morale, anche se i grandi scrittori politici «realisti» hanno sapientemente avvertito dell’illusorietà di simili presupposti, dell’impossibilità di «changer la nature humaine». Ma se così è, pare necessario, escludendo qui ogni ingenua utopia, pensare dei sostituti o delle supplenze: un discorso scivoloso che pur bisogna affrontare. A confronto e a sostegno di ciò accennerò ora a due esempi: uno della prima modernità, l’altro vicino (o quasi) alla nostra attualità.
Nel capitolo I 9 dei Discorsi, in particolare, Machiavelli risolve da par suo il complesso problema dell’Uno e dei molti, proponendo appunto una repubblica democratica basata su un potere duale. Che l’inizio, l’«ordinamento» di una repubblica debba avvenire ad opera di un singolo, è detto già nel titolo del capitolo: a «volere ordinare una republica» è «necessario essere solo». Il precetto è posto addirittura come «regola generale», per la quale «mai o di rado occorre che alcuna republica o regno sia da principio ordinato bene […] se non è ordinato da uno; anzi è necessario che uno solo sia quello che dia il modo e dalla cui mente dependa qualunque simile ordinazione». Al precetto fanno seguito pressanti consigli al legislatore: quello, soprattutto, che voglia «giovare non a sé ma al bene comune», alla «comune patria». Persino gli atti nefarii, come quello di Romolo che uccise Remo, devono essere «scusati» quando il fine del principe sia così alto.
E il problema della successione, e i molti? Per un verso il cerchio sembra chiudersi intorno all’Uno che detiene attualmente il potere, il quale, «prudente» e «virtuoso» com’è, non deve lasciare a un altro «quella autorità che si ha presa», perché, «sendo gli uomini più proni al male che al bene, potrebbe il suo successore usare ambiziosamente quello che virtuosamente da lui fusse stato usato». Ma questa cautela prelude in realtà a un profondo cambiamento di regime o d’ordine, che vede affievolirsi il tratto principesco a favore dell’azione democratica dei molti. L’Uno, il principe, e già Romolo con la fondazione del senato, si svestì di gran parte del suo potere per cederlo ai molti, ai cittadini e alle leggi, facendo perciò una kènosis della sua autorità, riservandosi il solo potere di «comandare agli eserciti» e di «ragunare il Senato» (I 9). I Discorsiuniversalizzano l’importante esperienza storica del regno di Francia: così in I 16, riferito solo alla Francia, il re conservò il potere «dell’armi e del «danaio», privandosi d’ogni altra cosa, mentre in Princ. IX, al re di Francia sembrano addirittura riservate solo le «cose di grazia». Pertanto, «se uno è atto a ordinare, non è la cosa ordinata per durare molto quando la rimanga sopra le spalle d’uno, ma si bene quando la rimane alla cura di molti, e che a molti stia il mantenerla». Dell’incapacità dei molti a fondare un ordine, Machiavelli fornisce pure la principale ragione, «causata dalle diverse opinioni che sono fra loro».
Si deve certo richiamare il fatto che l’iniziativa spetta qui solo al principe legislatore o che è garantita da un sistema «costituzionale» di leggi; ma ai molti rimane pur sempre un compito specifico e importante, come quello di mantenere concordemente l’ordine vigente. Anche qui dunque un potere duale di popolo e sovrano, sia pur non simultaneo. Pericle certo mantiene, informalmente, enormi poteri, ma, d’altra parte, è solo il popolo, «la cura di molti», che può conservare efficacia e durata agli ordinamenti voluti dal leader. Il «capo» non è nascosto, si badi, ma opera alla luce del sole, sulla pubblica piazza, con l’esibizione delle proprie capacità, sebbene sia privo di ogni convalida legale, che certo dissolverebbe però la stessa forma democratica, privando il popolo anche dei poteri che possiede, quali che essi siano. Del resto, la democrazia è una forma «paradossale», necessaria sì ma contraria persino al buon senso comune, come Platone sapeva, che costituisce una sfida al tradizionale, forte e chiuso, potere ottimatizio, tanto che non deve far troppo scandalo se talvolta si allontana dalle pure e ideali (a volte meramente libresche) forme di potere.
Torniamo a Rousseau del Contratto sociale sopra citato, alle difficoltà per cui è necessario che si faccia posto alla figura del legislatore, dal momento che il popolo è una «moltitudine cieca, spesso ignara di ciò che vuole, perché di rado sa cosa gli giova»: persino la «volontà generale», pur essendo «sempre retta», ha bisogno di un giudizio «illuminato» che la guidi, che le presenti «gli oggetti come sono e talora come devono apparirle», mostrandole la «buona strada che cerca», contro le «lusinghe delle volontà particolari» e contro «l’attrattiva dei vantaggi presenti», e così continuando circa il bisogno universale di «guida». Anche qui si assiste a un difficile dualismo di poteri: quello della volontà generale e quello del legislatore che, pur dovendo essere «un uomo eccezionale», non costituisce una magistratura né fa parte della «costituzione» o della «sovranità». Lasciando pur stare ora la pesante vena pedagogica e di comando, forse inattingibile, per com’è formulata, difficile da accettare in democrazia, torniamo sulle difficoltà che sempre caratterizzano il cammino della forma democratica.
La democrazia dei moderni, a parer mio, differisce da quella antica soprattutto per via della centrale presenza del partito politico (che mi pare, nella sua forma matura, una specifica «invenzione» del movimento operaio, un suo obiettivo diretto e consapevole): è il partito che fornisce soluzione ad alcuni dei gravi problemi del sistema democratico, che abbiamo indicato sopra seguendo Rousseau. Facilmente s’intuisce quali siano gli scogli maggiori lungo la via della costruzione e del mantenimento di una democrazia almeno decente. Il primo è un grave difetto di conoscenza: come oggi vediamo bene, il cittadino è chiamato a informarsi (e a misurarsi) su un numero incredibilmente alto di problemi molto difficili: da soli si è perduti, e nemmeno una certa propensione tocquevilliana a stare insieme, aggregando esperienze, né un’opera di reciproca istruzione paiono sufficienti. Ma il partito, finché è durato nella capacità di assolvere in qualche modo a questo ruolo, è stato, appunto, anche un grande mediatore dei saperi, idealmente capace di ridurre la complessità dei problemi a forme più semplici e comprensibili, di fare «scuola», com’era per esempio nei grandi istituti d’istruzione operaia della socialdemocrazia tedesca d’ante guerra mondiale (la prima ovviamente, precedente la catastrofe della votazione dei crediti di guerra).
E di qui, dall’accendersi della conoscenza, nasce anche la volontà di agire moralmente, consapevolmente, sul proprio mondo e sul mondo, che non è affatto un’attività solo della coscienza spontanea, ma dev’essere anche costruita e soprattutto sorretta. Ora, per tornare brevemente al nostro tema, non farò torto al lettore di spiegare come e perché, seppure alla lontana, per speculum et in aenigmate, il Pericle di Tucidite sembra assolvere a compiti in qualche modo simili a questi. Ed è anche perciò che la sua opera deve essere giudicata con più generosità, dal momento che, quasi con allusione a un moderno partito politico (a parte bisognerebbe ora parlare del centralissimo tema di Pericle e l’impero), dovette pour cause esercitare l’arte difficile della mediazione e persino forse della doppiezza.
[1] Si v. la discussione di quest’articolo da parte di Giorgio Cesarale nello stesso fascicolo e proseguita su FiM.
[2] «Il senso dell’etico-religioso. Intorno all’Enciclica Fratelli tutti», in Fratelli tutti? Credenti e non credenti in dialogo con Papa Francesco, 2022, a c. di Debora Tonelli, pp. 97-112 (contributi anche di p. Antonio Spadaro, dir. di «Civiltà cattolica» e Gianni Vattimo).
3 Mario Reale, Laicità, in AA.VV., Le idee della sinistra, Editori Riuniti, 1992; Id., Sulla laicità. Considerazioni intorno alle relazioni tra atei e credenti, in «Novecento» 1992, pp. 3-34; ma non sarebbe male se la Rivista progettasse un fascicolo su Laicità o Secolarizzazione. etc.
[4] Sulla complessa filologia relativa al Pericle di Tucidite, brillanti esempi si trovano, ne Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi, Marsilio Editori, quarta ed., testo greco e tr. it. a fronte, a c. di Luciano Canfora, Marsilio Editori, quarta ed. 1991.
[5] V. l’importante Domenico Musti, Polibio e l’imperialismo romano, Napoli 1978.