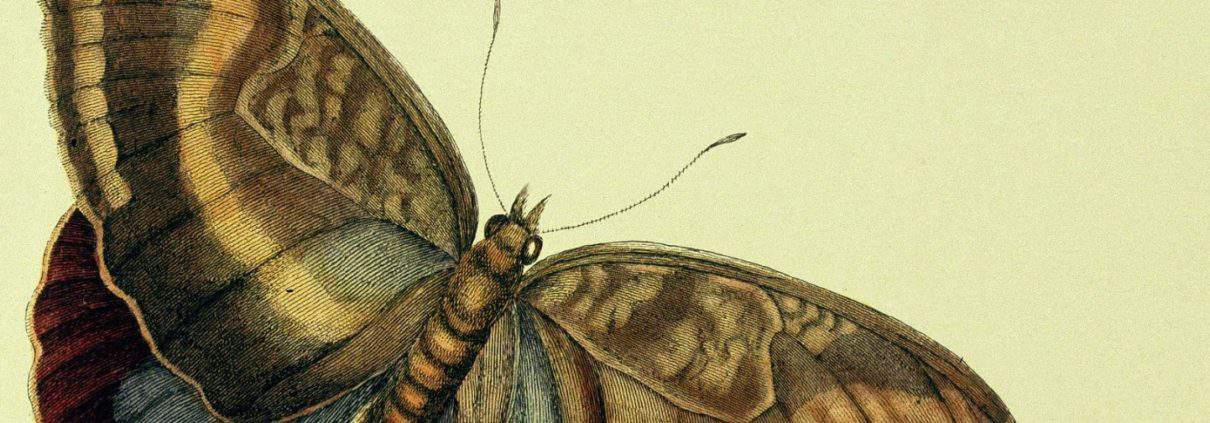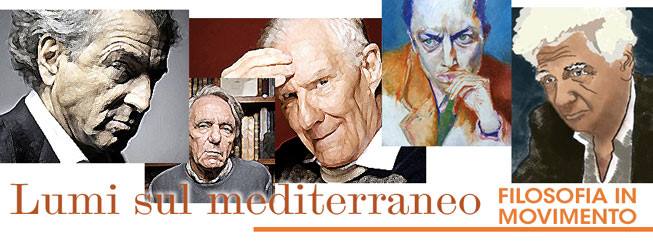Lady Sapiens. Come le donne inventarono il mondo
di Giulia Carletti
Un’antropologa, uno storico e un regista sono gli autori di Lady Sapiens. Come le donne inventarono il mondo (Piemme, 2022), un saggio che, come annuncia il sottotitolo originale (Enquête sur la femme au temps de la Préhistoire: Indagine sulla donna ai tempi della preistoria) si propone di tracciare scientemente un’alternativa alla narrazione tradizionale di questo antichissimo e lunghissimo periodo dell’umanità: il Paleolitico (da ca. 2,5 milioni a ca. 15-12 000 anni fa). La vita dell’Homo Sapiens maschio, predatore e soggiogatore, è stata a lungo la più rappresentata, non solo come oggetto di indagine degli studi preistorici, ma anche come immagine proposta nella cultura visiva, dalla pittura ottocentesca al cinema. Una giovane donna, chiamata “lady sapiens”, componeva l’altra metà di esseri umani che popolavano quella parte di mondo antichissimo e di cui, gli autori polemizzano, ci si è occupati poco o secondo la lente degli stereotipi di genere: dall’impalcatura di una rigida divisione sessuale delle mansioni fino ad una agognata fertilità femminile deliberatamente attribuita alle menti degli uomini preistorici. Nella prefazione, Sophie A. de Beaune ci dice: “tra la visione tradizionale della femmina schiacciata sotto il giogo maschile e quella, opposta, di una donna cacciatrice in tutto e per tutto simile a un uomo, manca un ritratto rigoroso e più sfumato che provi a integrare le fonti archeologiche con gli approcci etnografici” (p. 13). A un anno dalla pubblicazione de La Preistoria è Donna: Una storia dell’invisibilità delle donne (tradotto da Giunti, 2021), il libro cita ampiamente la storica francese Marylène Patou-Mathis, contribuendo così alla decostruzione di quel retaggio che vede il dominio dell’uomo sulla donna e le guerre fra esseri umani come presenti “dall’alba dei tempi”.
L’idea del sapiens paleolitico, preda di pulsioni aggressive e animali contro i suoi simili e contro la donna, è stata a lungo prevalente tra gli studiosi a partire dalla fine del Settecento, più che di questa disciplina, della mente, che iniziavano già a impostare una linea culturale pseudo-evoluzionistica che vedeva nella natura atavicamente scimmiesca la causa della pazzia umana, fuori dal controllo della ragione. Di conseguenza, essendo stato il cranio “centro delle ricerche sull’anima e sull’intelligenza, era abbastanza naturale che gli studiosi del XIX secolo si concentrassero sui teschi per tentare di comprendere e di identificare i nostri antenati; su quegli stessi teschi che erano stati utilizzati per difendere teorie evoluzionistiche che ai giorni nostri risultano alquanto imbarazzanti” (p. 36). A partire da inizio Ottocento, tali idee fecero breccia tra i fisiognomisti fino ad arrivare agli psicoanalisti, tutti autori di cui Patou-Mathis non aveva esitato a riportare le affermazioni più feroci contro la donna, debole per natura, difettosa e malata fin dalla nascita, quando non idealizzata, priva del corpo e di una sua sessualità. E la nascita dell’umanità sta proprio nel periodo che ci vide separarsi dalla filogenesi animale, un periodo conteso a volte più intellettualmente e culturalmente che scientificamente, dalle diverse discipline, quasi a voler avere un accesso per la verità umana, i suoi pensieri, i suoi “istinti”, per spiegare il comportamento e la mente di oggi.
La suggestione è che, invece, tale tipo di conflitti sociali presero maggiormente piede con la sedentarizzazione dei gruppi umani e con la loro organizzazione collettiva nel Neolitico, durante e dopo i processi di civilizzazione. Come anche suggerito da Patou-Mathis e come ci spiegano le autrici e gli autori del libro, non vi è un insieme consistente di tracce provenienti dal Paleolitico tale da riuscire a confutare un’ipotesi di pacifica convivenza tra tribù e tra uomo e donna cacciatori-raccoglitori, o, quanto meno, le tracce rinvenute spiegherebbero più che altro disuguaglianze materiali (ad esempio nelle mansioni, nell’alimentazione, nel vestiario), non tanto quelle immateriali (legate ai diritti sessuali e riproduttivi, la famiglia, la rappresentazione “artistica” della donna, etc): ma per gli autori tali disuguaglianze non bastano a definire la civiltà paleolitica come patriarcale (né tanto meno matriarcale). Un’immagine diversa di donna, però – forse ben prima della comparsa di Homo Sapiens! – è ciò di cui la nuova paleontologia e la neonata disciplina dell’archeologia cognitiva si stanno occupando.
Partendo dalla recente scoperta della Venere di Renancourt (ca. 27.000 anni fa), avvenuta in Francia nel 2019, Lady Sapiens riporta quelle ricerche sul substrato culturale del periodo preso in esame, passando in rassegna vari studi e report di scavi, insieme alle diverse ipotesi dei ricercatori su credenze e pensieri che potrebbero aver avuto luogo tra le comunità umane del Paleolitico. Il risultato è, fra gli altri, quello di decostruire le interpretazioni ottocentesche che a lungo hanno regnato (e in parte ancora oggi si fanno presenti) non solo nell’immaginario collettivo, ma nella stessa disciplina che, sotto forma di ipotesi fantasiose e mascherate da scienza della mente, si è spesso basata su prove insufficienti o inadatte a tracciare una solida linea evolutiva della donna sapiens e delle sue rappresentazioni nel Paleolitico. La stessa dicitura di “Venere”, dea bianca e occidentale, nasce dai primi studiosi della Preistoria, disciplina figlia della fine del XIX secolo, come anche il nome stesso “preistoria”, nato a Parigi in occasione dell’Esposizione Universale del 1867.
Articoli e studi, in cui gli autori e le autrici illustrano i nuovi metodi di scavo e di analisi del dna e delle ossa grazie a nuove tecnologie del settore (che rivelano non solo il sesso ma anche lesioni ossee da stress lavorativo, il periodo di allattamento, etc), sono ampliamente citati, documentati e raccontati al lettore con un ritmo fluido e un linguaggio divulgativo che ben connette le varie discipline prese in esame (paleontologia, paleoetnopologia, etnografia, antropologia, sociologia, etc.). Ad accompagnarli, le varie ipotesi di ricerca che, sempre più frequentemente negli ultimi anni, sono volte a indagare quegli aspetti immateriali e “culturali” nei gruppi di cacciatori-raccoglitori che in passato sono sfuggiti allo studio della preistoria.
Ne esce fuori un’immagine di donna abbastanza distante da quella tradizionalmente fatta appartenere al Paleolitico, anche solo sessant’anni fa: una donna con competenze diversissime – anche altre rispetto a quelle maschili – spesso madre, parte attiva e fondamentale del gruppo, con una muscolatura molto più sviluppata di quello che si ritenesse (e che è molto interessante confrontare con le rappresentazioni di statuine che la vedono estremamente in carne, di cui parlerò più avanti). Tra i vari compiti vi era anche l’impegnativa concia delle pelli e la partecipazione alla caccia degli animali di piccola taglia (la più costante e fruttuosa per il gruppo), anche tramite la costruzione di trappole. Il loro coinvolgimento nella vita attiva era totale e “la dicotomia tra ‘uomo cacciatore’ e ‘donna raccoglitrice’, dunque, così come è stata presentata negli anni Settanta, appare caricaturale”, ci dicono gli autori e le autrici, in quanto “non vi è ragione al mondo per cui i gruppi preistorici dovessero privarsi del prezioso aiuto di metà della popolazione adulta durante la caccia” (p. 145).
Ma forse l’ipotesi che più ci incuriosisce è quella che vede lady sapiens detentrice di saperi e creatività. Da un lato, gli unici “reperti” lasciati volontariamente, e cioè le ipnotizzanti immagini nelle caverne, ci mostrano spesso mani impresse in negativo, come quelle della grotta di Pech Merle. Gli studi più recenti, tra cui quelli di Snow, rivelano (p. 173) che si tratterebbe di mani anche femminili e di bambini. Artiste quindi? Un’ipotesi estremamente affascinante, “nemmeno concepibile per gli studiosi del XIX secolo” (p. 171), ma che potrebbe apparire anche molto plausibile, poiché più compatibile con il tempo richiesto da una tipologia di compiti “femminili” che “maschili”. Dall’altro, recenti studi sul dna salivare e sui tessuti ci suggeriscono una competenza nelle primissime forme di arte medica basate sulla conoscenza e utilizzo di piante, vegetali e resine, facendo strada a ipotesi più “avventurose” che le vedevano sciamane ante litteram, come ipotizzato da Nicholas Conrad che riscontra un legame tra magia a uso medico e femminilità.
Attraverso i capitoli, i primi più generali focalizzati sui costumi dei sapiens paleolitici e gli ultimi più specifici sulla vita e le attività della donna paleolitica, la curiosità cresce parallelamente su due livelli. Il primo – non strettamente legato alla tematica femminile – si dipana lungo la fitta esplorazione di tutti quegli oggetti non strettamente legati alla funzionalità materiale, o di cui si mette in guardia da una scontata interpretazione di questo tipo. Il rinvenimento di calchi di tessuti, decorazioni, di statuine forate, fino ad arrivare alle pitture rupestri e bassorilievi, apre la strada a ipotesi non solo su costumi ed esigenze estetiche, ma anche sulle relazioni tra individui, sugli aspetti sociali di potere o status, sui rapporti tra i primi esseri umani. Non è detto che l’orientamento all’utile fosse la caratteristica distintiva dell’uomo e della donna del Paleolitico. Gli autori contestano fermamente l’ipotesi che li vede schiavi dei soli bisogni fisici che li rende simili ai nostri antenati animali, ai nostri discendenti scimpanzé e oranghi, dalla quale filogenesi ci separammo milioni di anni fa. L’impiego di molto tempo per realizzare vestiti e pelli, in epoche in cui il clima non li rendeva ancora fondamentali alla sopravvivenza, fa nascere domande come: il vestiario, già nei primissimi millenni di vita del genere umano, poteva acquisire una funzione simbolica, di status, di socialità? La pelle stessa, l’organo più esteso del corpo umano, pare venisse trattata meticolosamente a giudicare dalle tracce di pigmenti rinvenuti nelle tombe. Come suggeriscono gli autori, esso era già allora “un vettore di comunicazione tra gli elementi e gli esseri viventi” (p. 60). La pelle, dunque, era già nella preistoria oggetto di un pensiero simbolico, affettivo e relazionale? Poteva contribuire a formare un’immagine culturale, terreno unicamente umano di sensazioni ed emozioni nel rapporto con gli altri, anziché ad avere una funzione prettamente protettiva del corpo?
Il secondo riguarda invece il cambio di prospettiva che il libro tenta di operare sugli uomini e la loro convivenza con le donne nel Paleolitico. Come accennato prima, quelli che gli autori definiscono come “stereotipi” ci dicono qualcosa sulle idee erroneamente predominanti della stessa natura umana che vedono nella “animalità” e “aggressività” dei preistorici una legittimazione per una ipotesi di natura umana ancestralmente e geneticamente violenta, aggressiva e patriarcale. Lady Sapiens decostruisce proprio l’idea stessa di esseri umani non solo orientati “per natura” alla funzionalità – dediti quindi unicamente al procacciamento del cibo e alla soddisfazione dei bisogni fisiologici (provviste, riparo, difese contro animali feroci) – ma anche alla sopraffazione sui propri simili e incapaci di pensieri affettivi e cognitivi non violenti. Esso si aggiunge così a tutta quella linea di ricerca della moderna antropologia, paleontologia, ma anche psichiatria e psicologia che mira a superare tali retaggi culturali, che vedrebbero l’attività della mente umana incentrata esclusivamente sul “controllo” di una presunta insita animalità perchè “atavicamente” aggressiva e violenta contro l’altro, contro la donna.
Il passaggio sulla sessualità della donna preistorica (a metà libro, nei capitoli “Sensualità e sessualità” e “Fondare una famiglia”) è significativo da questo punto di vista. E’ il caso di citarlo direttamente: “In effetti, il nostro bipedismo perfetto ha fatto sì che i segni dell’estro, che nelle femmine dei primati non umani indicano di solito il periodo fertile e provocano una risposta istintiva nei maschi, divenissero invisibili” (p. 73). Una sessualità non legata alla riproduzione, ma alla ricerca di rapporto? Nel cosiddetto “salto evoluzionistico”, nella separazione cioè con la filogenesi animale, c’è stata forse una “psichizzazione” della sessualità, del rapporto con l’altro? In questo senso, il dubbio degli autori riguarda anche il considerare la fertilità una caratteristica desiderabile a priori per lady sapiens: non è detto che nel Paleolitico una famiglia numerosa fosse un vantaggio e, men che meno, così comune come si è soliti pensare. La conoscenza e il controllo del proprio corpo, rispetto soprattutto alla gravidanza, pare abbia origini più antiche di quanto pensiamo, e sono al centro di ricerche ed ipotesi che il libro riporta soprattutto attraverso gli studi di Coquet, ricercatrice in antropologia culturale. L’impiego di metodi contraccettivi per impedire la fecondazione oppure il ricorso a metodi abortivi (pp. 112-114) sono un’ipotesi molto probabile se guardiamo agli studi etnologici delle popolazioni indigene con scarsi contatti ma, soprattutto, se esaminiamo le analisi di alcuni rinvenimenti di scheletri in cui appaiono tracce di un albero tropicale tra gli escrementi, pianta il cui infuso provoca l’aborto (p. 196). Ciò fa pensare ad una trasmissione di conoscenze che, Conard immagina, potevano passare anche attraverso la produzione di piccole statuine come, per esempio, la Venere di Hohle Fels (ca. 35 mila anni fa). Inoltre, dall’analisi isotopica dello smalto dentale effettuata da Vincent Balter, è possibile determinare che l’allattamento di Homo erectus e australopitechi avvenisse fino ai tre o quattro anni di vita: gli autori ci dicono che sia improbabile che il periodo di allattamento di Lady Sapiens si discosti molto da questo, anche se studi sul Paleolitico superiore devono essere ancora realizzati (p. 117). E’ possibile pensare che le donne paleolitiche avessero meno figli di quanto si pensasse, o comunque meno di quanto i rinvenimenti del Neolitico rivelino (p. 115). Basti pensare che il passaggio alla posizione eretta, insieme ad altri cambiamenti morfologici lungo l’evoluzione, probabilmente avevano reso il parto più rischioso rispetto ai periodi passati (p. 108): una plausibile difficoltà nella vita della donna paleolitica e, quindi, ostacolo alla sopravvivenza dei membri del gruppo. Una interessante suggestione ci arriva poi dall’invenzione del marsupio, strumento utile per potersi muovere in tranquillità dopo il parto: “legarsi il neonato sul dorso per liberare le mani permetteva effettivamente alla madre, una volta superati i postumi del parto, di essere di nuovo disponibile a svolgere le attività del gruppo” (p. 131).
Oltre a indagare su fertilità e maternità – i cui studi si basano più sull’analisi delle ossa e del dna – il libro apre uno sguardo sulla “produzione culturale” paleolitica, nient’altro che le più antiche rappresentazioni della figura femminile, sulle quali diversi studiosi, negli anni, hanno speculato e avanzato molteplici ipotesi: dalla dea madre a figure propiziatorie. Di certo, la stilizzazione della figura umana e, quindi, di quella femminile ci parla della capacità di un pensiero simbolico e astratto. Un aspetto che, forse, avrebbe potuto godere di più spazio, ma che comunque è arricchito da diversi studi e ricerche, non limitando l’immaginazione di chi legge. Nel Paleolitico superiore, infatti, il realismo, o comunque un qualche intento realistico di rappresentazione, appartiene alle figure animali piuttosto che a quelle umane. Tra queste, che costituiscono appena il 6% degli artefatti preistorici fino ad oggi conosciuti, l’immagine femminile rimane la più rappresentata, sia nelle pitture che nelle statuine a tutto tondo e nei bassorilievi. Spesso essa appare avente accentuati attributi sessuali e maternali (come ventre, genitali e seno, è proprio il caso della Venere di Renancourt), e/o affiancata alle raffigurazioni di animali – associazione perdurata per decine di millenni (dalla donna/bisonte/felino a Chauvet, per esempio, ca. 38.000 anni fa, fino ai bassorilievi di Roc-aux-Sorciers, risalenti al periodo Magdaleniano, l’ultima cultura del Paleolitico superiore europeo, ca. 15 mila anni fa). Ciò che caratterizza molti artefatti di questo tipo è, dunque, proprio l’attenzione rivolta alla rappresentazione di attributi sessuali femminili, esageratamente marcati oppure, anche se raramente, di un realismo ricercato (come si vede dalle rappresentazioni di Roc-aux-Sorciers, ma soprattutto nella bizzarra composizione della cosiddetta Origine del Mondo a Fontainbleau). Ciò non deve invitarci, dicono gli autori attraverso i pensieri di Nicholas Contrad e Catherine Schwab, ad associare tali raffigurazioni ad una preistorica “pornografia”, quasi come, di nuovo, a evocare una atavica e sempiterna oggettivizzazione dei corpi femminili. Lady Sapiens mette in dubbio anche l’univocità dell’ipotesi di una prodromica “dea madre” neolitica, come quella avanzata dalla nota studiosa Mirija Gimbutas, dando anche spazio alle voci degli studiosi Nicholas Conard e Denis Vialou. Il primo invita a una contestualizzazione storico-sociale di tale interpretazione – come fu quella preistorica di inizio Ottocento negli anni ‘60-’70 – “per poter misurare quanto la propria mentalità e la moda influenzino gli studi sulla Preistoria” (p. 201) e a pensare a una “analogia del mondo che i nostri avi abitavano” (p. 203). Il secondo spiega che “è pericoloso immaginare una divinità sopravvissuta per millenni senza che il ricorso alla scrittura potesse trasmetterne il culto di generazione in generazione” (p. 203). Oggi le interessanti ricerche dell’equipe di Médard Thiry, effettuate nel 2020 sui bassorilievi di questa curiosissima Origine del mondo ante litteram nella grotta di Fontainbleau (delle incisioni che richiamerebbero la figura di una vulva con annessa attaccatura delle cosce al ventre), suggerirebbero l’idea di un sistema idraulico artificiale che, quindi, avrebbe intenzionalmente avvicinato lo scorrere dell’acqua all’incisione della parete: si può forse pensare, come intuitivamente suggeriscono gli autori e le autrici del libro, più che alla simbolizzazione astratta di fertilità, a quella più precisa del momento della nascita, evocando la rottura delle acque? (p. 206).
Da lettrice, avventurarsi tra le civiltà preistoriche più antiche, quelle del paleolitico, scoprirne anche solo minimi aspetti provoca reazioni diverse. Da un lato, la tentazione è quella di partire con l’immaginazione, di fare le più disparate ipotesi sugli stili di vita dei nostri antenati, di ricercare addirittura delle spiegazioni sulla nostra natura umana di sapiens. Dall’altro, c’è la spinta alla ricerca e ai freni che questa, spesso, impone, sia per mancanza di prove, sia per retaggi culturali con i quali la disciplina della preistoria è nata. Forse un più frequente e completo impiego di datazioni dei vari reperti (anche se le prime quattro pagine sono occupate da una bella timeline preistorica) avrebbe aiutato meglio nell’orientamento in un periodo di tempo narrato che si fa molta fatica a immaginare, andando dai 100 mila ai 15 mila anni avanti Cristo. Tuttavia, basta fare riferimento alle fonti per ritrovarci subito ben forniti di date e reperti.
Lady Sapiens è un libro che può essere letto sia tutto d’un fiato, in virtù della sua scorrevolezza di ritmo e di linguaggio, sia a piccoli passi, per approfondire una questione alla volta, essendo ricco di riferimenti e di rimandi a fonti primarie e secondarie. Il “facile entusiasmo” per il quale il libro potrebbe essere (ed è stato) accusato riguarda forse più il tono a tratti celebrativo della narrazione che la metodologia scientifica sulla quale si basa. Ciò che il libro si guarda consapevolmente dal fare, infatti, è proprio creare (di nuovo) un’impalcatura dogmatica sulla realtà della donna preistorica appiattendosi su una presunta società matrilineare o matriarcale: non si cerca di ribaltare la preistoria, perché esiste una carenza di ritrovamenti, anche da parte di chi l’ha narrata “al maschile”! Piuttosto si cerca di far riflettere a quali visioni è stato concesso di avere spazio e a quali no, a parità di evidenze e reperti archeologici e paleontologici. L’invito è quello a una ricerca consapevole, che è ancora aperta, anzi, apertissima (p. 178). Una disciplina come l’archeologia preistorica deve fornire parecchi dati per definire bene teorie paleoantropologiche. Per ora, gli autori e le autrici hanno dato spazio a ipotesi diverse rispetto a quelle narrate da più di cento anni di studi preistorici. Sta al lettore valutare, ponderare e farsi un’idea non solo sulla scelta di una narrazione “convincente” sulla vita della donna preistorica, ma soprattutto su ciò a cui invitava anche Patou-Mathis, e cioè sulla preistoria come disciplina.