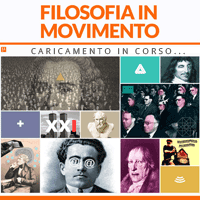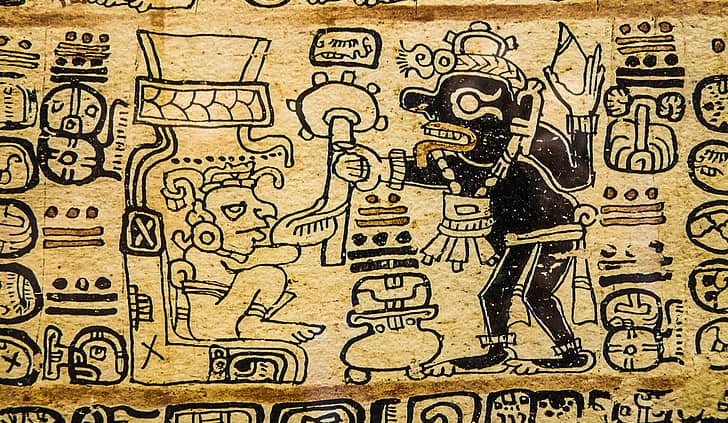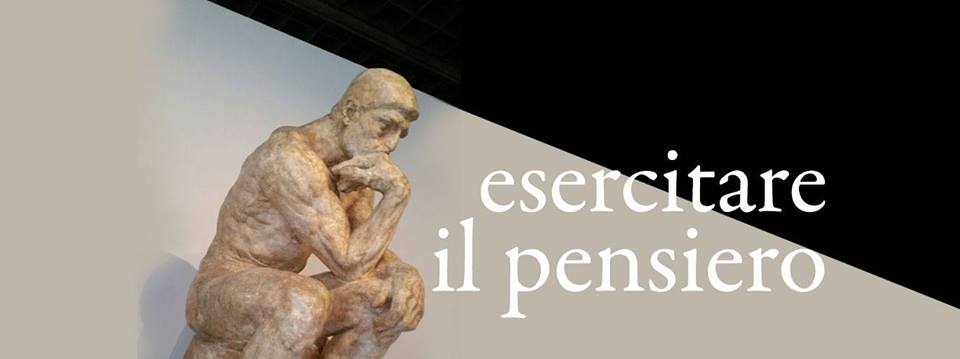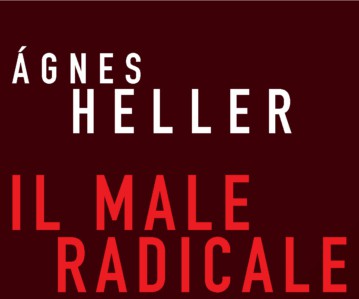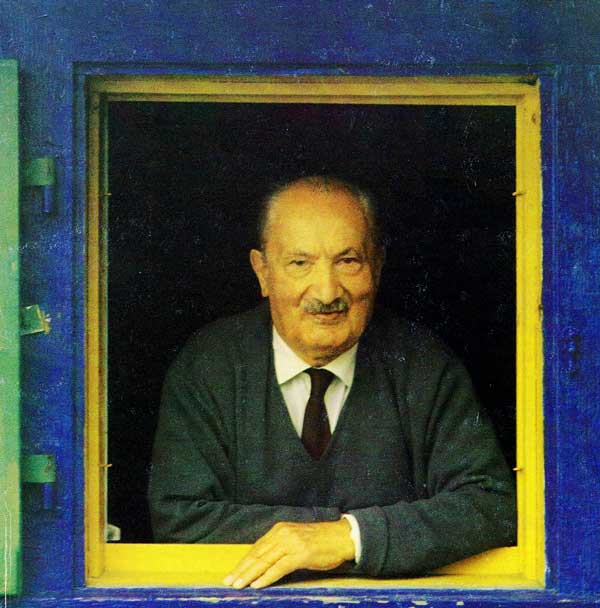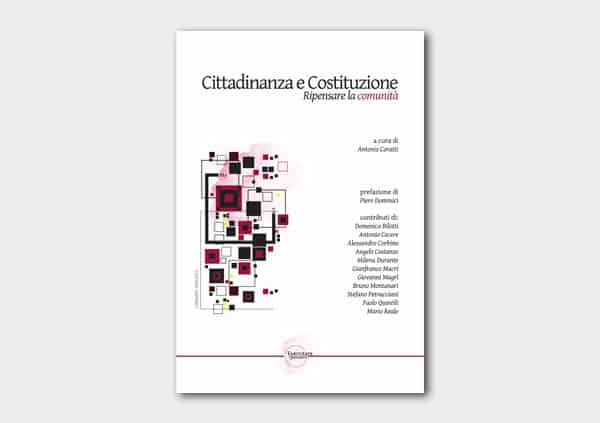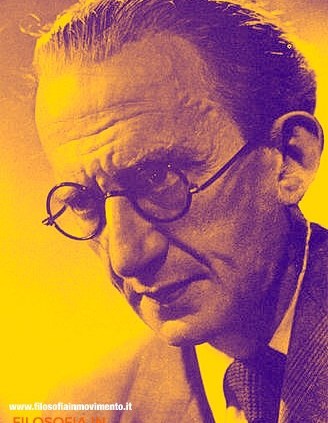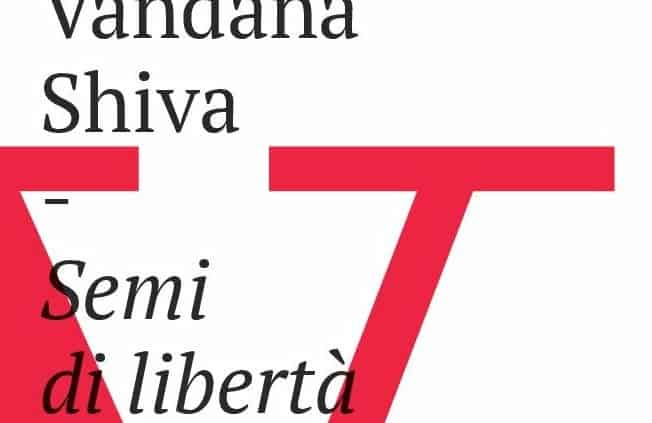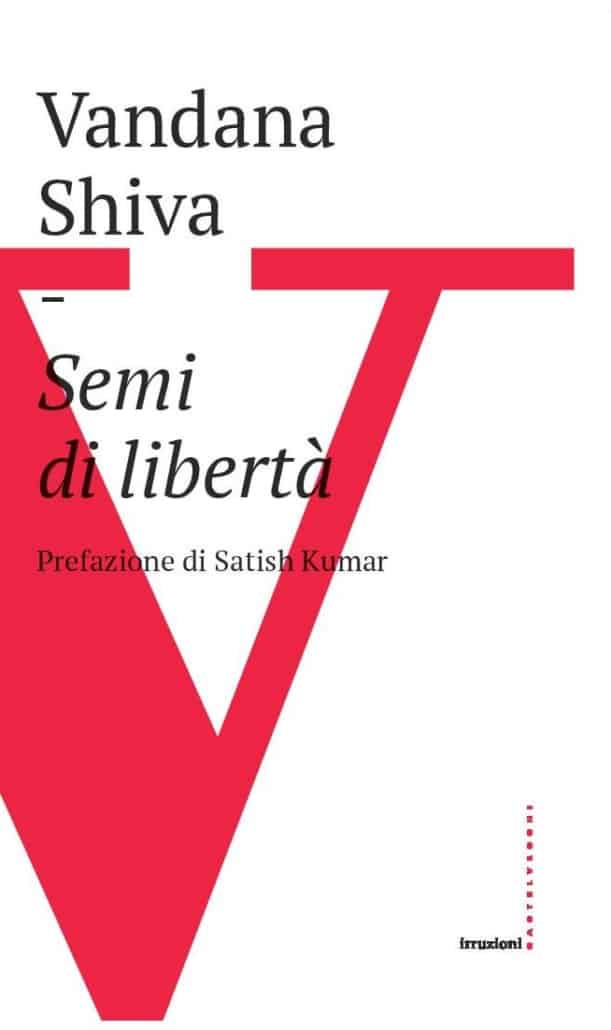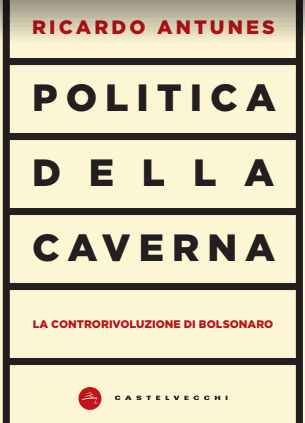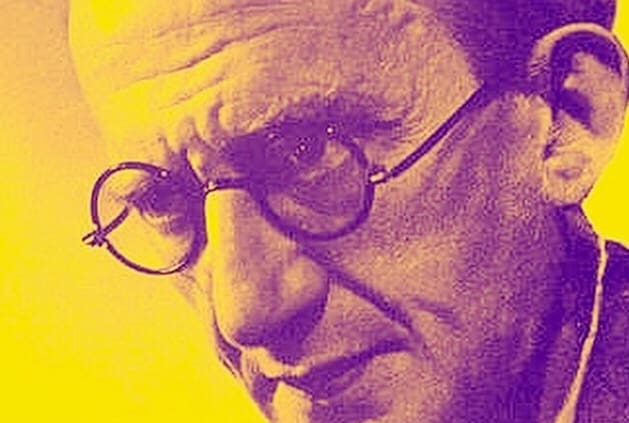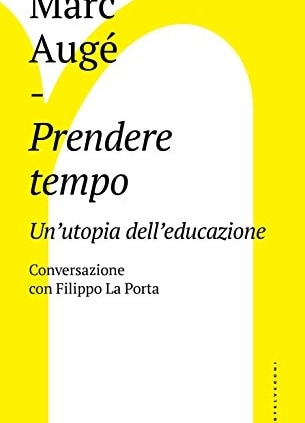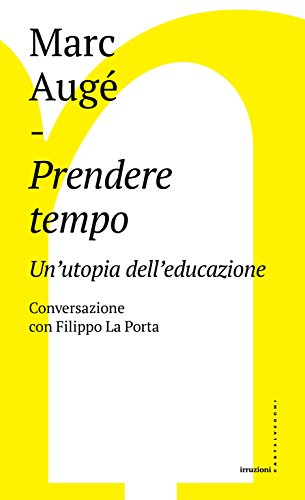di Anderson Deo[1]
(Traduzione in italiano a cura di Antonino Infranca)
I risultati delle elezioni generali in Brasile, nell’ottobre 2018, confermarono qualcosa che per molti sembrava impossibile. Dai militanti sociali agli analisti politici e agli intellettuali, di vari orientamenti ideologici, pochi – o addirittura rari – furono quelli che si arrischiarono ad affermare nel corso della campagna elettorale, che Jair Bolsonaro presentava condizioni tali da essere eletto. Forse, pressate dal desiderio che la tragedia non si realizzasse – principalmente l’ampio settore politicamente alla sinistra – le analisi puntavano all’impossibilità dell’elezione di un candidato che esprimesse ciò che di più reazionario e, pertanto, dichiaratamente antidemocratico, si è prodotto nel paese, in tutte le sue sfaccettature di disumanità che si esplicita mediante la barbarie imposta dal capitale. Intanto, così come annotava Karl Marx nella sua Critica del programma di Gotha, «ciascun passo del movimento reale è più importante che una dozzina di programmi», e non captando il “movimento reale” nella sua dinamica e processualità, le risposte pratico-politiche offerte, soprattutto dal campo democratico-popolare, non furono sufficienti per sbarrare l’avanzata della candidatura di carattere fascistizzante.
Il libro di Ricardo Antunes si caratterizza fondamentalmente come un primo sforzo di comprensione della dinamica sociale brasiliana, nelle sue complesse e intricate dimensioni, che portarono all’elezione di Bolsonaro. Contando sulla accurata traduzione di Antonino Infranca, il testo fu redatto durante il primo anno di governo che è iniziato il 1 gennaio 2019. Il testo percorre la dinamica e la riproduzione dei fatti, cercando di comprendere gli avvenimenti politici e sociali al di là della loro manifestazione fenomenica, ossia al di là della loro apparenza empirica, in uno sforzo di analisi di ciò che György Lukács identificherebbe come l’essere-proprio-così della totalità in questione. Esprime, pertanto, la caratteristica di uno scritto “nel calore del momento” che apporta possibilità di analisi e prassi politica. Con ciò, come è caratteristico degli scritti di Antunes, riflette elementi essenziali della singolarità nella formazione sociale brasiliana, le sue connessioni e dinamiche interne che danno forma alla particolarità storica di quel paese, nel suo processo di interrelazione di universalità nella riproduzione socio-metabolica del capitale.
Con la chiarezza e simbologia metaforica che gli è peculiare, Antunes enuncia già nel titolo dell’opera il contenuto storico di ciò che si annuncia come il governo di Bolsonaro: un’immersione sociale nelle oscure profondità di una caverna, come un momento di approfondimento della “controrivoluzione preventiva” in corso nel paese dopo il Colpo di Stato civile-militare del 1964. La caverna, nella oscurità che essa rappresenta, identifica la regressione político-culturale nella quale il paese entra con l’arrivo al potere di un governo che porta il marchio del discorso religioso della Teologia della Prosperità nella sua variante Neopentecostale, che riproduce il discorso fascistizzante dell’eliminazione di ogni e qualsiasi forma di manifestazione ideologica di sinistra, soprattutto comunista, di un fondamentalismo religioso di persecuzione delle donne, di riproduzione del razzismo e di discriminazione violenta della comunità LGBT e, fondamentalmente, di attacco ai diritti sociali storicamente conquistati da lavoratori e lavoratrici in Brasile.
La distribuzione dei capitoli analizza inizialmente il senso storico della dittatura militare, di carattere particolarmente bonapartista, che entra in vigore nel paese tra il 1964 e il 1985. Identifica, a partire da un’importante sintesi di Florestan Fernandes, il processo di controrivoluzione che si apre in quel periodo, come forma di frenare preventivamente qualsiasi prospettiva emancipatrice della classe lavoratrice, dove la borghesia rinuncia al potere politico in nome di un’autocrazia uscita dalle caserme, che riproduce una forma storica di sfruttamento intensivo ed estensivo della forza lavoro, ma, allo stesso tempo, rinforza la sua associazione subordinata ai nuclei centrali di riproduzione dell’imperialismo, principalmente degli Stati Uniti.
Analizzando il cosiddetto periodo di “ri-democratizzazione”, dove entra in vigore un ordine costituzionale fondato sui precetti liberali dello Stato di Diritto, identifica con chiarezza l’adozione del progetto neoliberale nel paese a partire dal governo Collor (1990-1992), dimostrando che lo stesso fu perfezionato e approfondito nei governi di Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), in un quadro internazionale di mondializzazione del capitale sotto l’egemonia della borghesia finanziaria. Il progetto del PT, riprodotto da Lula (2003-2010) e da Dilma Rousseff (2011-2016), è caratterizzato, per Ricardo Antunes, come una “politica di conciliazione tra entità sociali inconciliabili”, accennando al fatto che i governi di campo democratico-popolare non hanno rotto con la logica macroeconomica neoliberale, anche se è stato possibile avanzare con programmi di governo e politiche pubbliche di carattere sociale, come il Programma Fame Zero.
Fondamentale nell’analisi di Antunes, è la precisa connessione della realtà brasiliana nella riproduzione della totalità storica. Dato ciò, comprendiamo e riceviamo dalla lettura di questo libro, che il neoliberalismo è la risposta storica che la borghesia impone all’umanità di fronte alla crisi strutturale del capitale, che si esplica a partire dalla metà degli anni Settanta. L’offensiva del capitale sul lavoro – o come concepito dall’autore nei suoi scritti, “coloro-che-vivono-di-lavoro” – impone una serie di trasformazioni, nella forma socio-metabolica del capitale. Il processo di ristrutturazione produttiva, analizzato dall’autore nella sua vasta e proficua produzione teorico-politica nel corso di più di trenta anni, dà origine a una costante dinamica di precarizzazione delle condizioni di vita e di lavoro del proletariato, nelle sue diverse frazioni e morfologie, a livello mondiale. In forma parallela e concomitante, i complessi politici, che danno dimensione allo Stato borghese, riproducono, sempre più, un tipo di “democrazia di cooptazione” (nuovamente Florestan Fernandes), che identifichiamo come una forma autocratica istituzionale di dominio borghese, che si riproduce mediante i parlamenti e il potere giudiziario, in costante articolazione con i poteri esecutivi. Ecco l’elemento, nella nostra opinione, che il progetto di conciliazione del PT non rompe, al contrario, neppure affronta. E che finisce in maniera tragicomica, essendo lo stesso carnefice, nel Colpo di Stato che ha portato alla deposizione di Dilma Rousseff, nel 2016, così come l’arresto di Lula nell’aprile 2018.
Qui, ancora una volta, l’autore ci offre piste fondamentali per la comprensione dei fenomeni sociali, in modo da estrapolare l’apparenza degli stessi. Discutendo gli elementi costitutivi dell’articolazione politico-economica che hanno portato alla deposizione di Dilma, Antunes afferma che siamo “in un nuovo ciclo della controrivoluzione che rifiuta qualsiasi forma di conciliazione”; ossia, con l’approfondirsi della crisi strutturale e sistemica del capitalismo – pertanto una crisi della forma sociale retta dal capitale – iniziata dal 2008, osserviamo una nuova offensiva del capitalismo finanziario sulla ricchezza socialmente prodotta dal proletariato a livello mondiale. Dato che questa ricchezza è prodotta e realizzata all’interno delle frontiere dello Stato Nazionale, la borghesia si organizza e impone azioni politiche, più o meno violente, – in dipendenza dalle singole congiunture – per raggiungere i suoi interessi di classe. E qui, l’autore ci offre più di una metafora – brillanti come indizi – per comprendere l’essenza dei fenomeni politici così come questi ci si presentano nell’attualità. Dice Antunes: «Forse, si potrà dire che il capitalismo della piattaforma, dell’era digitale, informatica e finanziaria, somiglia molto alla protoforma del capitalismo”, questo perché nel suo periodo di accumulazione originaria (primitiva) il «capitale trasse la sua forza dall’intenso sfruttamento e spoliazione del mondo coloniale». E potremmo aggiungere che nell’attuale fase di offensiva del capitale, lo sfruttamento e la spoliazione si riproduce, anche, nelle “metropoli”, anche se con caratteristiche distintamente specifiche.
Questo ci sembra l’elemento nodale per comprendere la discussione che Antunes ci presenta sulle continuità e similitudini tra il governo di Michel Temer (2016-2018), emerso dal Golpe del 2016, e la sua continuità con Bolsonaro, in cui la figura del “super-ministro dell’economia” è, quanto meno, sintomatica. Paulo Guedes assume il ministero dell’economia con carta bianca per amministrare la ricchezza socialmente prodotta nel paese. È un autentico Chicago Boy, che ha preso lezione nelle università cilene negli anni della dittatura di Augusto Pinochet, e passa a proporre uno shock di profondo liberalismo nel suo contenuto ortodosso, o neoliberale, per il Brasile. Questo spiega l’appoggio della borghesia brasiliana alla candidatura di Jair Bolsonaro di fronte al disastro del suo allora candidato preferito, Geraldo Alckmin.
E di fronte a questo quadro, Ricardo Antunes conclude il suo libro fissando come sfida ai movimenti sociali e ai partiti politici di sinistra, la necessità di ricomporre le loro forme di lotta, comprendendo le nuove morfologie e necessità della classe lavoratrice, delle sue frazioni sempre più precarizzate, informali, “uberizzate”, nei loro ritagli e manifestazioni di genere e di razza, e che hanno bisogno di organizzare mediante un progetto politico di classe un confronto all’ordine del capitale, e che puntino a un progetto di emancipazione umana.
Così, il pubblico italiano ha nelle sue mani un bello e importante materiale che contribuirà alla comprensione dell’attuale quadro storico brasiliano. Il libro di Ricardo Antunes ci offre scintille vigorose, che possono venire a trasformarsi in vere fiamme, fuochi di luce che illuminano cuori e menti affinché lavoratrici e lavoratori brasiliani riescano ad attraversare e a rompere l’oscurità della caverna nella quale il Brasile – e perché non il mondo? – si trova.
[1] Dottore di ricerca in Scienze Sociali. Post-dottorato presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”. Professore di Teoria Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Economiche e del Programma di Post-laurea in Scienze Sociali dell’Università di San Paolo – Campus di Marília. Coordinatore del Nucleo di Studi di Ontologia Marxiana (NEOM/CNPq).