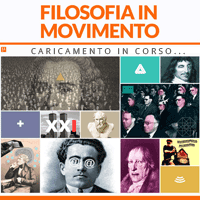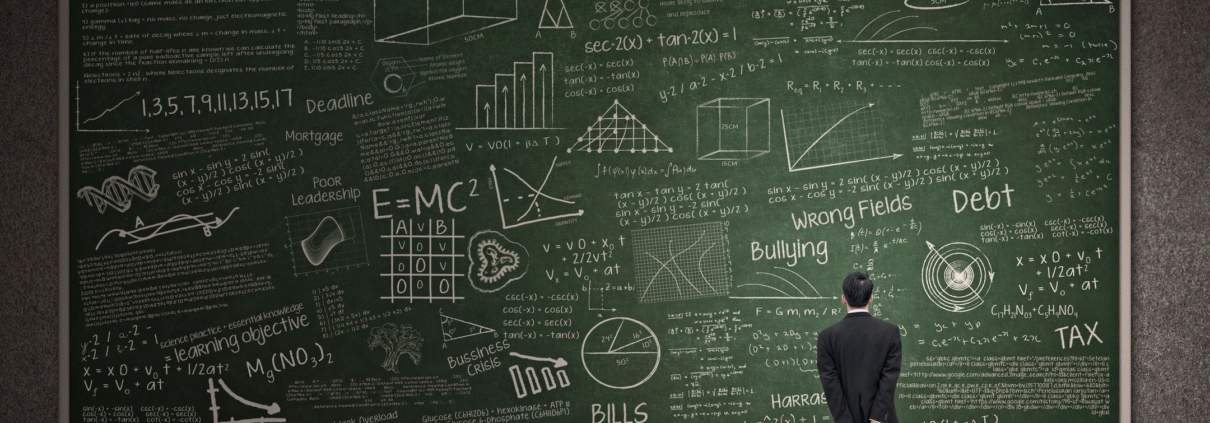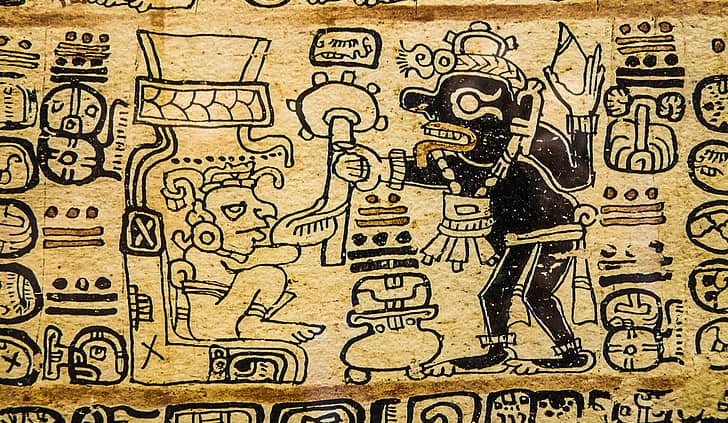Crisi sociale e pandemia: riflessioni sulla barbarie del capitale.
«So che nulla sarà come questa
mattina o dopodomani
resistendo nella bocca della notte un gusto di sole»
(Nulla sarà come prima/ Milton Nascimento e Beto Guedes)
di Anderson Deo
traduzione di Antonino Infranca
Una frase è stata ripetuta esaustivamente dalle grandi corporazioni dei media su scala mondiale: Nulla sarà come prima! Come una specie di mantra, tale espressione indica che la pandemia del nuovo coronavirus produrrà cambiamenti significativi, anche profondi, in diversi livelli della vita e, pertanto, delle relazioni sociali in tutta l’umanità.
La prima questione che vorrei affrontare è che la storia ci insegna che nessuna formazione sociale, nessun modo di produzione è mai entrato in collasso senza che ci fossero forze sociali organizzate a spingere tali processi. Trattandosi del modo di produzione capitalistico, nel corso del XX secolo, di fronte ai vari momenti di manifestazione della sua crisi strutturale e sistemica, questa forma sociale si è ristrutturata su nuove basi e contraddizioni, per riprodurre gli elementi fondanti della sua socialità. Pertanto, per quanto ne capisca, la pandemia di per sé non dà origine a nessuna forma di rivoluzione che punti al superamento del capitalismo o a una possibile forma di transizione socialista. Al contrario, la COVID-19/SARS 2, sembra essere l’espressione radicalizzata della barbarie, alla quale è sottomessa l’umanità, e che si approfondisce, sempre più, di fronte all’autocrazia del capitale finanziario mondializzato sull’umanità.
Così come ci indica István Mészáros nel suo Oltre il capitale, ciò che viviamo attualmente è il risultato della “crisi civilizzatrice” prodotta dal capitalismo, con la sua forma di produzione distruttiva. Questa crisi civilizzatrice, di una determinata forma di socialità, si manifesta attraverso crisi economiche mondiali (strutturali), che si riproducono in cicli sempre più corti, attraverso la crisi ecologica che pone l’umanità di fronte al dilemma dell’esistenza della propria specie, dovuta all’esaurimento delle risorse naturali del pianeta, alle forme di sfruttamento sempre più degradanti della forza-lavoro su scala mondiale, obbligando, secondo l’OMS, un contingente di, approssimativamente, i 2/3 della popolazione della Terra a vivere sotto la soglia di povertà. Si aggiunga a questo processo la scalata del Complesso Industriale Militare, sintesi massima della produzione distruttiva del capitale, che produce e perpetua conflitti in varie parti del mondo, come forma per mantenere il dominio esercitato dall’Occidente, sotto il controllo degli USA.
Tuttavia, non possiamo smettere di riconoscere che la crisi mondiale espliciti contraddizioni fondamentali dell’attuale fase storica del capitalismo, e le risposte che la stessa umanità produrrà per superare tale momento dipenderanno dalla nostra capacità di analisi, di organizzazione e di proposta di fronte a questo importante momento di radicale esposizione del carattere disumano della forma sociale sotto il dominio del capitale.
Nell’ottobre 2019, in una relazione di analisi periodica, il FMI ha divulgato l’informazione che stava avvenendo una “decelerazione sincronizzata” della crescita economica mondiale (Annual Report 2019). Quello che il FMI denominava “decelerazione sincronizzata” è un eufemismo della crisi economica mondiale che stava per essere generata, ancora una volta, nei centri dinamici dell’economia mondiale. Uno dei segnali più chiari che la crisi sarebbe esplosa con tutta la forza distruttiva nel 2020, fu la caduta vertiginosa del prezzo del barile di petrolio sul mercato mondiale, il cui deprezzamento aveva già raggiunto il 60% il 9/3/2020. Le dispute commerciali tra Stati Uniti e Cina, nel corso del 2018 e del 2019, o anche quelle tra Russia e Arabia Saudita, che coinvolgono specificamente la questione del petrolio, sono espressioni episodiche di questo processo di maggiore esplosione della crisi, che secondo Attilio Boron (La pandemia y el fin de la era neoliberal), sta producendo una riorganizzazione della geopolitica mondiale centrata nelle dispute tra USA-Cina-Russia.
Con dinamiche e spiegamenti distinti, questo processo di crisi scatenò grandi e massicce manifestazioni popolari in alcuni paesi del mondo. In America latina, per esempio, le ribellioni del 2019 in Cile, Ecuador, Colombia e Haiti, così come in Argentina l’elezione di Alberto Fernandez, esprimono un tratto comune delle più diverse rivendicazioni: si tratta di reazioni politiche al predominio di più di trent’anni di neoliberalismo. Gli attacchi neoliberali in America latina non furono uniformi nel corso di questo periodo e hanno riprodotto contraddizioni particolari nei diversi Stati nazionali della regione. Il fatto comune è che le azioni delle borghesie locali, anche con caratteristiche specifiche, si sono mantenute fedeli al presupposto dell’associazione subordinata all’imperialismo mondiale, soprattutto al comando statunitense; nel momento in cui le crisi economiche mondiali si sono acuite, le proposte portate avanti da questa borghesia imposero, in forma sempre più accentuata, l’espropriazione e la spoliazione delle risorse sociali gestite dagli Stati nazionali, mediante il meccanismo finanziario dell’indebitamente pubblico. Sia mediante “regole del gioco democratico”, sia mediante colpi di Stato, gli interessi del capitale finanziario si fecero valere e furono imposti all’insieme della popolazione del subcontinente. La deposizione di Evo Morales, legittimamente rieletto l’anno passato con un golpe, è un tipico esempio di come la borghesia latinoamericana combatte le istituzioni democratiche dello Stato liberale, trasformandosi in un’autocrazia della sua classe.
In Brasile la deposizione di Dilma Rousseff nel 2016, deve essere intesa come un momento dell’avanzata neoliberale nel paese. Questo processo ha guadagnato forza con Fernando Henrique Cardoso negli anni Novanta, e fu minacciato, ma non eliminato dai governi Lula e Dilma Rousseff; di fronte all’approfondirsi degli effetti della crisi economica mondiale, che nel paese si acutizzò a partire dal 2013, si passò ad elaborare un’articolazione politica, coinvolgendo parte della magistratura, le grandi corporazioni mediatiche del paese, le forze armate, i partiti conservatori e reazionari, alleati assoluti degli USA, con l’intenzione di allontanare la presidentessa eletta nel 2014, attraverso un colpo di Stato giuridico-parlamentare.
Le alternative presentate alla società brasiliana a partire dal 2016, guidate dal vice-presidente golpista Michel Temer, possono essere riassunte nell’espressione “meno Stato, più mercato”. Il risultato di questo processo, che ancora è in corso, è la distruzione totale della legislazione sociale che fu costruita nel corso del XX secolo. Una legislazione sociale che è sempre stata molto precaria e, pertanto, insufficiente. Non è possibile identificare in Brasile ciò che in Europa si è soliti denominare “Welfare State”. Il paese si è avvicinato a questo modello con la struttura giuridica della Costituzione Federale del 1988, che a partire dal 1992 è stata totalmente riformulata e oggi completamente distrutta. Il governo di Jair Bolsonaro rappresenta la continuità e l’approfondimento di questo processo, con l’aggravante della disputa ideologica che ha rinvigorito il lato peggiore della società brasiliana e dell’umanità: il discorso fascistizzante come alternativa ai problemi sociali.
È lo stesso discorso che si riveste di oscurantismo religioso di matrice neopentecostale – e qui forse si può rilevare come esso sia ancora più regressivo del fascismo alla sua origine – che nega la gravità e le conseguenze devastatrici della pandemia. Ma ancora, in contrasto con le evidenze e le conoscenze scientifiche sulla propagazione del virus, affrontando gli orientamenti di specialisti e della stessa OMS, esso mette in questione l’efficacia dell’isolamento sociale, stimola la popolazione a uscire nelle strade, argomentando che «l’isolamento sociale uccide più gente che la pandemia, poiché l’economia del paese sarà paralizzata». Tutto questo in nome del deus ex machina chiamato mercato! Se pensiamo che, come paese della periferia del sistema capitalista, il Brasile presenta problemi sociali strutturali nelle aree di salute pubblica, abitazione e risanamento basilare, e che questa situazione si è aggravata drammaticamente con l’avanzata del neoliberismo, possiamo avere una dimensione di quanto gravi siano le posizioni del presidente brasiliano. Tanto gravi che esistono già denunce formali presentate al Tribunale Penale Internazionale de L’Aia, accusando Jair Bolsonaro di genocidio e, pertanto, di crimine contro l’umanità.
La situazione del Brasile di fronte all’avanzata della pandemia è drammatica. Un sistema di sanità pubblica pensato come una garanzia per tutti i brasiliani, ma che ha sempre presentato mancanze strutturali e che negli ultimi anni sta affrontando un profondo processo di rottamazione e attacchi privatizzanti; un modello di occupazione territoriale che concentra più del 70% della popolazione (220 milioni) in grandi conglomerati urbani, con poca o nessuna pianificazione di occupazione di questi spazi, dando origine a grandi favelas in tutte le città brasiliane di medie e grandi dimensioni; un impoverimento crescente della popolazione, risultante dall’avanzata della crisi economica, dall’eliminazione di diritti dei lavoratori e della disoccupazione (12 milioni prima della pandemia, secondo dati ufficiali), dalla precarizzazione e dall’informalità, sempre più grandi nel paese. Uno degli effetti più perversi di questo processo è l’aumento del numero di persone che vivono nelle strade, senza un’abitazione, né condizioni minime di igiene, di alimentazione, di sanità fondamentale. Nella principale città del paese, San Paolo, secondo i dati ufficiali, 25.000 esseri umani si trovano in queste condizioni. Questa realtà, in differenti proporzioni, si ripete nella grande maggioranza delle città brasiliane. Non è necessario essere uno specialista in epidemiologia per immaginare gli effetti catastrofici che la pandemia potrà provocare in Brasile.
Anche riflettendo sulle possibili trasformazioni causate dalla pandemia, alcune misure economiche di emergenza dei governi dei paesi coinvolti ci danno già tracce di come la borghesia mondiale, organizzata all’interno degli Stati nazionali, reagisce all’accrescimento della crisi mondiale prodotta dal nuovo coronavirus. Ancora una volta, le voluminose risorse per salvare il capitalismo proverranno dalle casse pubbliche. Nel citato articolo di Boron, l’intellettuale argentino è tassativo nell’affermare che il «neoliberismo è un cadavere che bisogna seppellire» e che la crisi scatenata dall’epidemia evidenzia che il mondo avrà bisogno di «più Stato e meno mercato». Se è vero che l’attuale crisi esplicita i limiti e le contraddizioni scatenate dall’esaurimento del modello neoliberista, è necessario ricordare che nella storia del capitalismo lo Stato ha sempre posto a disposizione dell’iniziativa privata – pertanto della borghesia – gli sforzi e le risorse sociali, affinché i momenti di crisi fossero superati. Basta una rapida occhiata alla storia economica del XX secolo (crisi del 1929, della metà degli anni Settanta, o anche del 2008), per constatare che l’apparente opposizione tra interferenza statale e mercato libero, non è altro che una retorica ideologicamente orientata, in accordo con gli interessi borghesi, una volta che lo “Stato minimo” ha diminuito e anche eliminato i diritti dei lavoratori, ricomponendosi al tempo stesso come “Stato massimo” degli interessi del capitale.
Un’altra questione possiamo rintracciarla nella mondializzazione dell’epidemia. Tra gli importanti contributi di François Chesnais nel suo La mondialisation du capital troviamo la formulazione su come le trasformazioni capitalistiche negli anni Novanta tendevano a una mondializzazione delle relazioni commerciali, allo stesso tempo in cui gli Stati nazionali continuavano ad essere spazi geografici di contenimento della forza-lavoro e dei conflitti sociali. Il flusso delle merci doveva essere internazionalmente libero, ma non la forza-lavoro che lo produce. La propagazione del nuovo coronavirus obbedisce, per così dire, alla stessa logica della libera circolazione delle merci di cui parlava Chesnais, colpendo i “centri nervosi” del capitalismo mondiale per poi spargersi all’interno delle nazioni. In questo senso l’osservazione di Alain Badiou (Sulla situazione epidemica) ci sembra abbastanza importante nel suggerire che un’epidemia si riproduce sempre come un processo di doppia determinazione che in un dato momento converge: la determinazione ecologica e la determinazione sociale. Argomentando che l’attuale epidemia della COVID 19/SARS 2 non è propriamente una novità per gli scienziati del mondo (e per questo fa riferimento a una prima epidemia di sindrome respiratoria nel 2003, denominata proprio SARS 1), l’autore indica che ciò che viviamo risulta dall’incontro di una mutazione virale (la determinazione ecologica) con una serie di determinazioni sociali, risultanti dalla negligenza di una parte della comunità scientifica e delle autorità pubbliche, principalmente in Occidente, che guardano sempre alle epidemie nell’Estremo Oriente, o anche in Africa, come problemi sanitari di un mondo distante.
La prepotenza eurocentrica, propria della visione imperialista del mondo, ha sottostimato e ha trascurato gli effetti e le conseguenze della diffusione del virus per il pianeta. Se l’origine dell’epidemia si localizza in Cina, la propagazione e il contagio a livello pandemico è responsabilità diretta dei governi occidentali, principalmente europei e statunitensi, che furono inizialmente negligenti ritardando a prendere le misure indicate da scienziati e specialisti del mondo intero, in particolare l’isolamento sociale. Qui, a mio avviso, Badiou cade in errore nell’affermare che i governi starebbero agendo al di là degli interessi di classe.
Ad ogni modo, dato che la realtà storica deve essere compresa nelle sue possibilità e contraddizioni, l’isolamento sociale dimostra chiaramente che non c’è forma possibile di riproduzione economica, politica e sociale che possa prescindere dal lavoro e, pertanto, da quella classe che lo riproduce quotidianamente, nelle sue più diverse frazioni e determinazioni sociali. Mi riferisco qui al proletariato, che non può essere confuso o ridotto alla sua conformazione con il proletariato industriale della metà del XVIII secolo e del XIX secolo. Ma che continua a essere, con tutta la complessità delle sue trasformazioni contemporanee, il fondamento, il sostegno, l’elemento centrale della riproduzione sociale capitalista. Lo “sciopero generale” forzato dall’isolamento sociale mostra quello che cerco di affermare, constatando la disperazione dei capitalisti sparpagliati per le principali economie del mondo, che insistono nel mantenere le loro attività economiche – con la connivenza dei governi nazionali –, obbligando contingenti enormi di lavoratori e lavoratrici a lanciarsi nel “rischioso mondo del contagio” dei trasporti collettivi, delle fabbriche, delle grandi reti commerciali.
Un’altra frase è stata costantemente ripetuta dai mezzi di comunicazione, come forma di stimolo alla resilienza delle persone: Passerà! A coloro che pensano che questa crisi è passeggera, forse possiamo indicare due elementi; primo: la pandemia deve essere superata, così da poter riprendere le nostre attività quotidiane e ristabilire la dinamica delle nostre vite; secondo: la crisi economica tende ad essere duratura, con effetti drastici sull’insieme dei lavoratori ed è fondamentale che saremo tutti in perfette condizioni di salute, per tornare in strada e organizzarci, gridando a pieni polmoni che è necessario costruire un altro mondo, il cui fondamento non sia l’accumulazione privata della ricchezza, ma la piena emancipazione umana!