Prisca Amoroso, “Pensiero terrestre e spazio di gioco. L’orizzonte ecologico dell’esperienza a partire da Merleau-Ponty”, Mimesis, 2019
Editore: Mimesis
Anno: 2019
Collana: Itinerari Filosofici
Pagine: 238
Prezzo: 19,00 €
Pensiero terrestre e spazio di gioco è un titolo emblematico per un tentativo di rielaborare le categorie del corpo, della terra, dell’ecologia, nonché il pensiero di Merleau-Ponty. Manlio Iofrida, nella prefazione al testo, ne pone in evidenza un caposaldo, ovvero quello stilistico, che consiste in una struttura «stratificata» (come la definisce Amoroso nell’Introduzione, p. 17) dispiegata da «un metodo espositivo volutamente antiaccademico, antisistematico e quasi aforistico» (p. 9). La struttura del testo ne rispecchia lo scopo e il respiro: il tentativo che vi si pone è quello di presentare una soggettività ecologica, dunque anti-prometeica e anti-cartesiana, radicata in un corpo a sua volta installato in un suolo, evocando il gioco a ciò sotteso e la libertà vincolata che da tali premesse si viene a creare. L’esposizione e il contenuto sono «artigianali» (p. 19), fedeli più al lavoro creativo del bricoleur che a quello assemblativo dell’ingegnere di cui Levi-Strauss in Il pensiero selvaggio (1962) ci dà un’immagine. Vi è una ricostruzione del pensiero di Merleau-Ponty che ne scopre lati peculiari, accompagnata da intuizioni originali e personali dell’autrice. Per tale motivo, non è un rifacimento ristretto dei temi merleau-pontyani ma una rielaborazione di questi a partire da un punto di vista, quello specificamente eco-fenomenologico: ecologico, in quanto risponde all’esigenza di una soggettività non cartesiana, e fenomenologico, in quanto la soggettività si scopre ancorata alle cose; i due temi, è evidente, sono interdipendenti.
Inserirsi nel dibattito ecologico non implica necessariamente assumere un punto di vista politico, immediatamente morale. Forse, data l’urgenza della crisi ecologica – dove si intende la crisi ambientale in cui versiamo –, occorre ripensarne dapprima le premesse filosofiche in gioco. La considerazione dell’ambiente nelle vesti di un’alterità distante dal punto di vista umano e soggiogabile da quest’ultimo e, accanto, l’istituzione del soggetto umano moderno, signore della natura e forte di una libertà assoluta, rimandano ad uno specifico paradigma filosofico antropocentrico e prometeico. Nel testo in esame si tenta di presentare un paradigma alternativo ripensando due grandi temi fondamentali: il corpo e la terra. Il corpo cartesiano funziona alla stregua di una macchina; è un assemblaggio di parti funzionante meccanicamente, composto da ingranaggi e descritto da Descartes in Il mondo con alcune emblematiche metafore. I nervi, comandati dal cervello, inviano comandi al resto del corpo tramite un meccanismo che ricorda quello di un mulino, dove la sola forza dell’acqua che sgorga riesce a mettere in moto varie macchine; la respirazione, quindi, è resa continua dall’attività incessante dei nervi, come è continua l’acqua di un mulino; l’anima razionale che ha sede nel cervello, come un idraulico, è preposta al controllo dei tubi di queste macchine. Nelle Meditazioni Metafisiche gli sembra inevitabile diffidare che le figure che vede alla finestra siano dei veri uomini e che non siano piuttosto solo mantelli e cappelli: se concludiamo che siano effettivamente degli uomini è perché interviene l’intelletto a dare sostanzialità ai sensi. Laddove il corpo è pensato alla stregua di una macchina e la sensibilità suscita un sospetto che appare legittimo, in tale paradigma, la terra non è pensata come suolo (boden, nel linguaggio merleau-pontyano), ovvero non la si assume come un punto di vista imprescindibile solo a partire dal quale vi è la conoscenza.
Amoroso, contro l’ultimo esempio cartesiano citato, ne riporta uno in particolare celebre nella psicologia della Gestalt, preso in esame dallo stesso Merleau-Ponty proprio in opposizione a Cartesio nella lezione del 1945 Il cinema e la nuova psicologia: «spostando il punto di ancoraggio della nostra attenzione, in una stessa figura possiamo vedere una fanciulla o un’anziana signora. […] Nulla di arbitrario: il mondo si organizza sotto i nostri occhi a seconda del punto di ancoraggio che troviamo in esso e mai per un capriccio del nostro pensiero» (p. 60, il corsivo è aggiunto). Il «peccato originale della filosofia», anche titolo del capitolo da cui è tratto questo passo, fa capo a Cartesio e consiste sia nella diffidenza nei confronti della verità del corpo e della percezione, o meglio il rifiuto che la percezione sia «accesso alla verità» (p. 73), sia nel distacco effettuato da parte della filosofia dalla terra-suolo. La costruzione di un pensiero ecologico si edifica a partire dalla guarigione da tale peccato: gli sforzi sono focalizzati nel pensarci ancorati ad un corpo e ad una «arca-terra», nell’efficace formula dell’autrice (p. 87).
L’approccio fenomenologico è indispensabile, l’ancoraggio richiede un’installazione corporea dei nostri piedi nel terreno; scoprendoci ancorati, ci scopriamo anche anti-copernicani. Il richiamo alla fenomenologia husserliana è già evidente – Merleau-Ponty, d’altra parte, avanza sulla linea di Husserl, seppur sporgendosi oltre – ma nel capitolo L’arca terra. Merleau-Ponty a Lovanio e nel successivo, Le scoperte della terra e la scienza galileiana (pp. 87-100), vi è una rielaborazione originale in chiave ecologica. Il filosofo francese, in visita nel 1939 agli Archivi Husserl a Lovanio, legge il manoscritto sul Rovesciamento della dottrina copernicana nella corrente visione del mondo. Sia tale manoscritto che il tentativo di un pensiero ecologico sono radicalmente anti-copernicani – si badi bene: «si tratta, qui, più di un anti-copernicanesimo filosofico, che di un pre-copernicanesimo scientifico» (p. 100) – in quanto volti a riconoscere che prima della visione sull’Universo squadernata dalla rivoluzione copernicana c’è una prospettiva terrestre inaggirabile. L’arca-terra è un suolo non abbandonabile: «il suo abbandono, cioè, è inconcepibile al livello della relazione del soggetto al mondo, e la mossa filosofica che lo tenta – la rivoluzione copernicana […] – è la traccia di un’ontologia piena e non porosa […]». Ciò che al contrario si ricerca è proprio un’ontologia porosa, alimentata dall’immaginazione e dal gioco (due temi che vengono affrontati da Amoroso nella seconda metà del testo).
Se tutto è a partire da tale ancoraggio, se prima di tale postura non vi è nulla, si risponde al dubbio sollevato da Cartesio nelle Meditazioni: non è necessaria un’operazione di pensiero per reputare che le figure che compaiono alla finestra siano effettivamente degli uomini, «la domanda se ciò che vedo sia davvero il mondo non è che un falso problema. Merleau-Ponty lo dice bene: il mondo è ciò che io vedo». La fenomenologia è radicalizzata e curvata in senso ecologico: si crea lo spazio per un soggetto che è un corpo e che, in quanto tale, è già una sintesi psico-fisica, non una giustapposizione di mente e corpo, di sensi e intelletto.
Il testo di Amoroso ha il pregio di restituire un’ottica insieme epistemologica ed ontologica peculiare: le considerazioni sul corpo, sulla terra, sull’ancoraggio, sull’inerenza alla natura conducono non solo ad una specifica relazione tra il vivente (umano e animale) e l’ambiente (Von Uexküll è richiamato più volte), ma anche ad una postura filosofica che ha nel motivo del gioco il suo fulcro. Il gioco apre alla dimensione dello Spielraum (p. 128), dove si scopre la presenza di un fondo pre-tetico, primordiale, viscoso e sfuggevole al di sotto del mondo della scienza, dell’universo copernicano e galileiano della scienza moderna – Merleau-Ponty, d’altra parte, è evidentemente sensibile alla crisi delle scienze che apre il Novecento –. Il vivente non è completamente indagabile secondo le logiche della causalità; l’organismo, al contrario di una macchina, ha la capacità di sporgersi verso il piano della possibilità e dell’improvvisazione. Con una formula a dir poco efficace ed evocativa, Amoroso ci parla di «scandalo biologico dell’allegrezza» (p. 151): l’animale ha la capacità di fuoriuscire dalle logiche biologiche della mera sopravvivenza e dell’utile; il canto degli uccelli è una forma di gioco e di spontaneità non utile; lo scimpanzé che gioca con la sabbia lasciandosela scorrere tra le dita è immerso in una dimensione ludica (pp. 152-153). Cartesio, di fatto, non attribuisce al vivente una capacità di uscire dagli schemi e di aderire gioiosamente e allegramente con l’ambiente. Il gioco è un motivo ancora una volta ontologico ed epistemologico: ontologico, perché suggerisce una filosofia, come quella merleau-pontyana, indiretta, del primordiale, del vincolo e del continuo scavalcamento di questo (p. 132) – il che apre anche ad una diversa libertà, vincolata e non assoluta, sussistente grazie al vincolo e non malgrado esso –; epistemologico perché viene a crearsi uno spazio diverso, colorato dalla presenza del vivente al suo interno: uno Spielraum.
Nelle pagine di Amoroso, il gioco, l’improvvisazione e l’allegrezza sono declinazioni del rapporto di scambio che il soggetto vivente intrattiene con l’ambiente. Nella quarta sezione del testo, Essere, si approfondiscono alcune questioni ontologiche. Viene restituito al lettore il Merleau-Ponty che, con la figura del chiasma, supera la logica della dialettica e propone un’ontologia della porosità, dello scavalcamento continuo del positivo nel negativo, del soggetto nell’ambiente e viceversa. La dialettica viene superata perché un risolvimento verso una delle due istanze in gioco, verso l’essere o il nulla, verso il soggetto impositivo oppure verso la passività dell’oggetto, non è di fatto possibile, né affermarla ci renderebbe dei buoni fenomenologi (pp. 201-206).
Seguire un filo analitico attraverso gli impliciti teorici di questo testo non ne restituirebbe la freschezza. Tuttavia, si è tentato di rispettarne la struttura «stratificata», «narrativa» «artigianale» (p. 17). Occorre considerarne una parte finora tralasciata: al centro del testo, prima delle sezioni Gioco ed Essere, si colloca un intermezzo che rende ne evidente, se fosse ancora necessario, l’originalità. Ora, l’autrice non soltanto si inserisce nel dibattito e negli studi, in Italia e non solo, sia dell’ecologia che di Merleau-Ponty, ma pone un’avvertenza: il pensiero di quest’ultimo è «un’eredità la cui portata non è stata ancora del tutto misurata» (p. 217). Sembra che l’«intermezzo cinematografico» e il capitolo appena precedente, «la visione di sorvolo e i modi della conoscenza» (pp. 101-111) siano già una misurazione dell’eredità merleau-pontyana. Si rispetta il lascito di Merleau-Ponty e lo si arricchisce restandogli fedele nella sua filosofia indiretta, nel suo stile riconoscibile e letterario, nella sua creatività. La visione di sorvolo, che il geografo Paul Vidal abbraccia scattando una fotografia alla città di Parigi dall’alto di una mongolfiera, ritenendo di aver finalmente catturato la “vera” Francia, non fa che ridurre lo spazio «alla sua dimensione ottica» (p. 105) – s’intende, non vissuta – e schiacciare il soggetto con il suo corpo a «rappresentazione, non più presenza». «Qualcosa, nello spazio, sfugge ai nostri tentativi di sorvolo» (L’occhio e lo spirito, SE, 1989).
Il breve capitolo (in linea con lo stile aforistico di cui sopra) sulla visione di sorvolo, in particolare, è ricco di considerazioni dell’autrice che esulano dalla semplice trattazione merleau-pontyana: è un’ulteriore dimostrazione che il testo in questione è più che una rielaborazione del pensiero del filosofo francese in quanto pullula di aggiunte personali, di riferimenti che spaziano dalla cultura di internet, come la citazione di The Game (p. 164), alla letteratura, alla biologia, alla storia della scienza, alla psicologia e alla psicologia sperimentale. Se Merleau-Ponty era un pensatore completo ed eclettico – e, in definitiva, sistematico (p. 217) – pur difendendo la necessità di una filosofia della fragilità, del «limite come orizzonte» (pp. 113-117), di un atterraggio dell’uomo e del pensiero, allora le proposte di questo testo risuonano con tale completezza ed insieme fragilità. Ne risulta, di fatto, che completezza e profondità filosofica, dove per profondità s’intende capacità di toccare il fondo vero delle cose, non sono in contraddizione con un contenuto che inneggi al «valore della superficie» (pp. 81-82), all’affidabilità della percezione, della carne, della quotidianità.





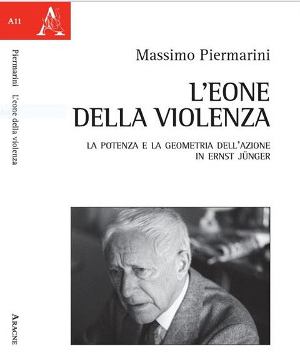
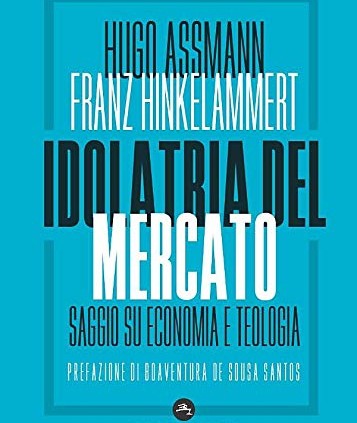



 (Edizioni Messaggero, 2020, pp. 114, € 11)
(Edizioni Messaggero, 2020, pp. 114, € 11)
