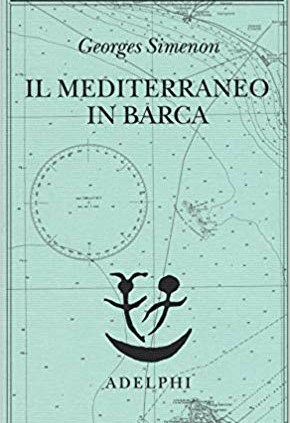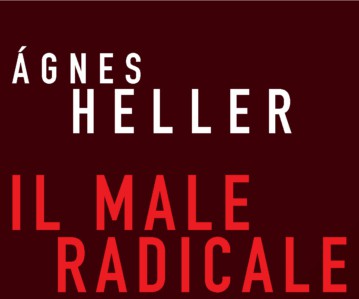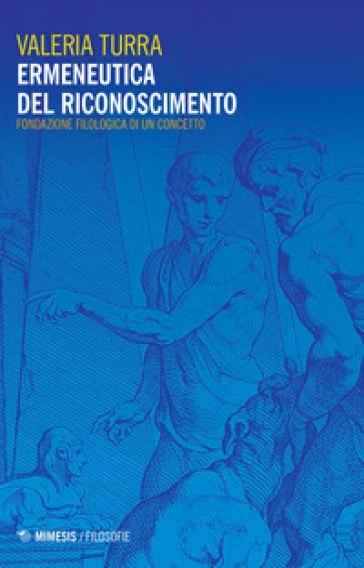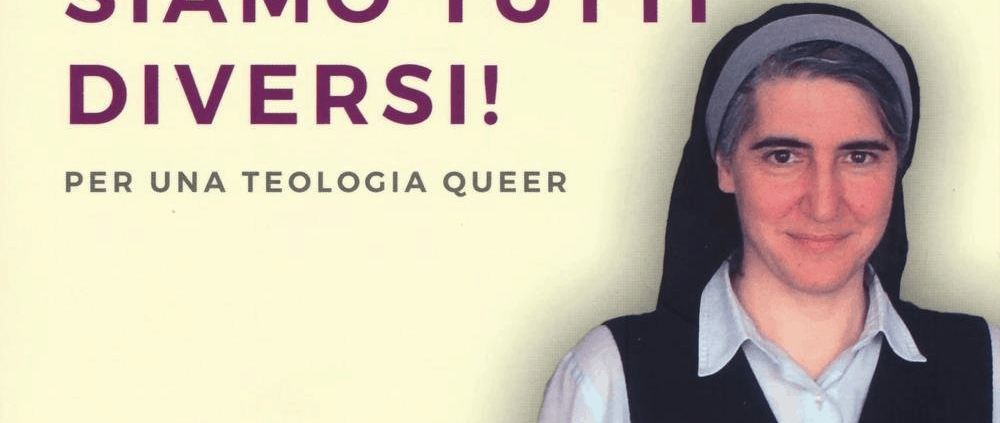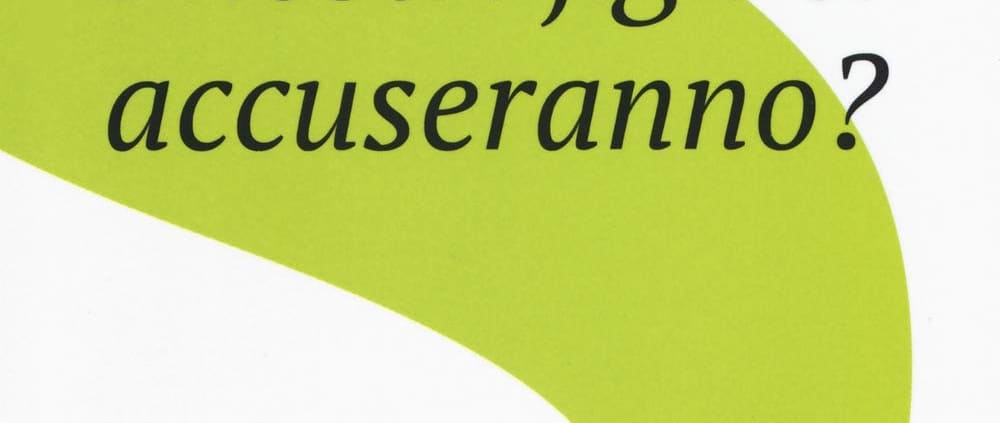Agnes Heller, “Il male radicale” (Castelvecchi, 2019)
La questione del Male Radicale rappresenta, ormai, il nodo nevralgico del pensiero post-bellico. Sebbene il problema del male occupi la riflessione filosofica nel suo intero, in quanto parte costitutiva dell’esistenza umana, l’indagine circa la sua radicalità rappresenta la cifra essenziale del pensiero moderno e contemporaneo. Ungherese sopravvissuta alla follia nazista, Agnes Heller nei quattro saggi raccolti in questo volume cerca di sciogliere quei dilemmi che hanno segnato la sua esistenza in maniera intima: come è stato possibile l’Olocausto? Esiste una ratio che permetta di comprendere un evento del genere? Che tipo di mondo permette che simili cose accadano? Cos’è la modernità? È possibile la redenzione?
Vandana Shiva, “Semi di libertà” (Castelvecchi, 2019)
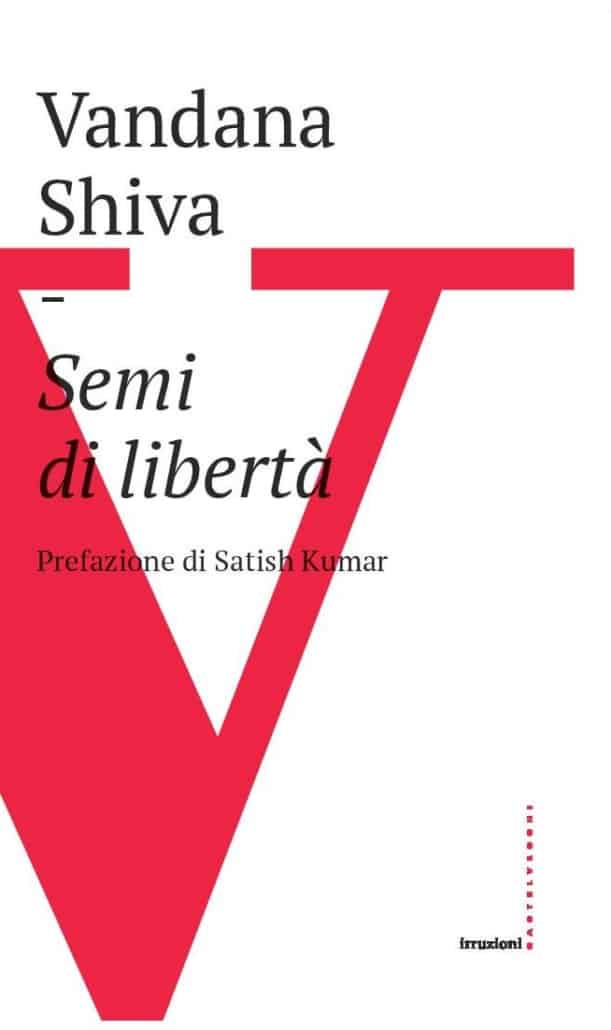
di Giulia Ceci
Edito da Castelvecchi nella collana Irruzioni, Semi di libertà è un libro tanto piccolo quanto grande, esattamente come il seme che ne è motivo portante, insieme simbolo e tema concreto di queste pagine. «Il seme è piccolo», si legge per l’appunto nella quarta di copertina, eppure in esso «le questioni ecologiche si intrecciano con quelle sociali». L’autrice Vandana Shiva, scienziata ecofemminista a capo di un programma internazionale per la tutela delle diverse culture ‒ chiamato “Navdanya”, ossia “nove semi” ‒, ha infatti compreso perfettamente cosa renda così importante questa realtà minuscola, non a caso sacra nelle civiltà del passato: il seme «contiene diversità», perciò «libertà». È dunque proprio la libertà ‒ o gratuità ‒ del seme a costituire una minaccia per le multinazionali dell’«agro-business» in piena globalizzazione. Tale libertà ha un duplice senso; ecologico da un lato, in quanto il seme si riproduce spontaneamente, economico dall’altro, giacché riproduce il sostentamento dell’agricoltore. Va da sé, allora, che la libertà del seme implichi necessariamente la libertà della classe contadina, o meglio delle libertà, una pluralità riflettente quelle diversità che vi si
trovano contenute.
Ribattezzata “la Gandhi del grano”, Vandana Shiva racchiude nel suo “Movimento per il seme” la lotta per un modello di vita ecosostenibile e autenticamente democratico, opposto alla farsa del libero mercato, nel quale, malgrado l’apparente «processo di nuove interconnessioni tra società», c’è posto unicamente per le grandi corporazioni. In questo contesto, il seme ‒ «primo anello della catena alimentare» ‒ è divenuto una merce, per la quale più di 25.000 contadini indiani, dal 1997 ad oggi, si sono tolti la vita. I brevetti o “Trips” ‒ Trade Related Intellectual Property Rights ‒ , «le attuali armi dell’imperialismo», hanno sancito il monopolio dei semi da parte delle corporazioni e l’egemonia dell’agricoltura industriale, basata sulla modificazione genetica del seme natio, confinando nell’illegalità i contadini.
Nella volontà di ribellione a un intero sistema che impatta distruttivamente non solo sull’ambiente e sulla sopravvivenza della classe contadina, ma alla fine della filiera produttiva si ripercuote sulla salute stessa del consumatore, riguardandoci tutti indistintamente, la preservazione del seme rappresenta un dovere morale e un atto politico di resistenza. Si ritorna all’intreccio di questioni ecologiche e sociali. Poiché la biodiversità mal si coniuga con l’uniformità innaturale e del tutto tecnica dell’agricoltura industriale ‒ il monopolio delle multinazionali ‒, il suo rispetto impone un decentramento della produzione, dove gli uomini non siano ridotti a scarti o avanzi delle macchine, i contadini a sorveglianti del procedimento meccanico, i consumatori a meri acquirenti dei supermercati, sommersi da quantità di cibo inesauribili, però di scarsa qualità nutrizionale. Scrive Vandana Shiva: «È questa connessione tra la diversità, la decentralizzazione e la democrazia ad aver guidato le mie idee e le mie azioni, sia a livello locale sia a livello globale».
Ricardo Antunes, “Politica della caverna: la controrivoluzione di Bolsonaro” (Castelvecchi, 2019)
di Anderson Deo[1]
(Traduzione in italiano a cura di Antonino Infranca)
I risultati delle elezioni generali in Brasile, nell’ottobre 2018, confermarono qualcosa che per molti sembrava impossibile. Dai militanti sociali agli analisti politici e agli intellettuali, di vari orientamenti ideologici, pochi – o addirittura rari – furono quelli che si arrischiarono ad affermare nel corso della campagna elettorale, che Jair Bolsonaro presentava condizioni tali da essere eletto. Forse, pressate dal desiderio che la tragedia non si realizzasse – principalmente l’ampio settore politicamente alla sinistra – le analisi puntavano all’impossibilità dell’elezione di un candidato che esprimesse ciò che di più reazionario e, pertanto, dichiaratamente antidemocratico, si è prodotto nel paese, in tutte le sue sfaccettature di disumanità che si esplicita mediante la barbarie imposta dal capitale. Intanto, così come annotava Karl Marx nella sua Critica del programma di Gotha, «ciascun passo del movimento reale è più importante che una dozzina di programmi», e non captando il “movimento reale” nella sua dinamica e processualità, le risposte pratico-politiche offerte, soprattutto dal campo democratico-popolare, non furono sufficienti per sbarrare l’avanzata della candidatura di carattere fascistizzante.
Il libro di Ricardo Antunes si caratterizza fondamentalmente come un primo sforzo di comprensione della dinamica sociale brasiliana, nelle sue complesse e intricate dimensioni, che portarono all’elezione di Bolsonaro. Contando sulla accurata traduzione di Antonino Infranca, il testo fu redatto durante il primo anno di governo che è iniziato il 1 gennaio 2019. Il testo percorre la dinamica e la riproduzione dei fatti, cercando di comprendere gli avvenimenti politici e sociali al di là della loro manifestazione fenomenica, ossia al di là della loro apparenza empirica, in uno sforzo di analisi di ciò che György Lukács identificherebbe come l’essere-proprio-così della totalità in questione. Esprime, pertanto, la caratteristica di uno scritto “nel calore del momento” che apporta possibilità di analisi e prassi politica. Con ciò, come è caratteristico degli scritti di Antunes, riflette elementi essenziali della singolarità nella formazione sociale brasiliana, le sue connessioni e dinamiche interne che danno forma alla particolarità storica di quel paese, nel suo processo di interrelazione di universalità nella riproduzione socio-metabolica del capitale.
Con la chiarezza e simbologia metaforica che gli è peculiare, Antunes enuncia già nel titolo dell’opera il contenuto storico di ciò che si annuncia come il governo di Bolsonaro: un’immersione sociale nelle oscure profondità di una caverna, come un momento di approfondimento della “controrivoluzione preventiva” in corso nel paese dopo il Colpo di Stato civile-militare del 1964. La caverna, nella oscurità che essa rappresenta, identifica la regressione político-culturale nella quale il paese entra con l’arrivo al potere di un governo che porta il marchio del discorso religioso della Teologia della Prosperità nella sua variante Neopentecostale, che riproduce il discorso fascistizzante dell’eliminazione di ogni e qualsiasi forma di manifestazione ideologica di sinistra, soprattutto comunista, di un fondamentalismo religioso di persecuzione delle donne, di riproduzione del razzismo e di discriminazione violenta della comunità LGBT e, fondamentalmente, di attacco ai diritti sociali storicamente conquistati da lavoratori e lavoratrici in Brasile.
La distribuzione dei capitoli analizza inizialmente il senso storico della dittatura militare, di carattere particolarmente bonapartista, che entra in vigore nel paese tra il 1964 e il 1985. Identifica, a partire da un’importante sintesi di Florestan Fernandes, il processo di controrivoluzione che si apre in quel periodo, come forma di frenare preventivamente qualsiasi prospettiva emancipatrice della classe lavoratrice, dove la borghesia rinuncia al potere politico in nome di un’autocrazia uscita dalle caserme, che riproduce una forma storica di sfruttamento intensivo ed estensivo della forza lavoro, ma, allo stesso tempo, rinforza la sua associazione subordinata ai nuclei centrali di riproduzione dell’imperialismo, principalmente degli Stati Uniti.
Analizzando il cosiddetto periodo di “ri-democratizzazione”, dove entra in vigore un ordine costituzionale fondato sui precetti liberali dello Stato di Diritto, identifica con chiarezza l’adozione del progetto neoliberale nel paese a partire dal governo Collor (1990-1992), dimostrando che lo stesso fu perfezionato e approfondito nei governi di Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), in un quadro internazionale di mondializzazione del capitale sotto l’egemonia della borghesia finanziaria. Il progetto del PT, riprodotto da Lula (2003-2010) e da Dilma Rousseff (2011-2016), è caratterizzato, per Ricardo Antunes, come una “politica di conciliazione tra entità sociali inconciliabili”, accennando al fatto che i governi di campo democratico-popolare non hanno rotto con la logica macroeconomica neoliberale, anche se è stato possibile avanzare con programmi di governo e politiche pubbliche di carattere sociale, come il Programma Fame Zero.
Fondamentale nell’analisi di Antunes, è la precisa connessione della realtà brasiliana nella riproduzione della totalità storica. Dato ciò, comprendiamo e riceviamo dalla lettura di questo libro, che il neoliberalismo è la risposta storica che la borghesia impone all’umanità di fronte alla crisi strutturale del capitale, che si esplica a partire dalla metà degli anni Settanta. L’offensiva del capitale sul lavoro – o come concepito dall’autore nei suoi scritti, “coloro-che-vivono-di-lavoro” – impone una serie di trasformazioni, nella forma socio-metabolica del capitale. Il processo di ristrutturazione produttiva, analizzato dall’autore nella sua vasta e proficua produzione teorico-politica nel corso di più di trenta anni, dà origine a una costante dinamica di precarizzazione delle condizioni di vita e di lavoro del proletariato, nelle sue diverse frazioni e morfologie, a livello mondiale. In forma parallela e concomitante, i complessi politici, che danno dimensione allo Stato borghese, riproducono, sempre più, un tipo di “democrazia di cooptazione” (nuovamente Florestan Fernandes), che identifichiamo come una forma autocratica istituzionale di dominio borghese, che si riproduce mediante i parlamenti e il potere giudiziario, in costante articolazione con i poteri esecutivi. Ecco l’elemento, nella nostra opinione, che il progetto di conciliazione del PT non rompe, al contrario, neppure affronta. E che finisce in maniera tragicomica, essendo lo stesso carnefice, nel Colpo di Stato che ha portato alla deposizione di Dilma Rousseff, nel 2016, così come l’arresto di Lula nell’aprile 2018.
Qui, ancora una volta, l’autore ci offre piste fondamentali per la comprensione dei fenomeni sociali, in modo da estrapolare l’apparenza degli stessi. Discutendo gli elementi costitutivi dell’articolazione politico-economica che hanno portato alla deposizione di Dilma, Antunes afferma che siamo “in un nuovo ciclo della controrivoluzione che rifiuta qualsiasi forma di conciliazione”; ossia, con l’approfondirsi della crisi strutturale e sistemica del capitalismo – pertanto una crisi della forma sociale retta dal capitale – iniziata dal 2008, osserviamo una nuova offensiva del capitalismo finanziario sulla ricchezza socialmente prodotta dal proletariato a livello mondiale. Dato che questa ricchezza è prodotta e realizzata all’interno delle frontiere dello Stato Nazionale, la borghesia si organizza e impone azioni politiche, più o meno violente, – in dipendenza dalle singole congiunture – per raggiungere i suoi interessi di classe. E qui, l’autore ci offre più di una metafora – brillanti come indizi – per comprendere l’essenza dei fenomeni politici così come questi ci si presentano nell’attualità. Dice Antunes: «Forse, si potrà dire che il capitalismo della piattaforma, dell’era digitale, informatica e finanziaria, somiglia molto alla protoforma del capitalismo”, questo perché nel suo periodo di accumulazione originaria (primitiva) il «capitale trasse la sua forza dall’intenso sfruttamento e spoliazione del mondo coloniale». E potremmo aggiungere che nell’attuale fase di offensiva del capitale, lo sfruttamento e la spoliazione si riproduce, anche, nelle “metropoli”, anche se con caratteristiche distintamente specifiche.
Questo ci sembra l’elemento nodale per comprendere la discussione che Antunes ci presenta sulle continuità e similitudini tra il governo di Michel Temer (2016-2018), emerso dal Golpe del 2016, e la sua continuità con Bolsonaro, in cui la figura del “super-ministro dell’economia” è, quanto meno, sintomatica. Paulo Guedes assume il ministero dell’economia con carta bianca per amministrare la ricchezza socialmente prodotta nel paese. È un autentico Chicago Boy, che ha preso lezione nelle università cilene negli anni della dittatura di Augusto Pinochet, e passa a proporre uno shock di profondo liberalismo nel suo contenuto ortodosso, o neoliberale, per il Brasile. Questo spiega l’appoggio della borghesia brasiliana alla candidatura di Jair Bolsonaro di fronte al disastro del suo allora candidato preferito, Geraldo Alckmin.
E di fronte a questo quadro, Ricardo Antunes conclude il suo libro fissando come sfida ai movimenti sociali e ai partiti politici di sinistra, la necessità di ricomporre le loro forme di lotta, comprendendo le nuove morfologie e necessità della classe lavoratrice, delle sue frazioni sempre più precarizzate, informali, “uberizzate”, nei loro ritagli e manifestazioni di genere e di razza, e che hanno bisogno di organizzare mediante un progetto politico di classe un confronto all’ordine del capitale, e che puntino a un progetto di emancipazione umana.
Così, il pubblico italiano ha nelle sue mani un bello e importante materiale che contribuirà alla comprensione dell’attuale quadro storico brasiliano. Il libro di Ricardo Antunes ci offre scintille vigorose, che possono venire a trasformarsi in vere fiamme, fuochi di luce che illuminano cuori e menti affinché lavoratrici e lavoratori brasiliani riescano ad attraversare e a rompere l’oscurità della caverna nella quale il Brasile – e perché non il mondo? – si trova.
[1] Dottore di ricerca in Scienze Sociali. Post-dottorato presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”. Professore di Teoria Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Economiche e del Programma di Post-laurea in Scienze Sociali dell’Università di San Paolo – Campus di Marília. Coordinatore del Nucleo di Studi di Ontologia Marxiana (NEOM/CNPq).
Marc Augé, “Prendere tempo. Un’utopia dell’educazione. Conversazione con Filippo La Porta” (Castelvecchi, 2016)

di Giulia Ceci
Edito da Castelvecchi nella collana Irruzioni, il libro trae spunto dalle conferenze che hanno visto dialogare Marc Augé e Filippo La Porta in occasione del Futura Festival di Civitanova Marche (2013-2014). Il sociologo francese di fama mondiale ripercorre, attraverso le domande e le considerazioni del critico letterario, le tematiche fondamentali della sua produzione, cercando di interpretare i nostri tempi, ma soprattutto il senso stesso del tempo ai nostri tempi. L’avvio non può che darsi a partire da quegli spazi in cui l’uomo contemporaneo trascorre parte delle sue ore e delle sue giornate: secondo la felice definizione di Augé, i «non-luoghi». Si tratta di aeroporti, stazioni ferroviarie, ipermercati, centri commerciali, per i quali la negazione dello statuto di luogo si riferisce principalmente
a ciò che li contraddistingue, ossia transitorietà e astoricità. Agli antipodi della piazza, i «non-luoghi» sono infatti luoghi di passaggio e senza passato, ai quali risulta difficile attribuire un’identità, data l’assenza di una memoria, la mancanza di una sedimentazione. Tuttavia, a dispetto di questa ambiguità, resta un fatto incontrovertibile la loro elezione attuale a luoghi della socialità, dove la relazione è necessariamente mediata dal consumo, spesso subordinata al potere d’acquisto.
Si incappa così in un apparente paradosso: proprio nella società che ha massimizzato la comunicazione, la relazione umana è costantemente a rischio, se non impossibile, a riprova dell’irriducibile differenza fra l’una e l’altra. Alla base di tale differenza v’è il tempo, presupposto irrinunciabile di qualsiasi forma di relazione. Per questo, «dovremmo imparare a pensare di nuovo nel tempo», respingendo l’immediatezza dei mezzi tecnologici, ossia quella dimensione virtuale di istantaneità che è venuta sostituendosi all’esistenza nel tempo e nello spazio.
È la stessa incapacità di padroneggiare il tempo, secondo Augé, la causa di un diffuso «sentimento di abbandono che abita i giovani», nella mutata socialità dei «non-luoghi». A prescindere dalla crisi economica e dalle insoddisfacenti prospettive di occupazione, si avverte un vuoto più profondo nell’istruzione. Occorre tornare a formare per formare, ricondurre l’istruzione al cuore dell’educazione, concedere tempo per sapere; investire nel tempo equivale a investire nell’istruzione. Finché si considera la scuola, nonché l’università, uno strumento teso all’ottenimento di un buon impiego, confinando la conoscenza all’applicazione ‒ ulteriore estremismo della logica del consumo ‒, ogni progetto educativo è destinato a fallire. Da questa consapevolezza nasce l’utopia di un’«educazione per tutti», dove il carattere utopistico non sta per fantasioso, ma ne indica la posterità. Augé immagina così una società nella quale l’essere umano come uomo generico, ossia l’uomo «planetario, indipendentemente dalle sue origini, dal suo sesso e dalla sua appartenenza culturale», sia accompagnato al compimento della sua finalità: «conoscere il più possibile». Un primo passo importante in tale direzione, ad esempio, sarebbe assicurare l’accesso alle fonti del sapere, poiché l’aumento delle diseguaglianze economiche non crea conoscenza, bensì ignoranza, che congiunta al progresso della tecnica annuncia «minacce e violenze di varia natura». Ne va, allora, della stessa visione del futuro, oggi abitato da un’apocalisse, come fossimo perennemente angosciati, effetto di un tempo subito e del tutto fuori controllo. Soltanto «un’utopia dell’educazione», in quanto riconquista del tempo, può scalzare
la distopia apocalittica.
Valeria Turra, “Dio è una foglia marcita, in autunno” (Mimesis, 2018); “Ermeneutica del riconoscimento. Fondazione filologica di un concetto” (Mimesis, 2018)
di Antonio Martone
Il breve ma densissimo testo Dio è una foglia marcita, in autunno è fondamentalmente dedicato alla questione dell’ateismo. Più precisamente, esso raccoglie una sfida titanica, ossia quella di render conto della questione del “fondamento” al tempo della nicciana morte di Dio, riflettendo sulle sue conseguenze immediatamente filosofiche e mediatamente politiche. L’A. afferma che la questione del
fondamento (già problematica in quanto definizione), vista la sua intrinseca complessità, o viene elusa con un “facile” ateismo, oppure appare sottoposta ad uno spostamento/dislocazione su ritualità svuotate di senso o, addirittura, viene proiettata su distruttivi fondamentalismi. L’A. colloca su un piano che definirei “topologico” l’oggetto dei propri interessi facendo interagire, con grande competenza e rigore filologico, le riflessioni (letterarie e filosofiche insieme) dei classici e dei moderni. Sofocle ed Euripide da una parte vengono convocati, con rara sapienza comparativa, insieme a Dostoevskij, Tolstoj, Nietzsche ed Hegel, intorno al rapporto istituito nella tradizione occidente fra rito e mito, fra l’agente del mito e quello del rito, al fine di far emergere l’estrema complessità della questione del fondamento e l’impossibilità di potersene facilmente sbarazzare come di un dato ormai non più storicamente influente. In questo orizzonte, si vede bene la volontà da parte dell’A. di valorizzare e far intervenire nella propria analisi, oltre alla speculazione filosofica, anche la narrazione letteraria. Soltanto la letteratura può infatti rappresentare nel “calore di una vita”, e nella cogenza delle
scelte immediate, personaggi capaci di far emergere ermeneuticamente la forza e la preesistenza di un fondamento altrimenti rigettato come un elemento appannaggio di tempi ormai consumati dalla storia. Fra i grandi autori presi in considerazione critica nel testo un posto di rilievo spetta senz’altro a Camus. È proprio all’autore franco-algerino, infatti, che l’A. dedica una ricostruzione a tutto campo, avvalendosi altresì degli apporti provenienti da direzioni le più diverse, al fine di farne vedere la valenza, fortissima, sebbene assai problematica, di grande autore del “fondamento”. Valeria Turra in-siste su tale enquête, peraltro, non lesinando a Camus stesso il rilievo di non essere giunto ad una definizione univoca del tema e di aver sottoposto i suoi oggetti di ricerca, di volta in volta narrati, ad una lunga sequela di slittamenti e di scossoni “semantici”. Ella aggiunge, tuttavia, che tale frammentaria strutturazione, oltre che inevitabile nell’andamento di un opera letteraria, è esattamente ciò che ha reso possibile l’elaborazione di una fitta coltre di metafore con le quali l’autore de Lo straniero cerca di render conto delle domande poste a se stesso, esistenziali e filosofiche nel contempo. È in particolare a questo livello dell’analisi che emerge anche l’assoluta differenza di ispirazione teorica (e di tenuta speculativa, aggiungo io) fra l’autore de La peste e il gruppo degli esistenzialisti della cosiddetta “scuola di Parigi” i quali, a giudizio dell’A. (ma anche nella valutazione dello stesso Camus), avevano troppo frettolosamente accantonato la questione di Dio, della natura e del “fondamento”. Del resto, Sartre e De Beauvoir (in particolare), soprattutto ai tempi de L’homme révolté, non gli avevano risparmiato strali e critiche – non soltanto scientifiche ma talvolta perfino personali. Non poteva essere altrimenti, e questo non soltanto perché, a mio parere, l’uno (Sartre) era uno scrittore brillante e l’altro (Camus) era invece un poeta visionario, ma anche, e soprattutto, poiché la questione della libertà sartriana appare decisamente estrinseca dall’orizzonte camusiano delineante la condizione “absurde” dell’uomo nella storia e nel mondo. Viene fuori, fra l’altro, che la questione del fondamento per Camus, ossia il suo voler tener vivo il discorso circa l’”origine”, è proprio ciò che ha permesso al grande autore franco-algerino, al contrario dei suoi detrattori “athées de bistrots”, di non cadere vittima dell’idolatria della storia. Per Camus, infatti, essendo quest’ultima una dimensione mondana, non potrà che compartecipare del male e dell’assurdo al quale l’uomo non può che contrapporre la morale della misura e del limite.
Il tema del fondamento è ripreso e ampiamente sviluppato nell’altro testo (monumentale) che qui si presenta, ossia Ermeneutica del riconoscimento. Fondazione filologica di un concetto. In esso, l’A. convoca entrambe le grandi linee teoriche della tradizione occidentale, ossia quella platonica e quella aristotelica, analizzate ambedue tenendo conto di una messe amplissima di testi e di autori – che vanno dalla filosofia, alla storia dell’arte, alla letteratura – che a quelle tradizioni si sono in vario modo riallacciate, facendo in definitiva convergere ambedue, speculativamente e comparativamente, in un confronto serrato con l’opera di Kant. Più in particolare, L’A. si sofferma su una rigorosa analisi critica del rapporto fra noumeno e fenomeno, tesa a mostrare l’irriducibilità del primo al secondo. A giudizio di Valeria Turra, valutazione che lo scrivente condivide integralmente, le dinamiche del riconoscimento e dell’identità – oggetto centrale di ricerca del testo – non possono essere comprese a pieno se non all’interno di un rapporto, sofferto quanto inevitabile, fra fenomeno e noumeno o, come piace dire a me, fra trascendenza e immanenza. È inevitabile, altresì, che senza uno sforzo simile, il tentativo stesso di una morale “intersoggettiva” sarebbe inesorabilmente tagliato alla radice. A questo proposito, l’A. scrive parole vibranti e dense nello stesso tempo: “Poiché siamo a noi stessi noumeno in ciò che più vorremmo sapere di noi, talvolta con gioia, talaltra con commozione, persino con paura e smarrimento ci abbandoniamo alla possibilità del riconoscimento dell’altro. Il suo essere per noi essenzialmente fenomeno non ci ferma: la consapevolezza della sua natura noumenica pone un limite al condizionamento dell’intuizione sensibile, che potrebbe ingannarci, e ci permette la comprensione – eccolo, è lui. Eccola, è lei. Da lì comincia il nostro percorso in un’interiorità che non smetteremo mai di voler cogliere. È in questo percorso – sempre frustrato, mai colmato – che il riconoscimento ha il suo vero significato e può diventare fondativo anche per la riflessione morale. Non perché vogliamo necessariamente, come credono alcuni, vedere al di là (il volto di un Dio), ma perché questo percorso ci occupa interamente: esaurisce in sé la ricerca del Senso” (p. 457). La modernità è fondata su un’idea di omologazione razionalistica, perfino opposta a quella del riconoscimento individuale. A partire almeno da Hobbes, l’Evo moderno si fonda sulla generalità identitaria a partire dal comune asservimento al sovrano. Tale sovranità non prevede che a far parte del corpo dei sudditi (poi cittadini) entrino individui riconoscibili; al contrario, nello spirito della modernità, alla soggettività è richiesto semplicemente di far parte di una serie. Tutto ciò significa (e comporta) che alla soggettività si imponga di cancellare se stessa. Più in particolare, nello stesso Hobbes il soggetto è
preso in considerazione soltanto nella sua capacità oggettiva di dare la morte e di mettere in questione, in tal modo, l’ordine politico, e non certo per i tratti che lo caratterizzino in maniera univoca o per le sue radici etiche e comunitarie. Se questa è la realtà moderna, e se la globalizzazione sradicante e spersonalizzante (ciò che nel mio linguaggio è la ecity contemporanea), della modernità costituisce, nello stesso tempo, l’esito e lo sviluppo, si comprenderà facilmente quanto sia necessario ritornare a parlare dell’uomo – come si fa in questi volumi di Valeria Turra – in quanto identità riconoscibile e unicità in atto.
Serge Latouche, “I nostri figli ci accuseranno?” (Castelvecchi, 2019)
di Diego Infante
«Uscire dall’economia». Questo il mantra che scandisce l’ultimo lavoro tradotto in italiano dell’economista e filosofo francese Serge Latouche, interamente dedicato al «pregiudizio di generazione» (Neri D. 2013: 102-104) che grava sul pensiero d’Occidente. Massima chiarezza fin dal titolo, per un agile diario di viaggio in quello che è l’«Antropocene», epoca in cui, come sottolinea l’autore, «L’uomo è diventato una forza tellurica in grado di interferire con i grandi cicli del pianeta».
A una iniziale pars destruens dedicata alla storia economica, ovvero alle cause più o meno remote della negazione del concetto di limite, il solo argine in grado di assicurare un credito verso le generazioni future, segue una pars construens, che individua nella decrescita la «fonte di un futuro sostenibile».
L’organigramma è il seguente: dall’originaria condizione di debito nei confronti delle forze cosmiche e del sacro immanente, si è infine giunti a un’accezione di “debito” di tutt’altro genere: come afferma Alexander Langer (citato significativamente in apertura e in chiusura), «Mai una generazione prima della presente ha avuto nelle sue mani la stessa decisione se lasciar continuare la successione di generazioni o se interromperla o metterla comunque assai pericolosamente a repentaglio».
Ecco perché, alla base dei cascami generazionali dell’economia moderna, Latouche individua giustappunto la «separazione radicale tra gli uomini e il loro fondamento naturale».
Da questo punto di vista, Francis Bacon raggiunge inusitati vertici di chiarezza, in buona continuità, del resto, con il celebre passo della Genesi (1, 26-28): «La natura è una prostituta; noi dobbiamo soggiogarla, penetrare i suoi segreti e incatenarla secondo i nostri desideri».
I presupposti teorici dell’Antropocene trovano poi in Cartesio un’ulteriore conferma. La separazione res cogitans-res extensa, ovvero mente-corpo, di fatto «assegna all’uomo moderno la missione di diventare signore e padrone della natura». Da qui alla riduzione del mondo a criteri puramente utilitaristici il passo è decisamente breve.
E infatti, sul banco degli imputati a noi più prossimi, l’economista Latouche pone proprio gli economisti: essi, come egli afferma, «Hanno giustificato, favorito e accompagnato il sistema produttivista e continuano in gran parte a farlo, dando prova di una straordinaria cecità che confina a volte con una cattiva fede criminale».
Già perché se da principio persino i vincitori del Nobel si premuravano di assecondare il più bieco negazionismo – nonostante gli allarmi lanciati dal Club di Roma –, le cose non sono poi così cambiate, visto che molti economisti, pur non negando un problema che ormai è sotto gli occhi di tutti, continuano a propugnare le solite ricette, arrivando a sostenere che solo la crescita può contribuire alla risoluzione del problema ambientale. Secondo costoro, infatti, l’aumento del PIL «consentirà di pagare il conto senza grandi difficoltà». In breve, una spudorata celebrazione delle «magnifiche sorti e progressive», già messe all’indice da Leopardi.
A questo punto il lettore si chiederà come sia possibile uscire da questa prigione, che non è solo teorica, ma soprattutto pratica. La proposta di Latouche, cui egli dà spazio nella seconda parte del testo, è una sola: la decrescita. Per contrastare quella che Günther Anders definisce l’«obsolescenza dell’uomo», occorre costruire una società dell’«abbondanza frugale», secondo la formula coniata dall’antropologo Marshall Sahlins, perché un pianeta finito non può ospitare una crescita che si suppone infinita. In breve, nulla a che spartire con le varie teorie dello sviluppo sostenibile, che hanno soltanto lo scopo di inoculare la malattia in forma più gradevole (degradabili a mero “greenwashing”), sebbene lo stesso Latouche ammetta la necessità di procedere per gradi.
Quanto alle proposte concrete, l’autore individua nell’economia circolare il ribaltamento del paradigma vigente improntato alla cultura dell’“usa e getta”, la cui rappresentazione più icastica risiede nella commercializzazione di prodotti destinati a un ciclo di vita abbreviato “ad arte” (cosiddetta «obsolescenza programmata»). Da precisare che non si tratta di inventare nulla di nuovo: come egli afferma, «La natura, in effetti, non produce rifiuti […] In essa tutto è riciclato».
Orbene, nonostante i vari esempi addotti (uno su tutti: le bioplastiche), Latouche sa perfettamente che il capitalismo, pur di sopravvivere, è pronto ad adottare ogni strategia possibile, fosse pure raschiare il fondo del barile. Ed è per questo che egli si fa portavoce di un’idea molto forte, probabilmente l’unica possibile: delegare il raggiungimento di questi obiettivi alla coercizione statuale.
Al contrario, ribaltare il paradigma “dal basso”, prosegue l’autore, può avvenire solo attraverso la (ri)scoperta del «dono» (evidente il riferimento a Marcel Mauss e alla sua scuola), della «lentezza» e della «vita contemplativa».
Nondimeno, ciò non significa abbandonarsi a velleità quali l’abolizione del denaro, che «deve servire e non asservire». Di più: è proprio grazie all’uso consapevole della moneta che è possibile ristabilire l’aspetto fiduciario e la reciprocità tra le persone. In breve, non un fine, ma un mezzo.
Per tirare le somme, con questo scritto Serge Latouche si conferma uno dei più acuti e dissacranti osservatori del nostro tempo, il cui ulteriore pregio risiede in un’ottima capacità narrativa, che consente anche al lettore meno avvertito di comprendere i meccanismi, più o meno occulti, che reggono il paradigma vigente. Del resto, espressioni quali «decrescita», «obsolescenza programmata», ma anche «decolonizzazione dell’immaginario» e «pedagogia delle catastrofi», sono ormai patrimonio consolidato di un lessico ambientalista degno di questo nome.
La conferma, se ce ne fosse bisogno, che parlare di economia a un pubblico vasto non solo è possibile, ma oltremodo necessario. A patto, ovviamente, di «uscire dall’economia».
J. Clarke, Football hooliganism. Calcio e violenza operaia (a cura di L. Benvenga), Deriveapprodi 2019
Intelligente operazione di scavo da parte dello studioso salentino Luca Benvenga, che offre un’ottima curatela dell’indagine storico-sociale di John Clarke sul fenomeno calcistico e sul tifo organizzato in Inghilterra (“Football Hooliganism. Calcio e violenza operaia”, per i tipi di Derive Approdi, 2018).
E. Dussel, Le metafore teologiche di Marx, Inschibboleth edizioni 2018
“Le metafore teologiche di Marx” del filosofo e teologo latinoamericano Enrique Dussel ci pone sin dal titolo di fronte ad una contraddizione: non siamo forse abituati a considerare il pensiero di Marx come totalmente ateo e quindi nemico della religione? Questo conflitto del resto ha generato rivalità storiche dall’aura quasi mitica come quella tra i partiti comunisti e quelli cristiani, immortalata poi in letteratura dalle figure di don Camillo e Peppone, emblemi di due mondi inconciliabili.