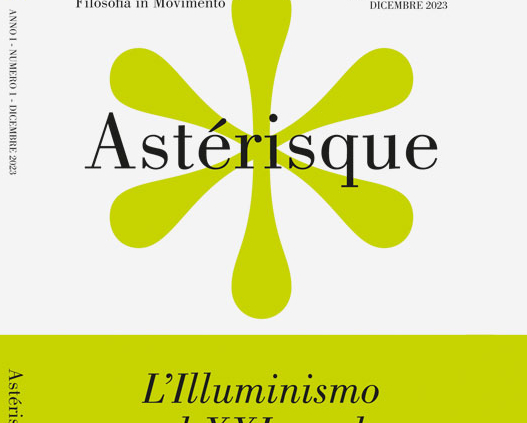Riposta alla risposta di Giorgio Cesarale al mio Illuminismo su «Astérisque»
Può darsi che nel mio scritto sull’Illuminismo vi sia qualche frettolosità e qualche semplificazione circa il punto che Giorgio Cesarale – nel Commento al mio articolo Illuminismo, «Astérisque», I 1, pp. 27-38, 39-46 – più mi rimprovera: la mia polemica contro l’idea di totalità, dell’intero e le sue conseguenze. Intanto sgombererei il campo dalla previa connessione della totalità con il misticismo. Non che il nesso non vi sia, ma il mistico si dice in molti modi, alcuni dei quali sembrano persino inseparabili dal filosofare e dalla comune esperienza. Se affermo che sono e mi sento parte di un più vasto organismo, al limite dell’intero genere umano, che condiziona il mio modo di pensare e a cui interamente mi rimetto, non si vede perché questa posizione dovrebbe essere censurata. Semmai il problema nasce qui dall’interno, quando hegelianamente comincia a presentarsi nella storia un’individualità che, al modo di Antigone, esorbiti, mettendola in crisi, da una comunità fino ad allora «totalitaria». Ma questo apre, come si vede, un altro problema: dove mai lo holon sociale potrebbe essere detto senza l’interna determinazione delle soggettività? La totalità dovrebbe essere allora costituita dall’insieme, dai singoli e dalle loro relazioni. Solo che in questo modo ci incamminiamo lungo una totalità composta di parti che nell’atto stesso nega ciò che qui c’interessa: un insieme che riduca a sé tutte le interne determinazioni e differenze, dove le soggettività e le «cose» non oppongano nessuna resistenza al loro assorbimento nel tutto, nessun ostacolo all’immane potenza unificante dell’intero. Parmenide esplicitamente esclude che l’intero dello sfero possa mai esser composto di parti, ciò che implicherebbe anzitutto la discontinuità di spazio e di tempo, la presenza di determinazioni. Ma, di contro, ogni volta che una determinazione e una differenza trovano posto, che il pensare-dire sia agito dal tronco aristotelico, nominando alcunchè è negata la forza esclusiva dell’intero, la totalità come reale dominio della conoscenza. Possiamo per queste ragioni tralasciare ora una piena presa d’atto del problema del misticismo, che o è un altro modo di dire la totalità o si risolve in vario modo nell’esperienza comune del gioco tra un intero e le sue parti.
Ma venendo ora propriamente alla «totalità», si può dire tanto che è una costante tensione, in certo modo ineliminabile dal pensiero, tanto che è un «luogo» dove il pensiero rischia di perdersi interamente, trovando un’annihilatio proprio al termine delle sue più alte prestazioni, una riconduzione a quell’oscurità da cui ci si è faticosamente distaccati. Ora, perché l’intero è legato a quelle determinazioni che pur fondano l’essenza del pensare? Un primo motivo, vien fatto di dire, è che le stesse determinazioni, nonché imporre la loro presenza, vengono, in una prospettiva dualistica, «costruite» o guadagnate, separate dalla (costruita) «totalità» che in qualche modo pur ci costituisce, attraverso le relazioni e le scissioni che affettano, a cominciare dalla corporeità e dall’affettività, la nostra soggettività. Il puro pensare deve, fino a un certo punto, liberarsi da questo peso dell’intero, non al punto però da non ritrovare nel suo cammino l’esigenza e la periodica verifica, anzitutto, di quell’insieme di mente-corpo, di cui si può fare epochè ai fini del pensare (fino a un certo punto, ripetiamo), ma che non si può mai presumere di vanificare del tutto. Anche le più trite e discutibili definizioni dell’uomo come zoon politicon, animal sociale et politicum esprimono a loro modo un «insieme», la cui traccia non si può mai lasciar cadere. Per questo aspetto dunque si deve dire che «l’intero» ci abita e che con esso, dentro di esso, lavoriamo, depurandolo e isolandolo per raggiungere la distinta chiarezza (quasi un innesto di Freud in Cartesio) delle determinazioni. Ci sono infinite cose nell’uomo e nell’atto del pensare che, oscuramente giacenti sempre al fondo dei nostri pensieri, possono talvolta ricomparire con forza all’interno e dentro la semplice e netta riflessione, una «totalità» che va ogni volta controllata e dominata, e semmai fatta giocare con la parzialità e la finitezza.
Dal lato della conoscenza, a parte obiecti, la totalità si presenta per il fatto che la determinazione, come pensare-agire, sposta sempre in avanti il suo limite, quasi un orizzonte che appena raggiunto presenta subito, in un mondo sferico, un’ulteriore meta. Il senso dell’oltre, la dimensione umana che è al tempo stesso, come in Ulisse, segnata dalla fondamentale finitezza, ma anche dall’apertura all’infinita «totalità», fa sì che la tensione all’intero, mai del tutto debellabile, e anzi essendo anche produttiva, deve essere ricondotta e ricomposta ogni volta dalle ragioni del finito, dall’imprescindibile orizzonte di ogni conoscenza. Se mai l’idea della totalità si attuasse per intero, prendendo corpo e dominio, risolverebbe in sé, dissolvendola, ogni soggettività, ogni pensiero e ogni teoria critica; ma al tempo stesso una «totalità» parziale, ristretta (e capricciosa), per servirsi di questi ossimori, sembra sempre aggirarsi, certo per essere fondamentalmente dominata, nelle nostre esperienze, ma anche talvolta per far da lievito, una volta ricondotta alla dimensione del finito, alle nostre più alte e significative pratiche. Lo sforzo della determinazione comporta anche costi, persino alti, di introspettiva autolimitazione, di sacrificio, sebbene ineliminabile perché si dia la sua produttività.
Diverso è il caso di quanti problemi una determinazione abbracci, e nel tempo, o fin dove s’estenda la sua rete. Qui vi è certo differenza tra le determinazioni, a volte circoscritte e a volta di larga portata, intensive ed extensive. Non si vorrà negare questa differenza, né l’invito a non abbandonare il terreno dei grandi problemi o, come si dice con qualche sdegno delle grandi «narrazioni», per affidarsi solo a quei piccoli interventi che popperianamente si dicevano «a spizzico», o alla «metafisica del potere», alle lotte sempre «circoscritte e locali» di Foucault, dopo l’abbandono, stimato necessario, dei «progetti globali e radicali». Ché altrimenti – come giustamente osserva Giorgio Cesarale – rinunciando a ogni più ambiziosa tensione critica, ci lasceremmo «determinare da strutture più generali di cui rischiamo di non avere né la consapevolezza, né la padronanza». Ma allora il caso consiste veramente nell’affrontare e riformulare la problematica drammaticamente difficile della totalità». proprio in questo caso si deve badare, come più facile deviazione, che i problemi più larghi e comprensivi slittino, proprio per questo, in un non ammissibile esito di «totalità».
S’innesta proprio qui, intorno alla discussione sul «difficile problema della totalità» la recensione-discussione di Giorgio Cesarale al mio articolo, fatto di apprezzamenti e critiche. Di ciò dirò solo poche parole, sia perché ognuno può leggerlo e giudicarlo da sé, sia perché la discussione sarebbe piuttosto tecnica e complessa, sia infine perché dovrebbe avvenire in absentia di Giorgio. In breve, la parte in cui siamo discordanti, come si legge nella conclusione dell’intervento di Giorgio, riguarda l’inizio del nostro filosofare, il «cominciamento» della stessa filosofia o scienza, come accade in apertura della grande Logica di Hegel. Giorgio ritiene che la filosofia giunga a verità e forza critica solo quando cominci e si mantenga nell’orizzonte dell’assoluto. Questo vuol dire che dalla filosofia debba essere esclusa ogni considerazione empirica o pragmatica, come sarebbe la dualità di essere e pensare, di io e mondo; e ciò potrebbe avvenire, come nel radicale idealismo della filosofia classica tedesca, solo se è il pensiero che pone a sé il suo stesso oggetto, scoprendosi non si sa come «essere» o anche «creatore del mondo», in concorrenza col Dio specificamente cristiano, non demiurgo ma creator ex nihilo. Questa identità parmenidea tra pensare ed essere, noein kai einai, dovrebbe ritrovare al suo interno (dedurre/causare) determinazioni e differenze, l’intera ricchezza del mondo, pur in una totalità priva di condizioni e con risultati che appaiono sempre «posti». Da parte mia ritengo invece che la filosofia può e debba nascere, più o meno in senso kantiano, solo dall’empirico e dal finito, da un dualismo originario, seppur subito rinvenibile nelle attività stesse del soggetto. Il risultato di questo così diverso inizio del filosofare è sconcertante, perché entrambi ci rimproveriamo, da due angoli diversi, la stessa cosa. Io dico che una prospettiva come quella di Giorgio che muova da una totalità che attraverso la totalità pervenga alla totalità non riuscirà mai a incontrare ed elaborare determinazioni e vita «reale»; Giorgio a sua volta mi rimprovera che sono io a non incontrare mai reali determinazioni, perché, essendo la mia prospettiva interamente empirica, le pretese determinazioni, innovazioni e differenze ripeterebbero – ma allora facendo intervenire il non congruente uso del trascendentale – senza alcuna consistenza, sempre e all’infinito, una sostanziale identità. Ora questa «bizzaria» non è suscettibile di ulteriori svolgimenti: monismo ontologico e dualismo sono entrambi presupposti infondati e infondabili, privi di dimostrazione. Forse – è la mia convinzione – è meglio abbandonare del tutto questo terreno di «filosofia prima», occupandoci di illuminismo militante e della mondana «filosofia» che esso di volta in volta genera.
Servirsi di un kantiano «pensare largo», ma al tempo stesso non rinunciando alla forza che proprio le determinazioni conferiscono alla nostra azione teorica e pratica, è il grande compito che la riflessione (in senso kantiano) deve oggi affrontare, cercando di ricondurre a ciò anche imponenti filosofie che abbiano passato questo segno. E poiché sono stato contrapposto al più forte pensiero di Foucault – un autore verso cui nutro qualche diffidenza, ma di cui si dovrebbe tornare a discutere, non fosse altro per la profluvie di scritti e discorsi che gli archivi continuano a sfornare ma anche per la sua complessa (e riduttiva) posizione verso la «filosofia politica», magari riprendendo quel confronto con Hanna Arendt cui da tempo è stato spesso associato, per similitudine o pur solo per differentiam – vorrei finire questa breve analisi con una citazione foucaultiana, con cui sono interamente d’accordo, tratta dalla conclusione di Il coraggio della verità:
«ma ciò su cui vorrei insistere, per finire, è questo: non vi è instaurazione della verità senza una posizione essenziale dell’alterità; la verità non è mai il medesimo; non può esserci verità che nella forma dell’altro mondo e della vita altra».
2) Su dualismo e assolutismo della totalità come posizioni ultime, non fondabili
La mia discussione con Giorgio potrebbe esser detta ‘Filosofia e illuminismo’. L’I ha bisogno della filosofia? Sì, anzitutto come determinazione di un ambito, sia pur impegnativo, di storicizzazione e concettualizzazione delle singole posizioni illuministiche nell’ambito dell’I stesso, nella vicenda più larga dell’intero I, ma senza trascendere i confini dei prodotti culturali dei fenomeni detti illuministici. Esempio insuperato di ciò resta forse la Filosofia dell’illuminismo di E. Cassirer, che si occupa di due secoli quasi pieni, il ‘600 e il ‘700, come sfondo dei temi illuministici. Chiamerò ciò Illuminismo-Filosofia (IF), che riguarda la sola filosofia richiesta dall’I. C’è poi un più vasto regno della filosofia, che potrebbe, in ipotesi, mettere a tema e smentire, al di là della storia, gli stessi risultati dell’IF. Non si può dunque abbandonare questo piano più largo sui fondamenti e le intere pretese suscitate da ciò che dirò Filosofia-Illuminismo (FI). Il problema è qui allora di capire quale filosofia possa essere omogenea alla FI e quale invece finisce per negare la stessa IF.
Qui, propriamente, nasce il dissidio tra me e GC. Se io cerco di tracciare alcuni punti di questo retroterra filosofico della FI, GC. mi sembra volto subito a far riferimento a una filosofia molto forte, qual è quella che riguarda l’assoluta totalità, che ha l’illuminismo come un sottoprodotto di cui si può parlare solo in quanto la FI ha trovato posto nell’ambito dell’intero, dell’hegeliano «ganz». Una deduzione e un compito che, mi pare di capire, ancora non hanno avuto adeguato sviluppo filosofico perché sembra che l’I possa rinascere solo quando i problemi come quello della totalità siano avviati a soluzione.
Ho detto sopra che a parer mio iniziare (e sviluppare) la filosofia dal punto di vista dell’assoluta totalità o dalla finitezza «dualistica» non è di per sé produttivo, in quanto questi due cominciamenti sono altresì la colonne d’Ercole del filosofare, ossia che essi sono né fondati, né fondabili. Tuttavia è anche necessario che – prima di abbandonare il campo per passare, eventualmente, all’I militante – si tenga conto di un’ultima considerazione, riguardante non tanto la cosa in sé quanto piuttosto i suoi fruitori. Se la discussione si articola intorno al concetto di totalità, abbiamo a che fare con un concetto così forte da ridurre a sé ogni altra questione.
Mi preme qui richiamare come l’orizzonte della totalità attiri a sé anche a parte subiecti, vale a dire che la stessa argomentazione è ricondotta al suo tema, essendo anch’essa composta di «proposizioni assolute». Anche saltando qui il problema del pensare-dire, non evitabile nemmeno aristotelicamente, resta che il discorso sulla totalità deve essere sorretto dal concetto di assolutezza, e ciò suppone che, non essendoci più totalità, unica sia la forma e il contenuto della sussunzione, esibizione (anche qui non dimostrazione) e della sua argomentazione, sorrette da una sorta di «pensiero unico».
Dalla mia prospettiva di pensiero finito e «dualistico» le cose stanno diversamente, nel senso che si danno (e si mantengono) reali possibilità di lavorare quelle che ho chiamate «determinazioni» e «differenze», senza divieti da parte della filosofia. Per quello che ora ci riguarda, vi sarà in questa prospettiva una pluralità di possibili opzioni filosofiche, una diversità ad esempio delle concezioni circa il bene, senza quella sorta di «ricatto» che il pensiero della totalità fatalmente esercita verso gli interlocutori, forzati ad accettare tutti lo stesso pensiero ché la totalità conoscerebbe solo se stessa. C’è per la verità la tradizionale risposta a ciò della filosofia, quando distingue episteme e doxa; ma il problema è qui come possono stare insieme queste due forme, dallo statuto così diverso, con difficoltà che riguardano lo stesso tentativo di pensare anche una recta ratio (orthos logos). Le colonne d’Ercole s’incontrano solo quando il pensare finito e «dualistico», tenta di trasporre in termini «fondanti», ontologici e metafisici, questo stesso orizzonte finito e duale, quando si ponga la durezza della «cosa in sé». Non traggo ora la necessaria conseguenza per cui come la posizione della «totalità» è incompatibile con ogni forma di empirico illuminismo, così, parimenti, la democrazia che almeno abbia qualche consistenza e consapevolezza di sé non è pensabile in questa tensione all’assoluto. Ma prima di ciò, la posizione che parte dal finito lascia a tutti la liberale e goethiana facoltà di pensare i condizionati e i plurali modi dell’illuminismo.