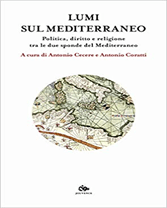DISAVVENTURE SOCIALI DELLA LAICITÀ CIVILE NELLA SUA CULLA
DISAVVENTURE SOCIALI DELLA LAICITÀ CIVILE NELLA SUA CULLA
di Domenico Bilotti
Ci sono dei temi e dei principi che restano indissolubilmente legati all’ambito o all’ordinamento entro cui hanno avuto primigenio, o più interessante, sviluppo. La moderna teoria dei diritti umani è difficile da immaginare fuori dal diritto internazionale, che se ne è assunto (nonostante i limiti) le necessità di tutela, protezione e promozione. Quando si discorre di equità, si tende a riferirsi o al diritto delle Chiese cristiane – entro cui l’equità si era munita di un raffinato e sostenuto sostrato teologico – o alle giurisdizioni equitative di common law (meno legislazione scritta e generale, più dibattimento e vincolatività del precedente). Stando alle proiezioni ultime della dignità umana, anche attraverso l’elaborazione del costituente tunisino Fathi Triki che parla espressamente del “vivere insieme nella dignità”, essa non potrà che trovare nuovi percorsi e opportunità ermeneutiche nell’intercultura e nel diritto interculturale. Se invece si parla di laicità, l’attenzione si rivolge immediatamente al diritto francese, che in più stagioni, dall’illuminismo alla crisi dello Stato liberale, dallo Stato sociale fino al neocostituzionalismo, ne è stato singolare laboratorio. Proprio per questo giunge quanto mai interessante il recente lavoro di Vincenzo Pacillo, per i tipi di STEM Mucchi (Modena, 2024), “Per sempre giovane. La laicità nel dibattito culturale francese: scrittori e politica ecclesiastica da Victor Hugo a Annie Ernaux”.
Nonostante le ricche analessi e prolessi che animano in primo luogo la sezione bibliografica, il criterio espositivo seguito è essenzialmente quello cronologico. Negli ultimi capitoli, all’esposizione cronologica si aggiungono ulteriori snodi tematici che arricchiscono lo sguardo più esso si avvicina ai conflitti del presente.
Il prequel del volume, che dà conto di un titolo quanto mai appropriato, anticipa il primo capitolo nel quale la laicità appare dalla sua lenta ma costante nomogenesi nella Francia rivoluzionaria fino al separatismo al tempo della Comune di Parigi. Fa molto bene l’A. ad enfatizzare come la laicità in Francia non nasca nello specifico di una connotazione irreligiosa (molti dei costituenti repubblicani erano profondamente religiosi, dal punto di vista individuale), bensì prettamente anticlericale. I passaggi più stimolanti riguardano lo “strano” caso di Gustave Flaubert (p. 72), autore a volte in bilico tra secolarizzazione dei costumi, facezie borghesi e pubblico conservatore, nonché la menzione di George Sand, scrittrice simbolo di un femminismo moderato repubblicano, eppure messa all’Indice dei libri proibiti nel 1863. Le vicende giuridiche sono fondamentali per il dibattito intellettuale, perché movimentano l’opinione, e non è un caso che nel capitolo, più che la scomunica del cattolicesimo liberale parigino, emerga la reazione francese al Sillabo pontificio “degli errori della nostra età” (quella moderna, ça va sans dire) e al rapimento del piccolo Edgardo Mortara, di origine ebraica.
Il secondo capitolo tratta dell’Affaire Dreyfus in modo assolutamente originale. Se anche fortissime tradizioni intellettuali lo hanno narrato secondo binari particolarmente rodati (repubblica e socialismo, antisemitismo e conservatorismo, garantismo e mentalità inquisitoria), qui a venire alla luce è lo scontro tra il clericalismo e la difesa dei valori repubblicani. Esiste la possibilità di una difesa cattolica e totalmente orientata alla civile convivenza anche nei confronti della presunta spia, perlopiù nel montante sospetto antiebraico del tempo? La nota posizione di Zola e del J’accuse è rimessa al paragrafo conclusivo (p. 137). Colpisce molto, invece, lo spazio dato a Charles Péguy, a lungo recuperato soltanto in letture reazionarie per la sua natura di socialista irregolare, di pessimista morale acceso dall’amore per la carità (p. 123).
Il modo in cui Pacillo affronta il profilo di Zola è simile ad alcune considerazioni già svolte per la Sand: due profili che nei rispettivi contesti nascono intransigenti nell’argomentazione, ma fondamentalmente moderati in contenuti e forme, finiscono poi per approssimare posizioni socialiste. È come se a un certo punto la laicità scindesse la sua anima borghese-rivoluzionaria e fosse necessario scegliere radicalmente se collocarla nei valori della conservazione (lo spirito della repubblica, le istituzioni del colonialismo prima e dell’assimilazionismo poi) o della liberazione. L’intellettualità francese militante, a costo anche di talune semplificazioni che perdurano fino ai giorni nostri, ha dimostrato di propendere per questa seconda interpretazione. È che la laicità della metà del XIX secolo aveva come suo canale di manifestazione lo scontro etico-politico tra Stati e magistero della Chiesa cattolica. Quella odierna, dopo aver lungamente difeso il più netto separatismo, ha impattato il mondo delle migrazioni e si è dovuta chiedere come veicolare l’inclusione e a che prezzo far cedere essa rispetto ai rapporti tra norme costituzionali e precetti delle culture religiose.
Il terzo capitolo è legato alla Legge di separazione del 1905. Se si ha memoria storica del diritto e della politica continentale, è il punto formale più alto dell’emancipazione statale nei confronti dell’ingerenza ecclesiastica e tuttavia anche l’ammissione di non piena scindibilità dei due orizzonti di senso (la vigenza alsaziana del concordato napoleonico, a guerre finite, lo dimostrerà sul piano delle fonti; la sostanza era già chiara).
Come si diceva, il quarto e il quinto capitolo sono due delle sezioni più cospicue del volume. Nel secondo Ottocento italiano, anche sulla scorta dell’esempio francese, c’erano stati vari filoni di insoddisfazione verso la giustizia sociale assente nella legislazione liberale e il suo intrinseco moralismo, nonostante le pretese separatistiche. Il verismo, la scapigliatura, poco oltre i crepuscolari e gli ermetici, su posizioni antiretoriche, aderirono diversamente alle medesime criticità di impianto. Il ruolo di sentinella intellettuale della laicità in Francia non si spegne nella critica agli statuti borghesi, peraltro poi trionfanti, ma arriva alle speranze del costituzionalismo post-bellico e a tutte le incognite successive alla fine del mondo imperniato sui grandi blocchi noti del capitalismo e del sovietismo. Va pur detto che ad abbeverare questa costante mobilità critica sia a lungo stata l’autorappresentazione degli intellettuali francesi (e della grandeur governativa). Il pensarsi sempre caso a parte, caso speciale, stimola la superficialità pretenziosa degli isolazionisti, ma anche la duttilità critica degli spiriti liberi. C’è così spazio per la dolente “eresia” morale di Georges Bernanos, non meno che per la vitalità intellettuale di Jacques Maritain: modello laicale del Concilio Vaticano II e contemporaneamente sensibilità religiosa nella mai davvero raggiunta codificazione effettiva della cooperazione internazionale.
Il quinto capitolo fornisce ragguagli importanti sui protagonisti del dibattito nel secondo Novecento, sia che si tratti di singoli autori che di soggetti collettivi. Si veda, a partire da p. 259, l’attenzione rivolta al Partito Comunista Francese, unico, insieme a quello italiano, ad avere in Occidente un peso così determinante per almeno tre decenni nelle opinioni pubbliche nazionali. In Francia e in Italia, in effetti, il dibattito sulla laicità, di là dall’interesse multidisciplinare per esso di ecclesiasticisti, costituzionalisti o gius-filosofi, è stato nel concreto delle società civili anche un discorso sull’inclinazione e sull’azione della sinistra politica – tanto quella riformista quanto quella rivoluzionaria.
Ai titoli di coda, c’è spazio per tutte le questioni che hanno affollato l’agenda dell’ultimo decennio, senza però sempre conseguire la adeguata risposta di sistema. L’antiterrorismo è divenuto essenzialmente antifondamentalismo, con strumenti tuttavia emergenziali sovente in tensione rispetto alle libertà fondamentali. È emerso un nuovo femminismo decisamente anti-confessionale e anti-convenzionale, nonostante le invocazioni femminili per il mantenimento delle culture di origine; hanno conseguito la ribalta le pose a volte estetizzanti degli intellettuali di grido, come Michel Onfray, nonostante l’oggettivo interesse di alcune loro posizioni.
Questo diffuso itinerario concettuale ha il merito di essere condotto con metodo giuridico e ricorrendo in misura determinante alle fonti letterarie di cui si abbevera. È come se il filone di studi chiamato “diritto e letteratura”, o “law & literature” (a tacere degli ambiti più ristretti che sotto la sua egida sono nati), fosse giunto a rivendicare la sua quarta dimensione. Dopo la base (l’ontologia: oggetto della materia), l’altezza (l’epistemologia: il discorso sul suo sapere scientifico) e il volume (la deontologia: il dover essere delle sue opportunità di studio), sembra arrivato il momento del “tempo”: la capacità del diritto e della letteratura di convergere sugli effetti sostanziali di lunga durata. La posta in gioco non appare la reciproca coabitazione accademica di umanisti e giuristi, di letterati e filosofi, di processualisti e sostanzialisti. C’è piuttosto in ballo la costruzione materiale e la costituzione formale di una civiltà della giustizia. Per quanto tante vicende ultime ce ne suggeriscano irrimediabilmente distanti, è forse corretto affermare che in essa, certo in vesti nuove e misurando problematiche diverse, la laicità non possa che restare “giovane”, centrale.