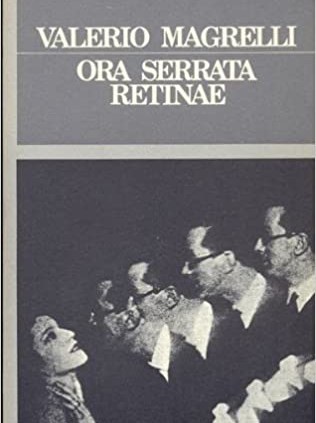Un commento a Nancy Fraser, “Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo?” (Castelvecchi, 2020)
di Laura Pennacchi
Condivido largamente la riproposizione che Nancy Fraser fa del “socialismo” per il xxi secolo basata su una “prospettiva allargata” con cui guardare tanto al capitalismo quanto al socialismo, lavorando sulla loro intrinseca multidimensionalità e pertanto ridimensionando visioni “ristrette”, sostanzialmente economiciste e deterministe. L’allargamento della visione del capitalismo compiuta da Fraser, fino a concepirlo come “ordine sociale istituzionalizzato”, comprende la critica dell’idea di meccanismi automatici che presiederebbero al suo funzionamento da cui scaturirebbe la tendenza naturale al “crollo” (prendendo invece pienamente atto della incredibile capacità di adattamento e di metamorfosi che il capitalismo storicamente ha manifestato), la presa di distanza dalla presupposizione di una linearità tra “crisi capitalistica” e conflitto sociale emancipante (linearità smentita tante volte dai fatti, che non di rado hanno portato ad esiti regressivi e pericolosi per la democrazia), la denunzia dell’errore di attribuire il primato alla sfera economica (e dunque alla produzione e alla lotta di classe) attribuendo un valore non primario alla storia, alla cultura, alla geografia, alla politica, all’ecologia, alle istituzioni, così sottovalutando come “contraddizioni secondarie” la distruzione ambientale, il razzismo, il sessismo, l’imperialismo, la divisione tra “economico” e “politico” (che in realtà spesso copre l’assoggettamento del “politico” e del “pubblico” – a cui Fraser attribuisce una grande importanza – all’”economico”).
Correlata è la visione allargata del socialismo alla cui costruzione, in una sorta di quadro polanyiano radicato sui “confini” tra sfere, Fraser ci sollecita, nella quale abbiano molto più peso di quanto non ne avessero nelle versioni precedenti, specie in quelle di stretta derivazione marxiana, gli apporti del femminismo attenti alla problematiche della “cura” e della riproduzione sociale, dell’ecologismo, del postcolonialismo, in grado di concorrere a configurare il socialismo non “solo” come “una trasformazione dell’organizzazione economica” (p. 27 e seg.), ma anche come trasformazione della riproduzione sociale e delle categorie sessuali e di genere, salvaguardia dal free riding del capitale sui “doni” gratuiti della natura, arresto della “espropriazione della ricchezza delle popolazioni razzializzate”, espansione della portata dell’autogoverno democratico. Ne scaturiscono da un lato un ampliamento della nostra stessa concezione della “crisi capitalistica” rivelandocene “innate tendenze autodestabilizzanti che vanno ben al di là di quelle interne alla sua ‘economia’”(p. 28), dall’altro una riconfigurazione del socialismo secondo quello che Giorgio Fazio chiama “punto di convergenza prospettico di tutte le soluzioni che è possibile escogitare, in uno spirito di ricerca cooperativo e sperimentale, ai mali strutturali delle nostre società” (p. 2).
L’ambizione che credo dovremmo nutrire è quella di un approfondimento ulteriore del quadro allargato che Fraser ci fornisce, in direzione di una discesa e di una risalita ancora più audaci nella fondazione filosofica del socialismo di cui abbiamo bisogno, se per filosofia intendiamo non qualcosa di astratto e di speculativo, ma la pensabilità stessa della vita e del mondo. Una pensabilità con cui dotarci, allo stesso tempo, sia di un di più di perspicuità cognitiva, sia di un di più di efficacia pratica e tale contiguità tra “cognitivo” e “pratico” non sembri un paradosso, tanto più nelle drammatiche condizioni odierne – con la recessione globale provocata dalla pandemia da coronavirus che assume le sembianze di un diluvio universale con disoccupazione, precarietà e inattività elevatissime – nelle quali dobbiamo riconoscere il carattere accentuatamente etico-politico di ogni accadimento, il quale chiama in causa in modo non banale la dimensione dei valori. Tale carattere etico-politico da una parte dà alla denunzia dei guasti sociali e politici un forte significato morale, dall’altra dà alla moralità un elevato contenuto critico: l’agire morale si presenta tout court come “un agire critico”. Dunque, gli aspetti “simbolici” e “culturali” alla cui considerazione Fraser ci richiama per costruire il socialismo come “ordine sociale istituzionalizzato” alternativo a quello racchiuso nel capitalismo debbono pienamente incorporare le strutture primordiali, e le categorie, della relazione, dell’ intercomunicatività, dell’alterità, della socievolezza, dell’apertura e quelle, connesse, della vulnerabilità e della interdipendenza, prestando grande attenzione, oltre che ad Habermas, a filosofi quali Lévinas e Ricoeur.
Grazie a tali categorie non rinunziamo a una elaborazione intorno alle soggettività, individuali e collettive, rinunzia alla quale, invece, ci invita una riflessione postmodernista e di stampo foucaultiano che scambia la deflagrazione del “soggetto/sostanza” di matrice cartesiana (declinante la sovranità del soggetto nei termini di una razionalità illimitata, operazionalizzabile in qualunque direzione, fino al delirio onnipotente dell’homo faber che soggioga non solo la natura ma se stesso al dominio della tecnoscienza “fabbricando” l’uomo nuovo) con la deflagrazione del soggetto tout court, in Heidegger spinta fino allo scherno sull’”umanesimo” (posto che è un’illusione che con l’umanesimo “l’uomo si sia emancipato dai ceppi precedenti”). L’elaborazione sulle soggettività è imprescindibile se si vuole ripoliticizzare il mondo. Dopo la lunga fase di depoliticizzazione imposta dal neoliberismo, la ripoliticizzazione della vita e del mondo passa attraverso la riabilitazione della dimensione morale e dunque attraverso processi di risoggettivizzazione che incorporino la scoperta della vulnerabilità dell’io e della sua intrinseca ambivalenza “tra sovranità e carenza, tra desiderio di autoaffermazione e senso di sradicamento, tra conquista e perdita”[1]. Perché dalla tensione, intrinseca al soggetto individuale, tra “sovranità sul mondo” e “assoluta subordinazione” (portata all’estremo dalla desoggettivazione dell’homo oeconomicus del neoliberismo) esplodono le “figure della soggettività politica, dalla cittadinanza alla classe”, a loro volta “all’origine nella modernità di infinte tensioni e contraddizioni … costitutive della figura dell’individuo così come delle diverse figure della ‘collettività’ (da quella del popolo a quella della nazione)”[2]. L’interesse economicistico è imprigionato sul “ritorno su di sé”, ma è l’ordine simbolico dei “significati” a permettere la valorizzazione della stessa sfera economica. Questa non riesce a produrre da se stessa il significato valorizzante, la sua fonte funzionale in grado di dare un senso all’ordine economico. Ciò che dà senso è il disinteresse, è la cura per gli altri, per il vivere e per il mondo, estrema reazione della coscienza morale di fronte a ciò che accade.
Due terreni di immediata ricaduta pratica si stagliano di fronte a noi: uno riguarda le questioni ecologiche e ambientali, per affrontare le quali abbiamo necessità di interrogarci sulla “forma di soggettività” che gli individui del mondo globalizzato debbono riscoprire e maturare per pensarsi e riconoscersi come un’unica umanità, sottraendo alla rimozione tratti costitutivi dell’umano come la vulnerabilità, la dipendenza, la reciprocità, la cura, senza tuttavia perdere il contatto con i grandi processi storici di trasformazione e di emancipazione, l’anelito alla autorappresentazione come tensione a una finalità, al dispiegamento di un potenziale ancora inespresso. L’altro terreno sono le problematiche del lavoro, sguarnite e trascurate da molti anni anche a sinistra (oggi presa – dopo la sbornia blairiana attenta primariamente al “merito” e alle “opportunità” – da una attenzione all’eguaglianza esclusivamente in termini redistributivi). Così si lascia solo a soggetti religiosi – come Papa Francesco, il papa che ha definito il neoliberismo “l’economia che uccide” e che grida “non reddito ma lavoro per tutti” – di mostrare una persistente forte sensibilità al binomio lavoro/persona, facendo uscire il lavoro dall’invisibilità, politica, ma anche teorica e analitica, in cui da decenni è caduto e tornando a ribadire con veemenza che il diritto al lavoro è primario, superiore alla stesso diritto di proprietà, e che il rapporto che ha per oggetto una prestazione di lavoro non tocca solo l’avere ma l’“essere” del lavoratore.
Di nuovo, un’impostazione apparentemente molto astratta, e che non rifugge da una specifica attenzione – di cui troviamo più di una traccia nel giovane Marx – a movenze spirituali, può rivelarsi più adeguata nell’interpretazione dell’oggi e, al tempo stesso, più utile a illuminare le nostre prassi. Penso in particolare al socialismo con “corposa concezione etica” di Honneth[3], il quale critica il marxismo tradizionale per la sua grave opacità quanto alla considerazione delle ricadute politico-morali del capitalismo e per il suo “monismo economicista disperante”, nel quale non rimane più “nessun spazio legittimo né per l’autonomia dei singoli, né per la ricerca intersoggettiva di una volontà comune”, consegnandosi a quella che si può definire “occlusione di un accesso normativo alla sfera politica” generato dalla propria stessa dottrina, la quale inibisce di pensare i diritti di libertà liberali (che sarebbero volti solo alla tutela della proprietà e della licenza di costruire patrimoni privati) come premesse, piuttosto che come ostacoli, delle libertà sociali. Qui c’è in embrione sollevato anche il punto importante della distinzione tra liberalismo e neoliberismo, su cui penso che Fraser converrebbe, e che io considero addirittura una cesura (a differenza di coloro, anche a sinistra[4], che non vedono tra i due alcuna “soluzione di continuità”), sulla base della quale ritengoo possibile, e auspicabile, un’alleanza tra liberalismo sociale e socialismo.
Del resto un’alleanza simile si è realizzata altre volte nella storia dando risultati straordinari. In un’altra sede Nancy Fraser ha ricostruito (con Rahel Jaeggi) la storia del capitalismo come una sequenza di “regimi di accumulazione” [5]: il capitalismo mercantile o commerciale, il capitalismo competitivo cosiddetto “liberale”, il capitalismo socialdemocratico o State-managed, il capitalismo finanziarizzato. Ecco, io non credo che i “Trent’anni gloriosi” e il compromesso keynesiamo in cui si è risolto lo State-managed capitalism possano essere considerati solo una fase in una successione lineare di “regimi di accumulazione”. Penso, invece, che si sia trattato di una rottura molto profonda, a tal punto che, per rovesciarla, è stato necessario per i conservatori e le destre di tutto il mondo pensare e organizzare la vera e propria “restaurazione” [6] in cui si è poi estrinsecato il neoliberismo. Non mi sfuggono i limiti (in particolare l’eteronormatività e la dipendenza istituzionalizzata delle donne dal salario della famiglia) del compromesso keynesiano e del welfare state, una delle realizzazioni più importanti dei “Trenta gloriosi”. Ma la straordinarietà di quel periodo risalta comunque indubbia ed essa si deve al fatto che, talvolta più talvolta meno intenzionalmente, sempre si puntò su una “riforma” in grande del capitalismo, una riforma profonda in cui una radicalità inusitata di progettazione teorica e di critica ideologica congiunse il pensiero innovativo keynesiano alle rivoluzionarie iniziative di Roosevelt e al riformismo radicale europeo – il laborismo inglese ispirato da Beveridge e la socialdemocrazia scandinava – che si opponevano, anche idealmente, ai totalitarismi. In quella fucina Karl Polanyi scrisse il suo libro più importante (pubblicato nel 1954), mostrando come il capitalismo e l’economia di mercato furono salvati (nella Grande Trasformazione sottostante alle crisi dei decenni precedenti) da una nuova concezione del potere pubblico e dalla edificazione del welfare state, entrambi alla base dei Trenta gloriosi.
Non dobbiamo sottovalutare la potente carica di mobilitazione morale, oltre che politica, che c’era in tutto ciò, di cui fino al tardo Novecento i protagonisti sopravvissuti rendevano commossa testimonianza. Anche il New Deal – che si dotò di una cifra “sperimentalista” per la quale Roosevelt traeva direttamente ispirazione dai filosofi pragmatisti americani e da Dewey – deve la sua immensa anima trasformativa alla sua “capacità progettuale” e alla sua “carica morale”. L’assumere drammatici problemi morali, quali la sofferenza umana, in quanto tout court problemi politici era proprio di una tradizione politica anglosassone che interpretava gli eventi sociali nei termini di suffering situations, cioè terreni di contesa innanzitutto morale tra vittime, oppressori, riformatori. Ciò che rende unico il New Deal è che tale assunzione venne riprodotta al fine di ridisegnare radicalmente la “forma di vita” dominante, sottraendo gli individui alla passività e all’apatia con la mobilitazione per il lavoro e per la moralità politica.
[1] E. Pulcini, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Milano, Bollati Boringhieri, 2001, p.21
[2] S. Mezzadra, Nei cantieri marxiani. Il soggetto e la sua produzione, manifestolibri, Roma 2014 pp. 27, 23 e 24
[3] A. Honneth, L’idea di socialismo. Un sogno necessario, Feltrinelli, Milano 2016, pp. 49 e seg.
[4] Per tutti si vedano P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde. Essais sur la societé néolibérale, La decouverte, Paris 2009 (tr. it. La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2013). Anche nel loro libro successivo (Commun. Essai sur la révolution au XXI siecle, La Decouverte, Paris 2014) Dardot e Laval rimangono all’interno di un quadro analitico sottovalutante gli aspetti più negativi del neoliberismo (in particolare l’aggressione al perimetro pubblico), il che li porta a caratterizzare il pubblico come “predone” (e “asservito” ai privati) non meno dei privati stessi, a considerare con uguale ostilità “pubblico” e “privato” e a vedere nel “comune” la sola alternativa da perseguire.
[5] Si veda N. Fraser, R. Jaeggi, Capitalism. A Conversation in Critical Theory, Polity Press, Cambridge 2018
[6] D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford 2005