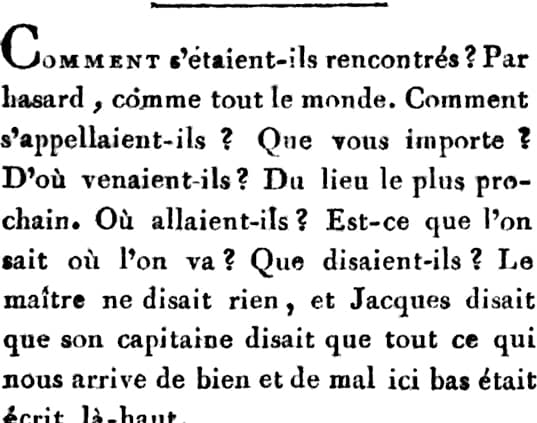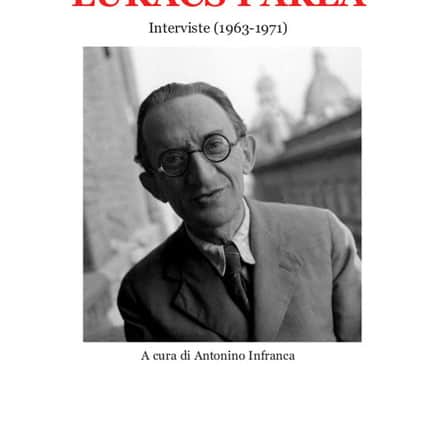traduzione di Antonino Infranca[ref] Journal do Brasil, 24-25 agosto 1969; ripubblicata in Lukács e a atualidade do marxismo, a cura di M. O, Pinassi e S. Lessa, San Paolo, Boitempo, 2002, pp. 125-132. Per rendere il testo più agevole, si sono tradotte soltanto le risposte di Lukács, tralasciando le osservazioni di Konder, che erano giustapposte alle domande.[/ref]
Presento al lettore italiano questa breve intervista di Lukács, ricordando che è apparsa nel 1969, cioè due anni prima della sua morte, e più di cinquanta anni fa. Nonostante la distanza temporale, alcuni temi rimangono ancora validi, altri sono stati superati dal tempo, come è naturale che avvenisse. Rimane, però, sempre palese la forza intellettuale di Lukács, un filosofo che non detta verità al suo interlocutore, dà risposte generali e teoriche, ponendo esigenze piuttosto che insegnamenti, e che chiude l’intervista con domande, approfittando dell’interlocutore per avere notizie e idee nuove. Lukács aveva 84 anni, ma la sete di conoscenza e di novità rimane cristallina, non c’è il minimo accenno a ricordi personali, suggestivi o patetici. Ci dà una lezione di come si possa restare giovani, intellettualmente parlando, anche se vecchi. Il lettore giudicherà il vigore della sua voglia di pensare.
L.K.- Come affronta l’attuale crisi del marxismo?
G.L.- Alla radice della nostra crisi c’è una modalità di opportunismo che è, forse, la più grave delle deformazioni che ci ha lasciato Stalin: il tatticismo. Al contrario di utilizzare i principi teorici generali del marxismo per criticare e correggere l’azione politica, li subordiniamo meccanicamente, in ciascun passo, ai bisogni immediati, alle esigenze momentanee della nostra attività politica. Con ciò, rinunciamo a una delle conquiste fondamentali della prospettiva marxista: l’unità di teoria e prassi. La teoria è ridotta alla condizione di serva della prassi e la prassi perde la sua profondità rivoluzionaria. Gli effetti di tale situazione sono catastrofici. Oggi, purtroppo, tutti i Partiti Comunisti sono più o meno tatticisti.
L.K.- Anche l’italiano?
G.L.- Anch’esso. È il partito che possedeva il livello teorico più elevato e che realizza nella sua attività le esperienze più interessanti nel campo del lavoro ideologico, ma ancora non si è liberato del tatticismo. Questa convinzione non mi impedisce di riconoscere in Togliatti un rivoluzionario di alto livello, un dirigente che alleava la sensibilità politica alla stoffa di intellettuale e pensatore. Tuttavia, non vedo in lui qualcosa che lo avvicini a ciò che potrebbe essere una specie di Lenin del nostro tempo.
L.K.- E Gramsci?
G.L.- Gramsci è un pensatore di eccezionale interesse e la sua influenza è stata, senza dubbio, molto feconda. Penso, intanto, che non si debba cercare in lui un elenco di risposte pronte per i problemi del presente. Per essere correttamente valutato, Gramsci ha bisogno di essere posto storicamente, ha bisogno di essere compreso nel suo ambiente, nella sua situazione.
Ritornando alla crisi del marxismo, Lukács aggiunge:
Stalin era dotato di molta intelligenza politica, quando fece l’accordo con la Germania nazista nel 1939 prese una misura che mi sembra essere stata la risposta certa alla situazione creata dalla procrastinazione dei governi occidentali. Per giustificare la misura tattica che prese, tuttavia, Stalin forzò un orribile “adattamento” della strategia comunista e dei principi generali della teoria marxista all’ingiunzione tattica, in modo che i comunisti francesi furono portati a dire alla classe operaia francese: «Il nemico è dentro il nostro stesso paese, il nemico non è tanto Hitler quanto la borghesia francese». Ancora oggi esistono cose così. Per dare maggiore appoggio ai popoli arabi contro la politica imperialistica di Israele, ci sono autori che in nome del marxismo descrivono volontariamente come socialiste determinate caratteristiche degli Stati arabi che non hanno nulla a che vedere con l’autentico socialismo. E c’è anche questo appoggio dato dall’Unione Sovietica alla Nigeria in questa orribile guerra in Biafra. Cosa hanno a che vedere con ciò i principi del marxismo e del socialismo?
Un’altra manifestazione del nostro opportunismo è il fatto che, finora, trascorsi più di 120 anni dalla pubblicazione del Manifesto Comunista, non siano stati pubblicati tutti gli scritti di Marx. Posso assicurargli che esistono numerosi scritti di Marx, annotazioni di studi legati alla preparazione de Il capitale, che rimangono ammuffiti in archivi inaccessibili. Di fronte alle attuali controversie tra marxisti – effervescenza che segnala un rinascimento del marxismo – tale situazione mi sembra particolarmente assurda.
L.K.- Questa rinascita del marxismo, alla quale si riferisce, è un processo appena pronunciato o già iniziato?
G.L.- È un processo che è già iniziato, ma è ancora all’inizio. Il capitalismo ha sofferto molti cambiamenti in questi ultimi decenni. Mentre non conosco nessuna analisi marxista del capitalismo attuale che possa essere comparata a ciò che Marx fece del capitalismo del suo tempo o che Lenin fece dell’imperialismo all’epoca della Guerra del 1914. Non dico del livello qualitativo, ma, almeno, riguardo alla sistematicità. Le ultime elaborazioni teoriche realmente fondamentali realizzate nello sviluppo storico del marxismo furono di Lenin.
L.K.- Come pone la sua propria opera nel quadro di questo sviluppo recente del marxismo?
G.L.- Sono tranquillamente convinto che non sono un nuovo Marx. Mi sono limitato a dare alcune indicazioni, che reputo utili, riguardo alla direzione in cui dovremmo lavorare nel campo teorico.
L.K.- Adesso si sta occupando dell’Etica?
G.L.- Sì. Per essere più esatto, all’introduzione all’Etica, che porta il titolo di Ontologia dell’essere sociale. L’elaborazione dell’ontologia del marxismo mi sembra essere un compito filosofico fondamentale per noi. Lo sviluppo di un sistema di categorie capaci di dare conto della realtà del reale (se mi permette l’espressione) è imprescindibile affinché i marxisti affrontino in maniera giusta gli equivoci diffusi intorno al carattere materialista del marxismo, è imprescindibile affinché i marxisti approfondiscano la critica delle posizioni esistenzialistiche e delle posizioni neopositivistiche. Dobbiamo sviluppare un’ontologia marxista capace di determinare più concretamente l’unità del materialismo storico e del materialismo dialettico. La base di una concezione che sia storicistica senza cadere nel relativismo e che sia sistematica senza essere infedele alla storia. Fin quando non avremo svolto questo compito, i marxisti saranno preparati malamente per affrontare le tendenze irrazionalistiche di tipo marcusiano, per esempio, o le posizioni razionalistiche formali diffuse dai neopositivisti e specialmente dagli strutturalisti. Inoltre, il razionalismo e il razionalismo formale possono essere rapidamente combinati, secondo i bisogni della lotta mossa dall’ideologia borghese contro la ragione dialettica.
L.K.- Se oggi tornasse a scrivere La distruzione della ragione, non darebbe maggiore importanza alle tendenze neopositivistiche che si stanno diffondendo nella filosofia contemporanea?
G.L.- Senza dubbio. Inoltre, la parte finale di quel mio libro è molto invecchiata, avrebbe bisogno di essere riscritta. Nei nostri giorni, ai marxisti si impone l’analisi delle nuove forme di alienazione. Nel secolo passato e all’inizio di questo, il capitalismo controllava la produzione e sfruttava il lavoratore, strappandogli plusvalore, nell’ambito della produzione. Attualmente, il capitalismo ha esteso il suo controllo al consumo. Mediante la pubblicità, la cui forza manipolatrice cresce di giorno in giorno, il capitalismo suscita bisogni artificiali e, per il controllo di essi, controlla il meccanismo degli acquisti e delle vendite, delimita le crisi generate dallo squilibrio del mercato. Con ciò, il lavoratore non è sfruttato solo come lavoratore: è sfruttato anche come consumatore. Perciò, nei paesi capitalistici ricchi, egli può ricevere anche salari reali più elevati, poiché sarà inesorabilmente portato a spendere il valore del suo lavoro nel mercato dei beni di consumo manipolato dal capitalismo. Una simile situazione comporta forme complesse di alienazione, che dobbiamo studiare con spirito critico rivoluzionario. Pertanto dobbiamo risolvere quegli equivoci con i quali i neopositivisti le circondano, quando cercano di slegarle dalla storia e dall’insieme della vita sociale.
L.K.- Lei crede che ci saranno nuove crisi del capitalismo, crisi del tipo di quella del 1929, per esempio?
G.L.- È possibile che accadano, però mi sento un po’ scettico riguardo a questa possibilità. Lo sviluppo della manipolazione e del controllo capitalistico delle condizioni di consumo forse è riuscito ad allontanare il fantasma della crisi. Questa conquista, intanto, ha implicato un prezzo molto alto, poiché le contraddizioni immanenti del capitalismo si sono aggravate e si sono estese al piano dell’esistenza umana che, fino a poco tempo fa, erano relativamente poco colpite da esse. L’autoregolamentazione della vita nel mondo creato dal capitalismo provoca, attualmente, un sentimento sempre più generalizzato di malessere e un numero sempre più grande di persone si dispongono a contestare i principi della società capitalistica. Questa è una delle ragioni più profonde della rivolta della gioventù. Il nostro compito deve essere quello di offrire un’alternativa concreta per tutta questa gente che rifiuta il capitalismo, presentandogli un socialismo sempre più libero dalle deformazioni inerenti al sistema capitalista.
L.K.- Per gli effetti confusi che portano con esse, quale delle due tendenze merita una critica più serrata da parte dei rivoluzionari marxisti: la marcusiana o la strutturalista?
G.L.- Veda, questa domanda non deve essere formulata così. Così come lei la sta presentando, essa rimane in un quadro ristretto, pregiudicato dal tatticismo. Sul piano dell’azione immediata, i bisogni tattici della lotta devono essere misurati in funzione delle circostanze. Sul piano teorico e del confronto delle idee, la situazione è diversa. Ancora da poco, ci siamo messi d’accordo sul fatto che le tendenze francamente irrazionalistiche o neopositivistiche, in senso lato, erano espressioni necessarie della prospettiva ideologica borghese. Su questo piano, di conseguenza, i marxisti sono obbligati alla lotta con lo stesso rigore e la stessa fermezza di principi contro entrambe. L’elaborazione teorica del marxismo, sebbene polemica, non può farsi in condizioni di stretta dipendenza dalle vicissitudini tattiche. Secondo la mia opinione, su determinati problemi generali non può variare secondo le fluttuazioni della politica quotidiana. Se pretende di essere scientifico, un giudizio sulle leggi della dialettica, per esempio, o sulla natura dell’ideologia borghese, non può essere completamente modificato ad ogni crisi ministeriale.
L.K.- Quando è stato in Francia ha conosciuto Sartre o Garaudy?
G.L.- Sartre no. Ho conosciuto Garaudy, che in quell’epoca era un fanatico stalinista.
L.K.- Adesso è cambiato…
G.L.- Ha cambiato il dogmatismo stalinista con il sentimentalismo liberale.
L.K.- Ma Garaudy, nonostante non sia un grande filosofo, ha sviluppato un lavoro positivo nel dialogo con i cristiani
G.L.- Guardi, considero la posizione filosofica di Sartre sbagliata, ma lo rispetto e lo ammiro come personalità. Di Garaudy non posso già dire lo stesso. Il dialogo con i cristiani è molto importante; per essere profittevole, comunque, ha bisogno di essere sviluppato senza demagogia, con rigore teorico.
L.K.- Qual è la sua opinione sull’America Latina?
G.L.- In generale gli intellettuali europei si ritengono soddisfatti con le informazioni deficitarie che posseggono sulla realtà latinoamericana. In maniera generale mi pare che la realtà concreta in diversi paesi dell’America latina non è ben conosciuta neanche dagli stessi latinoamericani. Gli studi che ho potuto leggere, anche quando sono interessanti, rimangono molto empirici, frammentari, sono lontani dalla sistematicità desiderabile. E il punto di vista marxista proprio della realtà latinoamericana dovrà risultare da un lavoro fatto da voi stessi; non si può sperare nessun contributo sostanziale da parte degli specialisti europei, dei tecnici marxisti dell’Europa. Per adesso, le forme concrete delle trasformazioni sociali in corso nei diversi paesi e le forme possibili di transizione al socialismo sono lontane dall’essere state sottomesse a un’analisi soddisfacente. Non credo, d’altro lato, che i cubani siano riusciti a raggiungere buoni risultati nella teorizzazione generalizzata della loro esperienza. Voi avete di fronte, in verità, un lavoro di proporzioni smisurate. Una domanda che mi sovviene, per esempio, è la seguente: perché il processo di trasformazione rivoluzionaria dei diversi paesi dell’America Latina presente così forti tendenze alla deteriorizzazione? Non parlo di rivoluzioni in senso socialista, ma anche nel caso della rivoluzione antiimperialistica o nel caso della rivoluzione democratico-borghese il fenomeno è abbastanza sensibile. Veda quanto succede con la rivoluzione messicana. Ha iniziato con molta energia, si è sviluppata con intensa partecipazione popolare ed è arrivata alla malinconica situazione in cui si trova adesso. Lei conosce qualche analisi marxista realmente sistematica della rivoluzione messicana e dei suoi problemi? Si considera in condizione di spiegare come e perché la rivoluzione messicana è arrivata al suo attuale punto di strangolamento? Forse l’esperienza messicana offre insegnamenti che, generalizzando, si rivelano utili per i rivoluzionari di altri paesi dell’America Latina, anche per il Brasile. E, per parlare del Brasile, voi possedete un’interpretazione marxista solida degli avvenimenti del 1964 [ref] Il colpo di Stato militare che terminò nel 1985. Si tenga presente che l’intervista fu ugualmente pubblicata in Brasile, nonostante che la stampa era fortemente controllata dai militari. Probabilmente le critiche allo stalinismo e ai partiti comunisti attirarono il favore dei censori militari, che non compresero il valore dell’intera intervista; NdT.[/ref] nel vostro paese?