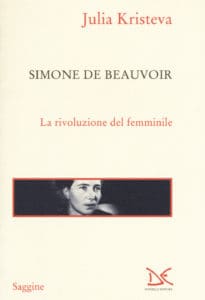di Gustavo Di Santo
Dottore di Ricerca, Università della Calabria
Summary
The work focuses on the theory of the autopoietic systems.
In the paper are defined the following statements:
- Observation is always a partial, relative, and unique perspective on a phenomenon;
- From the human sciences, it is possible to observe any phenomenon assuming the following criteria:
- the observant can define the boards of the systems/phenomenon analyzed;
- the operation of distinction made by the observant could be described as a mechanical process based on mathematical logic, through the transformation of phenomena in quantifiable variables;
- the closure of the systems suggests the adoption of an analytical approach based on the analysis of associations or correlations between variables. For this purpose, a theoretical model of “perturbative influences” is proposed in this work.
Keywords: social mentality, culture, observation, autopoiesis, systems theory.
Sommario
Il presente lavoro introduce un modello d’analisi detto a “influssi perturbativi” basato sui principi statistici di associazione e di correlazione.
Nello specifico, in riferimento alla teoria dei sistemi autopoietici vengono definiti i seguenti punti:
- l’osservazione è sempre un atto parziale, relativo e unico;
- l’osservatore definisce il confine del fenomeno da analizzare;
- il processo di distinzione, può essere descritto come un’operazione matematica, che conduce ad identificare un fenomeno in termini di variabili quantificabili, analizzabili statisticamente.
Parole chiave:mentalità sociale, cultura, osservazione, autopoiesi, teoria dei sistemi.
Parzialità, relatività, unicità dell’osservazione
Un aspetto fondamentale della teoria dei sistemi autopoietici è la sua caratterizzazione in termini relazionali.
Secondo Maturana e Varela, i due biologi che hanno coniato il concetto di “autopoiesi” (dal greco: autos = auto, poiesis = produzione), l’organizzazione di un sistema autopoietico è data come le relazioni che definiscono un sistema come unità e ne determinano la dinamica di interazione e di trasformazioni che il sistema stesso può subire (Maturana & Varela, 2012). La stessa identificazione di un sistema come unità è il prodotto di una distinzione fatta da un osservatore, per cui ne risulta che la nozione di sistema è relazionale non solo in se stessa come caratteristica della sua organizzazione, ma anche per il fatto che un sistema è una relazione tra un osservatore e un’entità, che viene da questi riconosciuta per mezzo di un’operazione (referenziale) di distinzione come unità distinguendola da uno sfondo.
L’osservatore è esso stesso un sistema autopoietico e come tale auto-referenziale. In questo senso, seguendo Luhmann – che rappresenta l’esempio più famoso di trasposizione della teoria dei sistemi autopoietici dall’ambito della biologia a quello sociologico – qualsiasi sistema autopoietico può osservare ed auto-osservarsi e quindi non necessariamente un sistema psichico che opera sotto forma di coscienza, ma anche i sistemi sociali che svolgono le proprie operazioni sulla base della comunicazione. (Luhmann, 1990).
L’osservazione viene quindi svolta da un autore descrivibile come autoreferenziale. Essa è un’operazione di distinzione e di designazione di un quid nel contesto di qualcos’altro, per acquisire informazioni su ciò che viene designato.
L’operazione di osservazione dev’essere pertanto riferita sia all’individuo inteso come sistema psichico e sia al sistema scientifico inteso come sistema sociale, a cui l’individuo è connesso per interpenetrazione (Addario, 2008).
Di fatto, nella descrizione di un fenomeno viene adoperato il codice comunicativo specifico del sistema nel quale l’osservazione è attuata. Tra individuo e sistema si crea un canale specifico di comunicazione, un medium che consente l’interpenetrazione tra i sistemi (psichici e sociali), in modo che diventino l’uno per l’altro, fonte di perturbazioni fintantoché viene mantenuta la relazione tra essi.
Ciò è facilmente riscontrabile, immaginando il caso di un’interferenza comunicativa dovuta all’adozione di un medium differente di comunicazione all’interno di un sistema sociale. Si pensi, per l’appunto, ad una conferenza accademica sul tema “religione ed economia”, il sistema sociale di riferimento è il sistema scientifico, definito secondo Luhmann dalla funzione di “descrivere e fare previsioni sugli altri sistemi” in quanto è in grado di analizzare altri sistemi sotto determinati aspetti che risultano inaccessibili ai sistemi stessi (Luhmann, 1990, p. 18), ed uno dei relatori, un accademico insigne, facendo riferimento ad un passaggio dell’Enciclica Rerum Novarum sul tema della giusta mercede, concluda la sua analisi fornendo una descrizione del capitalismo inteso come fenomeno iniquo prodotto dal “diavolo”. Una tale posizione può essere recepita dagli altri accademici presenti, o come un’affermazione ironica o come un atto fuori luogo; in entrambi i casi, la comprensione della comunicazione risulta essere distorta in quanto estranea al codice del sistema scientifico, causando un’interferenza di fondo che produce incompatibilità, ove invece all’interno del contesto sistemico religioso (ad esempio la conclusione di un sermone durante la messa domenicale) non avrebbe prodotto alcuna distorsione cognitiva.
Il sistema è da considerarsi in termini luhmannianicome dato reale; ossia come “insieme di relazioni”. La realtà viene così ad essere costituita da insiemi di relazionied il concetto di sistema anziché definire un’entità ontologica, rimanda al mondo in cui l’osservatore descrive la realtà stessa così come da questi compresa (Jedlowski, 2017).
La prospettiva muta al mutare del sistema osservante. Cosicché il fenomeno o l’ente osservato può divenire conoscibile nei modi e negli aspetti consentiti all’osservatore. La proclamazione del dogma dell’Assunzione della Vergine Maria ad opera di Pio XII nel 1950, può essere recepito dai fedeli, che sono parte dell’ambiente del sistema parziale della Chiesa Cattolica, attraverso il medium della fede, che caratterizza i processi comunicativi del sistema religioso. Al contempo, all’interno del sistema religioso, nella formulazione del dogma di fede, vengono posti in essere processi comunicativi caratterizzati da propri codici di riconoscimento, che traggono la propria validità proprio perché sono parte del sistema, permettendone il mantenimento dell’organizzazione. A sua volta, l’organizzazione sistemica consente la riproduzione ed il rinnovamento degli stessi codici (elementi e relazioni strutturali), garantendo l’autopoiesi e l’auto-referenzialità del sistema stesso. In tal senso, il dogma dell’Assunzione, viene riconosciuto come elemento interno al sistema religioso, perché caratterizzato da un codice comunicativo strutturato che si rifà alla fede (il medium di tale sistema), e viene prodotto a partire da strutture del sistema, come il richiamo al dogma dell’infallibilità papale, all’interno della costituzione apostolica: Munificentissimus Deus (anch’esso unità strutturale interna al sistema religioso).

Figura 1. L’Assunzione dipinta da Tiziano.
Dalla prospettiva del sistema religioso, il dogma dell’Assunzione della Vergine Maria è una questione comunicativa di fede e come tale viene trattata. In una società altamente differenziata, composta da sistemi e sottosistemi, ciascuno con una propria funzione e nicchia di competenza, si moltiplicano le prospettive possibili di osservazione: il sistema scientifico non farà uso del medium della fede per descrivere un dogma, la sua organizzazione non prevede un codesto tipo di comunicazione, così “l’accettazione per fede” rimarrebbe non-compresa, una semplice perturbazione ambientale che non verrebbe colta dal sistema. Ciò non significa che il fenomeno rimane inconoscibile; il sistema scientifico opera attraverso proprie strutture interne secondo la propria organizzazione e coglierà specifici aspetti del fenomeno nei limiti permessi dalla propria costituzione. Così, il dogma dell’Assunzione verrà osservato non come verità di fede (in questo aspetto rimane incomprensibile per il sistema scientifico) ma ad esempio dal punto di vista storico, o in chiave sociologica, secondo criteri attraverso cui risulta possibile per il sistema attuare un processo di osservazione.
Allo stesso modo, la differenziazione sistemica porta definitivamente a questionare il ruolo “dell’intellettuale organico” di stampo gramsciano, nella forma dell’accademico politicamente impegnato. Il problema è nella funzione sociale della ricerca scientifica rispetto al suo engagement per ragioni partigiane. Essendo il sistema scientifico ed il sistema politico autonomi nei rispettivi domini, un codice comunicativo propriamente scientifico non può essere riprodotto all’interno delle strutture comunicative della politica, verrebbe infatti colto come perturbazione ambientale e quindi non compreso.
L’inapplicabilità di un discorso scientifico nel dominio del sistema politico (o religioso), rafforza la necessità di trattare la società come differenziata in sistemi funzionali chiusi. Esiste la comunicazione tra i sistemi, ma questa è garantita dall’autonomia referenziale di ciascuno di essi. Così, i “paradigmi” di Kuhn come fondamento della prassi scientifica di una o più generazioni di ricercatori o i “programmi di ricerca” di Lakatos, assumono significanza all’interno del sistema scientifico proprio perché adoperano il codice comunicativo del sistema stesso; le influenze esterne al sistema, così come osservatedai due scienziati sociali, vengono riprodotte internamente al sistema, proprio perché riformulate dalle relazioni comunicative presenti come strutture in esso. Così un sistema psichico nella sua interpenetrazione con il sistema scientifico svolge una determinata funzione, che cambierà a seconda del sistema con cui avviene l’interpenetrazione.
Ogni sistema ha un suo medium di comunicazione e per consentire l’atto d’interpenetrazione è possibile utilizzare soltanto lo specifico canale proprio di ciascun sistema. Così, nel momento in cui si fa esperienza del “sacro”, sarà attraverso il medium della fede che questa viene vissuta a livello psichico; ma volendo comunicare tale esperienza in un convegno scientifico, sarà necessariamente attraverso il codice comunicativo del sistema scientifico, che diviene possibile creare un canale di interpenetrazione tra i sistemi coinvolti, in modo da consentire l’aspettativa di comprensione dell’atto comunicativo che è data in ultima analisi dall’organizzazione autopoietica dei sistemi coinvolti; scrivono Maturana e Varela (2012, p. 47):
“Tuttavia la conoscenza come esperienza è qualcosa di personale e di privato che non può essere trasferito, e ciò che si crede trasferibile, cioè la conoscenza oggettiva, deve sempre essere creato dall’ascoltatore: l’ascoltatore capisce, e la conoscenza oggettiva sembra trasferibile solo se egli è preparato a capire”
Ogni sistema ha quindi specifiche regole funzionali che caratterizzano la loro chiusura comunicativa. Da ciò si evidenzia il carattere parziale di ogni osservazione, compresa quella che si effettua all’interno del sistema scientifico. Qualsiasi lavoro di tipo accademico ad esempio, deve rispondere a regole stabilite all’interno del sistema stesso per essere compreso come tale. Si affermano infatti specifiche strutture di elaborazione informativa, come l’insieme dei metodi di conoscenza prodotti dalla sistematizzazione galileiana, nell’ambito delle cosiddette scienze esatte; od anche i criteri metodologici di ricerca nelle scienze sociali.
Di fatto, è necessario rispettare i codici comunicativi e processuali del sistema per porre in essere un rapporto interpenetrativo – ossia creare un processo di riconoscimento – che altrimenti, al di fuori di specifiche regole di compatibilità, non potrebbe avere luogo.
Inoltre, al carattere parziale dell’osservazione, si aggiunge la sua dimensione relativa: all’interno delle possibili strutture relazionali definite dall’organizzazione del sistema, non esiste una rigidità procedurale tale per cui è ammessa una ed una sola modalità di elaborazione del dato ambientale (il fenomeno osservato), ma più modelli di connessione informativa sono riconosciuti come validi. Cosicché, la sociologia come sistema parziale del sistema scientifico, attua le proprie osservazioni attraverso molteplici modelli analitici; si pensi in ambito sociologico alle teorie dell’agire sociale, dell’interazionismo simbolico, dell’agire comunicativo, della scelta razionale, ecc., la stessa visione funzional-strutturalista lhummaniana non è che una delle possibili chiavi interpretative della complessità del mondo come letta dal sistema stesso.
Parzialità e relatività si legano infine all’unicità di ogni osservazione.
Tutti i processi osservativi, come prodotti da sistemi autopoietici reali e contingenti, sono soggetti alla temporalità; cosicché ogni attività interna ed esterna al sistema si inquadra storicamente e risente del momentum in cui una tale attività o processo si attiva. L’osservazione si svolge sempre hic et nunc assumendo quindi le caratteristiche del momento storico in cui si attua. In tal senso è possibile parlare di sincronicità dell’osservazione. Il concetto, nella sua formulazione junghiana (I Ching, 2005), descrive adeguatamente la possibilità di mutamento dell’atto osservativo in riferimento al tempo in cui si svolge. Un fenomeno osservato al tempo t1à risulterà diverso se osservato al tempot2, poiché non solo il fenomeno muta le proprie caratteristiche che si prestano al riconoscimento dell’osservatore, ma anche la stessa osservazione muta in relazione ai cambiamenti occorsi a livello dell’organizzazione strutturale del sistema osservante nel corso del tempo. Tali cambiamenti possono essere innescati dalle perturbazioni avvenute nell’ambiente dello stesso sistema osservante. Ciò non deve far supporre rapporti di causazione di tipo input-output; in quanto è l’organizzazione del sistema che definisce e regola internamente le possibilità d’interazione in cui il sistema autopoietico di volta in volta può entrare.
Ogni cambiamento nei sistemi autoreferenziali è infatti determinato dalla propria organizzazione autopoietica. Il concetto di sincronicità descrive la chiusura sistemica durante lo svolgimento dei processi d’interazione in un lasso temporale definito, rimandando al sistema stesso, ossia ai sistemi coinvolti nella relazione (come atto interpenetrativo), l’elaborazione dei processi di comprensione e quindi modificazione delle strutture di possibilità comunicativa (necessaria al mantenimento della relazione) rispetto alla propria organizzazione hic et nunc.
Sebbene, ogni condotta di ciascun sistema (può trattarsi di sistemi psichici o sociali) sia intrinsecamente autonoma nella sua genesi dalla condotta dell’altro, in quanto determinata internamente solo dalla struttura del sistema comportante, la parte di sé che ciascuno rende visibile diviene per l’altro sistema fonte di deformazioni compensabili che possono essere descritte come aventi significato nell’ambito dell’interazione.
Allo stesso modo, l’osservazione messa in atto da un sistema autopoietico è sincronica nella maniera in cui il processo è contingente ed è prodotto della prospettiva di un sistema che può cogliere solo determinati aspetti di un fenomeno (sia esso un altro sistema, l’ambiente o un particolare oggetto) nei limiti della propria cognizione.
L’osservazione quindi, compresa quella scientifica, è sempre un atto parziale, relativo ed unico:
- parziale in quanto è propria di uno specifico sistema;
- relativo in quanto nei limiti organizzativi del sistema, la flessibilità delle configurazioni strutturali consentono diverse modalità di elaborazione informativa;
- unico in quanto è contingente (ossia si manifesta hic et nunc) e come tale ha carattere sincronico.
Alla ricerca del metodo
La filosofia greca antica già contestava la possibilità che tutto potesse essere compreso in maniera scientifica; ad esempio per Platone non sono conoscibili le realtà materiali e per Aristotele quelle accidentali. Il pensiero dei due metafisici, oggi si riflette in una società descritta da Luhmann come funzionalmente differenziata, in cui il sistema scientifico offre un’interpretazione della complessità del mondo che si affianca alle prospettive degli altri sistemi sociali e come tale rappresenta una visione parziale pari alle altre.
In particolare, all’interno del valore conoscitivo della scienza tout court, ossia rispetto alla parzialità dell’osservazione, si presenta la problematica dell’oggettività del sapere scientifico anche in relazione al presentarsi di ogni atto osservativo (che si è già detto essere parziale) come relativo ed unico. Relativo in quanto l’atto osservativo può originarsi da molteplici modelli euristici che fanno riferimento ad un’impostazione scientifica all’interno dei sistemi parziali rientranti nell’ambiente del sistema scientifico (sistema sociologico, storico, ecc.). Unico poiché ogni atto è contingente e relazionato nel caso specifico all’interpenetrazione tra sistema psichico di chi si dedica – potremmo dire in termini weberiani- professionalmente alla scienza e sistema scientifico.
In tal senso, non pare possibile sostenere un’oggettività delle scienze in generale;ciò è tanto vero per le “scienze dure” – basti

Figura 2 Werner Karl Heisenberg, Premio Nobel per la fisica 1932
pensare alla teoria della relatività di Einstein, al principio di indeterminazione di Heisenberg nella meccanica quantistica ed ai teoremi di incompletezza di Gödel nel campo matematico, – così come per le scienze umane.
In quest’ultimo caso, già Max Weber pur distante da quella che sarà la teoria dei sistemi di Luhmann – afferma come non esista qualcosa che possa essere considerato oggettivo, ovvero valido per tutti, in quanto ogni aspetto della realtà sociale è sempre filtrato dall’interpretazione di chi la guarda (l’osservatore).
La Parzialità, relatività ed unicità dell’atto osservativo, se da un lato sancisce l’impossibilità di comprensione di un dato fenomeno in maniera integrale, dall’altro non nega la possibilità di raggiungere un certo tasso di oggettività empirica in relazione alla prospettiva del sistema da cui muove l’osservazione. Non esiste un’oggettività in senso assoluto, o detto in termini di teoria dei sistemi, non esiste oggi un sistema in grado di poter rappresentare in termini di senso la complessità del mondo assorbendo in sé le funzioni di tutti gli altri sistemi, cosi da poter formulare atti osservati validi tout court; ma in una società (globale) funzionalmente differenziata diviene possibile riscontrare “possibilità d’oggettivazione” dei risultati di un’osservazione relativa al singolo sistema osservante e valide per esso stesso.
Ad esempio dalla prospettiva del sistema scientifico, Durkheim definisce sociologicamente il “sacro” come prodotto di “un’effervescenza collettiva” ossia di un’esperienza collettiva vissuta come straordinaria. Una simile visione, in cui il sacro viene ad essere mera produzione umana, se è valida quindi comprensibile all’interno del sistema scientifico, risulta essere incompleta se non distorta dalla prospettiva del sistema religioso, per il quale il sacro viene ad essere espressione della esperienza divina (reputata esistente) nell’uomo. Entrambe le prospettive d’osservazione hanno una propria validità intrinseca nei rispettivi sistemi. Ciò tuttavia non permette di dare un valore di verità all’informazione veicolata, in quanto le rispettive informazioni risultano incomprensibili se trasferite da un sistema all’altro, perché gli stessi processi di comunicazione si basano su codici differenti, che rendono impossibile la riproduzione del dato informativo (i risultati dell’osservazione) al di fuori del proprio sistema.
In definitiva, l’oggettività dei risultati di un atto osservativo non fanno riferimento alla corrispondenza del fenomeno osservato nei termini di aderenza alle sue caratteristiche costitutive – in questo senso il fenomeno rimane inconoscibile– mapiuttosto rimandano ai criteri (euristici) di validità specifici di ciascun sistema.
L’osservazione produce all’interno del sistema osservante un’oggettività dei risultati in relazione al fenomeno analizzato, che fa riferimento alla validità dei processi attuati durante l’atto osservante. Tale validità indica la comprensibilità dell’analisi stessa nel sistema; ossia: i risultati osservati sono compatibili con le premesse dell’osservazione. Detto altrimenti, i codici di comunicazione su cui è effettuata l’osservazione, risultano comprensibili all’interno del sistema, permettendo di cogliere la perturbazione ambientale (prodotta dall’osservazione), come innesco di autonomi processi interni di cognizione – nei sistemi psichici – e di modificazione delle strutture comunicative – nei sistemi sociali. La chiusura autopoietica dei sistemi non permette un passaggio d’informazioni; cosicché l’atto osservativo assume le seguenti caratteristiche:
- l’informazione non viene assunta dall’ambiente del sistema in termini di input, ma questa può essere elaborata autonomamente dalla prospettiva del sistema operante, a partire dalle perturbazioni che coglie nel medium di comunicazione;
- il sistema o fenomeno osservato sono per il sistema osservante parte dell’ambiente in cui può entrare in interazione (ciò avviene nel medium), che innesca durante il processo di accoppiamento strutturale, mutamenti di stato autonomi che conducono ad una comprensione dell’entità osservata in relazione al proprio dominio di cognizione, non coinvolgendo le caratteristiche proprie dell’osservato che rimangono inaccessibili;
- l’interazione stessa, innesca mutamenti di stato nel fenomeno osservato che sono riflessivi ai mutamenti di stato dell’osservatore, sebbene non vi è rapporto di causazione tra le rispettive modificazioni, fintantoché dura l’accoppiamento strutturale nel medium d’interazione. In tal modo, entrambi mutano autonomamente al perdurare dell’interazione, sulla base delle rispettive organizzazioni o codici di condotta interni.
Così definita, l’osservazione rimane un atto proprio del sistema osservante, in grado di dar luogo a risultati “oggettivamente validi” in relazione al sistema stesso.
Rivolgendo lo sguardo al sistema scientifico ed in particolare alle scienze sociali, la comprensione diventa la chiave stessa di validità delle analisi svolte al suo interno: se il fenomeno di studio in sé è inconoscibile, la parte di esso che entra in relazione con l’osservazione può essere tuttavia compreso dalla propria prospettiva, che è sempre parziale, relativa ed unica. All’interno del sistema, la comprensione viene permessa dai criteri di codifica riconosciuti come parte del sistema; così ad esempio il fenomeno del sacro viene compreso in relazione alla sociologia delle religioni, rimanendo incomprensibile rispetto ad una comunicazione dommatica propria del sistema religioso. Nello specifico, i criteri o codici comuni di comunicazione interna, permettono di creare l’aspettativa della possibilità di comprensione nei sistemi posti in interpenetrazione nel medium comunicativo; essendo infatti i sistemi autopoietici sistemi chiusi, è possibile avere solo la probabilità della riuscita di un atto comunicativo, pertanto la stessa osservazione rimane vincolata ai criteri del sistema osservante e diventa probabilmente comprensibile esclusivamente nel medium di comunicazione.
Dalla prospettiva delle scienze sociali, la teoria dei sistemi può fungere da schema di riduzione della complessità ambientale in funzione di una conoscenza scientifica della società, che si basi sulla (auto)consapevolezza della parzialità, relatività ed unicità dei risultati, che possono venir considerati oggettivi – nei termini di validità – solo rispetto alla prospettiva adottata.
Modelli matematici ed influssi perturbativi

Figura 3. Vilfredo Pareto.
Con riferimento ai lavori di Pareto (1978) e Henderson (1970), è possibile declinare il concetto di “sistema” per dare luogo ad una tecnica di ricerca (osservativa) di tipo statistico-matematico, affatto differente in linea di principio, alle tecniche applicate all’analisi fisiche dei fenomeni.
Una proposta di riduzione della complessità ambientale per le scienze sociali, passa anzitutto da una schematizzazione dei sistemi sociali in accordo al senso della propria funzione, che permette la differenziazione tra essi. L’operazione di distinzione di un sistema da uno sfondo ambientale è attutata da un osservatore, in questo caso lo scienziato sociale, che delinea i confini del sistema osservato in base alle proprie ipotesi di studio. L’operazione di distinzione non è un atto esterno al sistema osservato, ma si muove nel medium d’interazione con la parte del sistema che si lascia osservare (o detto altrimenti, con la sezione del dominio d’interazioni del sistema osservato, che entrano in accoppiamento strutturale con l’atto osservante), in relazione e nei limiti della prospettiva dell’osservatore (che muove dalle scienze sociali). L’osservatore non crea il sistema, che è esistente per sé, ma lo specifica in funzione al proprio interesse. La definizione dei confini diviene ad essere oggettivante dalla prospettiva dell’osservatore e rimane valida esclusivamente all’interno dell’osservazione.
Dalla prospettiva dello scienziato sociale, l’operazione di distinzione di un sistema da uno sfondo, permette di delineare i confini dell’oggetto di studio, identificando ipoteticamente gli elementi e relazioni che sono costitutivi del sistema e quindi propri dell’organizzazione autopoietica dello stesso.
La distinzione consente una semplificazione dell’oggetto di studio, altamente complesso nei suoi rapporti interazionali con gli atri sistemi sociali e psichici. Si attua di fatto una schematizzazione binaria applicata al principio di identità.
Definire ad esempio il sistema religioso, postulando come necessario il riferimento al trascendente e al soprannaturale; permette di distinguere la religione da altri fenomeni sociali quali possono essere i movimenti ideologici (es. comunismo e nazionalismo) e qualsiasi altra entità che possa rispondere ai bisogni ultimi dell’uomo, consentendo così l’utilizzazione della religione come variabile indipendente in quanto ne sono stati delineati i confini teorici (Di Santo, 2018).
L’identità del sistema (A=A) è caratterizzata dagli elementi e relazioni che garantiscono l’autopoiesi dello stesso e vengono a loro volta riprodotte dall’organizzazione strutturale del sistema; cosicché i componenti relazionali che nell’ipotesi dell’osservatore assumono tali caratteristiche, rientrano nella costituzione identitaria del sistema (valore identitario=1), tutti gli altri vengono esclusi (valore identitario=0). Può pertanto configurarsi un tipo di codificazione logico-matematica del tipo: viceversa che letto in italiano corrisponde: “per ogni x cheappartiene a S allora x ha valore 1, in caso contrario xassume valore 0”; dove x indica i componenti che fanno o non fanno parte del sistema (S) osservato o entro il quale si esplica come parte di esso il fenomeno oggetto di osservazione. A decidere l’appartenenza di un componente al sistema è l’osservatore in base ai presupposti teorici dai quali parte. Ciò non implica che i componenti reputati come facenti parte del sistema in osservazione, lo siano realmente; ma dalla prospettiva dell’osservatore assumono tale caratteristica in ragione dell’impostazione teorica seguita, che valida il processo all’interno del sistema osservante (sistema scientifico). In altre parole, la decidibilità che segue una procedura “meccanica” , ossia da una serie di istruzioni che consentono, in linea teorica, di determinare in maniera effettiva se il dato componente xappartenga (1) o non appartenga (0) al sistema (S), e quindi di attribuire in modo meccanico il valore alla sua funzione caratteristica . Si immagini di dover stabilire se un dato fenomeno appartenga al sistema religioso, una volta che dalla prospettiva dell’osservatore vengono definiti i criteri di confini del “sistema osservato” – ad esempio il riferimento al trascendente e al soprannaturale – a questo punto sarebbe sufficiente rendere calcolabili le variabili prese in considerazione nell’osservazione (il dato fenomeno x, i caratteri di “trascendenza” e “soprannaturalità”) attraverso una ridefinizione matematica delle stesse, stabilendo in seguito un processo algoritmico che consenta di volta in volta di decidere per ogni fenomeno x se appartenga oppure non appartenga ad S.
Tale modus operandi, permette di considerare singoli fenomeni, che di per sé non costituiscono un sistema autopoietico, e trattarli o come parte di un sistema (analisi del sistema come unità complessa), oppure come insieme unitario di uno (o più) sistemi autopoietici (analisi del sistema come unità semplice).
Definito il fenomeno ed inquadrato all’interno di una configurazione sistemica, occorre tenere conto della distinzione tra sistema sociale e sistema psichico, ove quest’ultimi sono parte dell’ambiente dei primi (Luhmann, 1990).
Il rapporto tra sistemi sociali e sistemi psichici (che possiamo per semplificazione, identificare come individui), avviene tramite i processi interpenetrativi. Ad agevolare il processo d’interpenetrazione tra i sottosistemi sociali (es. politico, religioso, ecc.) e i singoli sistemi psichiciinterviene la costituzione di strutture comportamentali codificate in codici comunicativi inter i sistemi sociali, che rendono possibile a livello individuale la formulazione di aspettative sociali d’interazione, ossia la credenza tacita della probabile riuscita di un atto comunicativo.
Codeste strutture definite da codici comunicativi, definiscono la cultura o detta altrimenti “mentalità sociale” (Marini, 2016) come sistema a sé stante e fungono nei sistemi psichici da risorsa simbolica cognitiva, ovvero da riduttore interno della complessità socio-ambientale, consentendo i processi d’interpenetrazione.
Detto altrimenti, il sistema culturale, che forma la mentalità sociale, definisce le strutture d’interazione inter i sistemi sociali e tra questi ed i sistemi psichici all’interno della società, consentendone il corretto funzionamento e veicolandone le trasformazioni.
Dalla prospettiva qui esposta, le perturbazioni causate a livello dei sottosistemi sociali, vengono ricondotte, attraverso la mediazione della cultura, all’interno di un processo di auto-orientamento individuale che consente da parte dei sistemi psichici di decodificare i processi di stimolo verificatesi nell’accoppiamento strutturale. I processi d’interazione, riformulati all’interno della struttura cognitiva dell’individuo, producono, a loro volta, una ristrutturazione dei codici comportamentali all’interno del sistema culturale, che portano a conservare quegli elementi che mostrano la capacità di cogliere le perturbazioni esterne, dismettendo invece quelli incompatibili (cambiamento culturale). Ciò da avvio ad un comportamento orientante da parte del sistema psichico, che va a perturbare il sottosistema sociale e così ricorsivamente fintantoché permane l’accoppiamento strutturale e quindi l’interpenetrazione sistemica.
Il processo interpenetrativo funziona solo se entrambi i sistemi condividono lo stesso medium comunicativo e in riferimento all’individuo, se questi riesce attraverso il sistema culturale, a cogliere cognitivamente le mutazioni avvenute in quello che considera il proprio ambiente, ovvero si mostra capace di produrre un comportamento compensativo al mutamento avvenuto nel medium comunicativo. Se ciò non avviene o si interrompe l’accoppiamento strutturale, il sistema che non è in grado di originare comportamenti orientanti interni, non può mantenersi in uno stato di equilibrio, quindi collassa disintegrandosi.
In questo modo, il sistema culturale funge da meccanismo di regolazione omeostatico a “retroazione negativa” in riferimento alle perturbazioni ambientali scaturite dai sistemi (sociali e psichici) nel medium d’azione. Fintantoché le perturbazioni sono ricondotte all’interno del circuito regolatore, l’individuo adopera in maniera “automatizzata” seppur non acritica la cultura come risorsa simbolico-cognitiva d’interpretazione del vivere quotidiano, orientando l’elaborazione dei propri comportamenti in base ad essa
Appare centrale in questo senso, teorizzare un modello interpretativo, che tenga adeguato conto della cultura come variabile (o aggregati di variabili), applicabile operativamente rispetto le dimensioni di essa che si vogliono cogliere nella misurazione.
Così l’influenza esercitata dal sistema culturale all’interno dell’interazione tra sistema psichico-sistemi sociali, può essere analizzata adoperando un modello teorico, che traduca il concetto di “perturbazione” in una “misura” rilevabile statisticamente.
A tale scopo, viene qui suggerito di adottare un modello d’analisi basato sulla tecnica statistica della associazione a cui può far seguito (o sostituirsi), l’analisi di correlazione e l’insieme delle tecniche proprie dell’analisi fattoriale (es. analisi delle componenti principali, analisi delle corrispondenze, analisi delle corrispondenze multiple); quest’ultima in grado di evidenziare strutture latenti o dimensioni non misurabili direttamente all’interno di un insieme di variabili direttamente osservabili (definite dall’osservatore), che si relazionino con tali tratti latenti; non limitandosi quindi a rappresentare l’esistenza di un’associazione statistica tra variabili ma predisponendo un’interpretazione scientifico-relazionale delle stesse.
La scelta di adottare un modello associativo, si lega al paradigma teorico qui adottato dei sistemi autopoietici, che respinge la concezione di causazione dei fenomeni.
Si è detto come la perturbazione non costituisce un attività di tipo causale che traduce l’azione di un elemento X (sia esso un sottosistema sociale o psichico) su Y e viceversa; ma essendo ogni sistema chiuso (a qualsiasi livello) a causa del suo carattere autopoietico, l’azione di un sistema sull’altro si presenta come un orientare reciproco all’interno dei rispettivi domini cognitivi, ovvero attraverso l’accoppiamento strutturale il sistema X innesca (perturba) nel sistema Y attività cognitive strutturalmente determinate dall’organizzazione cognitivo-culturale di Y stesso, è un processo di auto-orientamento, il cui risultato finale (l’output) è indipendente dall’innesco (Seidl, 2004), che ha dato avvio all’attività cognitiva stessa (in quanto il processo interno è già determinato dalla propria organizzazione).
Questo processo interpenentrativo tra sistemi psichici sottosistemi sociali, mediato dalla cultura, giustifica la proposta di un modello interpretativo basato su “influssi perturbativi” o di tipo associativo.
Il modello ad influssi perturbativi respinge quindi l’idea di relazione di tipo input-output; poiché tale relazione non tiene sufficientemente in conto della chiusura sistemica degli individui e dei sottosistemi sociali, che si traduce in una chiusura cognitiva dei primi e di una chiusura in termini di organizzazione strutturale dei processi di creazione delle proprie unità simboliche, dei secondi.
Sia l’individuo e sia i sottosistemi sociali sono sistemi chiusi, autoreferenziali ed autopoietici, non possono quindi sussistere scambi informativi diretti.
L’individuo è in rapporto interpenetrativo con i sottosistemi sociali fintantoché perdura l’accoppiamento strutturale, ovvero vi è un medium comunicativo condiviso. Tramite il medium, in cui si inserisce la cultura, i sottosistemi sociali ed i sistemi psichici entrano in interpenetrazione instaurando un rapporto perturbativo.
Così, il processo interpenetrativo, prodotto dall’accoppiamento strutturale tra sistemi, genera sollecitazioni attraverso il medium di comunicazione nel quale si inserisce la cultura come fattore mediante. Tali sollecitazioni vengonoricondotte rispettivamente all’interno del dominio cognitivo del sistema psichico (l’individuo) e nelle strutture organizzative dei sottosistemi sociali coinvolti nei rapporti di relazione.
Il concetto di chiusura sistemica non preclude che possano avvenire modificazioni all’interno del sistema (sia esso a livello sociale o psichico), ma queste non rispondono ad una logica di nessi causali, quanto piuttosto ad un complesso rapporto di inneschi di attività auto-organizzate. La mentalità sociale muta, ma ciò dipende da modificazioni autoindotte all’interno della propria struttura; i sottosistemi sociali innescano i processi interni alla mentalità che possono condurre al cambiamento. In presenza di un ambiente altamente dinamico, ovvero ove sono elevati i processi di interpenetrazione tra sottosistemi sociali e tra questi e gli individui, l’aumento degli stimoli perturbativi comportano a livello di sistemi sociali una ridefinizione delle nicchie di azione (ed è il caso dei processi di modernizzazione che producono una trasformazione della nicchia del sottosistema religioso) ed a livello individuale, la probabilità di mutamento della mentalità sociale (condizionata dai cambiamenti che accadono a livello dei sottosistemi sociali).
Nel caso dell’individuo, il sistema culturale, benché elaborato razionalmente a livello dei singoli (razionalità assiologica – Boudon 1980, 1986, 2007), lega al contempo gruppi di individui (aventi determinate caratteristiche quali: una lingua comune, stessa area geografica, stesso periodo storico, ecc.), che condividono a livello simbolico-cognitivo, un orientamento orbitante attorno ad una determinata scala di valori gerarchicamente strutturata.
In definitiva, il processo di “associazioni perturbative” permette di analizzare l’impatto dei sottosistemi sociali, sul processo decisionale dell’individuo e viceversa, tenendo in conto la mediazione comunicativa esercitata dal sistema culturale – o detto altrimenti dalla “mentalità sociale” – trattando i fenomeni sociali (la stessa interazione comunicativa tra sistemi psichici avviene all’interno dei sistemi sociali) come variabili statisticamente analizzabili, in riferimento alla prospettiva teorica dell’osservatore.
Quo vadis?
In conclusione, attraverso l’adozione del paradigma interpretativo dei sistemi autopoietici, si è qui discusso sulla necessità di trattare qualsiasi osservazione effettuata all’interno del sistema scientifico ed in particolare nell’ambito delle scienze sociali, come parziale, relativa ed unica:
- parziale in quanto muove dalla prospettiva del sistema scientifico;
- relativa in quanto adotta codici di riduzione della complessità ambientale che sono definiti dal sistema stesso, che si esplicano in differenti modelli teorici di comprensione informativa, validi per sé all’interno del sistema;
- unicain quanto è contingente (ossia si manifesta hic et nunc) ed è prodotta dall’interpenetrazione di un sistema psichico (il ricercatore) con il sistema sociale; ossia l’osservazione si attua attraverso una delle lenti di differenti paradigmi di ricerca – del sistema scientifico dispiegandosi nei modi compresi dall’osservatore (che è un sistema chiuso) su un fenomeno che lascia osservare quella parte di sé che entra in interazione con l’osservazione stessa (carattere sincronico dell’atto).
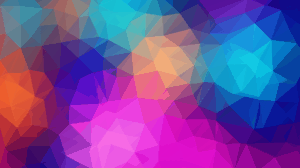 Da ciò emerge l’impossibilità di sostenere un’oggettività tout court della conoscenza prodotta dal sistema osservante sul fenomeno oggetto di studio. Si configura, invece, una “possibilità di oggettivazione” dei risultati che è specifica al solo sistema osservante e che dipende dalla comprensibilità dell’informazione prodotta all’interno del sistema, a seguito dell’innesco durante l’interazione osservativa, di specifiche procedure strutturali di produzione date dall’organizzazione del sistema stesso. La comprensibilità conoscitiva dipende dalla validità dei codici d’informazione adoperati in maniera autonoma dal sistema osservante rispetto alla riduzione delle perturbazioni ambientali, che vengono accolte dal sistema come fattori innescanti dei propri processi di produzione informativa.
Da ciò emerge l’impossibilità di sostenere un’oggettività tout court della conoscenza prodotta dal sistema osservante sul fenomeno oggetto di studio. Si configura, invece, una “possibilità di oggettivazione” dei risultati che è specifica al solo sistema osservante e che dipende dalla comprensibilità dell’informazione prodotta all’interno del sistema, a seguito dell’innesco durante l’interazione osservativa, di specifiche procedure strutturali di produzione date dall’organizzazione del sistema stesso. La comprensibilità conoscitiva dipende dalla validità dei codici d’informazione adoperati in maniera autonoma dal sistema osservante rispetto alla riduzione delle perturbazioni ambientali, che vengono accolte dal sistema come fattori innescanti dei propri processi di produzione informativa.
In altre parole, all’interno del sistema scientifico, ad essere compresi come oggettivamente validi, non sono i risultati in sé, ma i processi interni (criteri metodologici), che hanno condotto alla produzione di una determinata conoscenza all’interno del sistema, la quale sarà comprensibilelimitatamente al sistema stesso.
Ad essere “probabilmente” compresi sono quindi i processi che portano ai risultati, i quali acquisiscono validità interna al sistema, in virtù del riconoscimento dei codici (criteri metodologici) che regolano tali processi e di cui i codici stessi sono composti (autoreferenzialità).
La riduzione dell’oggettività (e della trasmissibilità) della conoscenza ad “oggettività rispetto allo specifico sistema”, porta a riflettere sulla capacità del sistema scientifico di produrre informazione interna che sia funzionale ad una conoscenza scientifica (pertanto particolare) del sistema-società.
Da qui la possibilità di un processo osservativo all’interno delle scienze sociali, che sulla base dei codici processuali definiti dai paradigmi euristici della teoria luhmanniana definisca un modello di ricerca – intesa come atto osservativo – riconosciuto come operazione valida all’interno del sistema.
Viene dunque proposto a partire dal concetto di “sistema”, un modello interpretativo di tipo statistico-matematico in grado di rendere possibile (probabile) il riconoscimento dei risultati prodotti come validi oggettivamente all’interno del sistema scientifico.
Il modello detto ad “influssi perturbativi” si basa sull’assunzione della chiusura autopoietica dei sistemi psichici e sociali. Una tale prospettiva esclude ogni tipo di rapporto di causazione nel senso di input-output; cosicché ad essere osservabile è il rapporto di relazione tra i fenomeni, che si traduce in un’analisi delle associazioni (oppure correlazione) degli stessi.
È l’osservatore (il ricercatore) che quantifica i fenomeni di studio in variabilicalcolabili operativamente, inserite in un contesto di differenziazione dei confini sistemici entro i quali i suddetti fenomeni acquisiscono significato per l’osservatore stesso, che si basa su un processo di distinzione binaria: dentro/fuori il sistema coinvolto, in relazione al principio d’identità. L’operatività del modello inoltre, deve tener conto, dell’impatto della “mentalità sociale”, sulla relazione dei fenomeni di studio, attraverso una scomposizione dimensionale del sistema culturale in variabili operative, a seconda delle ipotesi di partenza da cui muove l’osservazione.
Codesta proposta dev’essere considerata per ciò che di fatto è: un’analisi (osservazione) interna al sistema scientifico che muove dalle scienze sociali ed adotta un particolare paradigma di analisi così come compreso dall’autore del presente lavoro. Come tale, rimane una prospettiva parziale, relativa ed unica.
Bibliografia
Addario Niccolò (2008), Teoria dei sistemi sociali e società, Roma: Carocci Editore
Boudon, Raymond (1980), La logica del sociale, Milano: Mondadori.
——— (1986), Il posto del disordine, Bologna: Il mulino.
——— (2007), Essais sur la théorie générale de la rationalité, Paris : Presses Universitaires de France.
Di Santo Gustavo (2018), Valori Religiosi e Sviluppo in Brasile: Cattolicesimo e (Neo)Pentecostalismo verso la convergenza?Tesi di dottorato, Università della Calabria.
Henderson Lawrence J., (1970), On the Social System. Selected Writings, Bernard Baber (a cura di), Chicago: The University of Chicago Press.
I Ching. Il libro dei Mutamenti (2005),Wilhelm R. (a cura di), Jung C. G. (prefazione di), Milano: Adelphi Edizioni.
Jedlowki Paolo, (2017), Il mondo in questione. Introduzione al pensiero sociologico, Roma: Carocci editore.
Luhmann Niklas, (1990), Sistemi Sociali. Fondamenti di una teoria generale, Bologna: Il Mulino
Marini Matteo B. (2016), Le Buone Abitudini. L’approccio culturale ai problemi dello sviluppo, Roma: Donzelli Editore.
Maturana, Humberto R. & Francisco J. Varela (2012), Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Venezia: Marsilio Editore.
Pareto Vilfredo (1978), Compendio di Sociologia Generale, Torino: Einaudi Editore
Parini, Ercole G. (2007), Scienza e Tecnologia, in: Grande T. & Parini E. G. (a cura di), Studiare la società. Questioni, concetti, teorie, Roma: Carocci Editore.
Seidl, David (2004), Luhmann’s theory of autopoietic social system, Ludwig-Maximilians-Universität München School of Management, Vol.2.
Weber Max, Il Metodo delle Scienze Storico-Sociali, Pietro Rossi (a cura di), Einaudi, formato E-pub.





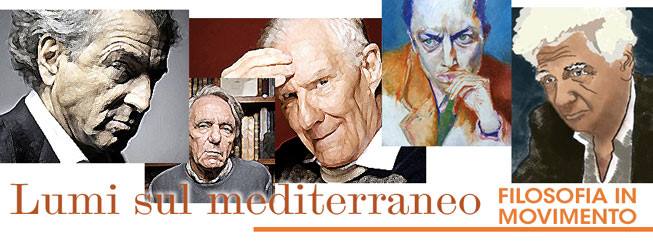




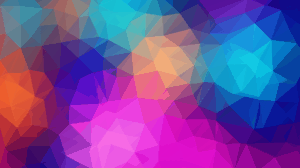 Da ciò emerge l’impossibilità di sostenere un’oggettività tout court della conoscenza prodotta dal sistema osservante sul fenomeno oggetto di studio. Si configura, invece, una “possibilità di oggettivazione” dei risultati che è specifica al solo sistema osservante e che dipende dalla comprensibilità dell’informazione prodotta all’interno del sistema, a seguito dell’innesco durante l’interazione osservativa, di specifiche procedure strutturali di produzione date dall’organizzazione del sistema stesso. La comprensibilità conoscitiva dipende dalla validità dei codici d’informazione adoperati in maniera autonoma dal sistema osservante rispetto alla riduzione delle perturbazioni ambientali, che vengono accolte dal sistema come fattori innescanti dei propri processi di produzione informativa.
Da ciò emerge l’impossibilità di sostenere un’oggettività tout court della conoscenza prodotta dal sistema osservante sul fenomeno oggetto di studio. Si configura, invece, una “possibilità di oggettivazione” dei risultati che è specifica al solo sistema osservante e che dipende dalla comprensibilità dell’informazione prodotta all’interno del sistema, a seguito dell’innesco durante l’interazione osservativa, di specifiche procedure strutturali di produzione date dall’organizzazione del sistema stesso. La comprensibilità conoscitiva dipende dalla validità dei codici d’informazione adoperati in maniera autonoma dal sistema osservante rispetto alla riduzione delle perturbazioni ambientali, che vengono accolte dal sistema come fattori innescanti dei propri processi di produzione informativa.