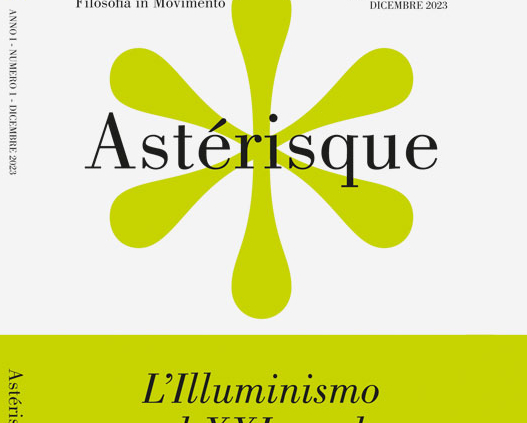L’Illuminismo fuori dell’Europa. Una lettura a partire dalla Filosofia della liberazione latinoamericana
Non c’è dubbio che i filosofi illuministici ritenevano di elaborare concetti e principi universali, cioè diretti e validi per l’intera umanità, trasformandoli in ideali da realizzare, principi regolativi[1] di ogni futura azione pratica che ad essi si ispirasse. Il modello di questa nuova forma del pensiero filosofico è rappresentato dal motto kantiano: “Agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale”[2]. Si tratta, come è noto, di un imperativo categorico formale, ma è, allo stesso tempo, regolativo di ogni futura legge universale. Enrique Dussel utilizza i principi regolativi universali in maniera non formale, ma materiale, cioè ponendo come contenuto del principio di comportamento morale «il principio di produzione, riproduzione e sviluppo della vita umana di ciascun soggetto etico in comunità». Questo principio potrebbe essere non realizzabile in toto, ma rimane come la stella polare per i naviganti il punto di riferimento, irraggiungibile praticamente, ma indispensabile per orientare la propria direzione, o meglio la propria azione pratica. Questo nuovo orientamento del comportamento pratico, che tiene insieme la formalità dell’imperativo categorico con la materialità della vita umana, viene dall’esperienza esistenziale, divenuta filosofica, di chi pensa e agisce moralmente nell’esteriorità dell’attuale sistema dominante, cioè fuori dal Centro del Mondo (Stati Uniti, Europa, Giappone). L’esperienza e il pensiero di Dussel, che userò come strumento per questo saggio, vengono dall’America latina, la prima vittima del sistema coloniale europeo, anzi la vittima che ha permesso con il suo sfruttamento la fondazione della Modernità[3], cioè con il saccheggio delle sue ricchezze naturali (metalli preziosi) l’accumulazione originaria del capitale, che è avvenuta soprattutto con l’uso del lavoro di schiavi strappati con la violenza dall’Africa.
Dussel indica chiaramente quali siano i principi normativi della politica: «I principi normativi della politica, gli essenziali, sono tre. Il principio materiale obbliga a curare la vita dei cittadini; il principio formale democratico determina il dovere di agire sempre rispettando le procedure proprie della legittimità democratica; il principio della fattibilità limita egualmente ad operare soltanto per il possibile (al di qua della possibilità anarchica, e al di là della possibilità conservatrice)»[4]. Secondo me, i principi normativi della politica devono essere ispirati ai principi regolativi universali di origine illuministica, più precisamente principi normativi sussumono in loro i principi regolativi universali, fino al punto che essi assumono una eticità in se stessi: divengono principi etici del comportamento comune, cioè collettivo e poi passano ad essere principi morali del comportamento del singolo individuo.
La patria dell’Illuminismo fu la Francia, che era contemporaneamente una potenza coloniale schiavista. I politici illuministi agirono per rendere questi principi regolativi principi normativi, in modo tale che qualsiasi azione pratica potesse trovare il consenso universale. Così la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1789), basato su un testo di La Fayette, con la collaborazione di Jefferson, e ispirata al pensiero di Montesquieu[5], Rousseau e Voltaire, venne intesa come una legge universale e come tale è riconosciuta. I principi a fondamento di quella dichiarazione, Libertà, Fraternità e Uguaglianza, sono stati negli ultimi due secoli a fondamento di qualsiasi civile dichiarazione o costituzione statale. Anche la “Dichiarazione Universali dei diritti umani” (1945) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite si ispira a quei principi regolativi, quindi quei principi sono stati a fondamento di una legislazione universale e di ogni azione di liberazione da qualsiasi forma di oppressione. Sono stati e, sicuramente, saranno per qualsiasi altra azione di liberazione, sia individuale che collettiva che sarà messa in pratica in futuro.
Anche la “Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America” (1776) si ispira a principi regolativi, ritenuti universali, che derivano dal pensiero di John Locke, il quale, per altro, riteneva legittima la schiavitù, in quanto riteneva la proprietà privata superiore alla stessa libertà. Alcuni di questi principi sono gli stessi della futura “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, come l’eguaglianza e la libertà, ma vi si aggiunsero il riconoscimento che ciascun essere umano ha diritti inalienabili, quali la vita e la felicità. Ma nel momento della stesura della “Costituzione degli Stati Uniti d’America” (1787) un evidente oblio fece dimenticare quei principi universali regolativi e la schiavitù non fu abolita, ma semplicemente regolamentata (vedi Artt. I, II e V). A questo punto è opportuno porsi qualche domanda: Perché la schiavitù non fu abolita? Forse gli schiavi non erano ritenuti uguali ai loro padroni bianchi? La risposta più ovvia è si, tant’è che anche dopo l’abolizione della schiavitù, nel 1865, la segregazione razziale non terminò e ancora oggi a più 250 anni dalla “Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America” e da più di 150 anni dall’abolizione della schiavitù la segregazione non è stata completamente superata, come insegna il movimento attuale Black Lives Matter. Buck-Morss avanza una propria interpretazione riguardo alla scarsa conoscenza delle vicende legate al mondo degli esclusi o degli oppressi: «Più le conoscenze sono specialistiche, più avanzato il livello della ricerca, più lunga e venerabile la tradizione accademica, più è facile che i fatti discordanti vengano ignorati. Va rilevato che la specializzazione e l’isolamento costituiscono un pericolo anche per nuove discipline come gli studi afro-americani»[6].
Ma è opportuno porsi un’altra domanda più radicale delle precedenti: In cosa consisteva l’ineguaglianza degli schiavi rispetto ai loro padroni? La risposta è ovvia ed evidente: erano neri, cioè non erano bianchi, o meglio non erano europei, perché soltanto gli europei si considerano veri bianchi, negando l’evidenza che anche gli asiatici (cinesi, coreani e giapponesi) sono bianchi. Pare che i principi regolativi universali valessero soltanto per gli europei e non per tutti gli esseri umani, quindi non erano universali, o meglio erano universali in teoria e non lo erano nella pratica, cioè nella società, nella politica e nell’economia. La stessa riproduzione della vita non era eguale tra i bianchi e i neri. La “Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America” era smentita dagli stessi cittadini che si erano dichiarati indipendenti dalla madrepatria inglese.
Una prima conclusione teorica si può trarre: nel momento in cui i principi regolativi universali dell’Illuminismo stavano per diventare principi normativi della politica non furono riconosciuti i tre principi normativi, come li ha indicati Dussel: il principio materiale fu fortemente ristretto alla semplice riproduzione della forza lavoro schiava, mentre totalmente negati furono il principio formale, in quanto gli schiavi non avevano dignità giuridica, se non come merci, e il principio di fattibilità, perché si realizzò l’unica possibilità esistente che era quella di considerare esseri umani come cose. Un’altra considerazione la ricavo dal bel libretto di Buck-Morss: la libertà come valore universale, si affermò nel momento di massimo sviluppo dello schiavismo[7], quindi un tale fenomeno, in piena espansione, ne condizionò la realizzazione pratica. Infatti la Buck-Morsse riporta un dato interessante: il 20% della borghesia francese viveva di economia schiavistica[8], quindi era liberale in patria e schiavista nelle colonie.
Data l’egemonia culturale degli Stati Uniti sulla cultura mondiale, questi avvenimenti sono molto noti e conosciuti. Molto meno conosciuta è la vicenda di chi realizzò effettivamente i principi regolativi universali della “Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino”: gli haitiani. Della piccola isola di Hispaniola si sa molto poco nella cultura europea. Si sa, senza dubbio, che esistono due piccole nazioni caraibiche: Haiti e la Repubblica Dominicana. Ma non è molto noto che queste due piccole nazioni si dividono l’isola di Hispaniola. Ho scritto “nazioni”, perché nelle due parti dell’isola si parlano lingue diverse: francese ad Haiti[9] e spagnolo a Santo Domingo. È ovvio pensare che si parli francese ad Haiti, perché fu una colonia francese, ma Haiti ha una particolarità che la differisce da altre colonie francesi, insieme a Martinica e Guadalupe, era l’unica colonia francese dove era ammessa la schiavitù. È vero che il 28 marzo 1792 e il 4 febbraio 1794 la schiavitù fu abolita anche nelle colonie, in conseguenza della “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino”, sebbene Robespierre si rifiutò di firmare di firmare il decreto di abolizione della schiavitù. Come negli Stati Uniti i principi regolativi universali rimasero tali nella teoria, nella pratica la segregazione schiavistica rimase inalterata fino al 1 gennaio 1804, quando i francesi abbandonarono l’isola per le pessime condizioni naturali dell’isola di Hispaniola, alle quali, invece, si erano adattati più facilmente gli schiavi africani, piuttosto che gli europei. I padroni bianchi erano riusciti, in nome dell’autonomia legislativa, a non far rispettare le decisioni della madrepatria francese del 1792 e del 1794, quindi la libertà e l’eguaglianza erano principi regolativi non universali, anzi subordinati all’autonomia legislativa delle colonie, così come era accaduto negli Stati Uniti, dove alcuni Stati della Federazione non avevano rispettato i principi regolativi di Libertà, Felicità e Vita. Quindi i principi regolativi universali avevano un limite nelle autonome decisioni di ciascun realtà politica: in pratica il loro carattere universale era negato. Naturalmente erano negati i principi normativi della politica come li intende Dussel. I principi regolativi universali erano negati dalla classe dei proprietari francesi di schiavi africani.
Ad Haiti, però, gli schiavi neri non accettarono pacificamente di rimanere schiavi, sapevano che in Francia la loro condizione di schiavitù era stata abolita e così desideravano che quei principi regolativi universali fossero messi in pratica nella loro terra. In realtà, erano le vittime della schiavitù che desideravano trasformare in pratica politica, economica e sociale, la teoria universalistica dell’Illuminismo francese. Questo movimento di liberazione dalla schiavitù trovò un leader nella figura di Toussant Louverture, ex-schiavo, che lottò contro la Francia rivoluzionaria e contro Napoleone, cercando di ottenere l’indipendenza di Haiti dalla Francia, perché l’indipendenza era l’unica condizione politica che avrebbe permesso la liberazione degli schiavi africani. La Francia illuministica, rivoluzionaria, giacobina e napoleonica represse sanguinosamente questo movimento di liberazione, finché la natura stessa dell’isola, le malattie, come la febbre gialla, e il clima tropicale decimarono le truppe francesi e costrinsero la madre patria dell’Illuminismo universalistico a lasciare l’isola e a permettere a Jean-Jacques Dessalines, successore di Toussant, che era morto in carcere in Francia, di trasformare i principi regolativi universali in principi normativi universali pratici. Nasceva così il primo vero territorio libero d’America, tenendo conto che negli Stati Uniti la schiavitù era rimasta in vigore. La rivolta delle vittime della schiavitù fece diventare i principi regolativi universali strumenti della lotta di classe. Iniziava realmente l’età delle lotte di classe in nome dei principi illuministici.
In verità la lotta di classe si fonda sull’esclusione dai principi regolativi universali di libertà, eguaglianza e fratellanza, come alcuni rivoluzionari francesi più radicali intuirono. La legge economica del mercato, invece, si fonda dall’esclusione dalla retribuzione per l’intero valore prodotto dal lavoratore. Marx si rese conto che il lavoratore escluso dalla proprietà dei mezzi di produzione era esterno al mercato, anzi il suo corpo era esterno, mentre la sua forza lavoro era elemento fondamentale della produzione della ricchezza. Quindi l’esteriorità è la categoria fondante l’esclusione e chi è più esterno dello schiavo africano? Egli vive lontano, fuori, dal mondo euro-centralizzato.
La legalità che i proprietari francesi di schiavi africani volevano imporre non era ispirata ai principi regolativi universali dell’Illuminismo, ma quella del mercato, che tende ad occultare uomini, relazioni e cose. In pratica si voleva legittimare l’esclusione, lo sfruttamento e la negazione della dignità umana. La critica di questa logica giuridica è, quindi, anche critica dell’economia politica sulla quale quella logica si fonda. Franz Hinkelhammert è molto chiaro su questo punto: «La legalità assoluta è l’ingiustizia assoluta. Questo non implica nessuna abolizione della legalità, bensì la necessità di intervenire, quando distrugge la stessa convivenza umana. Questa legalità nella sua logica è incompatibile con la vigenza dei diritti umani»[10]. Quindi la rivolta degli schiavi africani partiva dalle condizioni di vita in cui erano costretti dai proprietari francesi, i quali con la loro pratica economico-politica anti-illuministica stavano trasformando la razionalità dei principi regolativi universali in forme irrazionali di condizioni di vita inumana per gli schiavi africani. La giustificazione di una legislazione autonoma locale è proprio una forma di razionalizzazione dell’irrazionale. La rivolta degli schiavi africani, quindi, aveva come fine l’abolizione, anche violenta, di queste loro condizioni di vita inumana, in pratica gli schiavi africani si ribellarono alla propria condizione di cose, di merce, di reificazione della loro vita.
I principi regolativi universali avevano offerto, dapprima, agli schiavi africani una prospettiva di liberazione, ma la reintroduzione della legalità della condizione di schiavitù aveva negato e represso quella aspirazione universalistica alla liberazione dalla schiavitù e soltanto il loro atto violento di ribellione li aveva liberati da questa ricostituita legalità giuridica oppressiva e restituito la condizione di vita degna di essere vissuta, tenendo sempre presente che la loro abitudine di vita si confaceva alla natura tropicale dell’isola di Hispaniola.
Con le parole del sociologo Anibál Quijano scopriamo un altro aspetto della rivoluzione haitiana: «L’esperienza più radicale accade e non per caso ad Haiti. Laggiù, è la popolazione schiava e “negra”, la base stessa della dominazione coloniale antillana, quella che distrugge insieme con il colonialismo, la propria colonialità del potere tra “bianchi” e “negri” e la società schiavistica in quanto tale. Tre fenomeni nello stesso movimento della storia. Benché distrutto, più tardi con l’intervento neocoloniale degli Stati Uniti, quello di Haiti rappresenta anche il primo momento mondiale nel quale si uniscono l’indipendenza nazionale, la decolonizzazione del potere sociale e la rivoluzione sociale»[11]. Quijano, nel giocare nel contrasto tra “bianchi” e “negri” intende sottolineare che la liberazione degli haitiani fu anche la liberazione dal razzismo europeo, cioè dalla convinzione, elevata ad ideologia, che i “negri” fossero talmente inferiori da essere incapaci di ricevere un salario. Gli Stati Uniti d’America, paese fondato sui principi dell’Illuminismo, è intervenuto a restaurare il colonialismo ad Haiti, ma rimane l’esperienza vissuta (Erlebnis) di avere negato il colonialismo con la propria lotta di liberazione e di indipendenza, a conferma che la vera decolonizzazione si ha nella separazione dall’Europa liberale e illuminata.
Ma, come detto, il paradosso più grande consiste nel fatto che questa lotta di liberazione si ispira ai principi regolativi universali illuministici, che in sé sono così poco eurocentrici, che gli stessi europei li negano. Ma questi principi regolativi universali fanno sorgere anche nelle vittime l’esigenza di una pretesa di giustizia, che è sostanzialmente una pretesa politica di giustizia. Enrique Dussel così definisce la pretesa politica di giustizia: «La “pretesa politica di giustizia” è la posizione che adotta il soggetto politico (…) esercitando un atto umano che normativamente ha rispettato i principi che la politica ha sussunto dall’etica. Il soggetto politico ha coscienza normativa di praticare, dentro le limitazioni della condizione umana, un atto di “pretesa” di giustizia, onestà, in coerenza con i principi normativi che dice di difendere e praticare»[12]. Quindi usando la definizione di Dussel, possiamo considerare l’atto di ribellione degli haitiani una interpellazione, una richiesta di “pretesa politica di giustizia” proprio a partire dai principi regolativi universali, rivolta non solo ai proprietari francesi, ma a tutta l’umanità, perché un singolo atto di liberazione, cioè di passaggio dalla possibilità alla realtà fattuale libera ed eguale è un atto di comune e universale liberazione.
L’azione di liberazione degli schiavi africani ad Haiti dimostra che i principi regolativi universali e la pretesa che essi diventino principi normativi della politica sono strumenti critici nei confronti del sistema dominante. Le vittime dello schiavismo hanno chiesto la realizzazione della Libertà, dell’Eguaglianza e della Fratellanza, quindi a partire da questi principi regolativi universali hanno potuto criticare il sistema della schiavitù allora esistente. Il sapere da parte degli schiavi africani di Haiti, che quei principi sono stati dichiarati, ha armato la loro pretesa di giustizia. La liberazione dalla schiavitù è stata storicamente il primo passo per una pretesa di giustizia per l’intera umanità. Mi riferisco al movimento della liberazione femminile, che è nato dopo la liberazione dalla schiavitù. L’esperienza di liberazione dalla schiavitù è diventata l’arma dei movimenti femminili per la critica del sistema maschilista di esclusione. Anche in questo caso si è chiesto che i principi regolativi universali divenissero principi normativi della politica.
[1] Mi riferisco a quanto sostiene Enrique Dussel a proposito dei principi regolativi di matrice kantiana (cfr. E. Dussel, Ética de la liberación, Madrid, Trotta, 1998, p. 565). Dussel parla di “idea regolativa”, io preferisco usare il termine “principi regolativi”, perché sono momenti iniziali e fondamentali, mentre l’idea, soltanto nel senso platonico, può essere usata come principio e non voglio affatto rischiare di essere scambiato per un idealista di tipo platonico, che è un modo per banalizzare un discorso che banale non è di certo. Enrique Dussel (1934) è un filosofo argentino che, a causa della persecuzione della dittatura militare argentina, si è trasferito a Città del Messico. È professore emerito della UNAM, i suoi libri sono apparsi in inglese, francese, tedesco e in tantissime altre lingue. Castelvecchi ha pubblicato vari suoi saggi.
[2] I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, tr. it. P. Chiodi, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 49.
[3] Cfr. la mia opera Apocalisse. L’inizio e la fine della modernità, Trieste Asterios, 2020.
[4] E. Dussel, Venti tesi di politica, tr. it. A. Infranca, Asterios, Trieste, 2009, p. 95.
[5] Ricordo che Montesquieu era favorevole alla schiavitù.
[6] Susan Buck-Morss, Hegel e Haiti. Schiavi, filosofi e piantagioni, tr. it. F. Francis, Verona, Ombre corte, 2023, p. 11.
[7] Ivi, pp. 9-10.
[8] Ivi, p. 22.
[9] In realtà il francese è parlato da un’esigua minoranza della popolazione, perché la lingua più diffusa è il creolo haitiano, una lingua nata dal francese e dalle lingue degli schiavi africani. La lingua francese è stata sempre considerata dai governanti francesi come uno strumento per la formazione della nazionalità francese. Oggi è considerata la lingua ufficiale in 32 Stati e parlata da circa 270 milioni di esseri umani, ma in realtà i nativi parlanti francese sono 80 milioni. Così che dalla quinta lingua più diffusa al mondo, scende al 17° posto tra le madrelingue. Per capire bene questa situazione confrontiamo il francese con lo spagnolo. La lingua spagnola è parlata da 560 milioni di esseri umani e questa cifra la fa diventare la seconda madrelingua del mondo, dopo il cinese, ma più dell’inglese (430 milioni).
[10] F. Hinkelhammert, La maldición que pesa sobre la ley: Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso, Arlekín, San Josè de Costarica, 2010, p. 298.
[11] A. Quijano, “Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas”, in José Carlos Mariátegui y Europa. La otra cara del descubrimiento, a cura di R. Forgues, Lima, Amauta, 1991, p. 179.
[12] E. Dussel, “Pretensión crítico-política de justicia”, in Política de la liberación, vol. III, a cura di E. Dussel, Madrid, Trotta, 2022, pp. 707-708.