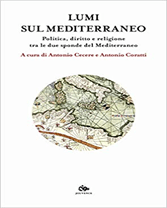Gianfranco Macrì
1. Le note di commento che seguono riguardano quello
che, in prima battuta, potremmo definire un piccolo trattato sui principi che
hanno regolato l’ordine internazionale nel corso del ‘900 e sul modo come
questi dovranno essere rielaborati di fronte alle sfide del nuovo secolo. Sullo
sfondo permangono antiche e nuove piaghe: la guerra, la diffusione di
pestilenze, la povertà, le disuguaglianze; tutto questo mette in allarme l’umanità,
sollecita soluzioni all’altezza della complessità globale, invoca l’azione di
nuovi attori in grado di comprendere lo scenario e di proporre alternative di governance
efficaci e risolutive.
C’è ancora bisogno del ruolo delle organizzazioni
internazionali? Come, questi apparati costruiti dopo la II guerra mondiale – e
finalizzati a garantire la pace e la cooperazione in campo politico, sociale ed
economico – riescono a garantire gli equilibri geopolitici di fronte all’avanzare
di nuove emergenze (specie migratorie e sanitarie)? Gli attori in scena
cambiano volto, e nuove soggettività, dai tratti non più soltanto statualistici,
si impongono in modo marcato, rivendicando visibilità e potere. Che fare?
Il quesito investe certamente la politica e la
storia (e poi l’economia, l’antropologia, etc.) ma anche il diritto e la sua funzione
di “scienza pratica”, perché le istituzioni politiche in diverse parti del mondo
sono sotto pressione, subiscono l’aggressione di fattori “concorrenziali”
(fondamentalismi religiosi, gruppi di interesse, ideologie nazionaliste, etc.)
che hanno ricadute sulla tenuta del principio democratico (come principio
equilibratore). L’esempio più calzante, perché
storicamente più noto, riguarda proprio l’incapacità da parte degli organismi
internazionali di governare lo strumento della guerra, praticando, in diverse
circostanze, la politica dell’affidamento alla “super potenza” di turno[1].
Qualcuno, a ragione, osserva che la trama dei
diritti umani non ha saputo innervare allo stesso modo i diversi poli del
pianeta; le crisi umanitarie sarebbero, perciò, crisi determinate anche
dal cattivo funzionamento del circuito della legalità internazionale. Certamente
sono mutati i criteri e i metodi di rappresentazione degli scenari – perché sono
cambiati gli assetti di governance di un tempo. Il Novecento (qualcuno dirà)
è finalmente alle nostre spalle, ma il suo fascino persiste, anche nelle
declinazioni più nocive. Si tratta, allora, di verificare quali saranno gli
effetti di una crisi mai così lunga e penetrante (adesso accresciuta sul fronte
sanitario) che dal 2008 si dispiega a livello mondiale seguendo tracciati
diversi, continuando a “mordere” in modo trasversale anche quegli spazi ritenuti
meglio attrezzati in termini di diritti e di garanzie (l’Unione europa, giusto
per fare un esempio di “prodotto” meglio riuscito del Novecento post-seconda
guerra mondiale).
Quello, dunque, del “veccho modello” di gestione delle
emergenze (concepito secondo una logica piramidale, con in cima pochi attori “padroni
del sistema”) rappresenta un “capitale” concettuale e operativo praticamente mai
dismesso – sebbene declinato in modo diverso a seconda del momento e dei
protagonisti coinvolti – dunque affidabile (intendo dal punto di vista
della “tenuta” e del controllo della società). Gli strumenti operativi possono
ovviamente essere diversi, finanche l’uso “retorico” e demagogico dei diritti e
delle libertà si presta al gioco: l’importante è che il sistema regga; a
qualunque costo. Un esempio? “Esportare la democrazia”[2]
dove le tradizioni culturali sono “altre” (con tutto quello che ne è scaturito
in termini di “messa in sicurezza” dei sistemi politico-istituzionali e
socio-economici). Sullo sfondo è sempre necessario che si consolidi la tesi che
c’è sempre qualcuno capace di affascinare, di “unire il popolo” proteggendolo
dal nemico esterno, di rievocare i fasti del passato e di indicare la strada,
soprattutto in tempi di “decadenza morale”, di crisi economica, di pericolo
grave per la salute pubblica, di “invasioni” pericolose anche connotate in
senso religioso (fondamentalismo, terrorismo, integralismo, etc.)[3].
Mai come in questo frangente della storia, la democrazia (quella di derivazione
liberale, rappresentativa e costituzionale, per intenderci) è tornata ad essere
al centro del dibattito politico e scientifico, a dimostrazione che non di una
conquista definitiva si tratta, bensì di un processo autoriflessivo all’interno
del quale vanno considerate variabili diverse e anche distanti tra loro, tutte
però accomunate dalla volontà di allargare i canali della partecipazione[4].
Questo scenario, così frastagliato, che vede prevalere,
a diverse latitudini (come il Mediterraneo) narrazioni politiche “egemoniche”, che
affascinano sempre più leader di nazioni “minori” smaniosi di instaurare regimi
politici neo-sovranisti aventi come obiettivo la critica, anche radicale, dei
sistemi (e delle regole) sovrastatuali di organizzazione degli interessi, dei
diritti e delle libertà (es. Unione europea in primis), riflette – come un
prisma – la progressiva sofferenza in cui è precipitato quel grande principio
consacrato nelle carte internazionali – fonte di pacificazione e di legalità
condivisa – che è la cooperazione. Si fatica, cioè, a valorizzarne il
primato, collocandolo al centro dell’agire civile dei popoli democratici.
I motivi di preoccupazione, allora, non mancano. Ben
vengano, quindi, quei contributi che possono aiutarci a verificare l’eventuale
presenza di fattori in grado, se non proprio di invertire la rotta, quanto meno
di indicare percorsi alternativi, lungo i quali imbattersi in figure, oppure
esperienze, all’altezza delle sfide in atto.
Tra i segnali di maggiore interesse che possono
aiutarci a comprendere il quadro generale delle problematiche adombrate, la
dimensione religiosa occupa un posto di prima grandezza. Si è parlato, non a
caso, di ritorno della religione nello spazio pubblico, ma non sempre si
riesce a spiegare a cosa questa espressione concretamente rinvia.
Da qui l’utilità del libro di Luigi Rossi, la cui
lettura si offre quale utile strumento per capire come il fenomeno religioso (e
non solo questo) ritrovi centralità nelle pieghe della geopolitica
contemporanea e come alcuni protagonisti – in questo caso Papa Francesco (il
protagonista dell’opera) – agiscano alla luce dei repentini cambiamenti in corso.
Una cosa è certa: siamo tutti consapevoli di trovarci di fronte ad un “giro di
boa” della storia mondiale, e che tutto quanto accade in qualsiasi posto del
pianeta, mai come adesso, riverbera ovunque, producendo conseguenze anche dirompenti
(il rimando al coronavirus- Covid-19 è ahimè automatico).
Luigi Rossi parla di «riflessione sulla spiritualità»[5].
Forse perché è finito (oppure attraversa un momento di crisi-ripensamento) il
tempo del discorso centrato in massima parte sul peso politico delle
organizzazioni religiose (a dispetto del sentimento religioso della persona e
delle comunità) ed è iniziato quello calibrato sulla ricerca di senso di un
nuovo homo viator. Certamente il discorso è più ampio. Qui, infatti, si
propone – in filigrana – un nuovo modo di “convertire” l’umanità al senso di
responsabilità, solidarietà, partecipazione, senza per forza passare “attraverso”
le chiese (lato sensu), oppure senza che il loro imprimatur continui ad
essere ritenuto decisivo per mettere in sicurezza le sorti del mondo. Quest’ultimo
si governa anche con l’ausilio delle organizzazioni religiose, ma sono
le persone (credenti, non credenti, diversamente credenti) che stanno a cuore a
Papa Francesco. Naturalmente gli apparati più conservatori presenti sia nella Chiesa
cattolica che in altre comunità religiose guardano con sospetto e apprensione a
questo capovolgimento di prospettiva, perché è chiaro che la tensione temporale
del potere religioso rischia di affievolirsi se sbilanciata a favore di quella “interiore”
che purifica e modella il cittadino-fedele. Ma Bergoglio si muove su un sentiero
diverso, quello diretto a recuperare lo “spirito delle origini” (un
cristianesimo dal volto umano) e da questo far nuovamente germogliare una novella
centralità ecclesiale.
2. Un argomento di grande dibattito è quello del rapporto
tra Islam e democrazia (occidentale). I grandi rivolgimenti avvenuti dopo l’11
settembre[6]
– fino alle “Primavere arabe” e oltre – hanno consigliato qualcuno a continuare
a battere il tasto della irriducibilità tra i due fattori in campo (Islam vs.
democrazia). A consolidare questo refrain si sono poi aggiunti una serie
di attentati terroristici in alcuni paesi europei, dai quali in molti – specie leader
di movimenti politici di estrema destra, o comunque populisti e neo-sovranisti –
hanno tratto l’assunto schematico Islam = terrorismo. Quella che va sotto il
nome di islamofobia non è altro che la materializzazione del teorema
appena enunciato, che ostacola, attraverso vari strumenti (politici, sociali,
giuridici, etc.) la costruzione di uno spazio pubblico aperto anche ai
musulmani (il progetto di un Islam europeo), il cui contributo in
termini culturali ed economici può anche non essere strumentalmente colto nella
sua valenza positiva, ma resta invece chiaro a quanti, animati da buone
intenzioni, lavorano fianco a fianco con le organizzazioni islamiche per la
costruzione di una società tollerante e inclusiva.
La cosa sorprendente è che questo “grande ossimoro”
(Islam vs. democrazia) continui a raccogliere ampio sostegno anche all’interno
dei circuiti culturali liberal-progressisti[7].
Riecheggia, dagli Stati Uniti fino all’Europa, l’esperienza del teorema neo-conservatore
americano, quel serbatoio di pensiero, imbastito da ex intellettuali di sinistra,
che ha legittimato, con argomentazioni anche argute e una buona attività di lobbying
posta in essere fino ai vertici della casa Bianca, la necessità di implementare
(sia in ambito domestico che internazionale) scelte politiche focalizzate sul
primato americano nella scena politica internazionale e, dunque, chiaramente
anti-islamiche[8].
Ecco, dunque, il dilemma: come si fa a costruire
un’arena internazionale aperta al contributo di tutti senza “appropriarsi” di
Dio? Senza cioè declinare la religione in chiave nazionalistica (modello “religione
civile” stile USA post-11 settembre) oppure come risorsa di senso avente lo
scopo di onorare la memoria del passato (imbalsamandola) e orientare (ideologicamente)
la storia?[9]
Una inversione di rotta così radicale (che significa
capovolgere il seguente paradigma: dalla religione immersa nel linguaggio
politico – che si fa istituzione e potere – alla religione come fatto
sociale che si offre al mondo) può condurre a due opposti approdi.
Per alcuni, potrebbe significare dover disperdere la
religione in qualcosa di riflessivo, in qualcosa cioè che “accompagna” il discernimento
ma che non si impone in modo “verticale” sull’esistenza umana (modello religioso-confessionale).
Questa modalità esplicativa permetterebbe di evitare gli errori del passato,
quando la religione “sorpassava” la dimensione del politico imponendo il suo
dogma, erga omnes. Per altri, invece, la religione andrebbe “recuperata”
innanzitutto come componente costitutiva della socialità, cioè in quanto fattore
inevitabilmente “reale” (dunque anche sotto il profilo organizzativo, ma non nella
versione confessionale), tenuto conto del fatto che mai come in questa fase
storica il fattore religioso sembra trovare sempre più spazio «[nei] corpi, [nel]le
pratiche (…) [e in] precisi luoghi sulla terra»[10].
La religione, quindi, intesa come fattore integrativo dell’esperienza umana che
“accompagna” l’esistenza del soggetto-persona e lo conforta nei momenti più
difficili della sua esistenza[11].
Di fronte a questo “conflitto” politico-religioso –
che spazia dalla dimensione nazionale a quella internazionale e che chiama in
causa soggetti diversi, afferenti non solo alla dimensione organizzata dei
culti ma pure alla società nella sua declinazione orizzontale – è legittimo indagare
quali sono le trasformazioni in corso sia all’interno del discorso politico che
di quello religioso. Su questo secondo fronte, indubbiamente l’avvento di Papa
Francesco rappresenta una delle novità più importanti. Partendo dal modo come egli
si approccia alla diversità (culturale e religiosa), specie quella più esposta
al rischio dell’intolleranza, è possibile raccogliere alcuni punti fermi, che
lasciano intravedere la costruzione di un modello di confronto con l’alterità
destinato ad integrare, più in generale, la costruenda nuova governance della
cittadinanza interculturale[12]. Quella di Bergoglio, allora, sembra essere una mano
tesa verso chi lavora alla costruzione di ponti e non all’innalzamento di muri.
E questo non può non essere motivo di contrasto prima di tutto con il
Presidente degli Stati Uniti Trump. Bergoglio [infatti] si colloca agli
antipodi, innanzitutto «psicologicamente [,] rispetto all’attuale inquilino della
Casa Bianca»[13]
il cui «muscoloso unilateralismo»[14]
non trova accoglienza all’interno del palazzo di vetro delle Nazioni Unite, né a
Santa Marta.
A costruire la giusta trama discorsiva attorno
alla “politica” religiosa di Bergoglio provvede l’Autore del libro, abile a
muoversi tra le pieghe del mito, specie quando rinvia ai «significati concreti
e simbolici»[15], contenuti
in un’opere come l’Odissea, che ci aiuta a comprendere la forza devastante – in
un clima sociale frammentato – che può scaturire da una distorta percezione della
diversità culturale[16].
Secondo Rossi, un sentiero praticabile per costruire una “coscienza globale” potrebbe
consistere nel sostenere lo stile diplomatico «di Francesco, che utilizza un
nuovo linguaggio, che risponde all’indole francescana e gesuitica fatta di
comunicazione diretta»[17].
A questo modus operandi del Papa, Rossi dedica una parte importante del
libro (la prima). Un passaggio, tra i tanti, colpisce il lettore:
«L’unica alternativa per realizzare un
equilibrio condiviso e armonioso, presuppone la pratica di una politica improntata
alla strategica fiducia, in alternativa a sterili e distruttive minacce, cioè
il soft power secondo la logica della diplomazia multilaterale»[18].
Quando Bergoglio usa l’espressione “Terza Guerra Mondiale
a pezzi”, ha chiaro il contributo che le religioni possono offrire «nell’attuale
contesto internazionale»[19].
Il fattore “R” (come lo chiama Rossi), allora, non solo non può essere
escluso dal circuito delle relazioni internazionali (perché si tratta di un
attore di prima grandezza, in primis sotto il profilo storico e sociale,
e perché grazie al contributo delle chiese e delle loro organizzazioni
periferiche in diverse parti del mondo la fiammella della speranza resta ancora
accesa), ma deve essere «trasformato in vincente strumento di soft power»[20].
Ovviamente, questo “ri-adattamento” al nuovo ordine delle cose, ha bisogno di
trovare il consenso e il sostegno di tutta la struttura ecclesiastica. Si
tratta, nelle intenzioni del Papa, di abbandonare il modello novecentesco delle
relazioni di vertice[21]
e di passare ad un sistema di presenza diffusa nelle pieghe della sofferenza,
testimoniando la fede e agendo fianco a fianco alle istituzioni civili. La dimensione
confessionale non può continuare ad essere ritenuta come prevalente fino a
schiacciare (e anche mortificare) le tante esperienze di solidarietà
orizzontale praticate su scala planetaria. Non cogliere le potenzialità di una “nuova
Chiesa” significa – sulla scia di Bergoglio – tradire il patto col Vangelo, far
percepire ai fedeli che la distanza con le gerarchie può rappresentare un
problema nel percorso di testimonianza e marginalizzare l’opera di tutte quelle
realtà attive nello spazio pubblico (le periferie del mondo) costituzionalmente
riconosciute (art. 118, ult. co.).
La trama della solidarietà è l’opera più
importante a cui il Papa ha deciso di dedicare la sua missione pontificale. È una
sfida di grado molto elevato, che soltanto adesso inizia a raccogliere l’attenzione
che merita e a trovare condivisione all’interno della Chiesa. Scoraggiare (rectius:
umiliare), perciò, tutte queste energie ancora in ordine sparso che attendono
di essere ricondotte ad unità, vorrebbe dire assestare un duro colpo alla
Chiesa-comunità e arrecare un danno enorme alla società, non ultimo, in termini
economici. Perché laddove lo Stato non riesce più ad arrivare[22]
– per carenze strutturali (detto in modo sintetico) – può farcela la società
civile organizzata (all’interno della quale sono comprese anche le diverse espressioni
del solidarismo cattolico e delle altre organizzazioni religiose) [23].
La trasversalità a cui ho fatto riferimento (sia
orizzontale che verticale) è allora uno dei cambiamenti più significativi di
fronte ai quali ci troviamo. Ma non pensiamo che sia “senza radici”, che non
abbia collegamenti con nessuna esperienza del passato, che sia frutto di un “esperimento
in vitro” in corso di approntamento e che richieda ancora del tempo per essere testato.
Intendo dire che, se Papa Francesco ha saputo catalizzare l’attenzione su di sé,
azionando una comunicazione degna di un qualsiasi grande protagonista della
storia, questo non toglie che, sfogliando le pagine del passato non sia
possibile trovare alcun riferimento circa il modo come le religioni sono state
capaci di contribuire alla costruzione di nuovi paradigmi di governo della
società (specie in posti di frontiera). Papa Francesco e la sua Chiesa sono
solo gli ultimi esempi di partecipazione alla costruzione di un nuovo sistema
di relazioni umane e politiche della contemporaneità. E insieme a loro, anche
altri attori afferenti alla galassia religiosa[24].
Rossi, da storico, non si lascia sfuggire l’occasione
per puntualizzare alcuni aspetti che possono aiutare la comprensione del
fenomeno in oggetto. Chiama perciò in causa addirittura i Padri fondatori della
democrazia americana[25],
che sebbene in larga misura deisti o scettici:
«non hanno mai dubitato del fatto che la
religione fosse una componente significativa dell’ordine sociale perché parte
essenziale dell’ordine morale»[26].
L’argomento trova ampia trattazione nel secondo
capitolo, dove si approfondisce il modo come le religioni, nelle diverse parti
del mondo, hanno influito sulle scelte di natura politica, e il modo come il
potere politico ha stabilito “rapporti” con questi importanti attori sociali. Si
tratta di una parte dell’opera dove l’Autore spiega, innanzitutto, come la
Chiesa ha impostato storicamente il suo ruolo nell’arena dei soggetti politici
internazionali. Da qui, una meticolosa ricognizione sul metodo adottato dalla
Chiesa cattolica (rectius: la diplomazia vaticana) durante il “lungo
Novecento” a difesa della cristianità e della pace. Una ricognizione che prende
in considerazione, tra i diversi strumenti a disposizione, alcune importanti encicliche
papali inquadrate come strumenti di diffusione di pratiche di smart power[27].
E così scopriamo la Mater et Magistra di Giovanni XXIII (1961), sulla “visione
planetaria della questione sociale”, la Populorum Progressio di Paolo VI
(1967), sullo “sviluppo umano di tutti i popoli”, la Sollecitudo rei socialis
di Giovanni Paolo II (1987) sulla solidarietà come strumento di umanità
universale, fino alla Caritas in Veritate di Benedetto XVI (2009) sulle
nuove prospettive dell’umanità tra mercato, verità e solidarietà. Quest’ultima
enciclica, in particolare, si presta – anche per ragioni temporali – a meglio aiutarci
a comprendere quanto e come, quello strumento “raffinato” rappresentato dalla fede
riesca a misurarsi rispetto alle problematiche del tempo attuale. Problematiche
che richiedono un approccio pragmatico, e dunque una fede sorretta da ferma ragione,
per non smarrirsi nel vortice del “rapimento” fine a sé stesso. È chiaro che un
criterio del genere, non solo si presta a stabilire migliori canali di
interazione tra mondi diversi (scienza e fede, per esempio), ma anche ad
allargare la platea dei soggetti a base religiosa desiderosi di contribuire col
proprio apparato di credenze agli svolgimenti dei fatti sociali[28].
3. Non sappiamo se Papa Francesco riuscirà a
condurre la Chiesa verso una «nuova Primavera»[29];
di certo, una serie di condizioni materiali sembrando indicare che questo
processo è in atto, ma la Chiesa è una società complessa, e con questa “complessità”
il pontefice si sta confrontando (non senza problemi), sapendo bene di godere
del sostegno di buona parte del “popolo di Dio” (e dell’episcopato), ma pure di
avere diversi nemici interni (ed esterni). Avendo “cura” di queste difficoltà
– e dunque guidando con benevolenza e decisione il suo gregge lungo il sentiero
della normalizzazione – Bergoglio prova a legare in sequenza nuove determinazioni
teologico-dottrinarie (sfida complessa) e nuove interpretazioni giuridiche e
liturgico-pastorali. Da quanto abbiamo appreso in questi anni di pontificato,
Bergoglio vuole una Chiesa adesiva ai valori del Concilio Vaticano II. In lui è
forte l’elemento della “relazione” tra la dimensione istituzionale della Chiesa
e la base dei fedeli: questo significa riconoscere a tutti i credenti la
possibilità di partecipare alla vita della Chiesa. Contemporaneamente immagina
di riconsiderare il momento dell’autorità “al servizio” della Comunità,
riconoscendo certamente la sua funzione essenziale ma all’interno di un
perimetro strutturato in forma più orizzontale.
Si tratta di una prospettiva indubbiamente fascinosa,
specie per chi guarda all’azione di Papa Francesco con occhio cooperativo e non
si lascia impressionare dalla supremazia dell’apparato di potere della Chiesa
(elemento ancora forte, specie in certi ambienti filo-curiali). Da punto di
vista, poi, di chi studia le relazioni internazionali, questa evidenza si concretizza
nei termini di in piano a cerchi concentrici che vedono, appunto, il Pontefice provare
a mettere in sintonia quanto accade in Europa rispetto a quanto accade oltre oltreoceano
(USA), in Ameria Latina, e nel Sud-est asiatico. Bergoglio teme il ritorno del dei
nazionalismi al pari dell’avanzare della povertà e della concentrazione delle
ricchezze nelle mani di poche persone. Si batte per la difesa delle radici
cristiane in Europa, ma ritiene altrettanto importante implementare lo sforzo
anche nella difesa dei diritti e delle libertà ovunque calpestati. La sua è una
metodologia ad ampio raggio, che non ammette gerarchie né corsie preferenziali
(intra ed extra Ecclesiam). Il primato del Vangelo è ciò che gli
interessa interamente; il resto (relazioni, regole, prassi, etc.) serve solo a
integrare questa premessa necessaria, che affascina anche persone e organizzazioni
non religiose, perché declinata sul primato della persona e sulla funzione
servente degli apparati di potere. È, il suo – in buona sintesi – un progetto
di convergenza della Chiesa sulla società contemporanea, che pero richiede
gesuitico discernimento. Ovviamente, la convergenza su cui Bergoglio sta
lavorando rappresenta per molti cattolici non-tradizionalisti una
speranza, perché significa che la Chiesa – pur attraversata da tanti problemi
(alcuni dei quali anche gravi) – prova a cambiare la società, cambiando essa
stessa. Da qui la sottolineatura di Luigi Rossi quando scrive che Francesco non
pone “condizioni” nel suo modo di comunicare, e che «solo chi è in malafede può
proporre una lettura eretica dei suoi messaggi»[30]
.
3.1. Bergoglio ha deciso di immergersi nel corpo vivo
di una «umanità in disfacimento»[31]
che però prende per mano proponendo una “lettura” della fede per nulla “credulona”
– una fede che mortifica il Tommaso contemporaneo[32]
–, bensì “fiduciosa”, capace di orientare senza togliere la libertà (che
è libertà di cercare la verità)[33].
Al Papa gesuita non importa (o non sembra importare) tanto il modo come la
Chiesa appare dal punto di vista istituzionale (questo non è indubbiamente
un profilo secondario, ma nella narrazione di Bergoglio resta più sullo sfondo),
quanto piuttosto il coraggio che dimostra nel saper tenere «la porta sempre
spalancata»[34], nel
provare a riconciliare l’umanità nella sua diversità (l’archetipo della trinità
come amore plurale che abbraccia la vita in tutte le sue forme)[35].
Si tratta di un messaggio dirompente perché alla base
c’è un grande anelito verso l’unità che si contrappone alle divisioni (le
verità, potremmo dire con linguaggio laico – che convergono verso un unico percorso
di salvezza, per tutti).
Scrive L. Rossi, parafrasando un passo del vangelo
di Luca:
«Dio non guarda al peccato, ma valuta
sofferenze e bisogni (…). La storia della salvezza [realizzata da Gesù col
suo sommo sacrificio] non prevede esclusioni, separazioni, respingimenti”
(187). Il “Regni di Dio procede sempre per inclusioni»[36].
De resto, se il primo ad entrare nel Regno di Dio
è «un uomo dalla vita sbagliata»[37]
– il malfattore che sulla croce cerca lo sguardo di Gesù e lo implora dicendogli
“ricordati di me” – allora capiamo quanto il messaggio di Bergoglio sia
tutto concentrato sulla prospettiva di Dio, sulla «solidarietà tra Dio e l’uomo»[38],
sulla fiducia, sul senso di responsabilità, sulla generosa costruzione di una
quotidianità che non distoglie lo sguardo dall’umanità (dal contesto dove
ciascuno di noi opera), che chiama all’impegno; dunque alla misericordia;
quel sentimento di intima commozione, scrive l’Autore, che genera
compassione, pietas e nello stesso tempo azione, impegno civile,
studio, doveri.
La cosa sorprendente, ascoltando Papa Francesco, è
vedere con quale pacatezza egli inviti tutti i credenti ad intraprendere una
sorta di pellegrinaggio interiore, a meditare sul significato dell’umano in
relazione con la società; una società dove sembra mancare la direzione, ma
pure il progetto comune. Ed ecco allora la preoccupazione per una Chiesa
che Bergoglio vuole impegnata a ritrovare la sua collocazione nel mondo (partendo
dall’angolo dietro casa), a farsi povera per entrare nuovamente in sintonia con
la sofferenza del genere umano, senza però smarrire il suo ruolo di “orientamento”
nello spazio pubblico e nelle dinamiche internazionali; a fungere da faro, da
punto di riferimento per quanti (cittadini e istituzioni) sono impegnati nella
costruzione di un nuovo ordine politico democratico.
Ma l’esempio di Papa Francesco ha bisogno di
testimoni coraggiosi. Perché questo è un papa difficilmente “catturabile”. Lo
sanno bene i cattolici conservatori (la lobby tradizionalista, direbbe
qualcuno). E il libro di Luigi Rossi non tradisce le aspettative. Rossi è concreto
come Bergoglio. È consapevole sia della cultura politica latinoamericana (del suo
peso nell’ecumene delle relazioni internazionali) sia del progetto
politico-ecclesiastico del Papa gesuita, della sua “radicalità”. Bergoglio,
scrive Rossi, vuole «ritornare alla sorgente della fede (…), liberandosi della
formalità (…) che certi moralisti tartufi pretendono d’imporre»[39]
e lavorare alla ricomposizione di una «Chiesa policentrica»[40],
una Chiesa aperta al dialogo, che rompe gli steccati e rinnova il proprio linguaggio,
che invita i battezzati a sentirsi protagonisti di questa impresa, una Chiesa
che «deve riscoprire le potenzialità della propria creatività missionaria mettendo
da parte il lamento sterile, generato da tentativi di autodifesa»[41].
Questa chiamata in sussidiarietà del popolo
di Dio – e di tutte le soggettività operanti nello spazio pubblico – presuppone
che la Chiesa-organizzazione si dichiari più vicina alle problematiche morali e
sociali; e dunque: «decentramento di alcune competenze alle chiese nazionali»[42]
e nuovo modo di intendere il primato petrino, declinato in senso “collegiale”, capace,
cioè, «come un cantiere sempre aperto»[43],
di valorizzare «gli episcopati nel discernimento di tutte le problematiche dei
loro territori»[44].
Insomma, una buona “cura dimagrante” per le strutture burocratiche romane «appesantite
[scrive l’Autore]
da una prassi che determina disfunzioni e allontana i vertici
della Chiesa dalla pratica di una visibile e credibile povertà, in grado di
favorire la definitiva opzione per i poveri»[45].
Da qui anche l’accento che il Papa pone ad “una riforma finanziaria che non
ignori l’etica”.
3.2. C’è un aspetto, poi, nel libro di Rossi – che
potremmo definire di diritto pubblico-ecclesiastico – che secondo me merita di
esser adeguatamente sottolineato. Mi riferisco al tema della sana cooperatio
come strumento di raccordo virtuoso tra dimensioni parallele: da un lato, la
società civile e le sue istituzioni pubbliche (dunque lo stato, nelle sue diverse
declinazioni anche ordinamentali e dunque multilevel), dall’altro la
Chiesa (anch’è essa vista come soggetto multiforme). Ebbene, l’art. 1 dell’Accordo
di modificazione del Concordato lateranense (legge n. 121/1985) parla esplicitamente
di «reciproca collaborazione [tra Italia e Santa Sede] per la promozione
dell’uomo e il bene del paese», e Rossi sottolinea il grande auspicio di Papa
Francesco affinché si venga a determinare una “convergenza” (tra sfera pubblica
e sfera religiosa, apparati politici e apparati ecclesiastici) su “azioni”
comuni aventi lo scopo di “trasformare la mentalità”, a partire da chi gestisce
il potere (quello economico in primis). A differenza del passato, quando
i due “ordini” (art. 7, comma 1 Cost.) si confrontavano (e si scontravano) quasi
sempre per logiche di potere (il timore era quello di perdere consenso e “presa”
sulla società), oggi, con l’avvento di Francesco, sembra possa finalmente maturare
una volontà generale diretta a farsi carico delle sorti dell’umanità – e dei problemi
pratici che la affliggono – cedendo, entrambi i fronti (quello civile e quello
religioso) quote della propria sovranità per il bene comune[46].
Un esempio calzante ce lo offre la questione ecologica,
sulla quale Papa Francesco incalza gli stati e raccoglie consensi ampi, capace
com’è di proporre una rinnovata narrazione antropologica in direzione contraria
rispetto alle «forme di potere condizionate dalla tecnologia»[47].
Su questo aspetto aggiungo solo che, rispetto al tempo in cui anche l’ecologia
era stata sfigurata dal vortice delle ideologie, oggi, con la presa in carico
del tema da parte di Papa Francesco (ma anche grazie al protagonismo di altri
soggetti capaci di imporsi all’attenzione dei media e dei poteri sovrastatali) il
problema del modo come «avere cura della casa comune, la Terra, nostra sorella
e madre»[48]
acquista una centralità politica che va al di là di ogni previsione. Anche in
questo caso, Rossi ricorre allo strumento dell’enciclica sfogliando Laudato
sì (2015), dove il Papa «invita a riflettere, senza innalzare steccati
ideologici»[49]. Questa
premessa è la forza del pensiero del Papa perché egli riesce dove altri
hanno fallito: rivolgersi a tutti (credenti e non) per valorizzare la responsabilità
di ciascuno. In continuità con i suoi predecessori, il pontefice utilizza
questo tema sia per valorizzare la dimensione collegiale intra Ecclesiam,
sia per allargare il raggio d’azione del suo pensiero costruendo una narrazione
politica: la costruzione di un idem sentire aperto alla meraviglia del creato.
Laudato sì è, perciò, una Enciclica assolutamente “sociale”, perché la
crisi che ci investe è socio-ambientale e richiede un approccio “integrale”[50].
4. Papa Bergoglio è un autentico figlio dell’altro
Occidente perché incarna al meglio la radicalità carismatica verso «le creature
e le cose»[51],
che è un tratto tipico della cultura latino-americana. Questo lo spinge a non
trascurare un fattore determinante di quella tradizione: l’amore per la natura
che si sposa con la società e le sue complesse articolazioni. Questa
sensibilità antropologica verso il creato, lo mette automaticamente più in
sintonia con quei sistemi politico-istituzionali che hanno “costituzionalizzato”
la dimensione del buen vivir – l’idea di una forma di vita in armonia
con la natura –(es. Ecuador e Bolivia) che, collegata al principio di
relazionalità «portano inevitabilmente all’affermazione di nuove forme di
partecipazione popolare e[a] nuove forme di governo e così [ad un] nuevo
constitucionalismo»[52].
Correttamente Rossi parla di «intima relazione fra i poveri e la fragilità del
pianeta»[53]. Una
relazione ontologica incentrata sulla “ricerca del senso”, dunque, intrinsecamente
solidaristica[54].
Questa ampiezza di visione, il Pontefice la radica
nella «sacralità della natura»[55]
per poi indirizzarla verso la condanna esplicita di qualsiasi logica di sfruttamento
dell’uomo sull’uomo, e del capitalismo finanziario che non garantisce uguali
opportunità perché provoca disuguaglianze e ingiustizie[56].
Siamo al cospetto di una trama che si dispiega lentamente ma inesorabilmente, perché
ha chiaro l’obiettivo e gli strumenti d’azione. Una trama all’interno della
quale uno dei nodi principali è il destino della Chiesa che il Papa vuole, per
un verso, de-clericarizzata – meno attenta a soddisfare l’ego dei singoli chierici
– e nello stesso tempo fortemente impegnata a dismettere l’antica pratica di “scambiarsi
la veste” col potere politico per finalità esclusivamente egemoniche. A seguire
vengono i giovani: la categoria sociale più a rischio perchè più facilmente condizionabile
dal fascino del denaro. Per Bergoglio, scrive Rossi, ai giovani bisogna
insegnare
«a pensare criticamente, superando i localismi
e affrontando i problemi mondiali con la consapevolezza di essere cittadini del
mondo, in grado quindi di specchiarsi negli altri con simpatetica
predisposizione»[57].
E infine, il ruolo dei laici nella chiesa del
nuovo secolo. Bergoglio vorrebbe una società all’interno della quale il laicato
diventi protagonista attento e attivo (fare politica è importante), anche a
costo di mettersi contro una certa «egemonia clericale»[58];
una “Chiesa in uscita”, capace cioè di rompere con le vecchie logiche centralistiche
e aperta al mondo, con le sue contraddizioni e le sue speranze. Rossi scrive che
«non bisogna aver paura della propensione a una radicale revisione
teologico-canonica»[59]
e aggiunge che questa profonda rigenerazione si inquadra nell’originale
approccio di Francesco alla geopolitica, riassumibile nella trama relazionale
del messaggio evangelico, irriducibile alle posizioni apicali e convergente sul
bene dell’umanità.
Nessuno, allora, dovrà sentirsi “lo scarto del mondo”
perché tutti sono necessari per costruire quel progetto “armonico” che già Paolo
VI riteneva essenziale. Il carisma di Bergoglio non sfugge certamente a Rossi, che
parla del Papa come del «primo nunzio della Santa Sede»[60],
enumerando alcune tra le più delicate vertenze internazionali verso le quali il
Papa ha già indirizzato l’attenzione; questo «anche a costo d’incomprensioni da
parte di chiese locali gelose della vita interna e attente a privilegiare lo
spazio clericale o specifiche concezioni etnico-politiche»[61].
A tutto questo, l’Autore aggiunge l’attenzione del
Pontefice verso le problematiche del sud del mondo, verso le tensioni che
attraversano la non ancora completa unità politica dell’Europa, verso il metodo
del dialogo interreligioso (unico antidoto al radicalismo falsamente ammantato
dalla fede) e in direzione dei rapporti con la Cina, gli Stati Uniti, la
Turchia, l’Egitto e la Russia (per citare gli attori più rilevanti). Tutti fronti
complessi, in buona parte in via di svolgimento.
Siamo nel pieno di una navigazione che non riesce ancora
a scrutare l’approdo finale. Ma forse Francesco ha ben in mente dove e come
arrivare. Di certo la sua missione terrena continuerà a offrirci occasioni
preziose da cogliere se vogliamo provare a cambiare le sorti dell’umanità e con
esse quelle delle comunità. Se c’è una cosa che il Papa argentino non è
disposto a lasciare in secondo piano questa è rinvigorire «la fecondità della
cattolicità romana»[62]
nello spazio scalpitante (e sofferente) della globalizzazione. E gli stati farebbero
bene a condividere alcune delle sue politiche, tenuto conto del fallimento
definitivo di vecchi modelli di governance delle relazioni internazionali.
[1] Sullo sfondo si posiziona la posizione di alcuni
critici del sistema-ONU. Ricordo in particolare la tesi di C. Rocca (oggi
direttore de Il Foglio), Contro l’ONU. Il fallimento delle Nazioni
Unite e la formidabile idea di un’alleanza tra le democrazie, Torino, 2005,
secondo cui l’alternativa a questo “fallimento” consisterebbe nel progettare un’alleanza
tra le democrazie avente il «compito di rimuovere gli ostacoli che i regimi
dittatoriali frappongono alla democrazia e al rispetto dei diritti umani».
[2] Tra i primi a sostenere la tesi, certamente F.
Fukuyama, Esportare la democrazia. State-building e ordine mondiale nel XXI
secolo, Torino, 2005.
[3] La politica c.d. dei respingimenti (v. il caso
italiano), i provvedimenti di natura giuridica aventi ad oggetto la messa in
sicurezza dei confini nazionali messi in pericolo dalle “invasioni” di immigrati
clandestini (in violazione della normativa internazionale, come specificato da recente
giurisprudenza), la comunicazione politica costruita ad arte “a ridosso” di
questa tipologia particolare di messaggio (c.d. sovran-populista), etc. rappresentano
il tentativo di replicare, su scala nazionale, la logica egemonica diffusa ad ampio
raggio da vecchi e nuovi protagonisti della scena planetaria (es.: il sogno di
un nuovo “califfato”, la grande madre Russia, il motto “America first”, etc.).
[4] D. della Porta, Democrazie, Bologna, 2011.
[5] L. Rossi, La geopolitica di Francesco.
Missione per l’ecumene cristiano, Francesco D’Amato editore, 2019, p. 65.
[6] A. Benazzo, Il dibattito su terrorismo,
democrazia ed emergenza dopo l’11 settembre, in Percorsi Costituzionali,
1/2008, pp. 127-136. Alla luce dei recenti fatti legati alla diffusione del virus
Covid-19 si impone una riflessione più ampia attorno alla categoria della
sicurezza che includa anche le tematiche ambientali, di salute pubblica e del “nuovo”
ordine pubblico ad esse conseguenziali.
[7] Molte realtà del nord-Europa, certamente non di
destra, si sono lasciate infatuare dal ragionamento sovranista, della necessità
cioè di non poter più essere (ridotto all’osso!) “tolleranti con gli
intolleranti”. Mai come nel caso dei musulmani gli schematismi funzionano bene,
purtroppo … e producono disastri! Da qui, l’affermazione, anche importante, di
molte opere letterarie, aventi come nucleo centrale del ragionamento la “presa
del potere” da parte di partiti politici di ispirazione islamica con i quali
dover scendere a patti per non mettere a rischio la civiltà europea. Ha fatto
scalpore il romando di M. Houellebecq, Sottomissione, Milano, 2015. Sul modo
invece come la sinistra europea guarda verso la tematica islamica, si rinvia,
tra i tanti, a O. Roy, L’Europa è ancora cristiana? Cosa resta delle nostre
radici religiose, Milano, 2019.
[8] Fra i tanti, F. Felice, Prospettiva “neocon”. Capitalismo,
democrazia, valori nel mondo unipolare, Soveria Mannelli, 2005.
[9] Prendo in prestito la frase dal libro di E. Gentile,
La democrazia di Dio. La religione americana nell’era dell’impero e del
terrore, Roma-Bari, 2006, p. 185, tra i migliori a saper descrivere il
ruolo della religione negli Stati Uniti dopo l’11 settembre.
[10] J.S. Jensen, Che cosa è la religione?,
Roma, 2018, p. 236 (il corsivo è dell’Autore).
[11] In questa ipotesi, religione e spiritualità è
come se viaggiassero sullo stesso treno; pur avendo parti costitutive diverse,
entrambe agiscono “a supporto” della ricerca di senso da parte dell’uomo. Una
società, in grado di procedere per assemblaggi virtuosi tra le diverse realtà che
la compongono, ne guadagnerebbe in termini di tenuta generale. Ovviamente, all’interno
dei diversi contesti geografici e politico-sociali, il modello può facilmente
trovare resistenze da parte delle organizzazioni religiose (o delle tradizioni
spirituali) di più antico radicamento, che si vedono accomunate ad altre
esperienze (non autoctone) a dispetto di una “memoria” che per loro “deve”
conservare la stessa matrice. Sul modo
come le religioni storiche reagiscono di fronte al tentativo da parte dell’Unione
europea di considerare tutti i sistemi di credenza equiparati dal punto di
visto giuridico, mi permetto di rinviare a G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Diritto
civile e religioni, Roma-Bari, 2013, p. 87.
[12] Icasticamente, L. Rossi, op. cit., p. 28, scrive:
«Che fare dello straniero?» (mio il corsivo).
[13] L. Rossi, op. cit., pp. 239-240.
[14] L. Rossi, op. cit., p. 271.
[15] L. Rossi, op. cit., p. 8.
[16] Rinvio a M. Ricca, Polifemo. La cecità dello
straniero, Palermo, 2011, p. 18, che ci guida a “scoprire” l’alterità e le
modalità attraverso le quali si è chiamati a organizzare l’incontro con l’altro.
«L’Odissea [scrive l’Autore] è una gigantesca
grammatica dell’incontro con l’estraneo (…). Come una profezia, la parabola
delle avventure di Ulisse potrebbe mostrarci l’esito di un relazionarsi con l’Alterità
che ci fa divenire estranei a noi stessi (…). Nell’episodio di Polifemo [in particolare],
narrato nel IX libro del poema, è racchiusa però la chiave narrativa di tutta l’epopea.
È quello, l’antro del Ciclope, il luogo immaginario dove Omero orchestra il
lato oscuro dell’essere ospite, la tragedia e il terrore dell’inaccoglienza,
del trovarsi indifesi e vulnerabili in terra straniera».
[17] L. Rossi, op. cit., p. 286.
[18] L. Rossi, op. cit., pp. 58-59.
[19] L. Rossi, op. cit., p. 69.
[20] L. Rossi, op. cit., p. 71. Si rinvia, per alcuni
aspetti più recenti legati al modo come Papa Francesco lavora per costruire una
nuova diplomazia della pace e del dialogo a M. Ventura, Il destino della
libertà religiosa, in La Lettura – “Corriere della Sera”, 1° marzo
2020, pp. 8-9.
[21] G. Zagrebelsky, Scambiarsi la veste. Stato e
Chiesa al governo dell’uomo, Roma-Bari, 2010.
[22] Pensiamo ai costi dei diritti sociali,
elevatissimi (e agli scarsi investimenti). La parabola della crisi economica
(2008 in poi) ha assestato un duro colpo a questa peculiare categoria di
diritti. Oggi, mentre scriviamo questo testo, si aggiunge l’emergenza “Coronavirus”,
destinata a far ripiombare il mondo nella paura e nell’incertezza. Servirà un
grande sforzo collettivo, passata l’emergenza, per riannodare i fili della solidarietà
e questo momento chiamerà in gioco sicuramente le organizzazioni internazionali
e gli Stati, ma pure le tante comunità religiose (a-religiose), spirituali e filosofiche
ovunque sparse. Il papa, ha già puntato l’obiettivo sul futuro e non sembra affatto
intenzionato ad abbandonare la presa. Con questa “caparbietà bergogliana”
dovranno confrontarsi (e scendere a patti) sia gli stati, sia le strutture del
potere ecclesiastico.
[23] È importante sottolineare il contributo di tante
chiese e comunità religiose, cristiane e non, nel complesso spazio della società
globale e multiculturale. Il fronte della solidarietà non è più “sotto il
controllo” esclusivo delle organizzazioni cattoliche, ma spazia all’interno di
una variegata offerta che si caratterizza per essere altamente affidabile e
meritevole di gratitudine. Un contributo a questo grande afflato caritatevole è
stato indubbiamente offerto dallo strumento del dialogo interreligioso. Smussando
antichi pregiudizi, l’incontro, nel rispetto delle diversità, fra religioni
diverse, diventa fonte di conoscenza e arricchimento reciproci, ma pure esercizio
di libertà e condivisione di progetti. Mai come adesso si sente forte la spinta
a cooperare tra esperienze religiose diverse.
[24] Se consideriamo il lavoro sui temi della pace,
del dialogo interreligioso (citato), della solidarietà, etc., i numeri sono tali
da poter dire con assoluta certezza che la partecipazione è massiccia e in molti
casi decisiva. Le organizzazioni che esprimo “sul campo” l’azione politica
delle istituzioni religiose si rivela fondamentale e in alcuni casi risolutiva
per il ripristino della normalità oppure per la messa in cantiere di percorsi
di appeasement all’interno di zone ad alto grado di conflittualità.
[25] La citazione a Tocqueville è praticamente
scontata. G. Buttà, The First Liberty. Politica e religione nell’età della formazione degli Stati Uniti d’America, in M. Tedeschi (a cura di), La libertà religiosa,
Tomo II, Soveria Mannelli, 2002, pp. 467-468, prendendo in prestito le parole
del pensatore francese, ben rimarca che: «Fin da principio, in America, la politica e la
religione si trovarono d’accordo e, in seguito, non hanno mai cessato di
esserlo. [Per poi aggiungere che] i Padri Pellegrini avevano stabilito nel
Nuovo Mondo un Cristianesimo (…) democratico e repubblicano che coglieva la
coessenzialità, quasi la complicità, della religione con la democrazia, e l’assenza
in America della resistenza delle Chiese, in particolare di quella cattolica, a
quel passo grande e necessario della società umana verso la democrazia, passo
preparato dai disegni stessi di Dio».
[26] L. Rossi, op. cit., p. 81, nota 124.
[27] L. Rossi, op. cit., p. 132 ss. Si tratta
di un materiale – quello delle encicliche – di grande valore socio-politico perché
aiuta a comprendere come, in un determinato momento storico e in particolari condizioni
sociali e politiche, un pontefice decide, di concerto con la sua Curia, di
affrontare un tema specifico e di “offrirlo” ai credenti e non solo. Ecco perché,
proprio in ragione di questo approccio ampio e trasversale, le encicliche vanno
studiate per quello che riescono a dire innanzitutto al cuore delle persone,
prima ancora che ai diretti interessati. Il loro afflato “politico” è dunque
inestimabile. Mi permetto di rinviare a G. Macrì, I rapporti Stato-Chiesa nell’evoluzione
della forma di Stato (1848-1871), Lancusi (SA), 2000, pp. 26 ss., dove ho affrontato
l’uso da parte della Chiesa delle encicliche quale arma ideologica per orientare
le masse contro quelle che, nei primi anni dell’800, venivano senza mezzi
termini definite “nuove eresie” (democratismo, liberalismo, comunismo, etc.). Ma
parliamo, appunto, di un’altra epoca.
[28] Un metodo del genere, per funzionare, a mio
parere, deve partire dal presupposto che nessuna fede (o sistema di credenze)
può vantare posizioni di supremazia rispetto agli altri. E dunque, per funzionare
concretamente, per essere cioè “utile” alla società e contribuire al miglioramento
delle relazioni pubbliche, avrà bisogno di un perimetro civile ampio e flessibile
connotato in senso laico. La laicità, allora, ritorna ad essere il
fulcro dello spazio politico democratico e pluralista. Una condizione
necessaria, che non richiede alcun imprimatur “esterno”, solo quello
della certificazione del primato della politica.
[29] L. Rossi, op. cit., p. 151.
[30] L. Rossi, op. cit., p. 167.
[31] L. Rossi, op. cit., p. 171.
[32] Scrive L. Rossi, op. cit., p. 173: «Come
discepolo Tommaso rimane vicino nonostante la distanza delle idee, ma la
crocifissione e la morte costituiscono una delusione per le sue speranze,
reagisce in nome della ragione contro le pretese di una fede evidentemente
credulona, che ritiene reale un fatto così distante da ogni prospettiva di
umana razionalità».
[33] Mi trovo in perfetta sintonia con quanto scrive M.
Ventura, Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di
fede, Torino, 2014, p. 21: «La vera differenza è […] un’altra. Il credente
si mette al servizio della storia, ci entra dentro per misurare i propri
limiti. La storia del credente è incessante superamento di sé. Inseguimento tra
il soggetto e l’oggetto, che si scoprono a vicenda. Il credulo, invece, sfrutta
la storia: sta fuori di essa e ne mette in tasca i pezzi di cui ha bisogno. La storia
del credulo è affermazione di sé. Ansiosa ricomposizione di un racconto che gli
serve per controllare il presente. E per ergersi a protagonista del futuro».
[34] L. Rossi, op. cit., p. 176.
[35] L. Rossi, op. cit., pp. 181-182.
[36] L. Rossi, op. cit., p. 187.
[37] L. Rossi, op. cit., p. 188.
[38] L. Rossi, op. cit., p. 189.
[39] L. Rossi, op. cit., p. 198.
[40] L. Rossi, op. cit., p. 202.
[41] L. Rossi, op. cit., p. 212.
[42] L. Rossi, op. cit., p. 203.
[43] L. Rossi, op. cit., p. 224.
[44] L. Rossi, op. cit., p. 203.
[45] L. Rossi, op. cit., p. 203.
[46] Sulla scia dell’art. 11 della Cost. che prevede
una sovranità cooperativa, non divisiva, al fine di favorire la costituzione di
organizzazioni internazionali rivolte al perseguimento della pace.
[47] L. Rossi, op. cit., p. 225.
[48] L. Rossi, op. cit., p. 225.
[49] L. Rossi, op. cit., p. 225.
[50] Card. M. Czerny S.I. – R. Czerny, COP25: preoccupate
lezioni sulla crisi del clima, in La Civiltà Cattolica, 7/21 marzo
2020, p. 460.
[51] L. Rossi, op. cit., p. 227.
[52] Così E.A. Imparato, I diritti della Natura e la
visione biocentrica tra l’Ecuador e la Bolivia, in DPCE on line,
2019/4, p. 2466. Si tratta di un filone del costituzionalismo (c.d. “nuevo
constitucionalismo”) sconosciuto alla scienza costituzionalistica classica
(Stati Uniti ed Europa) che però inizia a trovare addentellati anche all’interno
delle nuove proposte politiche ambientalistiche presenti nello scenario
occidentale. Da qui la collocazione della “politica” bergogliana “a cavallo”
tra Europa (Occidente) e America Latina, con importanti elementi di
contaminazioni destinati a dare frutti nel prossimo futuro.
[53] L. Rossi, op. cit., p. 227.
[54] Qui è chiaro il legame con le costituzioni
democratiche del mondo, all’interno delle quali, il legane funzionale tra
persona umana e fratellanza, trova ampio riconoscimento. D. Fares S.I., La
fratellanza nell’itinerario di Papa Francesco, in La Civiltà Cattolica,
20 luglio/3 agosto 2019, p. 129, rimarca come: «La fratellanza è il primo tema al quale
ha fatto riferimento papa Francesco nel giorno della sua elezione, quando ha
chinato la testa davanti alla gente e, definendo la relazione vescovo-popolo
come “cammino di fratellanza”, ha espresso questo desiderio: “Preghiamo sempre
per noi; l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una
grande fratellanza».
[55] L. Rossi, op. cit., p. 231.
[56] Qui il rinvio corre, tra i tanti, a J. Hickel, The
divide. Guida per risolvere la disuguaglianza globale, Milano, 2018,
secondo cui, per risollevare le sorti delle popolazioni povere del pianeta,
bisogna agire non sulla “condizione di natura” bensì sulle dinamiche all’interno
del sistema di sfruttamento economico mondiale.
[57] L. Rossi, op. cit., p. 233.
[58] L. Rossi, op. cit., p. 235.
[59] L. Rossi, op. cit., p. 237.
[60] L. Rossi, op. cit., p. 239.
[61] L. Rossi, op. cit., p. 239.
[62] L. Rossi, op. cit., p. 296.