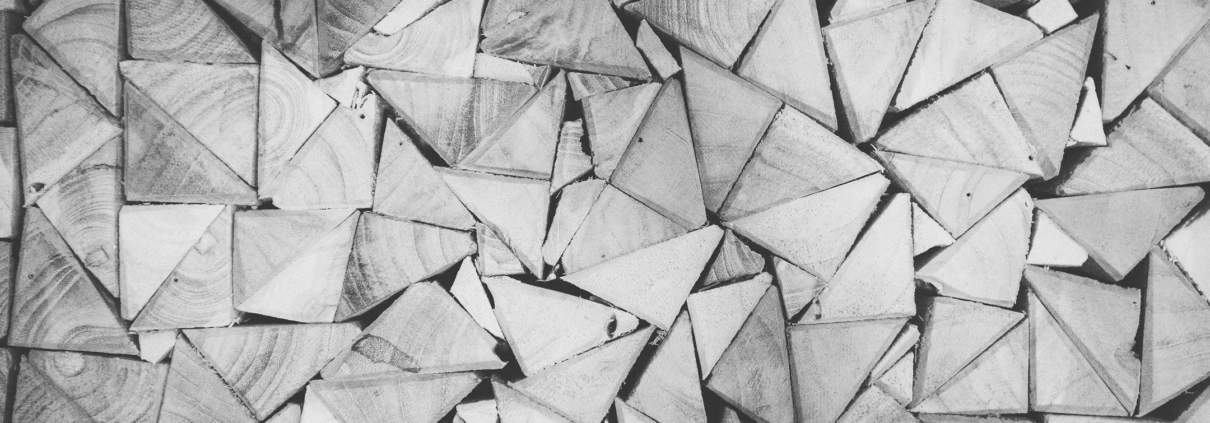Se il capitalismo è la malattia, qual è la cura?
L’ideologia capitalista moderna coloniale ha instaurato una concezione del corpo come un oggetto non permeabile che chiudeva l’Io, il soggetto pensante, oggetto, razionale. Perché il virus affetta di più gli uomini? Più che assistere unicamente a dimorfismi fisico-anatomici, che l’unica cosa che fanno è reificare le funzioni associate a uomini e donne, rinforzando il patriarcato, avventuriamoci qui in un’ipotesi immaginativa (anche con ispirazione a Haraway e Stengers, cioè incoraggiandoci alla finzione), perché sono loro quelli che sono più vicini a questa idea dell’Io, univoco, identitario, chiuso, accentrato su se stesso, che inalbera l’egoismo e l’impenetrabilità.
Sorvegliare e punire
C’è da chiedersi come sia venuto costituendosi un ambiente umano così divaricato tra obbedienti paurosi e trasgressori menefreghisti. Azzardo una spiegazione: la scarsa credibilità delle Istituzioni, in quanto tali, mentre determina la trasgressione facile, all’opposto, induce alla obbedienza non per stima politica, ma per pura paura. Ne restano fuori tutti coloro che, consapevoli della entità della situazione, vorrebbero vivere una condizione di autodeterminazione responsabile senza paura e senza sorveglianza.
Chi conta i numeri che contano?
Non è che io creda in un futuro migliore, lungi da me i versi di Majakóvskij in cui il poeta russo affermava: “Innamorato / rientrerò nel giuoco / rischiarando col fuoco la curva delle ciglia”. Non credo nell’amore e le mie ciglia si stanno spopolando, tuttavia sono arrivata alla maturità senza essermi suicidata.
Francesca Gargallo Celentani
A più di due mesi dall’inizio della “domiciliazione cautelativa” – ovvero dopo aver già provato timore per le persone più vulnerabili al virus, rabbia nell’osservare gli effetti tangibili della scissione politica fra pubblico e privato, eccitazione all’idea che tutto questo possa fornire un banco di prova per una società più democratica, panico all’idea di fallire e che lo stato di sorveglianza possa prendere il sopravvento –, eccola qua: una riflessione che rimette i binari di queste umorali montagne russe in pari con la potenza liberatrice della ragione scettica. Si tratta di un articolo di Francesca Gargallo, Agire dalla perplessità: tra pratiche di sopravvivenza, impotenza ideologica e dialoghi dalle autonomie, in cui la filosofa e attivista (attraverso le sue conoscenze accademiche e i dati delle sue esperienze nei collettivi femministi di donne indigene e popolari) prova a rispondere alla domanda: «Cosa intendono quando ci dicono che dopo questa crisi nulla sarà più come prima?». Come sempre Gargallo non indica delle soluzioni, ma i luoghi in cui dirigere lo sguardo quando ci sembra di poter interrogare nient’altro che le nostre mura domestiche.
Sdegnata dalla morbosità con cui i media guardano alla pandemia, con «stilo di bronzo e mano ferma» (citando, non senza ironia, Sulla volontà nella natura di Schopenhauer), Gargallo interrompe il discorso pubblico che come un giradischi si è incantato su due note: la semplicistica descrizione della totale distruzione ambientale e la completa fiducia nella soluzione tecnologica. Così scrive:
la convergenza [ref] Corsivo mio. Quando Gargallo parla di “convergenza” fa riferimento ai nuovi studi di informatica e di comunicazione, in particolare a quelli sulla multimedialità che rilevano come l’uso di una sola interfaccia per tutti i servizi di informazione (educazione, sorveglianza, commercio, servizi bancari, intrattenimento, ricerche, medicina, ecc.) porti alla capacità di discriminare in modo automatico le informazioni che ci interessano spostando i confini geopolitici delle zone abitate [/ref] dell’automazione robotica, delle tecnologie molecolari metaboliche e della geoingegneria climatica spinge i capitalisti mega-tecnologici come Bill Gates a immaginare interventi in interi ecosistemi. [ref] Nota Gargallo: «La Solar Radiation Management Governance Initiative (SRMGI) è una società di geoingegneria solare che Bill Gates finanzia dal 2012. La geoingegneria solare mira essenzialmente a simulare gli effetti di un’eruzione vulcanica massiccia per raffreddare il pianeta, senza misurare gli impatti atmosferici o la caduta a terra dalle particelle chimiche di colore scuro che un esercito di aerei (di chi?) farebbe cadere dall’alta quota per creare uno strato denso contro i raggi del sole». [/ref]. Attraverso le Nazioni Unite e la Banca mondiale, insistono che gli Stati obbediscano al loro elaborato progetto economico di investimento in tecnologie, eticamente dubbie, per evitare il calo delle prestazioni agricole [ref] Nota Gargallo. A tal proposito vedi: S. Ribeiro, J. Thomas, «Frente al tsunami tecnológico», in Tecnologías: manipulando la vida, el clima, el planeta, n. 543 della rivista América Latina en movimiento, 43, II, pp. 1-4. Scaricabile gratuitamente da: <https://www.etcgroup.org/es/content/tecnologias-manipulando-la-vida-el-clima-y-el-planeta>. L’ecologista Silvia Ribeiro fa parte del gruppo ETC che monitora l’impatto delle tecnologie emergenti e delle strategie corporative su biodiversità, agricoltura e diritti umani. [/ref] […]. [Al contempo,] si dice poco sugli studi che, senza scopo di lucro, si realizzano in periodi di tempo più lunghi, connettendo la conoscenza storica con quella biologica, gli studi femministi con le Scienze Ambientali e la Chimica con l’Antropologia.
Secondo la filosofa, il problema è sistematico e deriva – per proseguire con la metafora – dal fatto che “il braccio di lettura” di questo giradischi sia difettoso e vada dal centro alle periferie della società, escludendo la logica del movimento opposto. In ottica illuministica Gargallo si interroga sull’utilità della conoscenza, sull’equazione fra Sapere e Potere: se dal sapere non consegue direttamente (meccanicisticamente) una soluzione unica ai problemi più complessi del nostro rapporto col mondo, chi è in grado di dirsi narratore legittimo e privilegiato dei fatti del mondo? «Chi si appella al diritto di fare previsioni quando sappiamo che ogni forma di meccanicismo […] è anche una forma di riduzionismo?». Scegliendo di interrogare gli studiosi (“chi”) e non le discipline (“cosa”), più che un Tribunale della Ragione, l’autrice mette in piedi un Tribunale del(la?) Ragionante: riapre il dibattito sulla rilevanza scientifica di chi ricerca, osserva, valuta, quantifica e firma; di chi “contando” si fa titolare della razionalità dei numeri.
In prima battuta, nella misura in cui la logica mainstream coincide con quella del sistema capitalistico dominante, è facile intuire cosa – o chi! – conti.
Secondo il rapporto presentato il 20 Gennaio 2020 al World Economic Forum (a Davos) dall’organizzazione no profit Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM, la disuguaglianza economica è fuori controllo ed è classista, razzista e sessista. 2.153 miliardari nel 2019 possedevano più ricchezza di 4.600 milioni di persone, rivelando che il sistema economico valorizza l’élite privilegiata più del lavoro di assistenza essenziale, che viene calcolato in milioni di ore non retribuite e che viene principalmente svolto da donne e ragazze. La crescente disparità tra la popolazione miliardaria, che continua a mantenersi all’1% della popolazione mondiale [nonostante questa continui ad aumentare], che possiede la stessa quantità di denaro liquido o investito del restante 99%, è diventata più ricca a causa della crisi del 2008.
Ma cosa dicono questi numeri, queste percentuali? Si dice spesso che “sono i fatti a parlare”, “i numeri parlano da sé”, per affermare infine – senza soffermarci troppo ad analizzare la coerenza logica – che “i numeri contano”. Tuttavia, a voler dare per buona la metafora che antropomorfizza i numeri (parlanti), non ci si dimentica forse di chiedersi quale lingua parlino, che sistema di valori abbiano? In italiano “contare” è sinonimo tanto di “enumerare” (quantificare) quanto di “avere valore” (qualitativo) e nella frase “i numeri contano” noi vogliamo affermarli entrambi, contemporaneamente. Ma mentre è facile immaginare cosa (e persino chi) contino i numeri, quale sia il loro valore (qualitativo) è una questione tutt’altro che determinabile oggettivamente. A voler proseguire in questa logica, si giunge quindi al nonsense: chi, infatti, potrebbe prendere seriamente in considerazione che i numeri abbiano un loro linguaggio, un loro “sistema di valori” intrinseco? Se non viene da sé bisognerà dunque ammettere che ci sia un “di cosa” – o “di chi!” – i numeri hanno il valore e questa, sì, mi sembra una questione da dover determinare oggettivamente.
Chi conta
In questo momento più che mai si comprende perché Gargallo esiga di conoscere l’identikit di chi conta: nell’era del “Capitalismo della Sorveglianza” [ref] S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, Roma, 2019. [/ref] conoscere il valore attribuito di volta in volta alle informazioni (formalizzate, codificate, enumerate) di cui disponiamo riconduce inevitabilmente a chi li dispone, a chi ha possibilità di posizionarsi sul punto privilegiato di osservazione. In una domanda: chi ha il “visto” per accedere ai nostri osservatori scientifici?
Non è un segreto ormai che «la più ampia élite delle culture dominanti euroasiatiche, e poi di quelle americane, africane e australiane, sia costituita da uomini di identità maschile [ref] Nel testo si fa spesso riferimento alla distinzione, ormai divenuta classica, fra sesso e genere. Nonostante non ci sia ancora una definizione netta e chiara per tutte le teorie dei Gender and Women’s Studies, si accetta ovunque ormai – per comodità e nella misura in cui è necessaria all’analisi – la distinzione di base fra il corredo biologico sessuale e l’insieme delle caratteristiche sociali (che segnano la discriminazione).[/ref]».
Ma a mezzo secolo dagli studi comparati e interdisciplinari di genere, oggi sappiamo di più. Sappiamo anzitutto che il dato del dominio della rappresentanza maschile e bianca in tutti gli ambiti del sapere, non solo non ha affatto a che fare con la tanto declamata “meritocrazia”, ma che esso è strettamente connesso alla “sottorappresentanza” femminile [ref] C. Criado Perez, Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men, 2019; prossima pubblicazione in Italia, trad. C. Palmieri, Invisibili, Giulio Einaudi, 2020. [/ref], di modo che «la sussistenza della rappresentanza maschile dipenda dalla subordinazione femminile». Ovunque si tratti di informazione e comunicazione – e considerato che “non si può non comunicare” (primo assioma di Watzlawick) stiamo parlando di tutta la realtà significativa – si nota la tendenza a negare l’uguaglianza delle donne mentre si conferisce autorità morale alla rappresentanza maschile [ref] Nota Gargallo. Sulla dipendenza della rappresentanza maschile dalla subordinazione femminile e sullo status che questa conferisce agli uomini maschi [con tutta probabilità, si tratta ancora della distinzione fra sesso e genere]: Rita Laura Segato, Las estructuras elementales de la violencia: contrato y estatus en la etiología de la violencia, Serie Antropología, 334, Brasilia, 2003; http://www.escuelamagistratura.gov.ar/images/uploads/estructura_vg-rita_segato.pdf (consultado el 14 de enero de 2020). [/ref].
Nel caso delle donne, forse il più noto, le faccende domestiche, dette anche attività femminili, che comprendono cure fisiche e supporti emotivi, alimentazione, abbellimento, pulizia e manutenzione della casa, lavoro volontario e creazione di reti affettive, amministrazione dell’economia del nucleo di coesistenza, shopping, preparazione e cura dell’abbigliamento e delle calzature, sono considerate irrilevanti, di routine, naturali. Le poche donne che i gruppi reazionari considerano meritevoli di accettazione sono o schiave domestiche o donne mascolinizzate per un lavoro produttivo ad alto rendimento monetario. A queste ultime viene dato il diritto di sfruttare altre donne, quelle subordinate per motivi di classe, status di migrante o gerarchia scolastica. Ancora una volta, la condizione storica delle persone considerate “femminili” implica sottomissione.
Non è dunque il solo fatto di avere determinate caratteristiche fisiche e, tuttavia, non è vero neppure l’esatto contrario, che queste caratteristiche non abbiano alcuna rilevanza. Nella prospettiva che si sta qui seguendo, è un’identità che nasce “in negativo”, dal fatto di non prendere (pubblicamente) le distanze dallo spazio «misogino, xenofobo, omofobico e contrario ai dati che rivelano il grado di deterioramento ambientale», che infine è prerogativa di chi detiene il potere nella storia e nelle società attuali. Di più, la sua capacità rappresentativa è determinata dall’inerzia o dalla discriminazione attiva: mentre «normalizza la violenza e stigmatizza le donne che difendono i diritti umani» [ref] Delle donne, ad esempio, si «attacca la reputazione, l’onore e si definiscono madri che trascurano la loro progenie, cattive figlie, agitatrici, mogli che non si prendono cura del benessere esclusivo del marito, terroriste, per screditarle. Le si espone così a un’ostilità che i media e le chiese conservatrici aumentano squalificando pubblicamente il loro lavoro, fornendo dettagli sulla loro vita, minacciandole di portare via i loro figli e di fatto facilitando il loro attacco sessuale e la loro esposizione al pericolo». A tal proposito Gargallo indica l’Informativa di Michel Forst, Relatore Speciale dell’ONU, sulla situazione delle difensore dei diritti umani: https://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2019/20190228_ComPrensa_InformeForst.pdf [/ref], egli estende la sua identità e riconferma la legittimità della sua autorità. È in questione lo squilibrio fra forze di rappresentazione quando esse vengono fornite da una sola identità sociale, la quale inevitabilmente replica un’unica realtà. Parafrasando Bernard Shaw: l’uomo bianco, in sostanza, relega le altre identità a sottocategorie: e ne conclude che i loro saperi sono specifici. Gargallo indica quattro gruppi di persone che «aiutano a non cadere nella disillusione»: femministe, migranti, popoli originari ed ecologisti/e:
si tratta di diversi collettivi che si organizzano attorno alla vita quotidiana, personale e comunitaria, piuttosto che […] a quell’ideologia che, dalla Rivoluzione Francese alla crisi del neoliberalismo, ha provato a rappresentarci il sistema e a imporci un solo modo di azione. Popoli originari, ecologisti ed ecologiste si occupano di difendere l’acqua, i boschi, il diritto ad essere governati dalle culture che non fanno necessariamente parte del sistema capitalista dominante; i migranti e le migranti esigono la libertà di spostarsi sulla terra e le femministe aspirano a relazioni umane senza discriminazioni di genere e razza. I loro collettivi esistono in tutto il mondo e fanno parte di diverse culture; condividono il fatto di essere perseguiti, assassinati e umiliati dagli agenti d’impresa, dalle chiese e dai governi che puntano esclusivamente all’ordine del beneficio monetario.
Lasciateci contare
Ciò che rimprovera Gargallo alla narrazione “from nowhere” (che si pretende imparziale) non è solo che essa ci fornisce dati incompleti, ma che essendo identica a sé stessa quei dati siano, nella migliore delle ipotesi, inutili e, nella maggioranza dei casi, persino dannosi.
La stampa non presta attenzione alla responsabilità dei venditori di armi e prodotti agrochimici, né alle insidiose pubblicità del capitalismo sulle condizioni di benessere che fornisce, quando si tratta di riferire sulle disumane condizioni di migrazione o sulle quantità di rimesse che i migranti inviano alle loro comunità di origine per migliorare le condizioni di vita e di salute. Il razzismo diffuso si trova nella definizione di “problema di sicurezza regionale” per i rifugiati in fuga da guerre come quello in Siria. Mentre i conflitti armati continuano, il flusso di persone in cerca di sicurezza e detenuti ai confini produce enormi campi di concentramento, dove si riproducono le condizioni di disastro ecologico e aumenta la violenza contro le donne.
Cosa cambia quando sono questi gruppi a parlare? Quando, anziché essere oggetti della narrazione, quei gruppi emarginati dalla logica capitalistica si fanno collettivi e soggetti narratori, l’informazione ci guadagna in completezza ed efficacia politica. Così, ad esempio,
laddove i capi accusano [le donne] di essere divisive, queste contribuiscono a riflessioni fondamentali sulla relazione coloniale tra sessualità, aggressività e potere. La recente conversione della ribellione popolare contro il quarto mandato presidenziale di Evo Morales in un colpo di stato razzista e anti-popolare, da parte di gruppi neo-evangelici alleati ai bianchi ricchi del bestiame e della vasta regione agricola di Santa Cruz, ha evidenziato una relazione che le donne di Aymara e Quechua nelle Ande e Tacana dell’Amazzonia avevano già dichiarato: il rapporto tra umiliazioni, minacce e molestie, come forme di stupro allegorico, e stupro fisico come imposizione delle prerogative del gruppo maschile dominante.
In particolare, dall’Ottobre del 2018 Gargallo riferisce le testimonianze delle donne che transitano in Messico per attraversare il confine con gli Stati Uniti: le violenze subite da queste dai compagni di rotta, dalle autorità di immigrazione e dalla polizia sono solo alcune delle atrocità che connotano il fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Alcune mi hanno detto che da quando hanno deciso di attraversare il confine sapevano che ciò poteva accadere, quindi considerano le aggressioni sessuali come parte del processo. Tuttavia, una giovane donna honduregna che aveva lasciato San Pedro Sula per proteggere la figlia di 9 anni dalle bande criminali, mi ha spiegato perché crede che lo stupro sia una rapina e un crimine che molti uomini considerano normale. Era emigrata come gruppo quando una notte è stata violentata da sei migranti che “volevano divertirsi”. “Ecco come sono fatti gli uomini”, disse con grande rabbia. Si sentì tradita dallo stupro; credeva di essere emigrata con persone che, come lei, sono fuggite dalla violenza, che si sarebbero protette in gruppo, ma hanno scoperto che gli uomini “sfruttano” le donne che vanno da sole, che rispettano le donne degli altri uomini solo quando sono presenti e difendono la loro famiglia.
È un’altra normalità, un’altra narrazione quella che viene direttamente da coloro che stanno fuori dalla narrazione mainstream. Non è il semplice fatto che «i leader della comunità maschile non comprendono le strutture del desiderio delle donne», ma che ignorando queste contro-narrazioni, la narrazione unica incide gravemente sul diritto delle donne al loro rapporto col mondo, il quale – come sappiamo – oltre ad essere un diritto è una necessità iscritta nella costituzione stessa di ogni essere umano. Si fa quindi più chiara la relazione fra punto di osservazione e realtà; come, spostando la prospettiva legata all’identità di chi narra, cambino anche i numeri che vengono raccontati e le possibilità, le scelte che formano il discorso politico. Gli Studi di Genere assumono tutt’altra estensione epistemologica e rilevanza pratica, quando, ad esempio, sentiamo che «oggi circa 140 donne al giorno in tutto il mondo vengono uccise da uomini che presumibilmente le amavano […] e che il 42% degli omicidi di donne è legato a sottoculture che riconvalidano continuamente la differenza di genere in modo che gli uomini possano mostrare la loro mascolinità, associando [di fatto] il loro potere sessuale e sociale al potere di uccidere». Infine, diventa un dato pericolosamente credibile che
la crescita dell’estrema violenza contro le donne e le donne femministe che difendono i diritti umani può essere associata alla volontà di subordinare ed è facile accomunare alle pratiche di guerra: la violenza contro le donne che non si sottomettono al dominio della cultura maschile sarebbe, da questa prospettiva, una strategia difensiva.
L’analisi sulla discriminazione sessuale e sul genere smette di essere una questione di specializzazioni accademiche fini a sé stesse e diventa dirimente rispetto alle ulteriori analisi possibili.
Secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2019, 272 milioni di persone si sono trasferite fuori dal loro luogo di residenza oltre i confini internazionali, 51 milioni in più di migranti rispetto al 2010. In totale, donne, uomini, transessuali e neonati che sono emigrati indipendentemente dal loro status legale, a causa di sfollamenti forzati o volontariamente (sebbene sia sempre molto difficile determinare il grado di volontà), sono il 3,5% della popolazione mondiale, una cifra che continua ad aumentare rispetto al 2,8% nel 2000 e il 2,3% nel 1980. La devastazione ecologica si unisce ai conflitti armati per creare condizioni di povertà e insicurezza che spingono le persone a cercare rifugio o migrare.
Un’altra prova della rigidità con cui un sistema di pensiero impedisce il “libero movimento delle narrazioni”, nascondendo l’identità del narratore unico nell’universalità della conoscenza, si desume dalla difficoltà oggettiva che hanno alcuni (chi?) ad ottenere un visto (cioè il documento identificativo che consente di accedere ad alcuni territori; quali?). Se ancora non tutti sanno – e la stampa non parla affatto della paura diffusa di “restare a casa”, delle ragioni che hanno le donne per migrare e che raccontano a Gargallo «di essere fuggite dalle loro madri, le quali per proteggerle […], le tenevano chiuse in casa» – non è certo perché siano casi rari di comunità lontane nel tempo, a ben pensarci neppure in Italia. Eppure, chi tenta da un punto di vista privilegiato di raccontare l’immigrazione, persino chi – della stampa – prova a ricordarne il valore umanitario, ne parla spesso in toni paternalisti; come se il fenomeno riguardasse persone ontologicamente (e originariamente!) diverse da noi, perché connotate da bisogni e desideri che non “ci” riguardano. È qui in gioco la costitutiva opera di persuasione del sistema capitalistico che vuole convincerci che stiamo bene (tralasciando oltretutto che quella distribuzione di briciole di benessere di cui si vanta si regge sistematicamente sullo sfruttamento della nostra stessa Terra). Sicché “noi” del “primo mondo” – in attesa di ricevere la ricompensa (economica, morale, sociale) che formalmente quella narrazione ci promette – in barba alle nostre reali e materiali possibilità di mobilità (economica, morale, sociale e persino fisica) ci poniamo da questa parte della narrazione, osservatori muti e casse di risonanza di una narrazione che ci attraversa. D’altra parte, pagando con la loro stessa vita, oggi «i migranti e le migranti sono diventati agenti di una vivace riflessione, su che cosa sia la terra, cosa la ricchezza e quali i diritti delle persone che non godono della protezione dello stato. Naturalmente, la riscoperta delle culture di provenienza e il tentativo di una comunicazione autentica su un’umanità che si riunisce in una nuova storia collettiva, non è senza dolore, morte, resistenza a un ordine di esclusione e di rifiuto internazionale».
Gli stili di vita tradizionali sono profondamente colpiti, ma sono proprio gli sforzi congiunti di ecologi e comunità indigene e contadine che sono riusciti a frenare localmente la degenerazione della natura, difendendo i fiumi, arrestando le attività estrattive ed elaborando contro-discorsi che rivelano i pericoli di massimizzare i benefici monetari ai margini della buona vita delle persone.
Per concludere, di fronte alla crisi delle scienze della vita, secondo Gargallo, non c’è affatto un problema costitutivo universale, ma la rigidità e la conformazione delle narrazioni ad un narratore unico su tutti i campi. Se l’ascesa delle “scienze della complessità” degli anni ’70 e le narrazioni contemporanee di donne, migranti, popolazioni originarie ed ecologiste/i «non godono di copertura mediatica [è] perché, se riportano situazioni preoccupanti, non sono allarmisti»; banalmente non hanno bisogno di “comprare” niente, «diffondono informazioni comprovate e si basano su un’etica ecologica di base, quella di non correre rischi nella vita sulla Terra». È la narrazione dell’1% che non ammette la reversibilità dell’attuale modello sociale produttivo in un modello sociale per il 99% [ref] A tal proposito, suggerisco la lettura di un recente libro sulle politiche femministe materialiste: C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Femminismo per il 99%. Un manifesto, Laterza, 2019. [/ref].
In questo preciso momento, milioni e milioni di molecole si muovono coerentemente in ciò che chiamiamo materia. È improbabile, ma alla fine possibile, che il loro comportamento sia reversibile, proprio perché possono muoversi. Considerare questa qualità mobile della materia ci consente di pensare ad altri sistemi, forse enormi cambiamenti collettivi e, perché no, orizzonti tanto nuovi quanto imprevedibili.
Ci raccontano che il moto di accelerazione è costante per tutti e che necessariamente dobbiamo essere «in costante connessione con dispositivi che emettono suoni, messaggi e immagini che influenzano le nostre decisioni in termini economici e politici», ma in questo modo il 99% della popolazione non riesce «a trovare il tempo per analizzare informazioni diverse e originali». In tal senso, il diritto alla possibilità di cui parla Deleuze [ref] «Un po’ di possibile, sennò soffoco» scriveva Deleuze nel suo L’immagine-tempo del 1989. [/ref] come diritto a “non soffocare”, non è tanto e solo il recupero del valore epistemologico delle rêverie, come risposta alla crisi novecentesca della sovranità del Soggetto. Si tratta del diritto alla “situazionalità” della conoscenza come possibilità di accedere ad una molteplicità di vie d’uscita, di recuperare ogni ragione non prevista dalla razionalità dell’1% della popolazione che ha sempre scritto la storia (“che giudica e che assolve”), che conta i numeri che contano. La riflessione “perplessa” di Gargallo ricorda i moventi della più nota “Guida dei perplessi” di Mosè Maimonide nella misura in cui si interroga sul “conflitto di autorità”. Tuttavia, mentre per quest’ultimo si trattava del conflitto fra filosofia e religione, per Gargallo si tratta oggi di un conflitto più simile a quello che il filosofo Odo Marquard chiama la “Guerra Civile Ermeneutica”: una guerra “del senso” che non è affatto priva di spessore pratico ed estetico, affettivo e politico.
Il virus della Sacra Famiglia
di Laura Paulizzi
Il discorso di G. Conte del 26 aprile scorso, in cui sono state annunciate le nuove disposizioni per la fase 2 dell’emergenza sanitaria, ha messo in evidenza due aspetti della nostra società che meritano di essere approfonditi, soprattutto in seguito allo scalpore suscitato dall’inadeguatezza dei termini utilizzati. In particolare, ascoltando le parole del Presidente del Consiglio, è emersa l’assenza di un lessico confacente alle dinamiche sociali eterogenee del nostro tempo; questo significa che oggi viviamo uno scarto tra la parola e i processi relazionali a cui questa assegna un significato coerente e universale.
Se da un lato il linguaggio ha perso la sua aderenza con la realtà, dall’altro, quella stessa realtà, non più riducibile a definizioni ordinarie finora funzionali, deve essere ripensata a partire da quei pilastri che ne fondano il tessuto politico e culturale: famiglia e lavoro. Questi due elementi sono stati i veri protagonisti della crisi che stiamo attraversando, e proprio nel momento inaugurale della nuova fase acuiscono la loro problematicità. Tra le motivazioni per gli spostamenti concessi a partire dal 4 maggio ci sono infatti: comprovate esigenze lavorative e spostamenti mirati per far visita a congiunti. La condizione di “congiunto” è stata in seconda battuta e con difficoltà riformulata come “rapporto di parentela e stabili relazioni affettive”, e infine chiarita goffamente dal Viceministro Sileri che include in queste relazioni anche l‘amico, ma quello vero.
I primi a esprimere il loro dissenso come rappresentanti di una minoranza sociale importante, sono stati Gabriele Piazzoni (segretario generale dell’Arcigay), che ha sottolineato come al di fuori del legame biologico lo stato non veda e non riconosca altre realtà, e Fabrizio Marrazzo (portavoce del Gay Center), che ha lamentato il ricorso a logiche di parentela ottocentesche.
In effetti, è proprio tra il XVIII e il XIX secolo che si delinea una nuova immagine di donna e di uomo, non più nelle sole vesti di madre e padre, sudditi di uno potere sovrano, ma in quanto liberi cittadini. Nel 1800 è il passaggio dalla famiglia alla società civile, per dirla con Hegel, ad assicurare agli individui la loro emancipazione da dinamiche famigliari basate sul sentimento, sui legami di sangue e su quei ruoli che il focolare domestico conserva nella loro stabilità e immutabilità. Uscendo dalla famiglia, infatti, una donna non è più figlia, madre o moglie, ma una persona che incontra altre persone e si esprime attraverso nuovi linguaggi. La separazione dalla famiglia comporta la perdita di tutte le categorie in essa vigente, e conseguentemente l’acquisizione di nuove conoscenze, attraverso quelle dimensioni relazionali che le mura domestiche non ci consentono di esperire.
Il passaggio dalla famiglia alla società implica la perdita della propria identità come membro di essa, e l’assunzione di un’autonomia che si realizza nel lavoro, nell’arte e in tutte le connessioni inedite che solo l’uscita e la separazione dal focolare domestico garantiscono. Al di fuori di esso si conquistano indipendenza, autonomia e diversità. È proprio una nuova immagine di sé, non più come semplice membro di un nucleo fondato sull’appartenenza biologica, che la famiglia per sua stessa natura non ammette. Essa, infatti, non è che lo stadio inaugurale del processo di realizzazione di un individuo, quello più vicino a una dimensione naturale dell’umano, dove vigono quelle consuetudini che in uno spazio sociale extra-famigliare risultano inadeguate, in quanto non adatte a riflettere la più complessa identità che una donna, ad esempio, realizza quando smette di essere madre, figlia e moglie. Il tessuto relazionale che lo spazio sociale fonda e garantisce, è il superamento di ciò che era stato stabilito come valido all’interno di un contesto domestico. È in questo luogo che si realizza la volontà dell’individuo, quindi la sua libertà. Da un lato la libertà da precetti e dogmi che spesso strutturano l’educazione imposta dall’habitus famigliare, dall’altro, la libertà di essere responsabile del proprio agire mediante un mutuo riconoscimento sociale: “La civiltà pertanto nella sua determinazione assoluta è la liberazione e il lavoro della superiore liberazione, cioè l’assoluto punto di passaggio alla sostanzialità non più immediata, naturale, dell’eticità, bensì spirituale, infinitamente soggettiva, in pari tempo innalzata alla figura dell’universalità”. [ref] G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. di G. Marini, Bari, Laterza, 2021, §187, p. 158.[/ref]
Il passaggio dalla famiglia alla società civile, consente all’individuo di uscire da uno stadio naturale e soggettivo della propria esistenza, per abbracciare una dimensione universale dell’esistere che sia riconosciuta da tutti, non in funzione dell’appartenenza biologica da cui deriva, ma dal suo essere un soggetto agente, responsabile e libero di infrangere quelle leggi imposte dalla naturalità primordiale da cui la vita sviluppandosi si separa. L’individuo, nello spazio sociale, non è un membro della propria famiglia, ma parte di un contesto universale dove vige una normatività il cui principio non è il sentimento che lega i famigliari, ma la razionalità del diritto che lo stato incarna, tutelando e comprendendo questa eterogeneità.
Figlia del retaggio cattolico-ortodosso patriarcale che domina la nostra cultura, la famiglia, più che essere mantenuta e conservata nella propria sacralità, va ripensata come primo momento di un processo di emancipazione e di realizzazione di sé, affinché diventi il punto di partenza e non il fine dell’uomo.
In ciò che concerne l’altro virus che infetta il paese ormai da molti anni, la disoccupazione, possiamo dire di essere tornati a uno stato “pre-costituzionale” dell’esistenza. Nel nostro paese, uno dei mezzi di emancipazione dell’uomo, ma soprattutto della donna, è proprio il lavoro, che, come recita l’articolo 1, fonda l’Italia in quanto repubblica democratica, la cui sovranità, è bene ricordarlo, “appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Non tutte le classi dei lavoratori sono state colpite allo stesso modo dalla crisi sanitaria; ad alcuni non è cambiato molto, altri sono costretti a lavorare in condizioni disumane, e molti hanno perso il lavoro. Tra tutte le categorie, una in particolare resta invisibile agli occhi di questa società, quella degli artisti. Essi non vengono riconosciuti in quanto lavoratori, non sono rappresentati da alcun ente, e non costituiscono l’oggetto di un dibattito politico. Una testimonianza di questo mancato riconoscimento ci è giunta su un articolo apparso il 29 aprile su Repubblica di Bologna. Il cantante di un gruppo romagnolo stava andando a recuperare i suoi strumenti musicali, con tanto di foto e video dei live sul telefono e addirittura un articolo stampato per dimostrare la partecipazione del suo gruppo a un talent show italiano. Ora, il motivo dell’autocertificazione non ha convinto i carabinieri che, ritenendo che quello del musicista è un hobby e non un lavoro, lo hanno multato in “assenza di comprovate esigenze lavorative”.
L’arte è l’inconscio dell’umanità, la sua più potente forza creativa. Nata, secondo Bataille, 18 mila anni fa all’interno di una caverna a Lascaux, dove l’uomo con le prime pitture rupestri si distingueva dalla bestia, innalzandola “al di sopra dei compiti subordinati che accettava, dettati dalla religione o dalla magia”. In un paese come l’Italia, il cui patrimonio artistico la distingue da tutto il mondo, gli artisti riflettono l’assenza di un linguaggio in grado di esprimerne la loro identità. Un’identità che schiude una dimensione estetica non riducibile ai freddi meccanismi che governano l’odierna visione del lavoro, e che non si lascia sottomettere, proprio per la sua dionisiaca vitalità, al carattere razionale entro cui si tenta brutalmente di contenere la complessità dell’umano.
Il covid-19, da un lato, ci ha costretti a un ritorno alla casa e alla famiglia, dunque, a una dimensione primordiale della vita, in cui si è imposta una normalizzazione dell’agire umano, promossa da una propaganda mediatica che non fa che alimentare questo conformismo. Dall’altro, non solo ci priva di quella dimensione estetica e creatrice mediante cui l’uomo si è congedato dalla sua mera animalità, ma dà voce a istituzioni che non ne riconoscono l’esistenza.
Siamo tornati a vivere nel “si” heideggeriano (das Man), espressione di una condizione non autentica dell’esistenza, priva di scelta, in cui si lavora, si comunica, ci si esprime, sotto la stessa modalità e a prescindere dalle nostre specificità. Siamo nel dire del senso comune, molto lontano da quella chose du monde la mieux partagée di Descartes, più vicino all’ordinario discorso dissociato che lacera l’individuo moderno.
Il polverone sollevato dai termini che avrebbero dovuto chiarire le indicazioni da seguire in questa nuova fase, è giustificato, ma bisogna comprenderne le ragioni. Stiamo soffrendo l’assenza di un linguaggio che non è più in grado di dire la diversità della vita. Un linguaggio che non vede e non riconosce l’arte, in tutte le sue forme, come pars construens della nostra umanità; non considera la vita se non in funzione del suo carattere organico e biologico, sacrificando la dimensione universale e non razionale dell’umano che sola assegna alle donne e agli uomini la loro unicità.
Giudicare in tempo di crisi
di Alessio Lo Giudice
Nel profluvio di riflessioni sorte a commento degli effetti della pandemia da Covid-19, il richiamo al concetto e allo stato di crisi è uno dei più diffusi. È un richiamo da prendere sul serio se si vuole approntare una cornice concettuale di fondo in grado di inquadrare correttamente il rapporto tra le nostre azioni e il contesto generale scaturito dalla pandemia.
Il concetto di crisi è, come è noto, espressione di una categoria fondamentale della cultura occidentale, e ciò è sicuramente testimoniato dalla sua rilevanza semantica nella lingua greca. Derivando da krino, e quindi da separare, decidere, valutare, krisis evoca l’idea stessa della decisione ultima e definitiva. Una decisione, in particolare, che ha per oggetto alternative irriducibili come quelle che conducono a scegliere, ad esempio, tra la vita e la morte. E, non a caso, nell’ambito della scuola di Ippocrate la parola krisis designa il momento critico di una malattia. La fase in cui al medico tocca, appunto, prevedere quale sarà l’esito della lotta tra la vita e la morte. Nell’apparato teorico aristotelico la krisis indica, d’altra parte, tanto la posizione e la conservazione del diritto quanto la decisione fondata su un misurato giudizio politico. Ed è proprio il rapporto tra krisis e judicium a fare da sfondo ermeneutico alla filosofia dell’azione che ruota intorno al concetto di crisi sin dal mondo antico. Sia krisis sia judicium rinviano, infatti, ad una costellazione di significati giuridici che, con la cornice teologica del Nuovo Testamento, conducono al giudizio per antonomasia: il giudizio di Dio.
Di conseguenza, come sostiene Reinhart Koselleck (Il vocabolario della modernità, 2006), nelle matrici del pensiero occidentale il concetto di crisi comprendeva «tutte le situazioni decisionali della vita interna ed esterna, della singola persona e della sua comunità. Si trattava sempre di alternative definitive, sulle quali doveva essere presa una decisione adeguata, ma la cui realizzazione alternativa era anche insita nella cosa stessa di cui si trattava». È, dunque, l’urgenza dei fatti a porre l’alternativa, a illudere spesso l’uomo circa la possibilità di decidere adeguatamente su una realtà rappresentata in termini alternativi, secondo una logica addirittura binaria, anche quando, a ben vedere, la situazione rispetto alla quale occorre decidere è irriducibile ad alternative chiare e distinte. È il tempo che preme a identificarsi con la crisi. Perché è proprio quando il tempo a disposizione sta per esaurirsi che ci troviamo in crisi in quanto forzati a giudicare e decidere. Lo stato di crisi è, quindi, uno stato in cui occorre giudicare in condizioni di incertezza perché non vi è tempo per acquisire ulteriori informazioni, per valutare tutti gli aspetti della vicenda.
Naturalmente, nella modernità la crisi si trasforma sempre più in un concetto di filosofia della storia, esprimendo il punto di vista di chi presume di poter interpretare il corso della storia a partire dal contesto in cui egli si trova, e assumendo quindi il proprio tempo, necessariamente, come crisi. Ma, a prescindere dai modelli semantici generali riferibili al concetto di crisi, resta insuperata, dal punto di vista dell’esperienza esistenziale, l’idea greca di crisi come condizione nella quale il giudizio non è rinviabile, la situazione in cui si è obbligati a decidere. Non si può non essere, dunque, d’accordo ancora con Koselleck quando sostiene che «La crisi nel significato greco di necessità di decidere e di agire sotto l’incalzare dell’urgenza rimane un concetto irrinunciabile anche nelle complesse condizioni della società moderna».
Ebbene, l’odierno e diffuso utilizzo del termine crisi nelle letture della (e sulla) pandemia acquista un significato preciso nella misura in cui lo associamo proprio all’esperienza del giudizio. Nella misura, cioè, in cui interpretiamo la nostra condizione come quella di un sistema sociale che, a più livelli, si è trovato, e si trova, sistematicamente di fronte alla necessità di giudicare e decidere con il tempo che stringe. È questa la situazione che hanno dovuto gestire i medici dei reparti di rianimazione quando, a corto di posti disponibili in terapia intensiva e a fronte di una serie di motivate richieste di ricovero, sono stati chiamati a giudicare chi meritava, più degli altri, di essere curato. Ma è analoga, al netto di tutte le differenze specifiche, la situazione che il decisore politico ha dovuto affrontare di fronte al dilagare dell’epidemia, prima di procedere alla chiusura delle attività sociali e produttive. Oggi, lo stesso decisore politico si trova ancora a decidere, con urgenza, tra alternative che comunque si escludono, quando è chiamato a procedere alla riapertura delle attività a fronte dei risultati del contenimento del contagio. Per non parlare, poi, di tutte le ulteriori scelte quotidiane che molti hanno dovuto compiere in tale contesto, posti di fronte ad alternative quali quelle tra affetto e salute, o tra lavoro e salute. In altre parole, l’espressione “giudicare in tempo di crisi” indica l’esperienza diffusa che, meglio di altre, consente di dare un nome e un significato al tempo che stiamo vivendo, a causa della pandemia.
Ma, nel tentativo di attribuire un significato più preciso al nome che abbiamo dato alla nostra esperienza, occorre chiedersi se l’incertezza del giudizio, l’ampio margine di errore, il salto nel buio che un giudizio in tali condizioni sembra comportare siano caratteristiche soltanto della nostra condizione critica o se, invece, siano i tratti di ciò che la pratica del giudizio implica in sé. Se, come io penso, è ragionevole rispondere a tale interrogativo optando per la seconda alternativa, saremmo di fronte a ciò che spesso accade nelle situazioni limite. In tali situazioni, come è indubbiamente quella che stiamo vivendo, si rileva in maniera nitida, come le stelle in una notte tersa, la natura essenziale delle nostre esperienze. Si rivela, in questo caso particolare, la natura del giudizio quale facoltà drammatica che necessariamente ci appartiene. Ciò che la crisi pone in risalto, del resto, è l’urgenza del giudizio in assenza di criteri generali certi, indiscutibili e stabili, nonostante l’esistenza di linee guida, principi deontologici, pareri scientifici e tecnici. Questa è la situazione dei medici di fronte al dilemma etico, alla scelta tragica da compiere nel triage. Bisogna seguire a tutti i costi il principio della parità di trattamento? Occorre seguire il criterio della maggiore probabilità di successo clinico, con l’annessa valutazione sul discutibile parametro dell’aspettativa di vita? O invece basterebbe attenersi al criterio cronologico: chi prima arriva viene curato fino ad esaurimento posti? Ma è giudizio in assenza di una regola generale indiscutibile anche quello che il decisore politico deve esprimere di fronte alla necessità di aprire o chiudere lo spazio sociale ed economico-produttivo. Lo è perché si tratta di bilanciare, in concreto, principi e interessi costituzionalmente protetti che, nel loro insieme, esprimono la trama complessa di una società. Mettere in discussione uno qualsiasi di questi principi, dalle libertà alla salute, dall’uguaglianza all’iniziativa economica, comporta comunque una ferita nel tessuto sociale con tempi di recupero assolutamente non prevedibili.
In una situazione apparentemente ordinaria, il giudizio non è strutturalmente diverso da quello che sperimentiamo in tempi di crisi. La crisi è lo specchio in cui si riflette senza ombre e senza opacità il significato più intimo e complesso della nostra esperienza ordinaria del giudizio. Cartesio nelle Meditazioni Metafisiche (1641) sosteneva che l’errore di giudizio dipende «dal solo fatto che, dato che la volontà è più ampia dell’intelletto, io non la trattengo nei medesimi limiti di questo, bensì la estendo anche a quel che non intendo; e, poiché rispetto a ciò essa è indifferente, facilmente deflette dal vero e dal buono, ed è così che mi inganno o pecco». L’errore dipende dalla sproporzione che esiste tra l’ampiezza degli oggetti dell’intelletto e quelli della volontà. L’intelletto ha dei limiti: posso conoscere qualcosa, non posso conoscere tutto. La volontà è tendenzialmente illimitata, invece, nella scelta dell’oggetto del suo volere. Da questo scarto nasce l’errore. Precisamente quando la volontà si posa su ciò che non intendo e, si badi bene, non soltanto su ciò che non conosco assolutamente ma anche su ciò che non conosco sufficientemente. Si tratta di un errore eliminabile? In altre parole, è possibile giungere a un grado di conoscenza quantitativamente e qualitativamente certa e definitiva in modo da determinare con altrettanta certezza e definitività il mio giudizio e la mia volontà? A ben vedere, Cartesio coglie il problema ontologico del giudizio in quanto presa di posizione sul particolare. Infatti, tra intelletto e volontà c’è comunque uno scarto che, a volte, assume la forma di un abisso. L’abisso del giudizio. È questo il senso filosofico della questione del giudizio. Ma, se così stanno le cose, bisognerebbe, di conseguenza, rinunciare al giudizio? Quanto meno nei casi difficili? Di fronte alle scelte tragiche? O, al contrario, occorrerebbe assumere la consapevolezza dello scarto e dell’abisso che è in gioco nel giudizio per affrontarlo come problema esistenziale?
Questa seconda strada è quella battuta, a mio parere, da Kant nella Critica del Giudizio (1790). Una strada impegnativa ma che, allo stesso tempo, non si può non percorrere. Occupandosi del giudizio di gusto, Kant svela il carattere eminentemente politico del giudizio quale facoltà umana. E cioè il carattere pubblico e intersoggettivo del giudizio che si condensa nelle massime tratte dal sensus communis: 1) pensare da sé; 2) pensare mettendosi al posto degli altri; 3) pensare in modo da essere sempre d’accordo con se stesso. Se la prima implica un pensiero libero da pregiudizi (massima dell’Intelletto), e la terza il modo di pensare conseguente (massima della Ragione), la seconda è quella che per Kant corrisponde precisamente alla massima del Giudizio. Pensare mettendosi al posto degli altri non ha, però, nulla a che vedere con la capacità di usare correttamente la facoltà della conoscenza. Si tratta, invece, di un modo di pensare. In particolare, di un modo di pensare largo che si manifesta quando il singolo è in grado di elevarsi, come Kant afferma, «al disopra delle condizioni soggettive particolari del giudizio, tra le quali tanti altri sono come impigliati, e rifletta sul proprio giudizio da un punto di vista universale (che può determinare soltanto mettendosi dal punto di vista degli altri)».
Queste massime sono dettate dall’esperienza del giudizio riflettente, cioè del giudizio privo di fondamento. Privo di una regola generale sotto la quale sussumere il fatto che siamo chiamati a giudicare (come precisa Kant nella Critica del Giudizio, «se è dato invece soltanto il particolare, e il Giudizio deve trovare l’universale, esso è semplicemente riflettente»). Ebbene, la condizione descritta dal giudizio riflettente è, in realtà, la condizione prevalente del giudizio esistenziale che raramente, nell’esperienza quotidiana, può essere espresso sulla base di una regola generale fissa e indiscutibile. La gran parte dei nostri giudizi ha luogo, infatti, in assenza di una tale regola ed è, invece, dettata dalla pressione dei fatti, dalla necessità di decidere. Nella crisi questa natura del giudizio è perfettamente visibile, non può essere nascosta. Nei momenti tragici, quando il contesto in cui si vive non offre orientamenti precisi, in situazioni che sono dunque eccezionali, che sono di limite, la natura del giudizio emerge. In assenza di norme e criteri generali, giudicare significa chiaramente pensare se stessi nei panni degli altri. Significa posizionarsi, con la propria identità e attraverso l’immaginazione, nelle situazioni altrui, per poi poter agire. Nelle situazioni limite il giudizio appare limpidamente come espressione della capacità di pensare liberamente. Come unico modo per dare significato al mondo che viviamo e per agire come soggetti liberi. Il giudizio riflette dunque la responsabilità di chi giudica, pronto a rispondere della propria valutazione. Per queste ragioni, rifiutarsi di giudicare vuol dire essere irresponsabili. Vuol dire essere apolitici. E questo vale ancor di più se chi è chiamato a giudicare ha responsabilità generali di carattere politico, sociale, professionale.
Naturalmente, a monte del giudizio si situa il pensiero. Certamente, la facoltà di giudicare non è la stessa facoltà del pensiero. Il pensiero si rappresenta ciò che è assente, il giudizio è tale se ha per oggetto ciò che è particolare e presente. Ma è la correlazione tra pensiero e giudizio che è evidente. Una correlazione di cui dovremmo tenere conto, a tutti i livelli, sicuramente nel tempo ordinario e, a maggior ragione, nel tempo di crisi. Perché, come sostiene Hannah Arendt (Pensieri e riflessioni morali, 1971): «Il manifestarsi del vento del pensiero non consiste nella conoscenza; ma si esprime nella capacità di distinguere il bene dal male, il bello dal brutto. E ciò, nei rari momenti in cui si arriva a un punto di crisi, può realmente evitare catastrofi, almeno per me stesso».
L’ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. LA “CHIUSURA” ALL’ARTE È LA “CHIUSURA” ALLA VITA
di Fabrizio Vona
Purtroppo non abbiamo appreso nulla dalla riflessione di tutti i più grandi filosofi: da Hegel a Nietzsche, da Kant a Gadamer, Diderot, Voltaire, Schopenhauer, e tanti altri: ogni volta che parliamo di arte ci ostiniamo a considerarla un divertissement, un lusso, un momento di piacevole distrazione dopo le fatiche quotidiane. Continua a essere considerata solo un passatempo, un momento di ricreazione, una cosa dalla quale si può fare benissimo a meno. In pochi ormai sentono che l’arte non è semplicemente un diversivo, un semplice accidente, ma è propedeutica e costitutiva della vita umana. Anzi si potrebbe ben dire che l’arte è la vita stessa e senza di essa siamo ombre, siamo morti. Non ci rendiamo conto che quando ci rapportiamo con l’opera d’arte, con l’accadimento artistico, con l’esperienza estetica, che sia una mostra, un concerto sinfonico, uno spettacolo teatrale, ci predisponiamo senza volerlo, potremmo dire ontologicamente, ad una “situazione emotiva” che non è di semplice ascolto, come si è soliti dire, ma è un “luogo” dove ci offriamo ad essere partecipi di un’ aletheia, di uno svelamento, di una ulteriore e determinante comprensione del reale. Come ha colto Gadamer l’opera d’arte equivale ad una “trasmutazione nella verità” ed un ritrovamento “del vero essere delle cose”. Quando uno spettatore si trova dinanzi ad un quadro, quando entra in una sala concerti o in un Teatro, senza che se ne accorga sospende il suo quotidiano e mette il proprio essere in “ascolto della struttura profonda della Cosa”. Sia nello spettatore più attento che in quello più distratto e dis-educato questo miracolo accade a prescindere, come in una sorta di a-priori nel gioco-dell’essere. L’arte è necessaria quindi ed il Teatro in particolare vista la sua specificità di mettere al centro l’essere umano, la sua finitudine, il suo corpo. Quando vediamo Macbeth che rimane nella sua solitudine tragica e straziante, non vediamo solo quello che sta avvenendo “nello spettacolo”, vediamo il nostro Io, cogliamo il “mondo” illuminato da una luce nuova. Si apre uno squarcio di comprensione, un modo di rappresentar-ci e giustificar-ci il contingente, un modo per ordinare il nostro essere-nel-mondo, quello stesso mondo che necessita dell’uomo e della sua azione per non cadere nel dis-umano, nella malattia, nel tragicamente fallimentare. Afferma mirabilmente Diderot “Se si bandisce l’uomo, essere pensante e contemplante, dalla superficie della terra, lo spettacolo sublime e patetico della natura non è più che una scena triste e muta; l’universo tace, è invaso dal silenzio e dalla notte. Tutto si muta in una gran solitudine, ove i fenomeni, inosservati, si susseguono in modo oscuro e sordo. Soltanto la presenza dell’uomo rende interessante l’esistenza degli esseri: qual proposito può essere migliore, per chi voglia far la storia di quegli esseri, che l’accettare siffatta considerazione?[ref]Voce «Enciclopedia», in Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, ordinato da Diderot e D’Alembert, a cura di P. Casini, Laterza, Bari, 1968, p. 468.[/ref]. Non è solo una questione di divertimento quindi, di piacere, o di scegliere di concedersi una serata mondana, ma è una semplice e indispensabile necessità di conoscenza e visto che vivere è conoscere allora l’arte si offre come strumento per una vita vivente possibile. Se non seguiamo questa strada cadiamo in un pericoloso abisso, se ci precludiamo la possibilità della “relazione”, di creare, di pensare, di filosofare e quindi di conoscere, rischiamo di scadere nel non-umano. Non considerare tutto questo, non voler comprendere queste basilari certezze sarebbe una pericolosa ostinazione. Purtroppo dobbiamo registrare che in questi giorni questo tragico errore sta emergendo in tutta la sua portata e sta venendo chiaramente alla luce: la mancanza di priorità che si sta attribuendo all’arte, al Teatro, al mondo della cultura, della ricerca e dell’istruzione, ne è la dimostrazione inequivocabile. In questo tempo sciagurato e complicato abbiamo assistito come spettatori inermi e passivi allo “spettacolo” del Coronavirus. Siamo stati travolti e co-involti da una situazione inimmaginabile solo fino a qualche settimana fa. Impotenti dinanzi a scelte politiche, certo difficilmente contestabili, che ci hanno imposto forti limitazioni delle libertà personali, ci siamo ritrovati “chiusi” nelle nostre abitazioni, esclusi da ogni contatto con l’esterno, costretti a guardare con diffidenza ogni relazione sociale. Proprio una delle cose che caratterizza maggiormente il nostro essere-umani, il nostro esser-ci, il nostro essere-nel-mondo e cioè la possibilità della relazione, è la cosa che in questo momento ci è preclusa. Tutta la nostra umanità, tutto il nostro agire e conoscere non avrebbe né senso né origine senza la relazione, il confronto, la dialettica, lo scontro, l’amore: senza “l’altro da sé”, senza il polo dialettico, non c’è movimento, non c’è vita. Incredibilmente una delle locuzioni più usate e abusate nelle ultime settimane è stata proprio “distanziamento sociale”. Tutto è chiuso, tutto è morto, tutto è fermo… improvvisamente, in un colpo solo, da un giorno all’atro. Niente lavoro, niente ufficio, bar, ristorante, parco, passeggiata, amici, scuola, università, fabbrica, biblioteca, teatro, riunioni, gruppi di studio, aperitivi, negozi, nulla. Tutto è irrimediabilmente caduto nel “niente”. Il nostro vicino è diventato l’untore, il runner è irresponsabile, l’altro-da-me deve rimanere altro-da-me. Niente più dialogo, niente più relazione. E se non c’è relazione ovviamente non può esserci arte. Dialogo e relazione non sono più necessari al “movimento” della vita, non sono più ontologicamente indispensabili per far si che io esista, ma si sono trasformati in fonte di malattia, di virus, di morte. Quella morte a cui non pensiamo mai, non pensiamo più, che allontaniamo dalle nostre vite, ormai certi che la scienza prima o poi sarà in grado di eliminarla dalla nostra esistenza, come noi già l’abbiamo eliminata dal nostro linguaggio. Non è il caso di entrare nel merito delle scelte prese, probabilmente sono state dolorose ma necessarie. L’unico modo di fermare il contagio era proprio il distanziamento sociale. Ma adesso la questione sta prendendo una piega diversa e sta emergendo drammaticamente un problema sociale. Siamo tutti consapevoli che non si può chiudere tutto in eterno, non soltanto perché il nostro sistema economico, quello che credevamo imbattibile, non reggerebbe a lungo, ma anche perché è la Vita stessa che non potrebbe reggere. La morte, la malattia, il “negativo”, sono un qualcosa dal quale non si può fare a meno e la nostra pretesa di volerne a tutti i costi sfuggire non è altro che la dimostrazione, paradossale, della perversa trappola del mortifero nella quale stiamo cadendo. Proprio la fuga ossessiva dal “negativo”, dalla malattia, dalla morte non è il sintomo di una maggiore vitalità, ma al contrario, è il sintomo di un voler rimanere fermi, di un non-essere. Non andare “incontro alla tragedia della vita con un grido di sfida”, per usare una frase di Nietzsche, vuol dire rimanere immobili nell’astratto, vuol dire fuggire dall’inevitabile, vuol dire in definitiva essere già morti.
Ebbene, il trattamento che si sta riservando all’arte in questo momento, è uno dei sintomi chiari ed inequivocabili della malattia che ormai da tempo affligge il mondo contemporaneo. Proprio ora che si sta predisponendo la famosa FASE 2, quella in cui si dovrebbe decidere sulle riaperture, sul graduale ritorno alla “vita”, possiamo notare che si sta prevedendo di riaprire tutto: attività produttive, negozi, parchi, bar, ristoranti, i tabaccai erano già aperti, centri commerciali, qualcuno parla anche di riaprire i campionati, insomma tutto. L’Arte no. O meglio, si sta pensando ad una timida riapertura dei Musei, lasciando però nell’incertezza più totale i teatri, i cinema, la sale concerti, gli eventi culturali in genere. Stessa incertezza riguarda il mondo della scuola, dell’università, della ricerca. Ma quello che è ancora più grave il totale dimenticatoio nel quale è caduto il Teatro in particolare. A parte qualche buona intenzione annunciata o qualche assurda proposta, come quella di trasmettere il Teatro in TV, ossia l’antiteatro per eccellenza, costringendo quest’ultimo a chiedere l’elemosina a mamma Rai come ennesimo ultimo atto di umiliazione e prostrazione, non abbiamo udito proposte concrete ne da parte del governo ne da parte del Ministro della Cultura. Perché accade questo? Perché non consideriamo il Teatro come un “settore” necessario?
Questa scelta non è altro che la negazione della vita, la volontà del ritrarsi nel “non vivere” per vivere un po’ di più. E’ come vivere una vita da morti per evitare di morire. Ma non solo. E’ ancor di più è il sintomo dell’idea di uomo e di mondo dalla quale ci stiamo facendo dominare. Sta emergendo chiaramente una gerarchia delle riaperture. Da questa gerarchia si evince qual è la scala di valori che attribuiamo alle cose ed appare chiaramente che prevedere la riapertura “dell’arte”, dei teatri, dei cinema, soltanto per ultimi, non trova fondamento solo nel pericolo di un non meglio precisato contagio ma anche e soprattutto nella perversa e mortifera idea che “di queste cose” se ne può fare a meno. Se, come sta accadendo, su questa gerarchia delle riaperture hanno un peso, di fatto vincolante, le scelte prese da un comitato tecnico-scientifico, allora vuol dire che la Politica non fa più la Politica. Affidare “la decisione” della “riapertura della vita” alla sola “scienza”, affidare integralmente ad essa la nostra esistenza, l’intera organizzazione del reale, sarebbe un profondo errore. La scienza è condannata ad occuparsi di verità parziali, la scienza è necessariamente settoriale, questa è forse la sua forza ma al tempo stesso è il suo più grande limite. Per questo lasciata sola è irrimediabilmente perduta. Come ha fatto notare giustamente Emanuele Severino “la scienza moderna procede dall’assunto metodico di isolare dal suo contesto quella parte della realtà che essa intende studiare e controllare così l’epistème alla quale si riferisce la moderna “epistemologia”, non ha più a che fare col senso filosofico dell’epistème” [ref]Emanuele Severino, La Filosofia dai Greci al nostro tempo; La Filosofia antica e medievale, Milano, BUR Saggi, 2017, p. 29.[/ref].Il senso dell’epistème, a cui si riferisce Severino è direttamente collegato alla comprensione della totalità, della physis. Physis, come la intendevano i primi filosofi, è quella parola costruita sulla matrice indoeuropea bhu, che significa essere, e la radice bha, che significa luce, cioè l’essere nel suo illuminarsi. Potremmo dire l’essere che si manifesta, che si offre alla nostra comprensione per essere colto, e al tempo stesso, consentirci di cogliere i sensi del nostro esser-ci, divenendo così capaci di orientarci nel reale. Sarebbe necessario allora che la Politica si assumesse la responsabilità di indicare un orizzonte, di non assoggettarsi ciecamente alla scienza, me eventualmente utilizzare i suoi dati particolari per rispondere alla complessità del reale. Non è un caso che in un mondo così dichiaratamente “scientista” il settore di cui si può fare a meno, quello che può riaprire per ultimo, è proprio il settore Teatro. Non metterlo tra le riaperture urgenti, come le industrie, il ristorante, il tabaccaio, l’ agenzie delle entrare, il centro commerciale, è un preoccupante sintomo di una malattia ben più grave del Coronavirus. Senza questa rappresentazione e auto-rappresentazione non saremo più in grado di dare ordine al caos, si perderebbe il senso profondo del nostro esser-ci e perderebbe senso proprio il nostro essere gettati dentro quelle industrie, quei ristoranti, quei negozi, quei tabacchi, quei centri commerciali. Senza il Teatro, senza la mimesis, intesa in senso aristotelico e cioè non come copia pedissequa del reale ma come “rappresentazione” in grado di “illuminare” di luce nuova il mondo che ci circonda, ci allontaneremmo dal nostro essere-umani e ci avvicineremmo sempre più allo stato animale e alla macchina. Pensare che vivere senza il vitale, senza l’arte, il Teatro, l’esperienza estetica, ci possa far difendere dal dolore, dalla morte, significa non comprendere invece che solo la ricerca del senso ci mette al riparo dal dolore del non-umano, dal sentirsi un nulla in un niente.
Possiamo ben dire in conclusione che mai come in questo momento siamo dinanzi ad una scelta: cosa vogliamo farne dell’arte, del teatro, degli artisti ? in una parola cosa vogliamo fare con la vitalità, la sete di conoscenza ? Ora è arrivato davvero il momento di dirselo chiaramente: pensiamo che il teatro sia indispensabile o lo consideriamo un qualcosa di cui si può fare a meno ? E’ il momento del coraggio e delle scelte. Non è più tempo di riempirsi la bocca con parole inutili e retoriche. Se tutti noi pensiamo, se soprattutto la classe dirigente di questo paese crede che il teatro sia superfluo allora lo lasci anche morire una volta per tutte. Se pensate davvero che se ne possa fare a meno, allora basta, niente più mezze misure ed elemosine: lasciate che muoia. Ma se lo si vuole tenere in vita allora bisogna farlo veramente, bisogna metterlo una volta per tutte al primo posto, con coraggio. E metterlo al primo posto significa credere veramente che una vita senza conoscenza e senza teatro è forse una non-vita, significa pensare e soprattutto agire dimostrando davvero che si crede nel più grande insegnamento che Socrate ci ha donato: “una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”.
“Basta che c’è la salute…” (In uno stato di polizia)
di Giovanni Magrì
- “Dittatura” e “Stato di polizia” sono parole che urtano il nostro orecchio ben educato di cittadini democratici. Eppure, appartengono al “vocabolario delle istituzioni” (non solo) europee, e vi appartengono tuttora. Non come “parolacce”, né come termini di gergo. Forse, come reperti linguistici di un’epoca passata; tuttavia ancora utili per capire noi stessi, e non solo per rispondere alla classica domanda filosofica «da dove veniamo?», ma anche per interrogarci su «dove vogliamo andare?», quando la strada si fa meno dritta e sorgono degli imprevisti. Come in questi giorni.
Di dittatura parlerò dopo. Il concetto è in parte equivoco, perché la sua definizione politica può mettere in ombra quella giuridica, che pure si può dare. E tuttavia, in generale crediamo di sapere cosa intendiamo, quando usiamo la parola “dittatura”. Un po’ meno, quando sentiamo parlare di “Stato di polizia”. Perciò, su quest’altro concetto vale la pena di spendere subito due parole.
In questi giorni, le nostre strade sono presidiate dalle forze dall’ordine, in misura e con una visibilità – una presenza fisica, direi – non abituali. Ma questo è solo un indizio, non l’essenza del concetto: non è la presenza fisica più o meno invadente degli agenti di polizia e dei loro mezzi a fare, di per sé, lo Stato (che poi è anche uno stato, con la minuscola) di polizia.
Se poi – ipotesi di scuola – un gruppetto di idealisti più o meno connessi con la realtà, magari senza un vero intento provocatorio (non conscio, per lo meno), decide di manifestare in strada proprio in questi giorni per ribadire l’attualità di certi ideali e di certi eventi di “liberazione”, e viene fermato dalla polizia perché starebbe violando il divieto di assembramento, e tra le altre lamentele “di repertorio” grida allo Stato di polizia, ecco, già ci avviciniamo un po’ di più all’essenziale del concetto, ma senza coglierlo ancora, a questa distanza. Del resto, allo Stato di polizia si è sempre gridato, ad intermittenza, nell’Italia repubblicana, almeno da quando al Viminale c’era Scelba e gli agenti di pubblica sicurezza si chiamavano “questurini”. Eppure, il regime fascista era caduto da pochi anni, e non si poteva non notare la differenza…
In verità, le radici del concetto sono molto più risalenti, e in un certo senso più “nobili”.
La parola, anzitutto – “polizia”, dico – è ovviamente di origine greca: è la stessa “politèia” che si trova in Aristotele e che abitualmente si traduce con “costituzione” o “forma di governo”, che poi attraverso le lingue latine è penetrata in quelle germaniche, per esempio nell’inglese, ulteriormente ampliando la sua già vasta area di significati e però generando due parole distinte, “polity” (l’ente politico determinato, tipicamente lo Stato, ma non solo) e “policy” (la politica come linea di direzione amministrativa, tipicamente al plurale: “le politiche per l’impiego”, “le politiche abitative”, “le politiche europee in tema di immigrazione”, etc.). Ecco, direi che affine all’inglese “policy” sia da considerare l’area semantica del tedesco “polizei”. Che c’entra il tedesco, si chiederà il lettore? C’entra.
Perché – ecco una seconda radice “nobile” – se dovessi dare una definizione attendibile del concetto, non troverei di meglio, in prima battuta, che citare Voltaire: «Tout pour le peuple, rien par le peuple». Oppure (appunto: in tedesco) Giuseppe II d’Asburgo-Lorena: «Alles für das Volk, nichts durch das Volk». Sia in francese, sia in tedesco, il gioco di parole fondato sull’assonanza riesce. E, a quanto pare, l’idea è stata concepita in francese (da Voltaire, appunto), ma proclamata in tedesco (che la primogenitura sia di Giuseppe II o di Maria Teresa d’Austria o di Federico II di Prussia, sta di fatto che sia gli Asburgo sia gli Hohenzollern erano più inclini dei Borbone di Francia ad ascoltare i filosofi illuministi). Questo è quel che troverete in qualsiasi buon libro di storia, alla voce “dispotismo illuminato”. E lo Stato di polizia, anzi, il Polizei-Staat, è la forma di governo che corrisponde al modello del cosiddetto dispotismo illuminato.
Ora, cerco di organizzare le idee. Nella locuzione “Stato di polizia”, per “polizia” s’intende il complesso degli agenti e dei mezzi al servizio del potere di governo: non solo, quindi, l’attuale “polizia giudiziaria” (alle dipendenze funzionali della magistratura inquirente per reprimere i reati e perseguire i loro autori), né solo il complesso delle cd. forze dell’ordine che svolgono compiti di pubblica sicurezza, ma (in senso proprio) ogni funzione amministrativa pubblica e (per metonimia) tutti coloro che vi sono addetti e tutti i mezzi che vi sono impiegati. La polizia, in questa accezione, c’è da quando c’è una funzione pubblica, da quando, cioè, determinati compiti, non solo di sicurezza, ma anche di benessere, sono affidati non alle cure dei privati (ognuno per sé) ma ad una organizzazione pubblica, e a maggior ragione da quando quell’organizzazione fa capo allo Stato e l’assolvimento di quei compiti è parte degli obblighi assunti col cd. contratto sociale. Ciò che però caratterizza la polizia nello Stato di polizia (e distingue quest’ultimo dallo Stato di diritto) è che il governo cura l’assolvimento dei compiti di polizia non attraverso la legge e nel rispetto della legge, ma sovvenendo direttamente ed immediatamente ad esigenze particolari e concrete e prescindendo dalle previsioni generali e astratte della legge (che in tanto può prevenire, limitare e controllare l’esercizio del potere di governo, in quanto è adottata da un potere distinto, tipicamente dal Parlamento, organo rappresentativo del popolo, qui in quanto insieme dei “governati”).
E qual è il presupposto “ideologico” di un tal modo di agire? È evidente: che i governanti (i sovrani) hanno a cuore il bene dei governati (i sudditi), anche perché, dopo Hobbes e a metà tra la decapitazione di Carlo I Stuart e quella di Luigi XVI, hanno imparato (chi meglio, chi peggio) che il loro potere si fonda non solo e non tanto sull’elezione divina e sulla legittimità dinastica, quanto soprattutto sull’obbedienza volontaria dei sudditi stessi (per svariati motivi: non solo la paura, ma anche la convenienza, per esempio); e proprio per questo, si estendono i compiti di polizia (non ancora sanità, istruzione e previdenza sociale, magari; ma, oltre alla repressione dei reati e alla garanzia della proprietà, anche le opere di pubblica utilità: strade, ponti, ricoveri…). Tuttavia, a sapere quale sia il bene pubblico sono solo i governanti (magari consigliati dagli esperti…) e non i governati, i quali, bene informati (l’inciso è fondamentale), possano essere consultati e magari decidere per sé e su di sé (diventando, così, da sudditi che erano, cittadini); e ciò perché, in ultima analisi, la cura della sicurezza, ma anche del benessere, dei sudditi è, come si usava dire appunto nel XVIII secolo, una “graziosa concessione” del sovrano, non (ancora) un diritto dei cittadini cui corrisponda, da parte dei governanti, un vero e proprio obbligo e una posizione di “servizio”, accompagnata da un potere solo funzionale, così come sarà dalla metà del XIX secolo, con lo Stato di diritto e il parlamentarismo borghese.
Ecco: questo è lo Stato di polizia, le sue forme (puntuali atti di governo senza riserva di legge parlamentare) e i suoi fondamenti ideologici. Con un notevole tasso di semplificazione, che il lettore mi vorrà perdonare facendomi credito della sua fiducia. Sicché, tornando al nostro esempio di scuola, il nostro gruppetto di manifestanti fermato dalla polizia non avrà nulla di che lamentarsi se gli agenti potranno dimostrare di avere esercitato un potere interdittivo previsto dalla legge (e, in particolare nel secondo Novecento, anche dalla Costituzione); e se gli sarà accordata la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per fare dichiarare, invece, che quel potere è stato esercitato, eventualmente, in modo illegittimo, per fare rimuovere l’impedimento a manifestare e fare revocare qualsiasi misura limitativa della libertà personale o di altri diritti civili. Ove mancasse una di queste condizioni, e i nostri manifestanti si trovassero in balìa della decisione puntuale del potere di governo e della sua applicazione arbitraria, unilaterale, indiscutibile da parte degli organi di polizia, allora avrebbero scoperto, loro malgrado, di vivere in uno Stato di polizia.
Ma a questo punto, almeno sulla prima “parolaccia”, ne sappiamo abbastanza per lasciare le ipotesi di scuola e venire ai casi di cronaca.
- Dunque: tutte le misure di “contenimento” o di “distanziamento sociale” adottate sul territorio nazionale italiano a partire dal 1 marzo scorso hanno comportato la limitazione di diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, anche in posizione di particolare rilievo (penso, con un occhio a numerosi casi di cronaca, soprattutto agli articoli 14 e 16: ma l’elenco dovrebbe essere assai più lungo). L’articolo 16, in particolare, è emblematico: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza». Certo, nel nostro caso i motivi di sanità e di sicurezza ricorrono; ma non è secondario che le limitazioni ad essi legate debbano essere stabilite in via generale dalla legge.
I giuristi in questi giorni ci hanno messo più di una toppa, a maggior ragione considerato che l’ormai famoso “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” non è un atto tipico cui la Costituzione attribuisca forza e vigore di legge (per capirci: il decreto legge è sì un atto avente forza di legge, che può essere legittimamente emanato solo se sussiste un caso straordinario di necessità e urgenza, e che cessa di vigere dopo 60 giorni, salvo l’obbligo del Governo di presentare il decreto, il giorno stesso in cui lo emana, alle Camere per la sua conversione in legge ordinaria; ma, anche per un primo vaglio di costituzionalità, il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica, non certo adottato con D.P.C.M.). Se capisco bene, si è riconosciuto molto (troppo?) facilmente al Presidente del Consiglio una sorta di potere commissariale di salute e incolumità pubblica su tutto il territorio nazionale, cui conseguirebbe il potere di emanare ordinanze “contingibili e urgenti”, analogo a quello che hanno, rispettivamente, il Sindaco e il Prefetto sui territori del Comune e della Provincia; e non si è posto un problema formale di riserva di legge e di gerarchia delle fonti. Bene: poteva anche essere il caso. Ma poiché ora la questione si ripropone con riferimento alla cd. fase 2, cioè alla graduale riapertura delle attività economiche e, correlativamente, della libera circolazione delle persone, è abbastanza interessante osservare con quali argomenti si sta sviluppando un dibattito che deve, sì, concludersi in tempi relativamente brevi, ma non è più compresso dall’urgenza di far fronte a una curva precipitosamente crescente della mortalità.
Dunque? Il Presidente del Consiglio, già affermato giurista, risolve tutto dichiarando che «al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani» (11 marzo) e, un mese dopo, che “abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto» (10 aprile). Il presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” del 20 marzo, si lamenta dei colleghi che “cavillano” e fanno gli “azzeccagarbugli”: quelle del Governo «per ora mi paiono misure a favore della più democratica delle libertà: libertà dalla malattia e dalla morte. […] Quale diritto è più fondamentale del diritto di tutti alla vita e alla salute?». Ma soprattutto, «nelle situazioni di emergenza lo scopo giustifica i mezzi». Soggiunge Zagrebelsky: «Ma certamente non tutti. Solo quelli che abbiano ragionevolmente quella finalità». Di che ragionevolezza, o razionalità (in uno scritto non scientifico è difficile distinguere), stiamo tuttavia parlando? Della razionalità strumentale, dell’adeguatezza “tecnica” del mezzo al fine? Ma allora la riserva dell’insigne costituzionalista è (giuridicamente) pleonastica! I mezzi sono tali proprio perché rivolti a un fine (qui non si richiede neppure che siano “i più adeguati”, “proporzionati” o “commisurati” ad esso; ma debbo ritenere che la forma-intervista abbia fatto premio sul sicuro mestiere del giudice costitituzionale). E tuttavia, l’agire giuridico si distingue dall’agire tecnico (finché se ne vuole distinguere) proprio perché in diritto lo scopo non giustifica qualsiasi mezzo, ma solo determinati mezzi possono essere giuridicamente efficaci (in quanto anzitutto validi), dal momento che solo quei mezzi soddisfano i requisiti formali che li rendono tali da contemperare i diversi interessi, valori, beni coinvolti nella fattispecie: fini molteplici, cioè, e potenzialmente o attualmente confliggenti.
In tempi non sospetti (1921) Carl Schmitt si impegnò in una definizione di dittatura dal punto di vista della forma giuridica (non del contenuto politico) e scrisse che dittatura «significa il dominio di un modo di procedere interessato unicamente a conseguire un risultato concreto, l’eliminazione del rispetto – essenziale al diritto – per la volontà opposta di un soggetto di diritto, qualora questa volontà si metta di traverso al raggiungimento del risultato; quindi [dittatura] significa anche svincolamento del fine dal diritto». Dunque: Schmitt ci dice che essenziale al diritto è il “rispetto” per una volontà soggettiva astrattamente capace (perché a sua volta giuridicamente riconosciuta) di ostacolare il raggiungimento del risultato; se essenziale è invece il raggiungimento del risultato, con qualsiasi mezzo e, quindi, possibilmente col mezzo più efficace e più efficiente, anche “mancando” di quel rispetto (che non vuol dire necessariamente accoglimento della volontà opposta), allora siamo ancora nel campo delle “tecniche” di governo, ma già un passo fuori dal diritto.
Siamo nella dittatura? Politicamente, dubito, ed anzi mi sentirei di escludere, che vi sia la deliberata volontà di violare i diritti e le garanzie liberal-democratici e, soprattutto, di farlo in modo permanente e strutturale. “Dittatura”, però, oltre che un’ingiuria politica può anche essere un istituto (para-) giuridico; lo era, per esempio, nella res publica romana, con fini (anche molto generici: rei publicae constituendae causa et legibus scribundis) e per un tempo (sei mesi) pre-assegnati dall’ordinamento giuridico. L’essenza di questo istituto è magistralmente ricordata dallo stesso Schmitt: una sospensione del diritto, allo scopo di (ricostituire le condizioni per) attuare il diritto stesso. E, ci ricorda sempre Schmitt, «il fine buono, vero o presunto, non può legittimare alcuna violazione del diritto, come la realizzazione di uno stato di cose conforme a giustizia non conferisce di per sé autorità legale». Se, interrogato sulla dittatura, un giurista non ricorda (per lo meno, anche) questo, allora come giurista non sembra avere molto altro da dire sull’argomento.
- A questo punto, comincio a capire l’uscita di Giorgio Agamben: non la prima, quella tanto criticata dello scorso 11 marzo, ma una più recente, resa pubblica sotto il titolo Una domanda il 14 aprile. Così Agamben: «Un’altra categoria che è venuta meno ai propri compiti è quella dei giuristi. Siamo da tempo abituati all’uso sconsiderato dei decreti di urgenza attraverso i quali di fatto il potere esecutivo si sostituisce a quello legislativo, abolendo quel principio della separazione dei poteri che definisce la democrazia. Ma in questo caso ogni limite è stato superato […]. È compito dei giuristi verificare che le regole della costituzione siano rispettate, ma i giuristi tacciono. Quare silete iuristae in munere vestro?». Non si tratta, per come intendo i termini della questione, di un “conflitto delle facoltà” tra costituzionalisti e virologi per stabilire chi debba “dettare la linea” nell’emergenza presente (e a maggior ragione in quella a venire, che forse non sarà emergenza sanitaria ma certamente sarà emergenza sociale); si tratta piuttosto di una “lotta per la sopravvivenza” che i giuristi sono invitati a combattere con se stessi, per decidere se preservare la loro ragione di esistenza (culturale e civile) o abdicare, in nome del “buon senso” e/o del “senso comune”, a quelle ragioni squisitamente formali che definiscono la loro disciplina, in mezzo alle altre.
Se non che, Agamben da un mese ripete essenzialmente questa tesi: «Noi di fatto viviamo in una società che ha sacrificato la libertà alle cosiddette “ragioni di sicurezza” e si è condannata per questo a vivere in un perenne stato di paura e di insicurezza». Tesi di sicura presa tra chi orecchia la filosofia, perché richiama il Freud de Il disagio della civiltà, più alla lontana il Canetti di Massa e potere o il Marcuse di Eros e civiltà ma, soprattutto, la fondazione hobbesiana dello Stato e del contrattualismo dei moderni. E tuttavia, anche davanti a questa prospettazione un giurista consapevole dovrebbe avere qualcosa da eccepire. Anzitutto perché i termini in questione – sicurezza e libertà – sono univoci solo in quanto proiezioni della psicologia di massa “catturate” dalla propaganda politica, ma sono estremamente ambigui ed esigono di essere precisati se devono essere trattati come beni giuridici o valori costituzionali tra cui scegliere: per tacere della libertà, è evidente, per esempio, che altro è la minaccia alla sicurezza della vita rappresentata dal virus, altro è la minaccia a qualsivoglia altro bene giuridico rappresentata dall’ingresso, nel territorio dello Stato, di migranti “irregolari”. Ma soprattutto – e così muovendo da Agamben ci riallacciamo agli “stili comunicativi” del presidente Conte e del professor Zagrebelsky – perché presumiamo di trovarci in regime di “legalità costituzionale”, dove varie pretese sono tutelate come “diritti fondamentali” e questi ultimi possono evidentemente entrare in conflitto tra loro; allora, il conflitto non si dirime sacrificando una volta per tutte la libertà alla sicurezza (o viceversa), né tanto meno affermando che un diritto è più fondamentale degli altri; bensì – ci è stato insegnato per circa mezzo secolo – praticando una tecnica specifica, chiamata “bilanciamento” o “ponderazione”. Essa, ci insegna il teorico del diritto, consisterebbe nella «valutazione comparativa, condotta caso per caso, di quale principio prevalga in relazione a quel singolo caso», per cui «i rapporti fra princìpi costituzionali divengono così mobili, mutevoli da caso a caso»; tenendo conto, peraltro, che, «almeno nel controllo di costituzionalità accentrato, ‘caso per caso’ non significa ‘in relazione a ogni singolo caso specifico’, ma ‘in relazione a ogni singolo caso generico’ [ad ogni fattispecie astratta, si potrebbe dire]. A differenza dei giudici ordinari, infatti, la Corte costituzionale non decide su fatti, ma su norme (generali e astratte)» (così M. Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica, Giappichelli, Torino 2003, pp. 241-43).
Come si vede, questa tecnica del “bilanciamento” implica un ragionamento complesso: essa esige che si definisca il significato dei due (o più) principi coinvolti, che si definisca altresì la fattispecie astratta da disciplinare (o, nel giudizio della Corte, quella già disciplinata da una legge ordinaria) e che si valuti se, nella fattispecie in esame, i principi possano essere contemperati o, dove ciò non sia possibile, quale dei due debba prevalere in quel caso; con un giudizio che, d’altra parte, non può essere improntato al criterio di gerarchia né a quello di specialità (come si farebbe con norme che assumano la veste di “regole”) e che perciò non può consistere in una mera, immediata sussunzione. Al di là dei tecnicismi giuridici: in sostanza, si tratta di un ragionamento che si muove su più livelli di astrazione, e che richiede di attribuire un diverso peso a diversi fattori di somiglianza, i quali per parte loro sono irriducibili alla quantità di note comuni tra due o più fattispecie, perché hanno a che fare invece con i significati, le intenzioni normative e le strutture di valore. È un ragionamento, dunque, che molto difficilmente può essere svolto, o anche solo “imitato”, da una macchina o comunque servendosi di un algoritmo, perché non può consistere nell’esecuzione di un “programma” interamente predefinito, e semmai si espone al rischio che «l’interprete lavori sulla base di semplici sue “intuizioni valutative”». Anche per questo, il bilanciamento trova il suo luogo elettivo in una discussione collegiale, che si svolga sul jus conditum nella camera di consiglio della Corte costituzionale, o, de jure condendo, nell’aula del Parlamento in sede legiferante. La forma dell’atto (legge ordinaria, o tutt’al più decreto legge, anziché D.P.C.M.) trova dunque una spiegazione politico-sostanziale.
Ma, di tanta complessità, nel dibattito attuale v’è (troppo) scarsa traccia. Non traspare la consapevolezza che il primato della tutela della salute possa essere semmai, e legittimamente, un risultato del bilanciamento, non la sua premessa (ché, altrimenti, nessun vero bilanciamento avrebbe luogo). Né che il diritto possa e debba giudicare i mezzi impiegati (compresa la forma degli atti), non per la loro adeguatezza a un fine unico, ma per il loro rispetto di fini molteplici (o, forse meglio, plurali). Né che “sicurezza” (e, a dirla tutta, anche “libertà”) si dicano in molti modi, cioè possano significare molte cose diverse per diverse persone e diversi gruppi in tempi e condizioni diversi, e non si bilancino, né si scambino, mai una volta per tutte. In generale, l’impressione è che i giuristi non trovino il coraggio di dimostrare ai loro interlocutori che risposte come “sì e no”, “dipende”, “non è così semplice” o addirittura “non lo so” non sempre sono “cavilli” da “azzeccagarbugli”, ma (per lo meno: talvolta) esprimono senso della complessità, disponibilità al dialogo e, in ultima analisi, rispetto per l’alterità (tema, questo, caro da sempre a Bruno Montanari). Che cosa ci è successo? E che cosa è successo alla società civile, per cui i nostri discorsi non vengono più compresi?
- A queste domande sarà il caso di rispondere e io stesso mi riprometto di farlo, in altra sede. Qui tengo solo a precisarne lo spirito. Come ho già accennato, non ho inteso sostenere che in atto vi sia nel nostro Paese la volontà politica di instaurare uno Stato di polizia o una dittatura. Ve n’è, però – e di questa segnalazione mi assumo la responsabilità – la possibilità giuridica, accompagnata dall’assordante silenzio di alcuni tra coloro che sarebbero attrezzati per riconoscerne da lontano i contorni: i giuristi (non tutti ovviamente silenti, e tra i molti che hanno levato la voce mi limito a segnalare gli interventi, equilibrati e precisi, di Sabino Cassese e di Giovanni Pitruzzella). Ora, il diritto – questo lo sa chi lo pratica, e forse è difficile da cogliere dall’esterno, ma vi prego di rifletterci – non serve per distinguere i “buoni” dai “cattivi” e, in questo caso, per dubitare della “buona fede” del Governo (sulla quale metterei la mano sul fuoco, a titolo personale; ma questo non ha davvero nessuna importanza), bensì per essere relativamente garantiti che chiunque, animato da ottime o da pessime intenzioni, tuttavia non possa nuocere più di tanto ai beni fondamentali della convivenza. In quest’ottica, diventa fondamentale il fattore-tempo: se l’emergenza ha imposto una de-formazione delle forme giuridiche di garanzia, ebbene, questa deformazione deve durare il meno possibile e, in ogni caso, solo fin tanto che i tempi dell’emergenza non ricadano sotto la capacità di previsione e di gestione delle forme ordinarie. Salvo che non si voglia prendere atto – per restare nelle varianti semantiche derivate dalla parola “forma” – che la “deformazione” è stata l’annuncio di una “trasformazione”, sempre possibile e talora necessaria, ma bisognosa di una nuova legittimazione.
Se i virologi, gli immunologi, gli infettivologi, gli epidemiologi sono – a buon diritto – rigorosi e, auspicabilmente, anche trasparenti nel comunicare i loro parametri di valutazione del rischio e i loro protocolli di contenimento dell’infezione, i giuristi mancherebbero al loro dovere di studiosi e di cittadini se fossero omertosi nel comunicare un punto: non tanto che siamo in uno Stato di polizia, ma, piuttosto, che c’è una decisione grave da prendere (molte, in verità, che girano intorno a un paio di dilemmi etici da chiarificare); che non ne sappiamo abbastanza per eludere il rischio e la responsabilità della decisione; che la “tecnologia” per condividere la responsabilità delle decisioni in condizioni di incertezza esiste in Occidente da almeno duemilacinquecento anni, e si chiama “politica”.
La quale, ovviamente, quanto più si dispone ad affrontare (insieme) il novum, tanto più si giova di conoscenze acquisite: delle conoscenze sperimentali bio-mediche, così come del deposito di esperienza storico-sociale e istituzionale rinvenibile ad esempio nella Costituzione, ma più in generale nella cultura giuridica. Tutte queste conoscenze sono preziose per immaginare (rectius: rappresentarci) ciò che non sperimentiamo direttamente, e così definire sempre meglio ciò su cui si deve decidere. Ma, per quanto auspicabilmente sempre più ridotto, lo spazio della decisione, cioè dell’incertezza, del rischio e della responsabilità, non può essere logicamente assorbito nello spazio dell’informazione. Ha detto, in questi giorni, il “vegliardo” Habermas, in un’intervista rilasciata a Le Monde e tradotta per La Repubblica: «Da un punto di vista filosofico, mi colpisce che la pandemia oggi costringa tutti a riflettere su qualcosa che prima era noto ai soli esperti. Oggi, tutti i cittadini stanno imparando come i loro governi debbano prendere decisioni ben sapendo i limiti delle conoscenze degli stessi virologi consultati. Raramente, il terreno per l’azione in condizioni di incertezza è stato illuminato in modo così vivido. Forse questa esperienza insolita lascerà il segno nella coscienza della sfera pubblica». Per un verso, sarebbe ovvio che fosse così. Per un altro verso, non sembra una descrizione verosimile del modo in cui la “coscienza della sfera pubblica” sta evolvendo, sotto i nostri occhi, in Italia e in molti altri paesi occidentali. Ma se Habermas, dal suo osservatorio tedesco, sperimenta, e ci racconta, un altro modo di comunicare il sapere scientifico e di condividere la decisione politica, ebbene, anche questo vale per noi come minimale esercizio di utopia razionale.
BRASILE: NON C’È UN’ALTRA ALTERNATIVA
di Ricardo Antunes
traduzione di Antonino Infranca
(Articolo pubblicato nella rivista Serrote, n°. 33, novembre 2019, San Paolo)
La piaga della schiavitù
Nei nostri tristi tropici, il lavoro è stato quasi sempre una forma di vilipendio. Il “quasi sempre” decorre qui dall’eccezionale esperienza vissuta nel periodo in cui il Brasile non era ancora il Brasile. Prima di essere “scoperti” dal mondo “civile”, il lavoro esercitato qui, durante molti secoli, fu in comune, autonomo e autosostenuto, realizzato da comunità indigene, il cui la maggior parte del tempo di vita era dedicata alla fruizione e al piacere.
I portoghesi, che arrivarono nel 1500, ai primordi dell’accumulazione primitiva e del mercantilismo, ci insegnarono molte “novità”: la necessità della produzione di merci per la vendita e il profitto delle borghesie forestiere; la pragmatica dello scambio e i suoi scambi disuguali e, dopo infruttiferi tentativi di schiavitù indigena (che nell’America ispanica ebbero tristemente una vigenza durevole), ci imposero il lavoro sotto la forma più abietta, compulsiva e violenta che conosciamo: la schiavitù.
Così nasceva la giovane Colonia, che un giorno fu concepita come prototipo del “paese cordiale”. Questa lunga fase del passato, quindi, modellò indelebilmente la nostra storia del lavoro, che contempla, da una parte, coaguli di work, in particolare guardando alla nostra epoca pre-Scoperta, e, dall’altra, molte piaghe di labour, a partire dalla colonizzazione.
Dopo secoli di schiavitù africana (che tanti profitti darà alle borghesie mercantili), una confluenza di contraddittori movimenti ci portò, più che tardivamente, all’abolizione del flagello della schiavitù.
Ma, d’altra parte, il mondo coloniale (tanto al Nord, quanto nei Caraibi e nel Sud) ha vissuto un’enorme era di ribellioni negre contro la schiavitù, che la nostra storia ufficiale, fino ad oggi, ha cercato di mettere a tacere. Dal nostro fertile Quilombo dos Palmares* fino all’eroica e pioniera Rivoluzione Sociale di Haiti, il suolo coloniale in fiamme esigeva la fine della schiavitù.
Ma il mondo borghese emergente, risultato da una curiosa simbiosi tra prussianesimo e aristocrazia coloniale-schiavista che qui prosperò, seppe ritrovarsi. Finita la schiavitù, i lavoratori/trici negri/e furono esclusi dal nuovo mondo del lavoro salariato che si espandeva nell’universo urbano e nel locus industriale. Divennero nuovi schiavi, dato che le lavoratrici negre divennero una specie di “riserva di mercato” nelle case dei nuovi baroni bianchi, ampliando ancora di più le spaccature esistenti nella nostra divisione socio-sessuale e razziale del lavoro.
Per il nuovo mondo urbano-industriale, il tocco di classe signorile era ancora più presente: l’immigrato bianco, europeo, aveva il “passaporto di entrata” preferenziale. Italiani, tedeschi, tra gli altri, sempre molto candidi, furono scelti per l’esercizio del lavoro libero e salariato, relegando la forza-lavoro negra negli angoli della schiavitù domestica e in altre attività marginali. E così la Repubblica del liberalismo dell’esclusione riuscì a prolungarsi fino al 1930.
L’enigma della Consolidazione della Legislazione Lavorista
Fu con l’avvento del Varguismo* che tutto sembrò cambiare. Un curioso latifondista delle Pampe riuscirà, infine, a fermare la strana Repubblica del Caffè con Latte, per “modernizzare” il paese e trarlo fuori dall’arretramento. Guidando un movimento che fu più che un golpe e meno che una rivoluzione, Vargas seppe ridurre il potere della borghesia del caffè, senza escluderla dal nuovo raggruppamento, tessuto tra le diverse frazioni delle classi dominanti rurali, aggregando anche la borghesia industriale emergente. Ridisegnò un nuovo blocco di potere il cui condottiere spingeva la costruzione di un progetto nazionale, industrializzante e statale.
Ma, al contrario della fase repubblicana precedente, il Varguismo aveva la chiara coscienza che la riuscita di questo progetto non poteva prescindere dall’incorporazione della classe lavoratrice, sebbene questa “partecipazione” si realizzasse fuori del quadro dell’autonomia e dell’indipendenza di classe.
Ma, come contare sull’appoggio della classe lavoratrice urbano-industriale, senza scontentare il dominio borghese? È esattamente qui che entra in campo la legislazione sociale protettrice del lavoro. Introdurre e istituzionalizzare questo nuovo regolamento giuridico del lavoro risolveva tre equazioni in qualche misura contraddittorie.
Primo, garanzia di una nuova base sociale di appoggio al Varguismo, in modo da dargli forza e sostegno sociale di massa, necessari per riorganizzare l’equilibrio instabile tra le distinte frazioni borghesi che si disputavano l’egemonia in questo nuovo periodo.
Secondo, regolamentazione di importanti rivendicazioni provenienti dalle lotte operaie, che si intensificarono a partire dallo storico Sciopero Generale del 1917 e ricorrenti all’inizio degli anni Trenta, azioni queste che esigevano la creazione di un quadro protettivo al lavoro, praticamente inesistente durante la Repubblica Vecchia, dove la questione sociale era intesa come “caso di polizia”. Toccò a Vargas dargli una formattazione dentro l’Ordine.
E terzo, la regolamentazione della forza-lavoro stabiliva un livello minimo necessario per l’accumulazione del capitale (la determinazione del salario minimo, per esempio) e per il consolidamento di un solido mercato interno, elementi fondamentali per l’espansione di un progetto di industrializzazione, capace di spingere e servire gli interessi industriali in ascesa.
E fu così, in modo allo stesso tempo conflittuale e necessario, contraddittorio e imperioso, che le rivendicazioni operaie si andarono convertendo, nel corso degli anni Trenta, in leggi lavoriste e, successivamente, nel 1943, sanzionate e consolidate in un unico documento. Nasceva, allora, la Consolidazione della Legislazione Lavorista, che nascondeva al suo interno un chiaro enigma: aveva l’apparenza di dare e l’effettività della concessione. E finì per costituirsi, per la classe lavoratrice, nel corso di tanti decenni di vigenza, in una specie di costituzione del lavoro in Brasile. Forse, non c’è, nella storia repubblicana brasiliana, nessun documento con tanta forza popolare, con tanta accettazione nel seno della nostra classe operaia.
Questa ingegnosa costruzione della Consolidazione della Legge Lavorista aveva, intanto, nitido carattere bifronte: i diritti lavoristi furono effettivamente istituiti in vari punti importanti. Ma, allo stesso tempo, l’embrionale autonomia sindacale esistente (risultante dalle influenze anarco-sindacaliste e socialiste presenti nelle lotte operaie precedenti) fu completamente repressa, mediante l’obbligatorietà dell’unicità sindacale (ossia, era possibile soltanto l’esistenza di un unico sindacato riconosciuto per legge); dello “statuto modello” che doveva essere approvato dal Ministero del Lavoro; della proibizione di qualsiasi attività politica o ideologica nei sindacati, così come del controllo dello Stato delle loro risorse, mediante la tassa sindacale obbligatoria. E, last but not least, le masse salariate delle campagne furono escluse da qualsiasi diritto della Consolidazione della Legge Lavorista, esigenza dei settori agrari dominanti. Il latifondista delle Pampe dovette, ancora una volta, inchinarsi al prussianesimo coloniale.
Si consolidava, allora, il mito varguista del “Padre dei poveri” e dello Stato benefattore. E fu così che questa legislazione sociale del lavoro, con i suoi inciampi e scossoni, divenne longeva e attraversò i decenni seguenti, fino ad affrontare con il Golpe del 1964.
Durante la dittatura militare, come sappiamo, si ampliarono gli elementi di controllo sindacale statale – il cosiddetto sindacalismo di Stato – e si introdussero fratture nei diritti lavoristi, come l’eliminazione della legge di stabilità e la sua sostituzione con il Fondo di Garanzia del Tempo di Servizio*. Qui l’obiettivo era aumentare il turn over della forza-lavoro, capace di comprimere i livelli salariali a beneficio degli interessi borghesi, oltre al fatto che la dittatura proibì il diritto di sciopero (che era stato approvato nella Costituzione del 1946, così come la legge della stabilità).
Con molte lotte, resistenze, scioperi e rivolte, la dittatura militare arrivò alla sua fine, piegando, ma non eliminando la Consolidazione della Legge Lavorista. E fu nella cosiddetta “Nuova Repubblica”, con la promulgazione della Costituzione del 1988, che furono introdotti nuovi elementi (sebbene insufficienti, è necessario aggiungere) al capitolo referente alla democratizzazione sindacale. Per quello che riguarda i diritti del lavoro, ci fu un significativo ampliamento.
Ma un nuovo uragano si doveva abbattere sul nostro paese.
L’abbandono neoliberale
In Brasile, questo movimento iniziò con Collor e guadagnò consistenza con Fernando Henrique Cardoso, eletto per conferire una “razionalità” che non esisteva con Collor. Nell’universo della legislazione lavorista, Cardoso battagliò quanto poté per decostruire la Consolidazione della Legge Lavorista.
Poi Lula si equilibrò con un compromesso sociale di conciliazione di cui beneficiavano espressamente tutti i grandi capitali, ma riservava una piccola parte per la popolazione più povera. Con Dilma, intanto, il mito petista crollò e ci fu l’ecatombe.
Le ribellioni del giugno 2013 mostravano che i malcontenti sociali colpivano in pieno anche il Brasile. Con la crisi economica, che si aggravò a partire dal 2014, in un contesto in cui le denunce di corruzione si accumulavano, il golpe giudiziario-parlamentare approvò un impeachment che mise fine all’era del PT.
Iniziava, allora, una nuova controrivoluzione preventiva in Brasile, con il terziarizzato Temer scelto per realizzare la devastazione sociale. In relazione ai diritti del lavoro, i capitali esigevano la flessibilizzazione, la terziarizzazione e l’approvazione del lavoro intermittente (vedi le 101 proposte per la “modernizzazione” lavorista della Confederazione Nazionale dell’Industria del 2012).
La terziarizzazione si ottenne con l’approvazione del Progetto di Legge Costituzionale 30/2015, che eliminò la separazione tra attività-mezzo e attività-fine. Il suo significato è più che evidente: riduzione di costi (sempre a scapito del lavoro), compressione salariale e aumento della frammentazione della classe lavoratrice in modo da restringere l’azione dei sindacati. Successivamente, nei rantoli del suo governo, Temer estese ancora enormemente la terziarizzazione nel settore pubblico.
La flessibilizzazione del mercato del lavoro, la prevalenza del negoziato sul legiferato, il lavoro insalubre ampliato per le lavoratrici, le restrizioni alla Giustizia del Lavoro, tra tanti altri punti nefasti, furono consustanziati nella Riforma Lavorista (Legge 13.467) nel 2017. E se tutto questo già non bastasse, questa vera controriforma introdusse ancora uno dei più nefasti elementi presenti nel mondo del lavoro contemporaneo: il lavoro intermittente. A partire da allora, lavoratori e lavoratrici rimangono disponibili per il lavoro, ma ricevono soltanto se sono chiamati. Il tempo in cui aspettano, intanto, non è remunerato. Si convertono in ciò che ho denominato ne Il privilegio della servitù [di prossima pubblicazione in italiano], nei nuovi schiavi digitali di Uber, 99, Cabify, iFood, Glovo…
Con la vittoria elettorale di Bolsonaro e la sdrucciola combinazione tra neoliberalismo estremo e autocrazia tutelata, i risultati disastrosi in relazione al mondo del lavoro si approfondiscono. La Controriforma lavorista, che era ostentata come capace di incrementare il mercato del lavoro, ci offre un contingente di disoccupati di circa tredici milioni, oltre a quasi quattro milioni che vivono la “disoccupazione per scoraggiamento”, contando anche una popolazione lavoratrice sottoutilizzata vicina a quasi trenta milioni.
Fu questa l’eredità che l’intermittente Temer lasciò all’imprevidente Bolsonaro e, affinché la corrosione sociale sia completa, oltre alla demolizione della previdenza pubblica, il governo-di-tipo-lumpen offre ancora l’indecorosa proposta della Tessera del Lavoro “Verde e Gialla”, dove «il contratto individuale prevarrà sulla Consolidazione della Legge Lavorista» per i giovani in cerca di lavoro, secondo quanto risulta dal programma elettorale dell’ex-capitano. Se questo tragico scenario si concretizzerà, che resterà, allora, per la classe lavoratrice?
Qui, come altrove, il lavoro, inteso come valore, è diventato un disvalore, per creare plusvalore. Se così è nel sistema del metabolismo sociale del capitale, sarà necessario reinventare un nuovo modo di vita. There is no other alternative. Questo è l’imperativo cruciale del nostro tempo.
* Comunità autonoma di africani fuggiti dalla schiavitù, occupava un’ampia zona nel Nord-est del Brasile.
* Movimento politico populista nato attorno a Getulio Vargas, dittatore e presidente del Brasile tra il 1930 e il 1945 e tra il 1950 e il 1954.
* Fondo versato dal datore di lavoro a garanzia del lavoratore e pari all’8% del salario annuo.
Eurocentrismo e Transmodernità
di Enrique Dussel
traduzione di Antonino Infranca
Il testo di Dussel che presentiamo al lettore italiano è tratto dall’intervista “Critica desde America latina: filosofia, politica, modernidad”, rilasciata a Nicolas Del Valle Orellana e pubblicata nella rivista Pleyade, n*. 21, gennaio-giugno 2017.
Sostengo che la filosofia europea non è universale, perché è europea. Europa ha una centralità tale che si manifesta come il soggetto della modernità, ammesso anche dalle sue colonie come l’universale. Ma, in senso stretto, è la pretesa di universalità di una particolarità europea. Conseguentemente, si deve riportare questa universalità alla sua particolarità, si deve “provincializzare l’Europa”, come dicono quelli dell’India e dell’America latina. Pensare l’Europa come una particolarità, consentirebbe l’instaurazione di un dialogo orizzontale e non verticale come è stato fino adesso.
Siamo “periferici”, del Terzo Mondo, e qui la Filosofia della Liberazione pone una questione intorno al pensiero europeo, giapponese, russo, latinoamericano, africano, del mondo arabo, del sudest asiatico e finanche della Cina, che non è mai stata colonia, ma sì periferica. Pensiamo al mondo, non alla filosofia universale europea. Soltanto l’europeo è al centro di un mondo.
Qui sta il germe del pensiero decoloniale, che significa dire “smettiamo di essere colonia”. Decoloniale, anticoloniale, ma la colonialità assume un altro senso pensandosi globalmente. La Filosofia della Liberazione è la prima filosofia della storia mondiale che pone l’universalità della filosofia, senza un centro e una periferia, senza che neghi sé stessa e che accetti l’eurocentrismo come avviene dovunque: in India, in Cina, in Africa. Io mi muovo per il mondo e vedo l’accettazione di Hegel come pensatore universale. Nessun’altra cultura aveva uno Hegel nell’Età Moderna. I cinesi avevano grandi pensatori, ma smisero di avere grandi pensatori nei secoli XVI e XVII. Non c’è nessun pensatore cinese, né indù, né islamico che dica qualcosa al mondo; si sono colonizzati, si sono “provincializzati”.
La Modernità inizia nel 1492, ma nessuno dei cultural studies lo pensa, per loro la Modernità inizia con l’Illuminismo, ed è una questione principalmente anglosassone. Il passaggio dal coloniale al decoloniale viene dai Caraibi e non dalla parte continentale. Siccome i caraibici sono anglosassoni e con molta influenza francese, dopo la Seconda Guerra Mondiale lottano per la loro emancipazione, come mostra lo stesso Frantz Fanon in Martinica, e lo fanno cominciando a studiare il post-coloniale e affrontando il tema del razzismo a partire dal marxismo.
Ci sono argomenti molto forti che dimostrano che il capitalismo è parte costitutiva della Modernità, perché il suo sistema economico e i suoi fondamenti metafisici sono nel progetto stesso della Modernità, non nell’economia in sé. Si tratta dell’individualismo metafisico, della quantificazione della realtà, ovvero di tutto il progetto che comincia con Bacone, Descartes, Newton. Se io prima avevo argomenti secondari contro la Modernità, adesso le mie idee sono più forti: se continuasse, la Modernità annichilerebbe la vita sulla Terra. Il capitale manifesta l’impossibilità di superare il problema ecologico, perché la concorrenza esige di migliorare la tecnologia a breve termine, ottenendo meno valore dalla merce e distruggendo così le altre con un prezzo più basso di vendita. In questo senso, il problema ecologico non è un problema della tecnologia, è un problema di criterio e della concorrenza del capitale. Se non superiamo il capitalismo, non è che entreremo semplicemente in una tappa critica, no, sparirà la vita sulla Terra. L’argomento è molto forte: la vita o la morte.
Dobbiamo transitare a un nuovo tipo di civilizzazione transcapitalista, ma anche transmoderna, cioè si devono trasformare le relazioni con la natura, perché questa natura è parte della biosfera e, distruggendola, l’essere umano sparisce. L’aumento della temperatura sulla Terra, per esempio, è un argomento contro la Modernità e il capitalismo. E questo nessuno lo può negare. È la fine della vita umana. In questo momento sono convinto più che mai che il capitale e la Modernità siano due aspetti dello stesso fenomeno, senza dimenticare, certamente, che la Modernità è la totalità della cultura che dà i fondamenti al sistema economico capitalistico. Ed entrambi o terminano, o l’umanità non può entrare in un’epoca totalmente differente, basata su un altro tipo di relazioni politiche ed economiche, di genere ed etiche. Una relazione differente con la vita, perché o riusciamo a compiere questo passo, o sarà la sparizione dell’umanità, l’homo sapiens finirà in due secoli, perché la Terra non resisterà più.
Non sappiamo come sarà questa nuova civiltà, ma intuisco che somiglierà più a certi modelli dei popoli originari che alla Modernità, fondata su una riproduzione della vita più semplice, ecologica, con grandi invenzioni a livello elettronico e di altro genere, con un uomo come lo pensava Marx, più poetico, più spirituale, più creatore e meno interessato all’aumento quantitativo della realtà. Avremo meno mezzi di comunicazione e saranno più utili, spariranno molte cose non necessarie, saremo più asceti nell’uso del cibo e nello spazio delle case. Infine, un’altra civiltà e non so come sarà, ma la chiamo “transmoderna”, è un concetto negativo, ma non è il post-moderno – che era l’ultima tappa della Modernità –, sarà qualcosa di totalmente differente.
Il punto culminante della critica, che varia nella storia, è porsi nel luogo delle vittime del dominio di un sistema. Che l’operaio sia una vittima del capitalismo è un elemento che si deve considerare per dar conto che è lui a produrre plusvalore, è lui la vittima costitutiva del capitalismo. Ma non è la vittima finale. Oggi vediamo, infatti, moltitudini escluse dalla possibilità stessa di avere un lavoro, i “miserabili” che non hanno neanche un lavoro, sono loro le massime vittime, non più l’operaio. Ma in generale, le vittime del capitalismo sono le culture dominate e scopriamo oggi molte vittime, assumendo visioni critiche di sistemi particolari. Questo è un problema etico-politico che diventa teorico, ma la teoria è inserita in un’etica e non è una critica puramente teorica, bensì politica nel senso ampio del termine. A mio giudizio, la critica è sempre esistita, ma si deve scoprire di nuovo quali sono le vittime dell’epoca, per tornare a rinnovare il punto di appoggio critico al sistema dominante.
E per me, la politica è trarre principi astratti dall’etica per concretarli come principi normativi. Se non so che sono principi etici, non so quali sono i principi normativi, e la politica, in effetti, rimane in aria (il che succede in quasi tutte le politiche). Pongo un’etica che è il fondamento della normatività dell’economia, della politica, del problema di genere, di tutti i campi pratici. Grazie all’Etica della Liberazione, del 1998, ho sviluppato una chiara etica che adesso mi serve da fondamento per una politica a livello dei principi, a livello delle mediazioni istituzionali e mediante la prassi politica. È un’etica pensata che parte con Apel, al quale deve molto, ma che va molto al di là di lui, perché difende un principio materiale di fattibilità e soprattutto un principio critico che Apel non assume. In realtà, la parte centrale della mia Filosofia della Liberazione è etico-politica, ma include un’antropologia che fu la prima a cui ho lavorato: il pensiero ellenico e il pensiero semita. Nella Filosofia della Liberazione abitano vari subsistemi e voglio terminare di sviluppare l’estetica, che è differente ed esige altre categorie che non sono più dell’etica e che determinerà tutti i campi del pensiero umano.
Ho iniziato dalla mia tesi di laurea, pensando ciò che Aristotele chiama il principio teleologico. Il fine e il fine che determina i mezzi. Ogni azione ha un fine e il fine in politica è avere un progetto rivoluzionario come alternativa al presente. Se l’attuale è il capitalismo, c’è un progetto socialista ben definito che opera come alternativa. Walter Benjamin, tuttavia, comincia a porre in questione molte cose, passando dal campo celeste a quello terreno. Benjamin dice che non si può avere un progetto, perché il progetto si va facendo e la pretesa di sapere ciò che viene è un’illusione. Ciò che possiamo fare è stabilire i principi per mezzo dei quali scelgo le mediazioni che si presentano contraddittoriamente. Io la chiamo “la bussola”. Vado verso il nord, come è il nord?, non lo so e mai si sa. Un esempio è lo stesso capitalismo. Nel XVI secolo non si poteva dire: «Stiamo costruendo il capitalismo» come alternativa al feudalesimo, non si sapeva. Le masse borghesi delle città stavano lottando contro i signori feudali e questi cittadini lottavano contro i principi che accumulavano terre e che non le sfruttavano. Costruivano un mondo nuovo e certamente costruivano il capitalismo, ma non sapevano il nome, né avevano un progetto. La prima volta che avranno chiara certezza di ciò che stavano facendo sarà con La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, dove si definisce relativamente ciò che è il capitalismo. Ma questo dopo tre secoli e con l’egemonia politica ed economica dell’Europa su buona parte del mondo. Non c’è un progetto come tale. La bussola non dice come è il nord. Allora, come arrivo al nord?, camminando, e in ciascun passo cercando quello che risponde al criterio selezionato.
Nell’attualità è possibile constatare l’esistenza di piccole cooperative che riflettono le esperienze del lavoro comune nel Sud globale. I popoli originari che hanno le loro comunità da migliaia di anni, che resistono, che sono molto ecologici, che non ricevono gli impatti negativi dell’economia capitalista, sono anche molto ripetitivi. Ci sono altre esperienze: per esempio, quarantamila persone nel Cono Sud, di fronte ad una indigenza assoluta, hanno creato le loro monete e hanno iniziato a produrre un sistema economico, dove si riceveva questo denaro stampato e sorgeva una piccola bolla capitalista. A mio modo di vedere, si tratta di costruire principi per sapere scegliere tra le esperienze che si stanno facendo male e quelle che sono sostenibili mediante una strategia che si andrà dispiegando lentamente in decenni, e anche secoli. Non è rapido. La rivoluzione che cambia tutto un sistema in un giorno è illusoria. Si cambiano alcune cose, ma, in fondo, le strutture continuano eguali. Nell’Unione Sovietica, senza andare troppo lontano, si fece la rivoluzione socialista con Lenin, ma la Modernità rimaneva in piedi. E ancora, il socialismo reale è moderno, tanto moderno come il capitalismo e anch’esso si deve superare, perché accetta il mito del progresso quantitativo che dice: «Abbiamo aumentato la produzione, questo anno è stato un successo». Molto bene, abbiamo maggiore produzione per maggiore consumo, e la popolazione vive con maggiore prosperità materiale, ma questo regime che ha significato per l’ecologia? Il socialismo reale è parte integrante della civiltà del XX secolo anti-ecologica, non aveva nessuna considerazione per l’ambiente, continuò ad essere razzista, continuò ad essere patriarcale. Fu una rivoluzione al livello della distribuzione del mercato con un importante intervento economico dello Stato, ma tutto il resto continuò eguale e un giorno crollò tutto perché non lo avevano considerato. Pertanto, una rivoluzione profonda esige tempo, profondità e scelta di criteri che ci portino a un altro sistema sociale.
In cosa consiste la “trans-modernità”? Consiste nell’avere attenzione per la natura, consiste nell’avere rispetto per l’eguaglianza della donna, significa combattere il razzismo, significa un’educazione differente dei bambini e delle bambine, infine, significa molte cose che dobbiamo compiere. Questo subito va a cambiare l’orientamento quantitativo. La nostra civiltà uccide la vita e non sa come fermarsi davanti alla morte. Ciò che si deve fare, dice Benjamin, è porre un freno, tutto ciò che permette di frenare creativamente è la strada. Pertanto, se eliminiamo l’auto e poniamo mezzi comuni di trasporto, è un progresso. Se riusciamo a fare in modo che il lavoratore stia più vicino al suo lavoro, è progresso. Questo dovrebbe essere pianificato per dipendere meno dal trasporto, dall’auto, dalla benzina, ecc. Una vita diversa. Mangiamo più e ci ammaliamo. Dobbiamo essere più austeri. L’alternativa è inimmaginabile, ma si deve avere, altrimenti andiamo verso la morte.
La questione della vita è dietro tutto ciò che abbiamo detto fino a qui. Ciò che è in gioco oggi non è il male, l’ingiustizia, neppure il sacrificio; è la morte dell’umanità, la sua sparizione. Si deve affermare la vita come primo principio etico, e tutto il mio lavoro sull’etica è dedicato a questo. Si deve affermarla con il consenso, renderla fattibile, così che si faccia e si critichi ciò che si fa. Su questa etica della vita, direi che la vita sarà al centro e non l’aumento del tasso di profitto come nel capitalismo contemporaneo. Questi trasforma tutto; cambia le relazioni umane, l’infrastruttura, l’arte, la storia; sono tante le trasformazioni, questo compito implica avere una grande capacità visionaria, come fece Tommaso Moro nell’Utopia.
È bene che l’indigeno coltivi la sua identità e progredisca a partire dalla sua esperienza. Ma ciò nonostante, un uomo urbano non potrà essere indigeno, questo è impossibile. L’uomo urbano deve recuperare una capacità che ha perduto, perché l’umanità è diventata urbana e tra trent’anni il novanta per cento della popolazione vivrà in città. L’argomento sarà ancora più complicato: come umanizzare una città concentrata? È molto difficile. Ma si deve immaginarlo possibile, perché, al contrario, ciò che ci resta come alternativa è la sparizione. Per questo il mio argomento contro la Modernità è diventato travolgente, perché spariremo. Siamo in una civiltà che produce morte senza darsene conto, e ciò che si deve fare, al contrario, è affermare la vita. Sarà proprio questa etica che permetterà che l’umanità continui, al contrario sparirà. L’essere umano non può dimenticare le sue condizioni di possibilità nella vita, e a partire da ciò è necessario che umanizzi la società, ma non per mezzo dell’aumento del tasso di profitto, che distrugge la vita, distrugge i mezzi che rendono possibile la riproduzione della vita. L’una o l’altra, non c’è una terza alternativa. Teoricamente, si può fare moltissimo, rendendo responsabile e consapevole l’umanità che le alternative sono tra la morte futura e l’organizzazione di un mondo diverso.