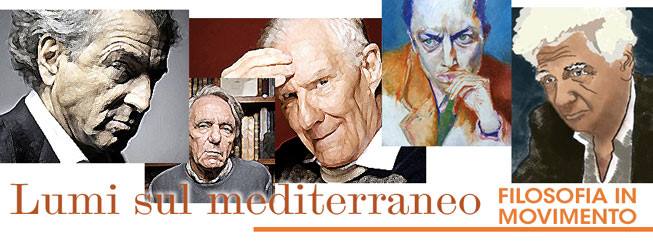La fede nella ragione critica ed emancipativa nel lavoro di Stefano Petrucciani (SP).
Una riflessione di Mario Reale sul pensiero e la ricerca di Stefano Petrucciani in questi anni di attività accademica. Discorso tenuto presso il dipartimento di Filosofia della “Sapienza” in Roma il 14 novembre 2023. Il presidente di Filosofia in Movimento traccia un profilo intellettuale del filosofo e studioso romano.
Il primo libro di SP dal titolo Ragione e Dominio. Autocritica della razionalità occidentale in Adorno e Horkheimer, Salerno Editrice, 1984, meriterebbe senz’altro, a quarant’anni esatti dalla sua uscita, una seconda edizione. Anzitutto perché, con padronanza dei testi e della letteratura critica, vi si esamina, in una sorta di amplissimo commento a Dialettica dell’illuminismo, la prima opera a quattro mani dei due fondatori della «scuola di Francoforte», e quindi perché vi sono chiamati in causa e discussi con acutezza, molti e impegnativi autori rilevanti per il tema prescelto: da Hegel e Marx, a Schopenhauer, Nietzsche e, con particolare cura, Lukàcs. Ma, più ancora, il testo si raccomanda per la maturità e novità dell’interpretazione che, per illustrare un’originale tesi circa la critica all’illuminismo dei due autori, si serve di tutte le possibili risorse della «razionalità occidentale», nella convinzione che mai dalla ragione – né sembri una cosa ovvia – si possa uscire, e che per «ragione» debba intendersi uno strumento critico e d’intrinseca ricchezza, come già in nuce nel pensare-dire di Aristotele in Metafisica IV, 4, quasi alle origini della tradizione del pensiero nato in occidente e che Kant riconosceva ancora necessariamente nostro. Da ogni immersione critica la ragione sembra riemergere quasi chiedendo una nuova definizione, poiché esce rafforzata ogni volta che, conoscendo il mondo, allarga altresì la sua forza e la consapevolezza di sé.
La ragione è una realtà che si mantiene, per quanto forti siano le critiche che possano esserle rivolte, e che debbono essere di necessità risolte per SP in auto-obiezione, in un movimento che va entro di sé, per uscirne più avvertito e vigoroso. Sembra ovvio e persino banale, ma non lo è. Tutti cerchiamo in un certo modo la ragione, la perenne ragione occidentale – quella stessa di Hegel, nonostante tutto, e di Marx – ma nel duro lavoro perché essa si affermi, aprendosi alle più pressanti novità (perciò nella tradizione «occidentale»), estendendosi e acuendosi, rischiamo spesso, ora più ora meno, di lasciarci travolgere da questo bisogno di critica, dalla specificità e autonomia di taluni problemi o campi del sapere, fino a smarrire la forza unitaria dello stesso soggetto di queste operazioni, o, in altri casi, fino a dichiararlo persino sistematicamente diverso e contrastante con la ragione. Al contrario, SP è, nei riguardi della ragione, come un chierico cha abbia già pronunciato da tempo i suoi voti solenni, attenendovisi poi rigorosamente e à jamais; o come il cristiano consapevole che i dubbi e l’ateismo sono ciò da cui sempre la fede deve riemergere. Semplicemente, ma in modi nient’affatto semplicistici, quasi fosse una raison illuministica vista come modesto e già segnato approdo, nella selbst-Darstellung di un suo libro, SP dice in modo piano – ed è la cifra propria di tutto il suo lavoro – di aver svolto la sua ricerca «senza nulla concedere all’irrazionalismo». Della ragionevolezza, per così dire, della ragione è ineliminabile compagna, in uno scavo che, come s’è detto, non termina mai, la sua «autocritica», che già la specificazione di «occidentale», nel suo aspro e contrastato cammino, lascia intravedere.
Questa fiducia – ma direi proprio anche fede – nella ragione, nel parler raison, è così forte, costitutiva in SP che non teme di affrontare, senza paura di perdersi, le sfide più ardue e perigliose, quando altri abbandonano il campo o lo circondano di numerosi schermi gergali e fumosi. La cosa è evidente già in questo stesso libro a proposito di Adorno. Molti direbbero che il sospettoso critico della ragione, sia il meno adatto a comprovare l’assunto di cui parliamo; ma SP è un «credente» che non si lascia smuovere né commuovere, ché anzi è disposto a iscrivere impavidamente nelle fila dell’universale ragione anche Adorno e il suo sodale Horkheimer di Dialettica dell’illuminismo, del resto molto amati, quando si tratti di ricondurre a ragione il nero, sfuggente e quotidiano campo, del «dominio». La sfida forse maggiore è consistita nel salvare Adorno dalle dure critiche che Habermas gli riservò nel Discorso filosofico della modernità, un testo d’altra parte fondamentale tra i points de repère di SP: esemplare è il modo in cui SP si pone contro l’attacco di Habermas ad Adorno, finemente riconoscendogli ragioni e un sostanziale torto.
L’altro termine del titolo, Dominio, non mi risulta essere un termine del lessico marxiano e marxista, nemmeno come Herrschaft del capitalista sull’operaio (ma con l’eccezione, almeno, di Gramsci, per il quale «dominio» è termine chiave come apparato coercitivo dello Stato novecentesco, in coppia con il diverso momento di direzione, consenso ed egemonia); con i francofortesi sta qui a significare, le forme di oppressione sugli altri uomini e su se stessi al di là, non fosse che per il trascorrere del tempo con le sue novità, delle distorsioni ormai canoniche, diagnosticate e combattute da Marx, e poste a base, da Adorno e Horkeimer, di ogni teoria critica ai fini di un’emancipazione sociale e politica: dalla famiglia e dalla riproduzione della vita, dall’«autorità» in generale, fino insomma a ciò cha accade prima e dopo la stretta sfera economica, persino del tempo libero e del divertimento. La ragione, d’altra parte, come s’é detto, se vuol essere pari a se stessa, deve poter mostrare un incessante volto critico, abbracciando e valutando ogni aspetto delle ferite e dei danni che gravano sulla nostra vita, mettendo sempre in campo, appunto, un’«autocritica». Ma con questa più vasta opera la ragione, qualificata subito come «occidentale», si muove entro l’unico modo di ragionare che, da Aristotele a Kant e fino a noi, si conosca; e, infatti, con movenza hegeliana, il pensiero torna indietro nello scavo intensive per andare avanti, giungendo al suo risultato attraverso un’autocritica della ragione stessa, che mentre conosce allarga altresì la sua capacità di comprendere, riemergendo ancor più forte da ogni esercizio critico.
Cercherò ora, a partire dall’ultimo libro appena uscito di SP – La Scuola di Francoforte, Carocci 2023 – di andar dietro geneticamente, fino appunto al capostipite Ragione e Dominio, avanzando in breve qualche motivo che è caratteristico dell’intera produzione scientifica di SP. Con l’avvertenza tuttavia che si tratta di note sparse, che avrebbero bisogno di ben altro impianto e spazio, poiché così come si presentano non sono sufficienti né intensive né estensive a dar conto dell’imponente ricerca di SP in più di 40 anni di intenso lavoro. E, Francoforte essendo non un luogo fisico il cui cuore, pur avendo dato i natali a Goethe, batte al ritmo delle quotazioni in borsa, ma una sorta di categoria dello spirito, una Geistige Heimat per SP, bisogna presupporre la presenza della sua ‘Scuola’, per lode o per qualche biasimo critico, in tutto ciò che verrò dicendo, anche quando non sia apertamente nominata.
La mia prima nota riguarda, come premessa, lo stile o il bello scrivere di SP, subito in qualche tacita opposizione alla prosa di Adorno. Benedetto Croce ha scritto che solo chi pensa bene scrive bene. Forse l’affermazione è troppo perentoria, gravata da un numero eccessivo di eccezioni, ma certo è che la prosa detta in senso largo «scientifica» (ossia non d’arte) ha molti scrittori «ben pensanti» al suo attivo, in una tradizione cui esemplarmene appartiene (o ne è per altri iniziatore), secondo una storia molte volte tracciata, Galilei e in cui si iscrive lo stesso Croce in quanto, è stato scritto, costituisce il «più grande prosatore italiano dopo Manzoni» (Benjamin Crémieux). Non voglio farla lunga, ma SP s’iscrive, a suo modo certo, in questa corrente le cui caratteristiche sono la chiarezza, la concretezza, la precisione e la vicinanza il più possibile al linguaggio comune, come voleva lo stesso Galilei. La notazione non è affatto irrilevante se si pensa che nei pensatori di cui SP si occupa c’è non di rado gergo o vertigine dell’oscurità e che è suo point d’honneur sciogliere ogni pesante ostacolo linguistico nella più limpida forma possibile, tanto ch’è un vero piacere leggerlo. Anche per questa tersità di scrittura, SP è divulgatore e mediatore tra culture di alta classe, come per esempio nella curatela della difficile Dialettica negativa adorniana, o nella laterziana Introduzione ad Adorno, che volge in buon italiano un pensiero originariamente espresso in prosa avvoltolata, capricciosa e sincopata. Adorno ha scritto un saggio per aiutare i lettori a leggere la difficile prosa hegeliana, posta sulle orme dell’antico Eraclito: ’Scoteinos, ovvero come si debba leggere uno scrittore oscuro come Hegel’ (in Tre studi su Hegel, ed. or. 1963, tr. it il Mulino 1971); ma Adorno stesso ha bisogno, per essere compreso ed esplicato, di traduttori e commentatori come SP, che assumono su di sé il difficile compito di tradurre il «traduttor d’Omero», il caliginoso Adorno. La chiarezza infine è pensata da SP quasi come un compito civile e morale verso i suoi lettori, che perciò gli dovrebbero essere riconoscenti.
La prima cosa di merito su cui ora mi soffermerò è la fedeltà di SP ai suoi temi, e dunque anche a se stesso. Questo può essere anche un limite, quando si continui a lavorare per anni un ristretto campicello; ma non c’è affatto pericolo che questo sia il caso di SP, la cui vastità d’autori e d’interessi è notevole. Ciò vorrà dire allora che non vi sono nel suo lavoro né retractationes di ciò che è stato fatto fin lì, né – refrattario SP a ogni moda, anche quando si occupi di autori alla moda come Marcuse – interruzione della continuità d’interessi in cui irrompano prospettive diverse e di segno al tutto contrario. Le vie sono classicamente segnate da SP fin da da quando era giovane, e il suo lavoro di ricerca consiste principalmente perciò in un lavoro di scavo e approfondimento, di un hegeliano tornare indietro per andare avanti. Già i due libri che abbiamo ricordati, il primo e finora l’ultimo, si occupano di una costellazione vasta di autori e problemi. E SP sa bene come allargare in mille modi questo dominio già non modesto. Penso ad esempio alle tre sillogi tematiche einaudiane che SP ha dedicato a: Modelli di filosofia politica (2003), il capostipite che io amo di più, Democrazia (2014), Politica (2020). In questi brillanti, acuti e del tutto attendibili exploits, non c’è affatto ripetizione del già noto, ma fili di domande originali che danno riperimetrazione e profondità al campo di lavoro. Ed è come fare ogni volta i conti con un intero sapere, che certo è costituito, per SP anzitutto dalla filosofia politica, in senso largo, con i suoi temi e autori, con la sua storia che giunge fino alle realtà che cominciano ad affiorare o si sono appena aperte – ma all’insegna di «novità» di cui vorrei segnalarne almeno due, riguardanti la storia e la filosofia, le due fondamentali conoscenze che Croce diceva geminae ortae.
La prima è la consapevolezza che la filosofia politica, come gli antichi fino Machiavelli ci hanno insegnato, riposa sulla storia tout court, storia come accadere di eventi in cui la politica è saldamente iscritta – attraverso i molti «accidenti» di Machiavelli o, attraverso la sua fonte polibiana, le molte lotte e fatti e peripezie (dia polllon agonon kai pragmaton) – potendo solo di qui trascorrere in idealizzazioni e persino in utopie. Per esempio, ricchi e poveri sono in Aristotele materia direttamente politica, quel che non saranno più in età moderna, quando la stessa complessità dei problemi e l’irrompere sulla scena politica di grandi masse renderanno necessario l’uso dell’astrazione con tutte le sue possibili mistificazioni, donde il limite di immediatezza in taluni dei pur notevolissimi scritti giovanili di Marx, come la Judenfrage. Il senso storico di SP è così vivo da trapassare talora, nelle sillogi di cui ho detto, direttamente nella storia generale cui a volte sono dedicate specifiche rubriche a riscontro di temi e figure filosofico-politiche; ricordo qui solo la Parte prima di Democrazia, con rubriche dedicate tutte e solo alla storia generale (v. per es. pp. 64-79).
L’altra novità sta nel modo d’intendere il rapporto di filosofia e politica nell’endiadi o sintagma «filosofia politica». C’è qui un pericolo che troppo spesso mi pare non venir scansato, quello cioè di intendere che la filosofia in quest’ambito sia solo quella che serve ai fini di un sapere politico: non di più, e trattato allora nelle convenienti e modeste maniere. Ma non è così, non esistono filosofie solo «locali» e la filosofia è sempre una. Non so, forse era meglio la dizione di Croce, che diceva «filosofia della politica», quasi un intero che si volga ad esaminare particolarmente un ambito della realtà, non una filosofia ricavabile volta a volta dal proprio oggetto. Fatto è che SP è innanzitutto un filosofo tout court, un filosofo «puro», non a caso formato alla scuola di Gennaro Sasso, che si occupa spesso o prevalentemente di politica, mantenendo tuttavia integra e piena la sua capacità di filosofare, a qualunque oggetto si volga. La filosofia nella sua interezza non è affatto un orpello o una belluria per il pensare politico e persino per la «Scienza politica»; tutt’al contrario fornisce non solo rigore logico, ma anche criteri ermeneutici, la capacità di proporre nuove tesi e suggestioni al pensare politico.
Quel che dico riuscirebbe alquanto astruso se non indicassi subito un esempio di ciò che intendo, ricordando uno dei libri più belli di SP, anche se forse non tra i più noti, che s’intitola Etica dell’argomentazione. Ragione, scienza e prassi nel pensiero di Karl-Otto Apel, Marietti 1988 (di cui, come per Ragione e Dominio, mi sembrerebbe molto utile una seconda edizione). Come Apel non è un filosofo politico, se non indirettamente per la congiuntura che lo accostò in un certo tempo ad Habermas, egli stesso non proprio filosofo politico, così del pari SP si tiene qui a questioni squisitamente filosofiche quali la «Fondazione della razionalità e l’idea di semiotica trascendentale», o «Spiegare e comprendere», e così via. Forse è evidente già di qui, inoltre, che questo non è un libro di storia della filosofia, ma di puro esercizio di filosofia in atto. E siccome neanche questa distinzione è del tutto ovvia nel senso che vi sono esimi cultori della storia della filosofia, che non hanno alcun senso e orecchio e gusto di quel che sia veramente filosofare, mi piacerebbe, se avessi tempo, soffermarmi su qualche problema determinato per mostrare cos’è questo filosofare nel libro di SP, seguendolo in esempio circa la domanda sull’«argomento migliore», se c’è e in che consista, un tema dibattuto nella prospettiva dialogica e deliberativa.
Nel denso Prologo a Modelli di filosofia politica, la silloge che m’è più cara SP s’interroga proprio intorno a questo problema, al fatto cioè che la filosofia politica «prima che essere politica è filosofia». Con Leo Strauss si osserva che ogni domanda su ‘cos’è la filosofia politica’ ne presupponga un’altra su ‘cos’è la filosofia’, domanda necessaria per un sapere non codificato, non avente un suo indiscutibile statuto. E’ sconsigliabile ora, ché mi porterebbe via molto tempo, soffermarmi su quale sia il concetto che SP ha della filosofia – che rinvia in generale a un metodo di «argomentazione pubblica, critica e aperta», in una sorta di «ininterrotto dialogo argomentativo», in un «continuo scambio di ragioni e critiche», nella ricerca di «argomenti persuasivi». Gli «strumenti del dialogo razionale» vengono impiegati per dirimere e innanzitutto impostare i grandi problemi della filosofia.
Ma qual è ora l’indirizzo metodico generale nello studio di questi problemi? SP si occupa spesso della classica distinzione tra approccio «normativo», che lui predilige, o approccio «realistico» alla filosofia politica – me ne occupo qui a partire dalla densa e bella ‘Parte prima’ di Politica. Una introduzione filosofica, Einaudi 2020. Il quadro generale entro cui SP si iscrive (e che ha irrobustito anche un mio personale convincimento) è che in ogni seria considerazione di filosofia politica, o della sua storia, non possa mancare né il momento normativo né quello realistico. Pare un asserto ovvio, ma non lo è affatto. Le resistenze maggiori a questa pacificazione, e dunque la permanenza in una guerra, vengono forse dai «realisti», attaccati platonicamente alle rocce, e sospettosi di ogni posizione che esuli dai cosiddetti «fatti» e dalla loro inaggirabile durezza. Ciò che soprattutto disturba questi austeri esprits forts, che, a partire dal Trasimaco e dal Gorgia di Platone, sempre affermano solo il diritto del più forte, è la presenza di un’antropologia comprensiva della capacità umana di morale e giustizia politica, in un vacuo discorso aperto, come si rimprovera loro, alle sirene dell’ideologia. Ma certo è, d’altra parte, che, sia pur non sempre sottraendosi esso stesso a configurazioni ideologiche, il realismo smaschera pigre abitudini, fa pulizia di ciò che Hegel chiamava la «pappamolla del cuore», ed è essenziale a ogni seria considerazione della realtà. I grandi scrittori realistici si leggono volentieri e c’è sempre da imparare da essi: da Tucidite a Machiavelli a Hobbes agli stessi Hegel e a Marx. In conclusione, SP mostra una buona dose di realismo e di critica profonda, che fanno così parte del suo bagaglio culturale, tanto da indurlo a scrivere in questa vena uno dei suoi saggi più belli dal titolo: «Democratizzare la Democrazia. E’ ancora possibile?».
Ma la sfera della morale costituisce, a sua volta, essa stessa un «fatto», una realtà dell’umano che, senza bisogno di alcun fondamento né ora di più complessi ragionamenti, si dà – es gibt, o es geht so – è qualcosa di cui nessuna teoria critica, benché sofisticata, potrebbe fare a meno, e che da parte mia risolverei, con Hobbes, nelle forme della socialità, distinte dai precetti religiosi. Del resto credo che, tra i due campioni moderni del realismo, Machiavelli e Hobbes, così come per certi versi anche in Hegel e in Marx, le cose siano più complesse. Machiavelli non può essere iscritto tout court all’ordine di un radicale e totale realismo, perché non può esser privato della volontà controfattuale di mutare il mondo e mutare se stessi (un centrale passaggio come si vede nella rigidezza dell’esser o impetuosi o rispettivi). Machiavelli fa in realtà ricorso – oltre che a realistici strumenti, come la volontà di un Principe o la ferma costruttività delle leggi repubblicane capaci di creare una seconda natura dell’uomo posta politicamente – alla risorsa morale, etica e persino profetica, dell’ultimo capitolo del Principe, o della «società bene ordinata» dei Discorsi. L’ardita costruzione di Hobbes d’altra parte, l’Hobbes’s argument, non potrebbe mantenersi senza la decisiva risorsa morale della legge di natura ai fini dell’ingresso nella politica.
Se moralità e realismo vanno sempre insieme, sospetta è allora la scelta di un criterio contro l’altro. SP, che pur potrebbe falsamente apparire, richiamandosi apertamente a questa impostazione, un deciso ed esclusivo normativista, non manca affatto di un chiara esigenza realistica, che lo distingue anche da tutti gli ingenui seguaci del solo dover-essere. Il realismo è decisivo come condizione di possibilità e al tempo stesso esito dell’intero discorso argomentativo e deliberativo. In generale a me sembra che SP ascolti con passione e interesse lo svolgersi nel mondo delle cose politiche. Solo che – oltre a considerare il piano della filosofia politica posto in un piano più alto delle mutevoli contingenze – non ama critiche che cerchino di mettere in crisi, nella loro puntualità, il suo intero apparato categoriale di riferimento, per esempio riguardo alla democrazia considerata a muovere, realisticamente, da quella che conosciamo oggi. Per SP la democrazia, a partire dal così come la sperimentiamo oggi, costituisce un obiettivo che, nonostante le esuberanti difficoltà del caso, si deve mantenere sempre sullo sfondo, contro le repubbliche «democratiche» solo «immaginate», come diceva Machiavelli, che mai si sono «viste né conosciute in vero essere» (Principe XV); o contro le forme antiche o di spericolate e irraggiungibili o persino sconsigliabili proposte di democrazia: una realtà che per SP si legge essenzialmente nel mondo moderno, tra liberalismo e (eventuale) socialismo (o altrimenti come consapevole e diretto prodotto «engelsiano» del movimento operaio con il modello da altri imitato del suo grande partito socialdemocratico di massa). Le grandi famiglie che costituiscono l’ossatura del pensiero politico moderno sono altresì il masterplan degli studi di SP.
Ci potremmo chiedere da ultimo come la personalità di SP si trasmette nel suo lavoro di grande e infaticabile studioso. Io direi così, che c’è in SP sia un’anima profondamente liberale che un senso forte della comunità. Il tratto liberale, continuerò a chiamarlo così, consiste, nel liberalismo quale veniva definito da Adolfo Omodeo in quanto cioè formazione e natura dell’uomo moderno, critico, laico, curioso, aperto agli altri e al futuro, disposto alla parità tra gli uomini, contrario a ogni forma di retriva chiusura; un liberalismo che deriva in SP da una naturale disposizione oltre che, come suppongo, anche da educazione familiare, e che si mostra ad ogni passo della sua vita e dei suoi studi (così mi apparve quando, ormai poco meno di 50 anni fa, lo conobbi). Ma, proprio perché questo liberalismo è radicale, l’attenzione di SP è rivolta, forse di preferenza, ai limiti e alle insufficienze della democrazia liberale, a ciò che essa ha trascurato, alle molte forme di dominio che non ha combattuto. Ciò apre per SP il grande interesse per il socialismo, la forza capace di colmare questi vuoti, in cui coerentemente Marx è inteso come grande storico e critico della società, pensatore della libertà, la cui intera lezione è insostituibile e inesauribile (cfr. di SP, Marx in dieci parole, Carocci 2020). In una simile lettura, che si è intensificata negli ultimi anni, sono scansate sia le secche delle anguste e minute analisi circa il «vero Marx», con esclusione di altri volti, come ad esempio il «giovane Marx», nonché, meno che mai, le critiche che ne fanno un «cane morto» perché i suoi quarti di scientificità (secondo un rinsecchito concetto di scienza) non sono puri, o infine i tentativi di farne un autore compiuto e magari disposto a esser messo in un insegnamento dogmatico.
L’altro tema, quello della comunità, è forse già in parte mostrato dai lavori di cui parliamo. La «scuola di Francoforte» rappresenta per SP una societas, un collettivo di cui egli è studioso e custode: si veda con quanta cura ne esamina via via le sue figure, per ora fino a Jaeggi e Rosa; e soprattutto con quanta vigilanza ne difenda, al di là delle naturali diversità, una sostanziale e ancor leggibile continuità. La Scuola di Francoforte e il suo lascito sono stati da SP in ogni modo salvaguardati e seguiti attentamente con grande considerazione, ad essi dedicando, come a una grande comunità, non poca fatica e molto tempo. Ma diligenza, solerte riflessione e vigilanza di SP si rivolgono sempre, secondo la sua vocazione, alle comunità di ricerca, non ai gruppi decisamente politici o di partito. La cosa forse più evidente è il caso del Manifesto: un insieme di lavoro culturale e politico, di cui SP ha fatto parte in modo continuo, impegnato e fedele, senza però esser mai coinvolto, mi pare, sul piano strettamente politico e nei tentativi di farsi partito. Nonostante la disposizione alla communitas SP non ha mai sentito il bisogno di aderire a una comunità di partito. Credo che ci sia qui, al fondo, una difficoltà del pensiero a primaria inclinazione liberale, anche nelle persone più aperte, intelligenti e disposte a una strategia di cambiamento politico come Norberto Bobbio – di cui SP fa gran conto, cominciando dall’apprezzamento della sua civile prosa – a comprendere il partito politico, dal punto in cui la volontà generale va oltre il volere dei singoli, dando appunto vita, non potendo il tutto risolversi nel semplice gioco di maggioranza e minoranza, a una speciale comunità (donde la frequente sopravvalutazione, a parer mio, dell’opera di Robert Michels). Ma è un tema difficile e qui solo enunciabile, del quale ho avuto modo di discutere con lo stesso Bobbio nella corrispondenza che per molti anni ho intrattenuto con lui. Mi è accaduto di pensare che SP somigliasse un po’ a Frank Cunnigham, il nostro compianto e comune amico, che, come il suo maestro C.B.Macpherson, cercava di pensare gli sviluppi avanzati della democrazia, a partire dalla situazione canadese e nordamericana, prescindendo cioè quasi del tutto dai partiti politici. Ma oggi che accade, quando la realtà di un partito politico come quelli che abbiamo conosciuto fino agli anni ‘90 costituisce un’esperienza a parer mio qusi interamente consumata, in una situazione che Pietro Scoppola definì come quella del passaggio dalla «democrazia dei partiti» alla «democrazia dei (singoli) cittadini»? Oggi francamente non so se, pur con la perdita di talune esperienze, SP non abbia visto anche prima e meglio di altri quel che si doveva fare e quali ne erano i punti di riferimento.
II Proposta sui consumi
Quando si pensa a quel che SP ha fatto è necessario, e comunque non se ne può fare a meno, considerare anche quel che potrebbe fare nel futuro. Mi permetto qui di avanzare alla fine una modesta proposta, che mi darà l’occasione, prima, di parlare ancora dei lavori di SP già eseguiti. Il punto più nuovo e originale di La scuola di Francoforte, il testo appena uscito, sono i tre saggi su Marcuse: non solo perché, vi si affronta con ampiezza e profondità un autore che nel primo libro aveva rilievo molto modesto, né perché si riscopra un filosofo di solito superficialmente ricordato per un solo libro, unius libri, per pochi slogan o per la generica vicinanza al movimento del’68. La ragione principale è che in queste, che sono tra le pagine più belle del libro, c’è una riflessione maggiormente autonoma, libera e originale di SP che si può vedere per esempio nel capitolo sesto, e già nelle sue pagine introduttive, dove si legge cosa SP intenda per capitalismo, crescita economica, rapporto mezzi e fini, neutralità della tecnica, totalità sociale, e così via. Il testo su Marcuse non è privo di un’interessante vena biografica collettiva e forse anche autobiografica, dedicata al «complicato rapporto», pratico o ideale tra i francofortesi e il movimento del ‘68. SP ha un vero talento nell’infilarsi in argomenti scomodi, al qual proposito molti tacciono e per cui occorre libertà e coraggio, come quando fu tra i pochi che affrontarono il tema del crollo dell’URSS. Qui non era affatto facile dire felicemente in breve cosa fu il magmatico e per certi versi anche sfuggente Movimento del’68, un tema di cui bisognerà ancora occuparsi.
Tra le molte altre cose notabili in questa sezione del libro su Marcuse mi soffermerò ora su un tema in apparenza marginale e curioso, che non so fino a che punto sia tutto frutto di Adorno e Horkheimer o se non appartenga anche alla sapienza ricostruttiva di SP, che sa pensare con e oltre i suoi autori, nella direzione da essi indicata. La questione potrebbe esser posta così: nessuna generale forma di vita può dipendere dalla settecentesca imposizione di un tiranno, del soldato o del prete, dal «mero arbitrio dei gruppi dominanti», da una sorta di «follia o insensatezza collettiva». Ci interessiamo molto all’emancipazione dei «servi», ma cosa ha consentito che questa situazione di oppressione durasse secoli o millenni? Qui si parla del capitalismo che da un lato incorpora in sé l’elemento «dell’assurdo o della contraddizione» e non riesce «a superare la scarsità e la penuria se non riproducendola sempre a livelli diversi e più alti» – un’acuta osservazione di SP circa la «società opulenta», su cui ricordo il contributo de La Rivista Trimestrale – cui si collegano tutte le altre distorsioni generate dal capitale. Ma dall’altro lato il capitalismo è pure una complessa struttura economico-sociale che riesce – si dice – oggi «imbattibile» sul piano dell’allocazione delle risorse produttive, riuscendo a «innescare l’uscita di intere aree del mondo dal cono d’ombra della scarsità e della penuria, di assicurare la soddisfazione di bisogni veri e non solo di quelli falsi e «indotti».
E’ quest’ultima capacità del capitalismo, come vediamo bene intorno a noi, che assicura sempre (se non proprio «occupazione» e «benessere» come voleva Adam Smith) beni che vanno ben oltre la proverbiale ciotola di riso al giorno per tutti i cinesi e che tengono in piedi il capitalismo opulento. Questa opportunità di lunga vita pone in realtà problemi acutissimi a ogni tentativo di pensare il socialismo, che dovrebbe in primo luogo e necessariamente sapere ciò da cui si discosta, ciò che supera. Ad Axel Honneth mi pare che in sostanza SP dica che, pur con molti pregi, il suo ripensamento del socialismo manca di «storicità» (non tocco il punto dell’eventuale tramonto del capitalismo che somiglia alla seconda venuta del Cristo nel cristianesimo: attesa dapprima come imminente, ma quando, rinviando rinviando, non viene, costringe a ripensare interamente e faticosamente l’essere della Chiesa e dei fedeli).
Questo problema – su che si regga una società di oppressi con pochi «signori» dominanti o perché un complesso sociale «tiene»anche quando vi sono innumerevoli «servi» – è valido, nel discorso di Horkheimer e Adorno ricostruito da SP non per il solo capitalismo, ma per un tempo sterminato, assicurando continuità alla storia per interi millenni, (v. di SP, Marx al tramonto del secolo, manifestolibri 1995, ‘L’autocritica della modernità nel pensiero di Adorno e Horkheimer’, pp. 95-114). In simili società precapitalistiche i rapporti di dominio hanno sempre avuto una duplice natura: la garanzia del privilegio, certo, ma anche la sopravvivenza e la giustificazione della riproduzione dell’intera totalità sociale. Quest’ultimo elemento, dice SP, può esser configurato come il momento di «universalità», congiunto indistricabilmente con quello della «particolarità» nel dominio. Com’è potuto accadere, si chiede Horkheimer, che «per interi periodi la subordinazione coincidesse con l’interesse dei dominati»? La prima e forse principale risposta degli autori francofortesi riposa sull’originaria penuria dei mezzi di sussistenza e sulle necessità da essa imposta: dalla formazione di un un piano preordinato, più o meno consapevole e manifesto, formulato con una qualche collaborazione dei subordinati (si può fare qui un confronto, dice SP, con il dominio e il consenso di Gramsci), cui tutti devono conformarsi per instaurare, tra l’altro, una stabile gerarchia sociale, a partire dalla distinzione tra lavoro intellettuale e manuale. E a questa risposta si devono aggiungere gli altri campi di dominio «umani e artificiali» di cui abbiamo detto. Né devono sfuggire le innovative ricerche di chi ha configurato il signore come la sola possibile umanità del servo.
Ma che tipo di rapporto c’è allora tra privilegiati e soggetti, tra dominio e consenso? Come si articola un simile problema? Anzitutto la lotta per fare autonoma la civiltà dalla mera natura, come dice bene SP, si deve ampliare nel contrasto all’artefatta instaurazione della coazione e della repressione non solo sociale ma delle più forti pulsioni individuali. Ciò è conforme alla tesi forte di SP per cui l’Illuminismo è criticato nei primi francofortesi non per troppo ma per manco di una più sviluppata teoria critica che abbracci, oltre all’arcaico dominio tecnico e scientifico sulla natura – exeundum e statu naturae, come dicevano Spinoza ed Hegel – anche le forme emancipative che si dicevano un tempo «morali»: l’oppressione degli uomini sugli altri uomini (e su se stessi), a cominciare dalla ricchezza astratta, in quanto illimitato fine a se stessa. Non è sufficiente, dice conclusivamente SP a proposito dei limiti di Marcuse, stabilire con «ingenuità» quali sono «i veri bisogni e i veri fini umani per aver risolto alla radice ogni problema di irrazionalità sociale», né meno che mai, aggiungiamo, per cominciare a risolvere praticamente il problema.
A questo proposito mi pare che ci sia uno iato o un vuoto tra la discussione delle migliori forme di vita e l’inizio della lotta per recarle praticamente, come già teoricamente, in atto, specie se si dice, non a torto a parer mio, che la formazione capitalistica è oggi, dal lato della produzione, «imbattibile» (che non vuol dire in tutto accettabile). Ma se non dalla produzione, si potrebbe forse partire dai bisogni e dal consumo – sostenuto da una forte domanda aggregata e collettiva, non affidata alla dispersione delle singole famiglie, quasi «fini» posti al capitalismo – per provare ad allentare e in parte correggere i difetti del capitalismo, in favore di una società più razionale, sociale, più giusta e, aggiungerei, anche più «bella»? Com’ è noto l’economia politica classica, Marx compreso, negano che il consumo possa mai essere reso nemmeno in parte autonomo dalla produzione. Ma sull’indipendenza dalla produzione stanno alcuni esiti irrisolti dell’economia politica classica, numerosi tentativi fatti dagli scrittori che sono stati detti «utopistici» dell’800, e anche da qualche teoria critica novecentesca. Le domande che in conclusione pongo a SP, volendo guardare avanti, e non solo ripercorrere il già fatto, sono le seguenti. Nella teoria critica francofortese c’è qualche cenno positivo al tema del consumo o i consumi sono solo tenacemente criticati nella forma attuale (consumi indotti, ecc.)? E SP, con la sua esperienza e autorevolezza, che pensa di questa via? e sennò, quali strade ritiene percorribili per cominciare a ovviare al problema che ho detto della riforma, almeno teorica, del capitalismo?
Foto di Antonio Cecere: Mario Reale e Stefano Petrucciani impegnati in una riunione del comitato scientifico di Filosofia in Movimento nel 2019.